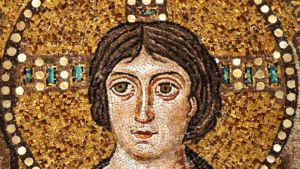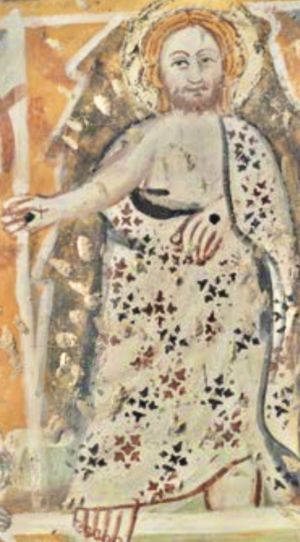don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Atteggiamento di Gesù rispetto alla Legge ebraica: motivazioni profonde, sapienza nascosta. Precetto - esigenza d’amore
Il Vangelo […] fa parte ancora del cosiddetto “discorso della montagna”, la prima grande predicazione di Gesù. Oggi il tema è l’atteggiamento di Gesù rispetto alla Legge ebraica. Egli afferma: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento» (Mt 5,17). Gesù dunque non vuole cancellare i comandamenti che il Signore ha dato per mezzo di Mosè, ma vuole portarli alla loro pienezza. E subito dopo aggiunge che questo “compimento” della Legge richiede una giustizia superiore, una osservanza più autentica. Dice infatti ai suoi discepoli: «Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli» (Mt 5,20).
Ma che cosa significa questo «pieno compimento» della Legge? E questa giustizia superiore in che cosa consiste? Gesù stesso ci risponde con alcuni esempi. Gesù era pratico, parlava sempre con gli esempi per farsi capire. Inizia dal quinto comandamento del decalogo: «Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai”; … Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio» (vv. 21-22). Con questo, Gesù ci ricorda che anche le parole possono uccidere! Quando si dice di una persona che ha la lingua di serpente, cosa si vuol dire? Che le sue parole uccidono! Pertanto, non solo non bisogna attentare alla vita del prossimo, ma neppure riversare su di lui il veleno dell’ira e colpirlo con la calunnia. Neppure sparlare su di lui. Arriviamo alle chiacchiere: le chiacchiere, pure, possono uccidere, perché uccidono la fama delle persone! È tanto brutto chiacchierare! All’inizio può sembrare una cosa piacevole, anche divertente, come succhiare una caramella. Ma alla fine, ci riempie il cuore di amarezza, e avvelena anche noi. Vi dico la verità, sono convinto che se ognuno di noi facesse il proposito di evitare le chiacchiere, alla fine diventerebbe santo! È una bella strada! Vogliamo diventare santi? Sì o no? [Piazza: Si!] Vogliamo vivere attaccati alle chiacchiere come abitudine? Sì o no? [Piazza: No!] Allora siamo d’accordo: niente chiacchiere! Gesù propone a chi lo segue la perfezione dell’amore: un amore la cui unica misura è di non avere misura, di andare oltre ogni calcolo. L’amore al prossimo è un atteggiamento talmente fondamentale che Gesù arriva ad affermare che il nostro rapporto con Dio non può essere sincero se non vogliamo fare pace con il prossimo. E dice così: «Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello» (vv. 23-24). Perciò siamo chiamati a riconciliarci con i nostri fratelli prima di manifestare la nostra devozione al Signore nella preghiera.
Da tutto questo si capisce che Gesù non dà importanza semplicemente all’osservanza disciplinare e alla condotta esteriore. Egli va alla radice della Legge, puntando soprattutto sull’intenzione e quindi sul cuore dell’uomo, da dove prendono origine le nostre azioni buone o malvagie. Per ottenere comportamenti buoni e onesti non bastano le norme giuridiche, ma occorrono delle motivazioni profonde, espressione di una sapienza nascosta, la Sapienza di Dio, che può essere accolta grazie allo Spirito Santo. E noi, attraverso la fede in Cristo, possiamo aprirci all’azione dello Spirito, che ci rende capaci di vivere l’amore divino.
Alla luce di questo insegnamento, ogni precetto rivela il suo pieno significato come esigenza d’amore, e tutti si ricongiungono nel più grande comandamento: ama Dio con tutto il cuore e ama il prossimo come te stesso.
[Papa Francesco, Angelus 16 febbraio 2014]
Trasfigurazione controcorrente. Fede e metamorfosi
Preghiera continua
La lotta incessante con noi stessi e con Dio
(Mt 7,7-12)
A volte mettiamo il Padre sul banco degli imputati, perché sembra lasciar andare le cose come le orienta la nostra libertà.
Ma il suo Disegno non è far funzionare il mondo alla perfezione dei transistor (di una volta) o dei circuiti integrati (nei rispettivi “package”) o “chip” [vari “pezzetti”]…
Dio vuol farci acquisire una mentalità da Nuova Creazione. La sua Azione ci modella sul Figlio, trasformando progetti, idee, desideri, parole, comportamenti standard.
All’inizio forse la preghiera può sembrare venata di sole richieste. Più si procede nell’esperienza dell’orazione nello Spirito del Cristo, meno si chiede.
Le domande si attenuano, sino a cessare quasi del tutto - nell’accoglienza sempre più cosciente, che si fa contemplazione e ‘unione’ reali.
Non sappiamo quanto tempo, ma il “risultato” subentra improvviso: non solo certo, bensì sproporzionato.
Ma come estratto da un processo d’incandescenza continua, dove non esistono reti logiche, né facili scorciatoie.
Riceviamo il Dono massimo e completo. E possiamo ospitarlo con dignità. Una nuova Creazione nello Spirito, un diverso aspetto.
Un Volto insperato - non semplicemente quello fantasticato o ben sistemato (come trasmesso o atteso).
Dio lascia che gli eventi seguano un loro corso, apparentemente distante da noi; quindi la preghiera può assumere toni drammatici e suscitare l’irritazione - come fosse una disputa aperta fra noi e Lui.
Ma Egli sceglie di non farsi garante dei nostri sogni esterni. Non si lascia introdurre nei limiti piccini.
Vuole coinvolgerci in ben altro che le nostre mète, di frequente troppo conformi a quello che abbiamo sotto il naso.
Inventa orizzonti dilatati, ci fa dialogare coi nostri stati profondi, affinché cediamo il punto di vista rigido e veniamo introdotti in altro genere di programmi.
Leggere gli accadimenti secondo un punto di vista totalmente “inadeguato” può aprire la mente - e modificare i sentimenti, trasformare dentro.
Quando qualcuno crede di aver capito il mondo, già si condiziona altre attese, più intense, che vorrebbero invadere il nostro spazio.
La preghiera allora dev’essere insistente, perché è come uno sguardo posato su di sé; non come avevamo pensato.
L’occhio interiore serve a fare una sorta di spazio sgombro, dentro, per accogliere la Presenza che non tira altrove l’io essenziale della persona.
Dimorando a lungo nella Casa della nostra essenza molto speciale.
Lo svuotamento consapevole dalle cianfrusaglie accatastate viene come colmato dal dialogo-Ascolto interpersonale con la Fonte dell’essere.
In essa è annidato il nostro Seme particolare: lì è come seduta e in fieri la ‘differenza di volto’ che ci appartiene.
Via le definizioni e aspirazioni da nomenclatura, in uno stato “scarico” ma colmo di energie potenziali - la nostra Pianta caratteristica e inconfondibile sfiora la condizione divina.
Attraverso il dialogo incessante col Padre nell’orazione, facciamo spazio alle radici dell’Essere, per una sorte differente.
Ciò nella lacuna consapevole di quella parte di noi che cerca sicurezze, approvazioni.
La preghiera continua (ascolto e percezione senza posa) scava e smaltisce il volume dei banali pensieri ridondanti.
In tale spazio si spalancano opportunità, si crea la pulizia interiore affinché giunga il Dono - anche stravagante. Non di seconda mano.
[Giovedì 1.a sett. Quaresima, 26 febbraio 2026]
Preghiera Continua: condizione di grazia e di forza, che non svia
Venir meno senza venir meno: lotta incessante con noi stessi e con Dio
(Mt 7,7-12)
A volte mettiamo il Padre sul banco degli imputati, perché sembra lasciar andare le cose come le orienta la nostra libertà.
Ma il suo Disegno non è far funzionare il mondo alla perfezione dei transistor (di una volta) o dei circuiti integrati (nei rispettivi “package”) o “chip” [vari “pezzetti”]…
Dio vuol farci acquisire una mentalità da Nuova Creazione. La sua Azione ci modella sul Figlio, trasformando progetti, idee, desideri, parole, comportamenti standard.
All’inizio forse la preghiera può sembrare venata di sole richieste. Più si procede nell’esperienza dell’orazione nello Spirito del Cristo, meno si chiede.
Le domande si attenuano, sino a cessare quasi del tutto.
I desideri di accumulo, o rivalsa e trionfo, lasciano il posto all’ascolto e alla percezione.
L’occhio che penetra si accorge di quanto è a portata di mano e dell’inusitato - nell’accoglienza sempre più cosciente, che si fa contemplazione e unione reali.
Non sappiamo quanto tempo, ma il “risultato” subentra improvviso: non solo certo, bensì sproporzionato.
Ma come estratto da un processo d’incandescenza continua, dove non esistono reti logiche, né facili scorciatoie.
Riceviamo il Dono massimo e completo. E possiamo ospitarlo con dignità. Una nuova Creazione nello Spirito, un diverso aspetto.
Un Volto insperato - non semplicemente quello fantasticato o ben sistemato (come trasmesso dalla famiglia o atteso a contorno).
Dio lascia che gli eventi seguano un loro corso, apparentemente distante da noi; quindi la preghiera può assumere toni drammatici e suscitare l’irritazione - come fosse una disputa aperta fra noi e Lui.
Ma Egli sceglie di non farsi garante dei nostri sogni esterni. Non si lascia introdurre nei limiti piccini.
Vuole coinvolgerci in ben altro che le nostre mète, di frequente troppo conformi a quello che abbiamo sotto il naso.
Inventa orizzonti dilatati, ma in questo travaglio dev’essere chiaro che non bisogna venir meno a noi stessi. Ossia al carattere della nostra essenza e vocazione.
Tutto ciò, proprio venendo meno a noi stessi - ossia cedendo il punto di vista rigido e dialogando coi nostri strati profondi.
Tale processo sposta l’accento condizionato.
Non è che Dio si compiace di farsi incessantemente pregare e ripregare dai poveretti.
Siamo noi ad aver bisogno di tempo per incontrare la nostra stessa anima e lasciarci introdurre in un altro genere di programmi che non siano conformisti e scontati.
Leggere gli accadimenti secondo visioni totalmente “inadeguate”, eccentriche o eccessive, meno contratte dentro le solite armature (e così via) può aprire la mente.
L’espansione dello sguardo accresce l’intuizione, modifica i sentimenti, trasforma, attiva.
Coglie altri disegni, spalanca differenti orizzonti - con risultati intermedi già prodigiosi, sicuramente imprevedibili.
Quando qualcuno crede di aver capito il mondo, già si condiziona auspici ulteriori, più intensi, che vorrebbero invadere il nostro spazio.
Questa “natura” artificiale di assetti spuri, esterni, o altrui, blocca l’itinerario che va verso la natura del carattere, la vera chiamata e missione personale.
La preghiera dev’essere insistente, perché è come una visuale posata su di sé; non come avevamo pensato: autenticamente.
L’occhio interiore serve a fare una sorta di spazio sgombro e individuale dentro, che apre alla nostra e altrui Presenza, tutta da guardare. Nel modo che conta.
Sarà il più sapiente, forte e affidabile compagno di viaggio… che porta la nostra identità-carattere e non tira altrove l’io essenziale della persona.
Lo svuotamento consapevole dalle cianfrusaglie accatastate [da noi stessi o altri] dev’essere colmato nel tempo mediante una intensità di Relazione.
Ecco il dialogo-Ascolto interpersonale con la Fonte dell’essere.
In essa è annidato il nostro Seme particolare: lì è come seduta e in fieri la differenza di volto che ci appartiene.
Sarà la profondità radicale del rapporto con la nostra Radice - forse smarrita in troppe aspettative regolarissime, anche elevate o funzionanti - che conferisce un’altra Via, più convincente.
E farà scoprire la tendenza e destinazione unica che ci appartiene, per la Felicità che non pensavamo.
Obbiettivi, propositi, discipline, memorie del passato, sogni di futuro, ricerche dei punti di riferimento, valutazioni abitudinarie di possibilità, cumuli di merito... talora sono zavorre.
Essi distraggono dalla terra dell’anima, dove il nostro grano vorrebbe attecchire per divenire ciò che è in cuore.
E dal Nocciolo far comprendere la proposta di Missione ricevuta - non conquistata, né posseduta - affinché conceda un’altra caratura prodigiosa (non: visibilità).
Spesso il sistema mentale e affettivo si riconosce in un album di pensieri, definizioni, gesti, forme, problemi, titoli, mansioni, personaggi, ruoli e cose già morte.
Tale morfologia d’interdizione smarrisce il presente autentico, dove viceversa attecchisce il Sogno divino che completa - realizzandoci nella specificità.
Allora, ecco la terapia dell’assoluto presentimento nell’Ascolto - della non pianificazione; a partire da ciascuno.
Ciò nella lacuna consapevole di quella parte di noi che cerca sicurezze, approvazioni, e asseconda banalità.
Attraverso il dialogo senza posa col Padre nell’orazione, facciamo spazio alle radici dell’Essere, che nel frattempo ci sta già colmando di visuali e occasioni per una sorte differente.
Riattivando la carica esplorativa soffocata negli ingranaggi, creiamo la giusta intercapedine e ripartiamo nell’Esodo.
Accontentarsi, fermarsi, installarsi in un punto, tramuterebbe le conquiste anche qualitative in una terra di nuove schiavitù.
Obbligherebbe a recitare e ripercorrere tappe ormai acquisite - che viceversa siamo per vocazione richiamati a valicare.
Esodo… all’interno di una Relazione sorgiva, cosmica e identificativa, singolarmente fondante.
Grazie all’Ascolto protratto nella preghiera, noi figli acquisiamo il sapere dell’anima e del Mistero.
Dimoriamo a lungo nella Casa della nostra essenza molto speciale.
Così la piantiamo o radichiamo ancor più a fondo - per capirla e recuperarla completamente, nitida e colma.
Ormai affrancata dal destino tracciato in ambiente di ristrettezze, già segnato ma privo di sogni.
Quando saremo pronti, l’Unicità scenderà in campo con una nuova soluzione, anche stravagante.
Essa partorirà ciò che siamo davvero, al meglio - dentro quel caos che risolve i veri problemi. E di onda in onda balzerà a Traguardo.
Via le definizioni e aspirazioni da nomenclatura, in una sorta di venir meno di noi stessi - in uno stato “scarico” ma colmo di energie potenziali - daremo spazio al nuovo Germe che la sa più lunga di tutti.
Già qui e ora la nostra Pianta caratteristica e inconfondibile vuole sfiorare la condizione divina.
La preghiera continua [ascolto e percezione senza tregua] scava e smaltisce in questo spazio il volume dei banali pensieri ridondanti.
In tale interstizio e “vuoto” si spalancano opportunità. Si crea la pulizia interiore affinché giunga il Dono - non di seconda mano.
Vogliamo una decisiva conversione? Desideriamo il richiamo alla totalità dell’esistenza umanizzante, senza limitazioni e nella nostra unicità?
Allora l’azione divina può raggiungere chiunque? Attecchisce in qualsiasi volto? E come si fa a non spezzarla?.
Perché non ora il nuovo inizio?
La preghiera e il “nuovo pieno” dello Spirito diventano per noi - figli in fase di crescita - il latte dell’anima.
Intimità e Preghiera
Come dice sant’Agostino: «La tua preghiera è la tua parola rivolta a Dio. Quando leggi è Dio che ti parla; quando preghi sei tu che parli a Dio». Origene, uno dei maestri in questa lettura della Bibbia, sostiene che l’intelligenza delle Scritture richieda, più ancora che lo studio, l’intimità con Cristo e la preghiera. Egli è convinto, infatti, che la via privilegiata per conoscere Dio sia l’amore, e che non si dia un’autentica scientia Christi senza innamorarsi di Lui. Nella Lettera a Gregorio il grande teologo alessandrino raccomanda: «Dedicati alla lectio delle divine Scritture; applicati a questo con perseveranza. Impegnati nella lectio con l’intenzione di credere e di piacere a Dio. Se durante la lectio ti trovi davanti a una porta chiusa, bussa e te l’aprirà quel custode, del quale Gesù ha detto: “Il guardiano gliela aprirà”. Applicandoti così alla lectio divina, cerca con lealtà e fiducia incrollabile in Dio il senso delle Scritture divine, che in esse si cela con grande ampiezza. Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete”».
[Papa Benedetto, Verbum Domini n.86]
Svolta decisiva
1. Con l’incarnazione del Verbo di Dio la storia della preghiera conosce una svolta decisiva. In Gesù Cristo il cielo e la terra si toccano, Dio si riconcilia con l’umanità, si riallaccia in pienezza il dialogo tra la creatura e il suo Creatore. Gesù è la proposta definitiva dell’amore del Padre e, al tempo stesso, la risposta piena ed irrevocabile dell’uomo alle attese divine. È perciò Lui, Verbo incarnato, l’unico Mediatore che presenta a Dio Padre ogni preghiera sincera che sale dal cuore umano. La domanda, che i primi discepoli rivolsero a Gesù, diventa quindi anche domanda nostra: “Signore, insegnaci a pregare!” (Lc 11, 1).
2. Come ad essi, così anche a noi Gesù “insegna”. Lo fa innanzitutto con l’esempio. Come non ricordare la toccante preghiera con cui Egli si rivolge al Padre già nel primo momento dell’incarnazione? “Entrando nel mondo, dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato . . . Allora ho detto: Ecco io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per fare, o Dio, la tua volontà” (Eb 10, 5). Successivamente non c’è momento importante della vita di Cristo che non sia accompagnato dalla preghiera. All’inizio della sua missione pubblica, lo Spirito Santo scende su di lui mentre “ricevuto il battesimo, stava in preghiera” (Lc 3, 21 s). Dall’evangelista Marco sappiamo che, al momento di avviare la predicazione in Galilea, Gesù “al mattino si alzò quando ancora era buio e, uscito di casa, si ritirò in un luogo deserto e pregava” (Mc 1, 35). Prima della elezione degli apostoli “se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione” (Lc 6, 12). Prima della promessa del primato a Pietro Gesù, secondo il racconto di Luca, “si trovava in un luogo appartato a pregare” (Lc 9, 18). Anche al momento della trasfigurazione, quando sul monte la sua gloria s’irradiò prima che sul Calvario s’addensasse la tenebra, Gesù pregava (cf. Lc9, 28-29). Particolarmente rivelatrice è la preghiera nella quale, durante l’ultima Cena, Gesù effonde verso il Padre i suoi sentimenti di amore, di lode, di supplica, di fiducioso abbandono (cf. Gv 17). Sono gli stessi sentimenti che riaffiorano nell’orto del Getsemani (cf. Mt 26, 39. 42) e sulla croce (cf. Lc 23, 46), dall’alto della quale Egli ci offre l’esempio di quell’ultima, toccante invocazione: “Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34).
3. A pregare Gesù ci insegna anche con la sua parola. Per sottolineare la “necessità di pregare sempre, senza stancarsi”, Egli racconta la parabola del giudice iniquo e della vedova (cf. Lc 18, 1-5). Raccomanda poi: “Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole” (Mt 26, 41). Ed insiste: “Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto” (Mt 7, 7-8).
Ai discepoli, desiderosi di una guida concreta, Gesù insegna poi la formula sublime del Padre nostro (Mt 6, 9-13; Lc 11, 2-4), che diventerà nei secoli la preghiera tipica della comunità cristiana. Già Tertulliano la qualificava come “breviarium totius evangelii”, “un compendio di tutto il Vangelo” (De oratione, 1). In essa Gesù consegna l’essenza del suo messaggio. Chi recita in modo consapevole il Padre nostro “si compromette” col Vangelo: non può infatti non accettare le conseguenze che per la propria vita derivano dal messaggio evangelico, di cui la “preghiera del Signore” è l’espressione più autentica.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 23 settembre 1992]
Al di là dei desideri e della coscienza
«Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto». Sollecitato dal brano liturgico del Vangelo di Luca (11, 9-10), nella messa celebrata a Santa Marta giovedì mattina, 9 ottobre, Papa Francesco è tornato a meditare sul tema della preghiera, soffermandosi sulla condizione dell’uomo che chiede e sull’amore di Dio che risponde e dona in sovrabbondanza.
Dopo aver ricordato il testo della colletta pronunciata prima della liturgia della parola — «O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito, effondi su di noi la tua misericordia: perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare» — il Pontefice ha iniziato la sua riflessione notando che «è proprio della misericordia di Dio non solo perdonare — quello tutti lo sappiamo — ma essere generoso e dare di più e di più...». Nel soffermarsi in particolare sull’invocazione «e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare», Francesco ha sottolineato: «Noi forse nella preghiera chiediamo questo e questo, e lui ci dà di più sempre! Sempre, sempre di più».
Riprendendo poi le fila del racconto evangelico, il Papa ha ricordato come, qualche versetto prima del passo proposto dalla liturgia, gli apostoli avessero chiesto a Gesù che insegnasse loro a pregare come Giovanni aveva fatto con i discepoli. «E il Signore — ha detto — gli ha insegnato il Padre Nostro». Dopodiché il Vangelo passa a parlare della «generosità di Dio», di quella «misericordia che dà sempre di più, di più di quello che noi crediamo si possa fare».
Papa Francesco è entrato nel cuore del testo: «Se uno di voi ha un amico, a mezzanotte... Ci sono tre parole, tre parole chiave in questo brano: l’amico, il Padre e il dono». È lo spunto per legarsi all’esperienza quotidiana di ogni persona: nella nostra vita, ha detto il Pontefice, ci sono amici d’oro, «che danno la vita per l’amico», e ce ne sono anche altri più o meno buoni, ma alcuni sono amici in maniera più profonda. Non ce ne sono moltissimi: «La Bibbia ci dice “uno, due o tre... non di più”. Poi gli altri sono amici, ma non come questi».
Sempre sulla falsariga del brano lucano, il Papa ha proseguito: «Io vado a casa di lui e chiedo, chiedo, e alla fine si sente importunato per l’invadenza; si alza e dà quello che l’amico chiede». Proprio «il legame di amicizia fa che ci sia dato quello che noi chiediamo». Ma, ha spiegato, «Gesù fa un passo avanti e parla del Padre», ponendo queste domande ai suoi ascoltatori: «Quale padre tra di voi, se un figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?». Da qui la successiva rassicurazione: «Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre del cielo!». Ciò significa che «non solo l’amico che ci accompagna nel cammino della vita ci aiuta e ci dà quello che noi chiediamo; anche il Padre del cielo, questo Padre che ci ama tanto», fino a preoccuparsi — dice Gesù — di dar da mangiare agli uccellini del campo.
In questo modo il Signore, ha fatto notare Papa Francesco, «vuole risvegliare la fiducia nella preghiera». E citando ancora il Vangelo di Luca — «Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto» (11, 9-10) — il Pontefice ha spiegato: «Questa è la preghiera: chiedere, cercare il come e bussare al cuore di Dio, l’amico che ci accompagna, il Padre» che ama tutte le sue creature.
Alla fine del brano, ha messo in evidenza il Papa, c’è una frase che «sembra un po’ criptica: “Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà quello che chiedete?” Sì! Darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». Proprio «questo è il dono, questo è il di più di Dio». Perché il Padre, ha sottolineato, «mai ti dà un regalo, una cosa che gli chiedi, così, senza incartarlo bene, senza qualcosa di più che lo faccia più bello». E «quello che il Signore, il Padre ci dà di più, è lo Spirito: il vero dono del Padre è quello che la preghiera non osa sperare». L’uomo bussa con la preghiera alla porta di Dio per chiedere una grazia. E «lui, che è Padre, mi dà quello e di più: il dono, lo Spirito Santo».
È questa, ha ribadito il Papa, la dinamica della preghiera, che «si fa con l’amico, che è il compagno di cammino della vita, si fa col Padre e si fa nello Spirito Santo». L’amico vero è Gesù: è lui, infatti, «che ci accompagna e ci insegna a pregare. E la nostra preghiera deve essere così, trinitaria». Si tratta di una sottolineatura importante per Papa Francesco che, avviandosi alla conclusione, ha richiamato un tipico dialogo avuto tante volte con i fedeli: «Ma lei crede? Sì! Sì! In che crede? In Dio! Ma cosa è Dio per lei? Dio, Dio!». Una concezione un po’ generica, astratta, che per il vescovo di Roma non corrisponde alla realtà. Perché, ha affermato, «esiste il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo: sono persone, non sono un’idea nell’aria» Insomma, ha precisato, «questo Dio spray non esiste: esistono persone!».
Questo in sintesi il messaggio finale del Pontefice: «Gesù è il compagno di cammino che ci dà quello che chiediamo; il Padre che ha cura di noi e ci ama; e lo Spirito Santo che è il dono, è quel di più che dà il Padre, quello che la nostra coscienza non osa sperare».
[Papa Francesco, s. Marta, in L’Osservatore Romano 10/10/2014]
Quale strada conduce al Padre?
e manifestazioni del potere di Dio sulla terra: nulla di esteriore
(Lc 11,29-32)
La corrispondenza umana non cresce col moltiplicarsi dei segnali da capogiro. Dio non costringe i poco convinti, né surclassa con prove; così guadagna un patrimonio d’Amore.
La sua Chiesa autentica, senza strepiti né posizioni persuasive - apparentemente insignificante - è raccolta tutta in intima unità col suo Signore.
La regina del mezzogiorno cercava soluzioni accattivanti a curiosità enigmatiche, ma le poteva conoscere dentro la sua anima e nella vita.
Incarnazione: non ci sono altri segni validi che gli accadimenti e le nuove relazioni con se stessi e gli altri - le quali porgono la Persona stessa e inaudita del Risorto, senza involucri.
L’Eterno non è più la pura trascendenza dei giudei, né la vetta della sapienza del mondo antico: il Segno emozionante di Dio è la vicenda di Gesù vivo in noi.
Confidiamo in Cristo, quindi niente droghe spirituali che c’illudano di felicità.
È il senso della nuova Creazione: abbandono allo Spirito, ma tutto concreto (non di maniera) e che procede trascinando la realtà alternativa.
Egli è Segno unico, che scioglie dai molti surrogati della religione delle paure, delle pastoie, dei ruoli consolidati che vorrebbero imprigionarlo in un “alleato” facitore di miracoli seducenti; immediatamente risolutivi.
Alcuni membri di comunità sembrava volessero inquadrare il Messia nello schema delle normali attese sacrali e scenografiche.
Già se la intendevano e si mostravano stufi...
In questi “veterani” di Lc non c’era cifra alcuna di conversione all’idea del Figlio di Dio come Servitore, fiducioso nei sogni senza prestigio.
In loro? Nessuna traccia d’idea nuova - né cambio di passo che segnasse un tramonto della società plateale, disumanizzante, cui erano abituati.
C’è sempre chi rimane legato a una ideologia di potere. Quindi non vuole aprire gli occhi se non per farsi catturare i sensi in modo banale.
A costoro il Signore non riserva mai conferme impressionanti - che sarebbero la paradossale convalida dei convincimenti antichi.
Unico ‘segnale’ è la sua Chiesa vivente e lo stesso Risorto che pulsa in tutti coloro che lo prendono sul serio; ad es. nei recuperi, risanamenti e rivalutazioni impossibili.
Ma nessun fulmine a scorciatoia.
Guidati dall’Amico invisibile, saremo una sola umanità inventiva ‘nel Maestro’.
La nostra testimonianza libera e vivificante alimenterà una esperienza di Fede rigeneratrice, singolarmente incisiva.
Assai più dei miracoli, gli appelli della nostra essenza e della realtà faranno riconoscere il richiamo e l’agire di Dio negli uomini e nella trama della storia.
Il Padre vuole che i suoi figli producano ben altri sbalordimenti e prodigi di bontà divino-umana che visioni e sentimentalismi, o magie.
Unico «segno» di salvezza è Cristo in noi, senza cuciture isteriche; immagine e somiglianza dell’umanità nuova.
Per l’autentica ‘conversione’: potenza nativa - e nulla di esteriore.
[Mercoledì 1.a sett. Quaresima, 25 febbraio 2026]
Le manifestazioni del potere di Dio sulla terra: nulla di esteriore
Quale strada conduce al Padre?
(Lc 11,29-32)
Gesù si scontra con l’incredulità. Essa viene da vari accecamenti e partiti presi, o (soprattutto nei discepoli) nasce da disattenzione.
Il Signore si allontana da chi lo mette alla prova e da coloro che rifiutano ciò ch’è donato da Dio, pretendendo di fissare come debba agire.
Il Figlio dell’uomo rispetta ogni persona che lo segue, ma fa comprendere che le decisioni e ancor prima la mancanza di percezione acuta impediscono l’Incontro e la redenzione della vita.
In tale ottica, i credenti non vivono per “dimostrare”. Cristo stesso non ci aspetta in manifestazioni subliminali e mirabolanti, ma sulla sponda d’una spiritualità terrestre.
Il Valore non ha bisogno di applausi (arma a doppio taglio) - maschera della proposta artificiosa, e della vita inautentica.
La corrispondenza umanizzante non cresce col moltiplicarsi dei segnali da capogiro.
Dio non costringe i poco convinti, né surclassa con prove; così guadagna un patrimonio d’Amore nella crescita.
La sua Chiesa autentica, senza strepiti né posizioni persuasive - apparentemente insignificante - è raccolta tutta in intima unità col suo Primogenito: potenza nativa, portentosa e rigeneratrice - solida e reale.
La regina del mezzogiorno cercava soluzioni accattivanti a curiosità enigmatiche, ma le poteva conoscere dentro la sua anima e nella vita.
Incarnazione: non ci sono altri segni validi che gli accadimenti e le nuove relazioni - con se stessi e gli altri - le quali porgono la Persona stessa e inaudita del Risorto [quello senza involucri].
L’Eterno non è più la pura trascendenza dei giudei, né la vetta della sapienza del mondo antico.
Il segno dell’Altissimo è la vicenda di Gesù vivo in noi. Essa apre la strada emozionante che conduce verso il Padre.
Confidiamo in Cristo, quindi niente droghe spirituali che c’illudano di felicità.
È il senso della nuova Creazione: nell’abbandono allo Spirito - ma tutto concreto (non di maniera) e che procede trascinando la realtà alternativa.
La sua Persona è segnale unico, che scioglie dai molti surrogati della religione delle paure, delle pastoie, dei ruoli consolidati.
Tare che vorrebbero imprigionarlo in “alleato” facitore di miracoli seducenti e immediatamente risolutivi.
Qualcuno in semplice purificatore del tempio o in un personaggio da mulino bianco - e così noi, se ci lasciamo manipolare.
Infatti, i leaders religiosi cui Gesù si rivolge sono quelli di ritorno nelle sue comunità!
Si trattava di giudaizzanti i quali volevano inquadrare il Messia nello schema delle normali attese cui erano stati da sempre abituati.
O già se la intendevano e si mostravano stufi...
In questi “veterani” non c’era cifra alcuna di conversione all’idea del Figlio di Dio come Servitore, fiducioso nei sogni senza prestigio.
In loro? Nessuna traccia d’idea nuova - né cambio di passo che segnasse tramonto della società plateale, disumanizzante, e anche sacrale - dell’esterno.
Ai leaders popolari talora sfugge il significato dell’unico Segno vivo: Gesù Alimento della vita.
Per causa loro, non dei lontani, il Signore «geme nello spirito» [cf. Mc 8,12 testo greco] - ancora oggi, rattristato da tanta cecità.
La vita è infatti preclusa a chi non sa spostare lo sguardo.
Subito dopo Lc (12,1) si riferisce infatti al pericolo dell’ideologia dominante che faceva perdere alle stesse guide la percezione obiettiva degli accadimenti.
Un «lievito» grossolano ma radicato nell’esperienza penosa della gente; che stimolava gonfiori persino nei discepoli, contaminandoli.
Ai primi della classe poteva sembrare che Gesù fosse un leader come Mosè, per il fatto che aveva appena alimentato il popolo affamato nel deserto [cf. Mt 15,32-39; Mc 8,1-9].
Ma il rifiuto è netto: in specie Mc (8,12) lo rende acuto sottolineando il senso di sofferenza del Maestro.
Quindi come anche Mt e Lc nell’episodio appunto di Giona - il suo radicale, perentorio diniego.
Per salvare il popolo bisognoso di tutto non c’è altra via che partire da dentro.
Poi procedere verso una pienezza di essere che dilaga, ci approva, e sfociando consente di spezzare la vita in favore dei fratelli.
Non c’è scappatoia.
Unicamente la comunione con la sorgente celata del proprio Sé eminente e il dialogo rispettoso e fattivo con gli altri, salva da una mentalità di gruppo chiuso.
In tal guisa, nessun club è ammesso - che rivendicasse l’esclusiva monopolista su Dio e sulle anime (Lc 9,49-50) con esplicita pretesa a disciplinare le moltitudini.
La comunità del Risorto aborrisce la concezione competitiva della stessa vita religiosa, se riflesso sacrale del mondo imperiale e d’una società che angustia e amareggia l’esistenza dei piccoli.
Sarebbe una vita malata nella ricerca di prestigio purchessia, anche solo apparente.
Viceversa, nelle realtà fraterne «il più piccolo tra tutti, questi è grande» (Lc 9,48).
Quindi bisogna assolutamente evitare che nei fedeli s’insinui una mentalità piramidale e dello scarto.
Spirito di competizione che poi inesorabilmente finisce per cercare rifugio nel miracolismo ipocrita, surrogato della vita di Fede.
Lo stesso fa il Maestro per educare i membri di Chiesa che restano [alcuni tuttora] affetti da senso di superiorità nei confronti delle folle e degli estranei.
Sentimento di popolo eletto e privilegiato (Lc 9,54-55) che si stava infiltrando persino nelle comunità primitive.
A chi non vuole aprire gli occhi se non per farsi catturare i sensi da fenomeni tutti da discernere - perché malgrado il credo ufficiale che professa rimane legato a una ideologia di potere - il Signore non riserva mai conferme impressionanti venute «dal cielo» (Lc 11,16) che ne sarebbero la paradossale convalida.
Unico segnale è e sarà la sua Chiesa vivente: “vittoria” del Risorto, che pulsa in tutti coloro che lo prendono sul serio.
Senza gerarchie fisse - sotto la guida infallibile della Chiamata e della Parola - i figli sanno reinterpretare, anche in modo inedito.
Tale il prodigio, incarnato nelle mille vicende della storia, della vita personale e comunitaria; nei recuperi, risanamenti e rivalutazioni impossibili.
L’autentico Messia non elargisce alcuna esibizione cosmica.
Nessun festival che obblighi gli spettatori a chinare il capo, a cospetto di tanta gloria sconvolgente e degnazione - come se fosse un dittatore celeste.
E nessun fulmine a scorciatoia.
Nel corso dei secoli le Chiese sono cadute spesso in questa tentazione “apologetica”, tutta interna alle devozioni dall’impulso arido: cercare segni meravigliosi e sbandierarli per mettere a tacere gli avversari.
Stratagemmi per un banale tentativo di chiudere la bocca a coloro che chiedono non esperienze di parapsicologia, bensì testimonianze poco avvizzite e senza trucco o escamotage: di concreta disalienazione.
Niente male, questa nostra attività di liberazione in favore degli ultimi, e che tiene duro; non avvinghiata all’idea d’un arruffapopolo dagli aspetti trionfalistici o consolatori.
Preferiamo l’onda del Mistero.
Aneliamo essere guidati da una energia sconosciuta, che ha in serbo un obbiettivo non artificioso - condotti dall’Amico eminente ma intimo e nascosto. Esclusivo in noi.
Saremo una sola umanità nel Maestro, sulla Via giusta e che ci appartiene. Anche percorrendo sentieri interrotti e incompleti, persino di smarrimento.
A commento del Tao Tê Ching (i) il maestro Ho-shang Kung scrive:
«L’eterno Nome vuol essere come l’infante che ancora non ha parlato, come il pulcino che ancora non s’è sgusciato.
La perla luminosa sta dentro l’ostrica, la bella gemma sta in mezzo alla roccia: per quanto all’interno esso risplenda, all’esterno esso è stolto e insipiente».
Tutto ciò è forse valutato “incoscienza” e “inconcludenza”... ma porta ciò che siamo - esprimendo un altro modo di vedere il mondo.
In noi stessi e dentro il Richiamo dei Vangeli abbiamo una potenza fresca, che approva il percorso differente dall’immediatamente normale e dal vistoso lampante.
Un Appello che è incanto, delizia e splendore, perché ci attiva rimettendo in discussione.
Verbo che non ragiona secondo gli schemi.
Istanza accorata, che non si fa impressionare dalle cose eccezionali, dalle recite che soffocano l’anima in ricerca di senso e autenticità.
Genuina Meraviglia, impulso indomabile annidato nella dimensione di pienezza umana, e che non si arrende: vuole esprimersi nella sua trasparenza e farsi realtà.
Una sorta d’Infante intimo: si muove in modo giudicato “astruso”, ma rimette le cose a posto, dentro e fuori.
La testimonianza libera e vivificante, attenta e sempre personalmente geniale, sarà innata e inedita, graffiante, inventiva senz’accorgimenti, imprevedibile e affatto conformista.
Essa farà scaturire e incessantemente rialimenterà una esperienza di Fede convinta, singolare, incisiva - malgrado possa apparire perdente e non di successo, poco onorevole e insensazionale.
Assai più dei miracoli, le suppliche della nostra essenza e della realtà faranno riconoscere il richiamo e l’agire di Dio negli uomini e nella trama della storia.
Inviti che possono germinare altri sbalordimenti e prodigi di bontà divino-umana, che visioni parossistiche condite di nevrosi e sentimentalismi vuoti o magie.
Unico segno di salvezza è Cristo in noi - senza cuciture, né grandi gesti isterici.
Persona immagine e somiglianza dell’umanità nuova; manifestazione del potere di Dio sulla terra.
Per l’autentica conversione: nulla di esteriore.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Di che genere è la tua ricerca di prove?
In cosa si discosta il tuo Segno che fa credere dagli espedienti, da atti di forza, o da quello che altri vorrebbero che diffondessi?
Giona annuncia l’avvenimento di Gesù
2) Il libro di Giona ci annuncia l’avvenimento di Gesù Cristo – Giona è una prefigurazione della venuta di Gesù. Il Signore stesso ci dice questo nel Vangelo del tutto chiaramente.
Richiesto dai giudei di dar loro un segno che lo riveli apertamente come il Messia, risponde, secondo Matteo: "Nessun segno sarà dato a questa generazione se non il segno di Giona profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il Figlio dell’uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra" (Mt12,39s).
La versione di Luca delle parole di Gesù è più semplice: "Questa generazione [...] cerca un segno ma non le sarà dato nessun segno fuorché il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il Figlio dell’uomo lo sarà per questa generazione" (Lc 11,29s). Vediamo due elementi in entrambi i testi: lo stesso Figlio dell’uomo, Cristo, l’inviato di Dio, è il segno. Il mistero pasquale indica Gesù come il Figlio dell’uomo, egli è il segno in e attraverso il mistero pasquale.
Nel racconto veterotestamentario proprio questo mistero di Gesù traspare del tutto chiaramente.
Nel primo capitolo del libro di Giona si parla di una triplice discesa del profeta: egli scende al porto di Giaffa; scende nella nave; e nella nave egli si mette nel luogo più riposto. Nel suo caso, però, questa triplice discesa è una tentata fuga davanti a Dio. Gesù è colui che scende per amore, non per fuggire, ma per giungere nella Ninive del mondo: scende dalla sua divinità nella povertà della carne, dell’essere creatura con tutte le sue miserie e sofferenze; scende nella semplicità del figlio del carpentiere, e scende nella notte della croce, infine persino nella notte dello Sheòl, il mondo dei morti. Così facendo egli ci precede sulla strada della discesa, lontano dalla nostra falsa gloria da re; la via della penitenza, che è via verso la nostra stessa verità: via della conversione, via che ci allontana dall’orgoglio di Adamo, dal volere essere Dio, verso l’umiltà di Gesù che è Dio e per noi si spoglia della sua gloria (Fil 2,1-10). Come Giona, Gesú dorme nella barca mentre la tempesta infuria. In un certo senso nell’esperienza della croce egli si lascia gettare in mare e così placa la tempesta. I rabbini hanno interpretato la parola di Giona "Gettatemi in mare" come offerta di sé del profeta che voleva con questo salvare Israele: egli aveva timore davanti alla conversione dei pagani e al rifiuto della fede da parte di Israele, e per questo – così dicono – voleva farsi gettare in mare. Il profeta salva in quanto egli si mette al posto degli altri. Il sacrificio salva. Questa esegesi rabbinica è diventata verità in Gesù.
[Papa Benedetto card. Ratzinger, Lectio in s. Maria in Traspontina, 24 gennaio 2003; in “30Giorni” febbraio 2003]
Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)
Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)
You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]
Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]
In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)
In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)
Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)
Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)
In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)
Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))
Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.