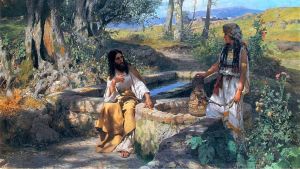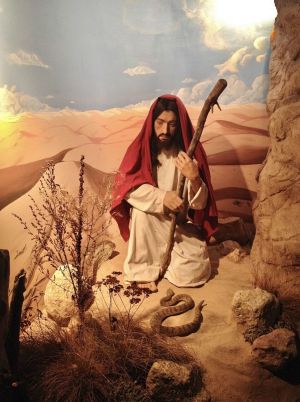don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Samaritana, affaticata al pozzo. O Gesù fresca Sorgente a portata di mano. Fede Assenso, Fede Sponsale, Fede Innesco, Fede Sbalordimento
2a Domenica di Quaresima
Seconda Domenica di Quaresima (anno A) [1 Marzo 2026]
*Prima Lettura dal libro della Genesi (12,1- 4)
Le poche righe che abbiamo appena letto costituiscono il primo atto di tutta l’avventura della nostra fede: la fede degli ebrei, poi, in ordine cronologico, dei cristiani e dei musulmani. Siamo nel secondo millennio a.C. Abram* viveva in Caldea, cioè in Iraq, e più precisamente nell’estremo sud-est dell’Iraq, nella città di UR, nella valle dell’Eufrate, vicino al Golfo Persico. Viveva con sua moglie Sarai, presso suo padre Terach, e con i suoi fratelli (Nahor e Aran) e il suo nipote Lot. Abram aveva settantacinque anni, sua moglie Sarai sessantacinque; non avevano figli e, vista la loro età, non ne avrebbero mai più avuti. Un giorno il vecchio padre, Terach, prese la strada insieme ad Abram, Sarai e al suo nipote Lot. La carovana risale la valle dell’Eufrate dal sud-est al nord-ovest con l’intenzione di scendere poi verso la terra di Canaan; ci sarebbe una strada più corta, certo, per collegare il Golfo Persico al Mediterraneo, ma attraversava un enorme deserto; Terach e Abram preferirono percorrere il “Crescente Fertile”, che porta bene il suo nome. L’ultima tappa a nord-ovest si chiama Harran. È lì che il vecchio Terach muore. Ed è soprattutto lì che, per la prima volta, circa 4000 anni fa, intorno al 1850 a.C., Dio parlò ad Abram.
” Vattene dalla tua terra” dice la nostra traduzione liturgica, ma essa omette le due prime parole, probabilmente per evitare interpretazioni eccessive di cui non sempre ci si è astenuti. In realtà, in ebraico, le prime due parole sono “Tu, va!”. Grammaticalmente, non significano altro. È un appello personale, una messa da parte: si tratta di un vero e proprio racconto di vocazione. Ed è a questo semplice invito che Abram ha risposto. Spesso si traduce “Va per te”, ma si tratta già di una sovra-interpretazione di fede. “Va per te”: bisogna essere consapevoli che ci si allontana dalla letteralità del testo per entrare in un’interpretazione, in un commento spirituale. È Rashi, il grande commentatore ebreo dell’XI secolo (a Troyes in Champagne), che traduce “Va per te, per il tuo bene e per la tua felicità”. In effetti, è ciò che Abram sperimenterà nel corso dei giorni. Se Dio chiama l’uomo, è per il bene dell’uomo, non per altro! Il disegno misericordioso di Dio sull’umanità è racchiuso in queste due piccole parole: “Per te”. Già Dio si rivela come colui che desidera il bene dell’uomo, di tutti gli uomini**; se bisogna ricordare una cosa, è questa! “Va per te”: un credente è qualcuno che sa che, qualunque cosa accada, Dio lo conduce verso il suo compimento, verso la sua felicità. Ecco dunque la prima parola di Dio ad Abram, quella che ha scatenato tutta la sua avventura… e la nostra! Tu, va, lascia il tuo paese, la tua parentela e la casa di tuo padre, e va’ verso la terra che ti mostrerò. E il seguito sono solo promesse: Farò di te una grande nazione, ti benedirò, renderò grande il tuo nome, e tu sarai una benedizione… In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Abram viene strappato al suo destino naturale, scelto, eletto da Dio, investito di una vocazione di portata universale. Abram, per il momento, è un nomade, forse ricco, ma sconosciuto, e non ha figli; sua moglie Sarai ha superato ampiamente l’età di avere figli. Eppure è lui che Dio sceglie per diventare il padre di un grande popolo. Ecco cosa significava quel “per te” di prima: Dio gli promette tutto ciò che, a quell’epoca, costituisce la felicità di un uomo: una numerosa discendenza e la benedizione di Dio. Ma questa felicità promessa ad Abram non è solo per lui: nella Bibbia, nessuna vocazione, nessuna chiamata è mai per l’interesse egoistico di chi è chiamato. È uno dei criteri di una vocazione autentica: ogni vocazione è sempre per una missione a servizio degli altri. Qui c’è questa frase: “In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra”. Significa almeno due cose: primo, il tuo successo sarà tale che sarai preso come esempio: quando si vorrà augurare felicità, si dirà: Possa tu essere felice come Abram. Secondo, questo “in te” può significare attraverso te; e allora significa “attraverso di te, io, Dio, benedirò tutte le famiglie della terra”. Il progetto di felicità di Dio passa per Abram, ma lo supera, lo trabocca; riguarda tutta l’umanità: “In te, attraverso te, saranno benedette tutte le famiglie della terra”. Per tutta la storia d’Israele, la Bibbia resterà fedele a questa prima scoperta: Abramo e i suoi discendenti sono il popolo eletto, scelto da Dio ma a beneficio di tutta l’umanità, fin dal primo giorno, dalla prima parola a Abram. Resta che le altre nazioni restano libere di non entrare in questa benedizione; è il senso della frase apparentemente curiosa: “Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò”(12,3). È un modo per dire la nostra libertà: chiunque lo desideri può partecipare alla benedizione promessa ad Abram, ma nessuno è obbligato ad accettarla! L’ora della grande partenza è arrivata; il testo è straordinario per la sua sobrietà: dice semplicemente “Abram partì come gli aveva ordinato il Signore”(12,4) e Lot partì con lui. Non si può essere più laconici! Questa partenza, al semplice richiamo di Dio, è la prova più bella di fede; quattromila anni dopo, possiamo dire che la nostra fede trova la sua fonte in quella di Abramo; e se le nostre vite intere sono illuminate dalla fede, è grazie a lui!. E tutta la storia umana diventa il luogo del compimento delle promesse di Dio ad Abramo: compimento lento, progressivo, ma certo e sicuro.
Note: *All’inizio di questa grande avventura, colui che chiamiamo Abramo si chiamava ancora solo Abram; più tardi, dopo anni di pellegrinaggio, riceverà da Dio il nuovo nome, quello con cui lo conosciamo: Abramo, che significa “padre di moltitudini”.
**Questo “per te” non va inteso come esclusivo, anche se inizialmente non si era capito subito. Solo dopo una lunga scoperta dell’Alleanza di Dio i credenti hanno potuto accedere alla verità piena: il progetto di Dio non riguarda solo Abramo e i suoi discendenti, ma tutta l’umanità. Questo è ciò che chiamiamo l’universalità del progetto di Dio. Questa scoperta risale all’Esilio a Babilonia, nel VI secolo a.C.
Aggiunta: In un altro momento della vita di Abramo, quando offrirà Isacco in sacrificio Dio userà la stessa espressione “Tu va” per dargli la forza d’affrontare la prova. ricordandogli il percorso già compiuto. La Lettera agli Ebrei prenderà la partenza di Abramo per dire che cosa è la fede (cf. Eb 11,8-12)
*Salmo responsoriale (32/33)
Torna tre volte la parola “amore” in questi pochi versetti; e questa insistenza risponde molto bene alla prima Lettura: Abramo è il primo di tutta la storia umana a scoprire che Dio è amore e che ha progetti di felicità per l’umanità. Bisognava però credere a questa straordinaria rivelazione. E Abramo ha creduto, ha accettato di fidars delle parole di futuro che Dio gli annunciava. Un vecchio senza figli, eppure, avrebbe avuto tutte le buone ragioni per dubitare di questa incredibile promessa di Dio. Dio gli dice: Lascia il tuo paese… Farò di te una grande nazione. E il testo della Genesi conclude che Abram partì come Signore gli aveva detto.
Un bellissimo esempio per noi all’inizio della Quaresima: bisognerebbe credere in ogni circostanza che Dio ha progetti di felicità per noi. Questo era proprio il senso della frase pronunciata su di noi il Mercoledì delle Ceneri: “Convertitevi e credete nel Vangelo”. Convertirsi significa credere una volta per tutte che la Novità è che Dio è Amore. Geremia diceva da parte di Dio: “Io conosco i pensieri che ho su di voi – oracolo del Signore – pensieri di pace e non di sventura, per darvi un futuro e una speranza” (Ger 29,11). Così, le prime due domeniche di Quaresima ci invitano a una scelta: per la prima domenica abbiamo letto nel libro della Genesi la storia di Adamo: l’uomo che sospetta di Dio davanti a un divieto (quello di non mangiare il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male), immaginando che Dio possa forse perfino essere geloso! Sono le insinuazioni del serpente, che significa veleno. Per questa seconda domenica di Quaresima, invece, leggiamo la storia di Abramo, il credente. Poco più avanti, il libro della Genesi dice di lui: Abram credette al Signore che lo reputò giusto. E, per aiutarci a seguire lo stesso cammino di Abramo, questo salmo ci suggerisce le parole della fiducia: “l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore per liberarlo dalla more”. All’inizio leggiamo: “Dell’amore è piena la terra… e poi l’espressione “chi lo teme” è spiegata nella riga successiva: è chi spera nel suo amore”, quindi ben lungi dalla paura, anzi proprio il contrario! La tentazione è voler essere liberi e fare tutto ciò che si vuole… obbedire solo a se stessi. Tutto questo nasce dall’esperienza e per questo il popolo eletto può dire: “l’occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore” perché Dio ha vegliato su di loro come un padre sui suoi figli. Quando si afferma che li libera dalla morte non si parla della morte biologica. Bisogna ricordare che all’epoca in cui questo salmo è composto, la morte individuale non era considerata un dramma; ciò che contava era la sopravvivenza del popolo nella certezza che Dio avrebbe fatto sopravvivere il suo popolo. In ogni momento, e specialmente nella prova, Dio accompagna il suo popolo e lo libera dalla morte. Mentre il riferimento al tempo di fame è certamente un’allusione alla manna che Dio fece cadere durante l’Esodo, quando la fame diventava minacciosa. Tutto il popolo può testimoniare questa sollecitudine di Dio in ogni epoca; e quando si canta “Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera” si ripete semplicemente il nome di Dio misericordioso e fedeleche si è rivelato a Mosè (Es 34,6). La conclusione è una preghiera di fiducia:”Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo” è un invito per il credente a offrirsi a questo amore.
*Seconda lettura dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo (1,8b-10)
Paolo è in prigione a Roma, sa che presto sarà giustiziato e qui consegna le sue ultime raccomandazioni a Timòteo: “Figlio mio carissimo, con la forza di Dio, soffri con me per il Vangelo”. Questa sofferenza è la persecuzione che è inevitabile per un vero discepolo di Cristo. come Gesù aveva detto (cf. Mc 8,34-35). Sia all’inizio che alla fine del brano torna il riferimento al Vangelo che si presenta così come un’inclusione e al centro, incorniciato da questi due identici riferimenti, Paolo spiega che cosa sia questo Vangelo. Usa la parola Vangelo, nel suo senso etimologico di buona notizia, proprio come Gesù stesso all’inizio della sua predicazione in Galilea dice: “Convertitevi e credete al Vangelo, alla Buona Notizia” vuol dire che la predicazione cristiana è l’annuncio che il regno di Dio è finalmente inaugurato. Per Paolo, è nella frase centrale del nostro testo che scopriamo in che cosa consista il Vangelo: in definitiva, si riassume in poche parole: Dio ci ha salvati per mezzo di Gesù Cristo. *“Dio ci ha salvati”: è un passato compiuto, qualcosa di acquisito; ma nello stesso tempo, perché gli uomini entrino in questa salvezza, è necessario che il Vangelo sia loro annunciato. È dunque davvero una vocazione santa quella che ci è stata affidata: “Dio ci ha salvati e ci ha chiamati a una vocazione santa”(1,9). Vocazione santa perché affidata dal Dio che è santo; vocazione santa perché si tratta di annunciare il progetto di Dio; vocazione santa perché il progetto di Dio ha bisogno della nostra collaborazione: ciascuno deve prendervi la propria parte, come dice Paolo. Ma l’espressione “vocazione santa” significa anche qualcos’altro: il progetto di Dio su di noi, sull’umanità, è così grande da meritare pienamente questo nome. La vocazione particolare degli apostoli si inserisce in questa vocazione universale dell’umanità.
*”Dio ci ha salvati”: nella Bibbia, il verbo salvare significa sempre liberare. È stata necessaria una lunga scoperta progressiva di questa realtà da parte del popolo dell’Alleanza: Dio vuole l’uomo libero e interviene incessantemente per liberarci da ogni forma di schiavitù. Le schiavitù sono di molti tipi: schiavitù politiche, come la servitù in Egitto o l’Esilio a Babilonia; e ogni volta Israele ha riconosciuto nella sua liberazione l’opera di Dio; schiavitù sociali, e la Legge di Mosè come i profeti non cessano di chiamare alla conversione dei cuori affinché ogni uomo possa vivere in modo dignitoso e libero; schiavitù religiose, ancora più subdole. I profeti non hanno mai smesso di trasmettere questa volontà di Dio di vedere l’umanità finalmente liberata da tutte le sue catene. Paolo dice che Gesù ci ha liberati persino dalla morte: Gesù “ha vinto la morte e ha fatto rsplendere la vita e l’incorruttibilità per mezzo del Vangelo”(1,10). Paolo lo afferma proprio
mentre si prepara a essere giustiziato. Gesù stesso è morto e anche noi moriremo tutti. Gesù dunque non parla della morte biologica. Di quale vittoria si tratta allora? Gesù ci dona, colmo di Spirito Santo, la sua stessa vita, che noi possiamo condividere spiritualmente, e che nulla può distruggere, nemmeno la morte biologica. La sua Risurrezione è la prova che la morte biologica non può annientarla per cui per noi la morte biologica non sarà che un passaggio verso la luce che non tramonta: nella liturgia dei funeraldiciamo: “La vita non è tolta, ma trasformata”. Se la morte biologica fa parte della nostra costituzione fisica, fatta di polvere – come dice il libro della Genesi – essa non riesce a separarci da Gesù Cristo (cf. Rm 8,39). In noi c’è una relazione con Dio, che nulla, nemmeno la morte biologica, può distruggere: è ciò che san Giovanni chiama “la vita eterna”.
*Dal Vangelo secondo Matteo (17,1-9)
“Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni”: ci troviamo ancora una volta davanti al mistero delle scelte di Dio. È a Pietro che Gesù aveva detto poco prima, a Cesarea: “Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa; e le potenze della morte non prevarranno su di essa” (Mt 16,18). Ma Pietro è accompagnato dai due fratelli, Giacomo e Giovanni, i due figli di Zebedeo. “E Gesù li condusse su un alto monte, in disparte”: su un alto monte Mosè aveva ricevuto la Rivelazione del Dio dell’Alleanza e le tavole della Legge; quella Legge che doveva educare progressivamente il popolo dell’Alleanza a vivere nell’amore di Dio e dei fratelli. Sullo stesso monte, Elia aveva avuto la rivelazione del Dio della tenerezza nella brezza leggera… Mosè ed Elia, le due colonne dell’Antico Testamento…Sull’alto monte della Trasfigurazione, Pietro, Giacomo e Giovanni, le colonne della Chiesa, ricevono la rivelazione del Dio di tenerezza incarnato in Gesù: «Questi è il mio l’amato, nel quale mi sono compiaciuto». E questa rivelazione viene loro concessa per rafforzare la loro fede prima della tempesta della Passione. Pietro lo scriverà più tardi (cf. 2 Pt 1,16-18).
L’espressione “il mio Figlio amato: ascoltatelo” designa Gesù come il Messia: per orecchie ebraiche, questa semplice frase è una triplice allusione all’Antico Testamento, perché richiama tre testi molto diversi tra loro, ma ben presenti nella memoria di tutti; tanto più che l’attesa era intensa al tempo della venuta di Gesù e le ipotesi si moltiplicavano: ne abbiamo la prova nelle numerose domande rivolte a Gesù nei Vangeli. “Figlio” era il titolo abitualmente attribuito al re, e si attendeva il Messia con i tratti di un re discendente di Davide, che avrebbe finalmente regnato sul trono di Gerusalemme, rimasto senza re da molto tempo. L’amato, nel quale mi sono compiaciuto evocava invece un contesto del tutto diverso: si tratta dei “Canti del Servo” del libro di Isaia; era dire che Gesù è il Messia non più alla maniera di un re, ma di un Servo, nel senso di Isaia (Is 42,1). “Ascoltatelo” diceva ancora un’altra cosa: che Gesù è il Messia-Profeta nel senso in cui Mosè, nel libro del Deuteronomio, aveva annunciato al popolo: “Il Signore tuo Dio susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta come me: a lui darete ascolto” (Dt 18,15). “Facciamo tre capanne”: questa frase di Pietro suggerisce che l’episodio della Trasfigurazione possa essere avvenuto durante la festa delle Capanne, o almeno in un clima legato a essa, festa che si celebrava in memoria della traversata del deserto durante l’Esodo e dell’Alleanza conclusa con Dio, nella fervente esperienza che i profeti chiameranno più tardi il fidanzamento del popolo con il Dio di tenerezza e di fedeltà. Durante questa festa si abitava nelle capanne per otto giorni attendendo e implorando una nuova manifestazione di Dio che si sarebbe compiuta con la venuta del Messia Sul monte della Trasfigurazione, i tre apostoli si trovano improvvisamente davanti a questa rivelazione del mistero di Gesù: nulla di sorprendente che siano presi dal timore che coglie ogni uomo davanti alla manifestazione del Dio santo; non sorprende neppure che Gesù li rialzi e li rassicuri: già l’Antico Testamento aveva rivelato al popolo dell’Alleanza che il Dio santissimo è il Dio vicino all’uomo e che la paura non è appropriata. Ma la rivelazione del mistero del Messia, in tutte le sue dimensioni, non è ancora alla portata di tutti; Gesù ordina loro di non raccontare nulla per il momento, prima che il Figlio dell’uomo sia risorto dai morti. Dicendo quest’ultima frase, Gesù conferma la rivelazione che i tre discepoli hanno appena ricevuto: egli è davvero il Messia che il profeta Daniele vedeva sotto le sembianze di un uomo, venire sulle nubi del cielo (cf. Dn 7,13-14). Lo stesso Daniele presenta il Figlio dell’uomo non come un individuo solitario, ma come un popolo, che egli chiama “il popolo dei santi dell’Altissimo”. La realizzazione è ancora più bella della promessa: in Gesù, Uomo-Dio, è l’umanità intera che riceverà questa regalità eterna e sarà eternamente trasfigurata. Ma Gesù ha detto chiaramente: Non dite nulla a nessuno prima della Risurrezione. Solo dopo la Risurrezione di Gesù gli apostoli saranno capaci di esserne testimoni.
+Giovanni D’Ercole
Tra lotta intima e non opporsi al malvagio
Perfezione: andare sino in fondo. E nuova Nascita
(Mt 5,43-48)
Gesù proclama che il nostro cuore non è fatto per orizzonti chiusi, ove si accentuano le incompatibilità.
Egli proibisce l’esclusione, e con essa i risentimenti, le difficoltà di comunicazione.
In noi c’è qualcosa in più di ogni sfaccettatura d’opportunismo, e dell’istinto del ribattere colpo su colpo... pareggiare i conti... persino chiudersi nel proprio gruppo esemplare.
In latino perfĭcĕre significa compiere, completare, condurre a perfezione, fare completamente.
Lo capiamo: qui è indispensabile introdurre altre energie; lasciar agire virtù misteriose... tra gli spazi più profondi che ci appartengono, e il mistero delle vicende.
Altrimenti assimileremmo un modello d’integrità esterno, che non sgorga dalla Fonte dell’essere e non ci corrisponde nell’essenza.
Dentro i paradigmi di perfezione l’Unicità prigioniera non saprebbe più dove andare.
Perfetti sembrano i diamanti - da cui però non nasce nulla: i ‘perfetti’ di Dio sono coloro che vanno ‘sino in fondo’.
Gesù non vuole che l’esistenza di Fede sia marcata dalla solita dura lotta estrinseca - fatta d’intime lacerazioni.
Le differenze ci sono, tuttavia Egli ordina di sovvertire le consuetudini della saggezza antica, delle divisioni interessate (accettabile o meno, amici o nemici, vicini o lontani, puro e impuro, sacro e profano).
Il Regno di Dio, ossia la comunità dei figli - questo germoglio di società alternativa - è radicalmente diversa perché parte dal Seme, non dalla gestualità esteriore; né usa edulcoranti, per celare lo scontro intimo.
Gli accadimenti rigenerano spontaneamente, fuori e persino dentro di noi; inutile forzare.
La crescita e destinazione permane e si farà magnifica, anche grazie alle beffe e costrizioni allestite in modo avverso.
Arrendersi, cedere, deporre l’armatura, farà spazio a nuove gioie.
Combattere gli “allergici” confonde l’anima: sono proprio gl’inciampi sul percorso previsto ad aprire e accendere lo spazio vitale - normalmente troppo stretto, soffocato dagli obblighi.
Sottile consapevolezza e Perfezione che distingue l’autentico uomo nuovo nello Spirito dall’imbonitore che ignora le cose del Padre e cerca scorciatoie affannose, passando sottobanco favori e “mazzette” onde sbrigare immediatamente la propria pratica con Dio e il prossimo.
Amare il nemico che ci [trae fuori e] fa Perfetti:
Se gli altri non sono come abbiamo sognato, è una fortuna: le porte sbattute in faccia e il loro pungolo stanno preparandoci ben altre gioie.
L’avventura della Fede estrema è per una Bellezza che ferisce e una Felicità anormale, prominente.
L’alternativa ‘vittoria-o-sconfitta’ è falsa: bisogna uscirne.
Qui, solo chi sa attendere trova la sua Via.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Quale consapevolezza o fine ti proponi nel coinvolgere il tempo, la percezione, l’ascolto, la gentilezza? Apparire diverso dalla tua indole, per piacere agli altri? Farsi accettare? O essere perfettamente te stesso, e attendere gli sviluppi che si stanno preparando?
[Sabato 1.a sett. Quaresima, 28 febbraio 2026]
Perfezione: andare sino in fondo. E nuova Nascita
Tra lotta intima e non opporsi al malvagio
(Mt 5,43-48)
Nella sua prima enciclica papa Benedetto scriveva:
«Con la centralità dell'amore, la fede cristiana ha accolto quello che era il nucleo della fede d'Israele e al contempo ha dato a questo nucleo una nuova profondità e ampiezza. L'Israelita credente, infatti, prega ogni giorno con le parole del Libro del Deuteronomio, nelle quali egli sa che è racchiuso il centro della sua esistenza: Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze” (6,4-5). Gesù ha unito, facendone un unico precetto, il comandamento dell'amore di Dio con quello dell'amore del prossimo, contenuto nel Libro del Levitico: “Amerai il tuo prossimo come te stesso” (19, 18; cfr Mc 12, 29-31). Siccome Dio ci ha amati per primo (cfr 1 Gv 4, 10), l'amore adesso non è più solo un “comandamento”, ma è la risposta al dono dell'amore, col quale Dio ci viene incontro.
In un mondo in cui al nome di Dio viene a volte collegata la vendetta o perfino il dovere dell'odio e della violenza, questo è un messaggio di grande attualità e di significato molto concreto» [Deus Caritas est, n.1].
L’alternativa “vittoria-o-sconfitta” è falsa: bisogna uscirne
Gesù proclama che il nostro cuore non è fatto per orizzonti chiusi, ove si accentuano le incompatibilità.
Egli proibisce l’esclusione, e con essa i risentimenti, le difficoltà di comunicazione.
In noi c’è qualcosa in più di ogni sfaccettatura d’opportunismo, e dell’istinto del ribattere colpo su colpo... pareggiare i conti... persino chiudersi nel proprio gruppo esemplare.
In latino perfĭcĕre significa compiere, completare, condurre a perfezione, fare completamente.
Lo capiamo: qui è indispensabile introdurre altre energie; lasciar agire virtù misteriose... tra gli spazi più profondi che ci appartengono, e il mistero delle vicende.
Come per noi raggiungere la cima del Monte delle Beatitudini. Per una nuova Nascita, un nuovo Inizio.
Impossibile, se non lasciamo si sviluppi una Sapienza innata, primigenia - magmatica, però assai più integra e inappuntabile.
Avventurarsi lontano dal proprio recinto - addirittura fuori dal coro mondano - non rende forse originali, ma inizia a curare la nostra eccentrica eccezionalità.
Altrimenti assimileremmo un modello d’integrità esterno, che non sgorga dalla Fonte dell’essere e non ci corrisponde nell’essenza.
Dentro i paradigmi di perfezione, l’unicità prigioniera non saprebbe più dove andare. Girerebbe a vuoto credendo di salire [in religione, come su una scala elicoidale, che non porta a nulla: meccanismo tipico delle forme ascetiche].
Nell’esasperazione dei modelli fuori di noi, assoggettiamo l’anima allo stile delle celebrità (perfino ecclesiali).
L’ansia prodotta dalle ristrettezze di carisma, dei campioni, di ruoli privi di sintonie profonde, sarà allora pronta ad attaccarci; si presenterà dietro l’angolo come invincibile avversaria.
Perfetti sembrano i diamanti - da cui però non nasce nulla: i perfetti di Dio sono coloro che vanno sino in fondo.
Dice il Tao: «Se vuoi che ti sia dato tutto, molla tutto».
“Tutto” significa anche l’immagine che siamo abituati a porgere agli altri, per piacere a ogni costo. Bisogna venirne fuori.
Un Gesù trasgressivo incontra la Sapienza di ogni tempo, anche quella naturale - assolutamente non conformista.
Non vuole che l’esistenza di Fede sia marcata dalla solita dura lotta estrinseca [tipica della mentalità “spirituale”] fatta d’intime lacerazioni.
Ancora oggi - purtroppo - in molte realtà credenti si viene formati all’idea dell’inevitabile contrapposizione tra istinto alla vita e norme perbene.
Il Signore sorvola l’idea assuefatta della fatica devota, e lo fa osando completare la Scrittura antica, quasi correggendo le radici dell’identità civile e veneranda del popolo, identificata nella Torah.
Diverse volte e di seguito suggerisce di modificare il Tesoro sacro e inappellabile della Legge: «Fu detto [...] Ora io vi dico».
Le differenze ci sono, tuttavia Gesù ordina di sovvertire le consuetudini della saggezza antica, le divisioni interessate: accettabile o meno, amici o nemici, vicini o lontani, puro e impuro, sacro e profano; così via.
Il Regno di Dio, ossia la comunità dei figli - questo germoglio di società alternativa - è radicalmente diversa perché parte dal Seme, non dalla gestualità esteriore; né usa edulcoranti, per celare lo scontro intimo.
Non è “nuova” come ultima delle astuzie o invenzioni da allestire... Ma perché soppianta tutto il mondo degli artifici unilaterali.
In tal guisa: le anime devono prendere il passo delle cose, per cogliere il ritmo stesso di Dio, che sapientemente crea.
Gli accadimenti rigenerano spontaneamente, fuori e persino dentro di noi; inutile forzare.
La crescita e destinazione permane e si farà magnifica, anche grazie alle beffe e costrizioni allestite in modo avverso - dagli esibizionisti più plateali e insinceri, o da chi sembra vicino.
Arrendersi, cedere, deporre l’armatura, farà spazio a nuove gioie.
Combattere gli “allergici” confonde l’anima: sono proprio gl’inciampi sul percorso previsto ad aprire e accendere lo spazio vitale - normalmente troppo stretto, soffocato dagli obblighi.
Nel Tao Tê Ching si legge: «Se vuoi ottenere qualcosa, devi prima permettere che sia dato ad altri».
La fioritura seguirà l’indole naturale dei figli: sarà senza sforzo alcuno, né recita di santità volitiva, sovraccarica (simpatica o altro).
Sottile consapevolezza e Perfezione che distingue l’autentico uomo nuovo nello Spirito dall’imbonitore che ignora le cose del Padre e cerca scorciatoie affannose, passando sottobanco favori e “mazzette” onde sbrigare immediatamente la propria pratica con Dio e il prossimo.
Amare il nemico che ci [trae fuori e] fa Perfetti:
Se gli altri non sono come abbiamo sognato, è una fortuna: le porte sbattute in faccia e il loro pungolo stanno preparandoci ben altre gioie.
L’avventura della Fede estrema è per una Bellezza che ferisce e una Felicità anormale, prominente.
Qui, solo chi sa attendere trova la sua Via.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Quale consapevolezza o fine ti proponi nel coinvolgere il tempo, la percezione, l’ascolto, la gentilezza?
Apparire diverso dalla tua indole, per piacere agli altri? Farsi accettare?
O essere perfettamente te stesso, e attendere gli sviluppi che si stanno preparando?
Nuovo inizio
«Siate santi, perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo» - si legge nel Libro del Levitico (19,1). Con queste parole, e i precetti che ne conseguono, il Signore invitava il popolo che si era scelto ad essere fedele all’alleanza con Lui camminando sulle sue vie e fondava la legislazione sociale sul comandamento «amerai il tuo prossimo come te stesso» (Lv 19,18). Se ascoltiamo, poi, Gesù, nel quale Dio ha assunto un corpo mortale per farsi prossimo di ogni uomo e rivelare il suo amore infinito per noi, ritroviamo quella stessa chiamata, quello stesso audace obiettivo. Dice, infatti, il Signore: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste» (Mt 5,48). Ma chi potrebbe diventare perfetto? La nostra perfezione è vivere con umiltà come figli di Dio compiendo concretamente la sua volontà. San Cipriano scriveva che «alla paternità di Dio deve corrispondere un comportamento da figli di Dio, perché Dio sia glorificato e lodato dalla buona condotta dell’uomo» (De zelo et livore, 15: CCL 3a, 83).
In che modo possiamo imitare Gesù? Gesù stesso dice: «Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli» (Mt 5,44-45). Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità. L’apostolo Paolo aggiunge: «Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?» (1 Cor 3,16). Se siamo veramente consapevoli di questa realtà, e la nostra vita ne viene profondamente plasmata, allora la nostra testimonianza diventa chiara, eloquente ed efficace. Un autore medievale ha scritto: «Quando l’intero essere dell’uomo si è, per così dire, mescolato all’amore di Dio, allora lo splendore della sua anima si riflette anche nell’aspetto esteriore» (Giovanni Climaco, Scala Paradisi, XXX: PG 88, 1157 B), nella totalità della vita. «Grande cosa è l’amore – leggiamo nel libro dell’Imitazione di Cristo –, un bene che rende leggera ogni cosa pesante e sopporta tranquillamente ogni cosa difficile. L’amore aspira a salire in alto, senza essere trattenuto da alcunché di terreno. Nasce da Dio e soltanto in Dio può trovare riposo» (III, V, 3).
[Papa Benedetto, Angelus 20 febbraio 2011]
Perdonare e Donare. Le parole di Gesù sono realistiche?
Ma mi domando: le parole di Gesù sono realistiche? È davvero possibile amare come ama Dio ed essere misericordiosi come Lui?
Se guardiamo la storia della salvezza, vediamo che tutta la rivelazione di Dio è un incessante e instancabile amore per gli uomini: Dio è come un padre o come una madre che ama di insondabile amore e lo riversa con abbondanza su ogni creatura. La morte di Gesù in croce è il culmine della storia d’amore di Dio con l’uomo. Un amore talmente grande che solo Dio lo può realizzare. È evidente che, rapportato a questo amore che non ha misura, il nostro amore sempre sarà in difetto. Ma quando Gesù ci chiede di essere misericordiosi come il Padre, non pensa alla quantità! Egli chiede ai suoi discepoli di diventare segno, canali, testimoni della sua misericordia.
E la Chiesa non può che essere sacramento della misericordia di Dio nel mondo, in ogni tempo e verso tutta l’umanità. Ogni cristiano, pertanto, è chiamato ad essere testimone della misericordia, e questo avviene in cammino di santità. Pensiamo a quanti santi sono diventati misericordiosi perché si sono lasciati riempire il cuore dalla divina misericordia. Hanno dato corpo all’amore del Signore riversandolo nelle molteplici necessità dell’umanità sofferente. In questo fiorire di tante forme di carità è possibile scorgere i riflessi del volto misericordioso di Cristo.
Ci domandiamo: Che cosa significa per i discepoli essere misericordiosi? Viene spiegato da Gesù con due verbi: «perdonare» (v. 37) e «donare» (v. 38).
La misericordia si esprime, anzitutto, nel perdono: «Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati» (v. 37). Gesù non intende sovvertire il corso della giustizia umana, tuttavia ricorda ai discepoli che per avere rapporti fraterni bisogna sospendere i giudizi e le condanne. È il perdono infatti il pilastro che regge la vita della comunità cristiana, perché in esso si mostra la gratuità dell’amore con cui Dio ci ha amati per primo. Il cristiano deve perdonare! Ma perché? Perché è stato perdonato. Tutti noi che stiamo qui, oggi, in piazza, siamo stati perdonati. Nessuno di noi, nella propria vita, non ha avuto bisogno del perdono di Dio. E perché noi siamo stati perdonati, dobbiamo perdonare. Lo recitiamo tutti i giorni nel Padre Nostro: “Perdona i nostri peccati; perdona i nostri debiti come noi li perdoniamo ai nostri debitori”. Cioè perdonare le offese, perdonare tante cose, perché noi siamo stati perdonati da tante offese, da tanti peccati. E così è facile perdonare: se Di ha perdonato me, perché non devo perdonare gli altri? Sono più grande di Dio? Questo pilastro del perdono ci mostra la gratuità dell’amore di Dio, che ci ha amato per primi. Giudicare e condannare il fratello che pecca è sbagliato. Non perché non si voglia riconoscere il peccato, ma perché condannare il peccatore spezza il legame di fraternità con lui e disprezza la misericordia di Dio, che invece non vuole rinunciare a nessuno dei suoi figli. Non abbiamo il potere di condannare il nostro fratello che sbaglia, non siamo al di sopra di lui: abbiamo piuttosto il dovere di recuperarlo alla dignità di figlio del Padre e di accompagnarlo nel suo cammino di conversione.
Alla sua Chiesa, a noi, Gesù indica anche un secondo pilastro: “donare”. Perdonare è il primo pilastro; donare è il secondo pilastro. «Date e vi sarà dato […] con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio» (v. 38). Dio dona ben al di là dei nostri meriti, ma sarà ancora più generoso con quanti qui in terra saranno stati generosi. Gesù non dice cosa avverrà a coloro che non donano, ma l’immagine della “misura” costituisce un ammonimento: con la misura dell’amore che diamo, siamo noi stessi a decidere come saremo giudicati, come saremo amati. Se guardiamo bene, c’è una logica coerente: nella misura in cui si riceve da Dio, si dona al fratello, e nella misura in cui si dona al fratello, si riceve da Dio!
L’amore misericordioso è perciò l’unica via da percorrere. Quanto bisogno abbiamo tutti di essere un po’ più misericordiosi, di non sparlare degli altri, di non giudicare, di non “spiumare” gli altri con le critiche, con le invidie, con le gelosie. Dobbiamo perdonare, essere misericordiosi, vivere la nostra vita nell’amore. Questo amore permette ai discepoli di Gesù di non perdere l’identità ricevuta da Lui, e di riconoscersi come figli dello stesso Padre. Nell’amore che essi praticano nella vita si riverbera così quella Misericordia che non avrà mai fine (cfr 1 Cor 13,1-12). Ma non dimenticatevi di questo: misericordia e dono; perdono e dono. Così il cuore si allarga, si allarga nell’amore. Invece l’egoismo, la rabbia, fanno il cuore piccolo, che si indurisce come una pietra. Cosa preferite voi? Un cuore di pietra o un cuore pieno di amore? Se preferite un cuore pieno di amore, siate misericordiosi!
[Papa Francesco, Udienza Generale 21 settembre 2016]
1a Domenica di Quaresima
Prima Domenica di Quaresima [22 febbraio 2026]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Mi scuso se mi dilungo oltre misura oggi nella presentazione dei testi, ma è centrale per la vita cristiana capire in profondità il dramma della Genesi (prima lettura) che san Paolo riprende nella seconda lettura portandolo a piena comprensione. Ugualmente il salmo responsoriale si capisce a partire dal dramma raccontato in Genesi cap.3 e ugualmente il vangelo ci mostra come reagire per vivere nel regno di Dio già su questa terra. Secondo me è una visione della vita che va ben focalizzata per capire il dramma del rigetto pratico e spesso inconsapevole di Dio che si consuma nel mondo davanti alla domanda cruciale: perché il male nel mondo? Perché Dio non lo distrugge?
Buona Quaresima
*Prima Lettura dal libero della Genesi (2,7-9; 3,1-7a)
Nei primi capitoli della Genesi appaiono due diverse figure di uomo: il primo che vive felice in piena armonia con Dio, con la donna. e il creato (cap. 2) e invece poi l’uomo che rivendica la propria autonomia afferrando per sé il frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male (cp.3). Gesù riassume in sé “tutte le nostre debolezze” (Eb4,15), messo duramente alla prova sarà il segno della nuova umanità: “l’ultimo Adamo divenne spirito datore di vita” (1Cor 15,45). Prima allora di affrontare questo testo, bisogna ricordare che il suo autore non ha mai preteso di fare opera di storico. La Bibbia non è stata scritta né da scienziati né da storici, ma da credenti per dei credenti. Il teologo che scrive queste righe, probabilmente al tempo di Salomone, nel X secolo prima di Cristo, cerca di rispondere alle domande che tutti si pongono: perché il male? Perché la morte? Perché le incomprensioni nelle coppie umane? Perché la difficoltà di vivere? Perché il lavoro è faticoso? Perché la natura è talvolta ostile? Per rispondere, egli si fonda su una certezza che è quella di tutto il suo popolo: la bontà di Dio. Dio ci ha liberati dall’Egitto, Dio ci vuole liberi e felici. Dalla celebre uscita dall’Egitto, sotto la guida di Mosè, dalla traversata del deserto, durante la quale ad ogni nuova difficoltà si è sperimentata la presenza e il sostegno di Dio, non si può più dubitarne. Il racconto che abbiamo appena letto si fonda dunque su questa certezza della benevolenza di Dio e cerca di rispondere a tutte le nostre domande sul male nel mondo. Con un Dio buono e benevolo, come è possibile che esista il male? Il nostro autore ha inventato una parabola per illuminarci: un giardino di delizie (questo è il significato della parola “Eden”) e l’umanità rappresentata da una coppia incaricata di coltivare e custodire il giardino. Il giardino è pieno di alberi, tutti più attraenti gli uni degli altri. Quello che sta in mezzo si chiama “albero della vita”; si può mangiare il suo frutto come quello di tutti gli altri. Ma c’è anche, da qualche parte nel giardino – il testo non precisa dove – un altro albero, il cui frutto invece è proibito. Si chiama “albero della conoscenza di ciò che rende felici o infelici”. Davanti a questo divieto, la coppia può avere due atteggiamenti: o fidarsi, sapendo che Dio è solo benevolenza, e gioire di avere accesso all’albero della vita; se Dio ci proibisce l’altro albero, è perché non è buono per noi. Oppure sospettare in Dio un calcolo malvagio, immaginare che voglia impedirci l’accesso alla conoscenza. È questo il discorso del serpente: si rivolge alla donna e si mostra falsamente comprensivo: “Allora? Dio vi ha davvero detto: non mangerete di nessun albero del giardino?”(3,1). La donna risponde: “Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare , ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare altrimenti morirete” (3, 2-4). Avete notato lo spostamento: semplicemente perché ha ascoltato la voce del sospetto, ella non parla più che di quell’albero e dice “l’albero che è in mezzo al giardino”; ormai, in buona fede, non vede più l’albero della vita al centro del giardino, ma quello “della conoscenza di ciò che rende felici o infelici. Il suo sguardo è già alterato, solo per il fatto di aver lasciato che il serpente le parlasse; allora il serpente può continuare il suo lento lavoro di demolizione: “No, non morirete affatto! Anzi Dio sa che, il giorno in cui voi ne mangerete, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male” (3,5). Ancora una volta la donna ascolta troppo bene queste belle parole e il testo suggerisce che il suo sguardo è sempre più falsato: “La donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza”(3,6). Il serpente ha vinto: la donna prende il frutto, ne mangia, lo dà a suo marito ed egli ne mangia a sua volta. E la storia finisce così: “Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi”(v.7). Il serpente aveva detto bene: “i vostri occhi si aprirebbero”(3,5); l’errore della donna è stato quello di credere che parlasse nel suo interesse e che svelasse le cattive intenzioni di Dio. Non era che menzogna: lo sguardo è cambiato, è vero, ma è diventato falsato. Non è un caso che il sospetto gettato su Dio sia rappresentato con i tratti di un serpente: Israele, nel deserto, aveva fatto l’esperienza dei serpenti velenosi. Il nostro teologo della corte di Salomone richiama questa dolorosa esperienza e dice: esiste un veleno più grave di quello dei serpenti più velenosi; il sospetto gettato su Dio è un veleno mortale, avvelena le nostre vite. L’idea del nostro anonimo teologo è che tutte le nostre disgrazie provengano da questo sospetto che corrode l’umanità. Dire che l’albero della conoscenza del bene e del male è riservato a Dio significa dire che solo Dio conosce ciò che fa la nostra felicità o la nostra infelicità; il che, in fondo, è logico se è lui che ci ha creati. Voler mangiare a ogni costo il frutto di questo albero proibito significa pretendere di determinare noi stessi ciò che è bene per noi: l’avvertimento “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare , altrimenti morirete” indicava chiaramente che si trattava di una strada sbagliata.
Attenzione! Il racconto va ancora oltre: durante il cammino nel deserto, Dio ha dato la Legge (la torah) che da allora in poi bisognava osservare, quella che chiamiamo i comandamenti. Si sa che la pratica quotidiana di questa Legge è la condizione della sopravvivenza e della crescita armoniosa di questo popolo; se si sapesse davvero che Dio vuole unicamente la nostra vita, la nostra felicità, la nostra libertà, ci si fiderebbe e si obbedirebbe alla Legge di buon cuore. Essa è veramente “l’albero della vita” messo a nostra disposizione da Dio.
Dicevo all’inizio che si tratta di una parabola, ma di una parabola la cui lezione vale per ciascuno di noi; da quando il mondo è mondo, è sempre la stessa storia. San Paolo (che leggiamo questa domenica nella seconda lettura) prosegue la meditazione e dice: solo Cristo ha avuto fiducia nel Padre in ogni cosa; egli ci mostra la via della Vita.
Nota: Nel testo ebraico, la domanda del serpente è volutamente ambigua: «Davvero! Dio vi ha detto: non mangerete di ogni albero del giardino? «הֲכִי־אָמַר אֱלֹהִים לֹא תֹאכְלוּ מִכֹּל עֵץ הַגָּן?» “Ha-ki amar Elohim lo tochlu mikol etz ha-gan? Posta così, infatti, la domanda può essere intesa in senso restrittivo:“Davvero Dio ha detto: non mangerete di alcun albero del giardino?” interpretando “tutti gli alberi” come negazione totale. Oppure in senso generale e colloquiale: “Davvero Dio ha detto: non mangerete di tutti gli alberi del giardino?” interpretando “tutti” in senso assoluto, oppure come tutti gli alberi tranne uno, albero della vitao l’altro della conoscenza del bene e del male. l serpente usa questa ambiguità per seminare dubbio e sospetto, insinuando che Dio potrebbe mentire o trattenere qualcosa di buono. Nei manoscritti ebraici più antichi non ci sono segni di punteggiatura come oggi, quindi il gioco di parole e la doppia lettura era intenzionalmente più forte. Gli esegeti notano che il serpente non fa un’affermazione chiara, ma forma una domanda subdola, che sposta il focus sul dubbio: “Forse Dio vi sta ingannando?” Questo racconto della Genesi ha molte risonanze nella meditazione del popolo d’Israele. Una delle riflessioni suggerite dal testo riguarda l’albero della vita: piantato in mezzo al giardino di Eden, era accessibile all’uomo e il suo frutto era permesso. Si può pensare che il suo frutto permettesse all’uomo di rimanere in vita, di quella vita spirituale che Dio gli aveva insufflato: “IlSignore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo, soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente” (Gen 2,7). Allora i rabbini hanno fatto il collegamento con la Legge data da Dio sul Sinai. Essa infatti è accolta dai credenti come un dono di Dio, un sostegno per la vita quotidiana: “Figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento e il tuo cuore custodisca i miei precetti, perché prolungheranno i tuoi giorni, gli anni della tua vita e ti daranno pace” (Pr 3,1-2).
NB Per maggiore complemento aggiungo questo: C’è il primo divieto: l’albero della conoscenza del bene e del male in Gn 2,16-17, Dio pone un solo limite all’uomo: “Di tutti gli alberi del giardino puoi mangiare, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiar”. L’albero della vita non è proibito in questo momento. Il divieto riguarda solo l’albero della conoscenza del bene e del male perché Dio è colui che decide che cosa è bene e che cosa è male e l’uomo è chiamato a fidarsi, non a sostituirsi a Dio. Mangiare il frutto dell’albero della conoscenza significa dire: “Non mi fido di Dio, decido io ciò che è bene e ciò che è male”. Dopo il peccato c’è il secondo divieto (l’albero della vita) perché la situazione cambia radicalmente. In Genesi 3,22-24 leggiamo: “Ora, che non stenda la mano e non prenda anche dell’albero della vita, ne mangi e viva per sempre”. Solo dopo il peccato, Dio impedisce l’accesso all’albero della vita. Perché? perché l’uomo, separato da Dio dal peccato, non può vivere per sempre così. Vivere eternamente con le conseguenze del peccato sarebbe una condanna, non un dono. Dio quindi protegge l’uomo da un’immortalità deformata. In altre parole: Dio non toglie la vita per punire, ma per impedire che il male diventi eterno.
*Salmo responsoriale (50/51)
“Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; secondo la tua grande misericordia cancella il mio peccato. Lavami interamente dalla mia colpa, purificami dalla mia offesa”. Il popolo d’Israele è riunito in una grande celebrazione penitenziale nel Tempio di Gerusalemme. Si riconosce peccatore, ma conosce anche l’inesauribile misericordia di Dio. Del resto, se è riunito per chiedere perdono, è perché sa già in anticipo che il perdono è stato concesso. Questa era stata, ricordiamolo, la grande scoperta del re Davide: Davide prese Betsabea di cui si era invaghito e fece uccidere Uria suo marito perché qualche giorno dopo, Betsabea aspettava un figlio da lui. Quando il profeta Natan andò da Davide, non cercò anzitutto di ottenere da lui una parola di pentimento; cominciò invece col ricordargli tutti i doni di Dio e con l’annunciargli il perdono, prima ancora che Davide avesse avuto il tempo di fare la minima confessione (2 Sam 12). In sostanza gli disse: “Guarda tutto ciò che Dio ti ha dato… ebbene, sappi che è pronto a darti ancora tutto ciò che vorrai!”. E mille volte, nel corso della sua storia, Israele ha potuto verificare che Dio è davvero «il Signore misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di amore e di fedeltà», secondo la rivelazione che ha concesso a Mosè nel deserto (Es 34,6). Anche i profeti hanno trasmesso questo annuncio, e i pochi versetti del salmo che abbiamo appena ascoltato sono pieni di queste scoperte di Isaia ed Ezechiele. Isaia, per esempio: «Sono io, proprio io, che cancello i tuoi misfatti per amore di me stesso, e dei tuoi peccati non mi ricorderò» (Is 43,25); oppure ancora: «Ho cancellato come una nube le tue ribellioni e come una nuvola i tuoi peccati. Ritorna a me, perché ti ho riscattato» (Is 44,22).
Questo annuncio della gratuità del perdono di Dio a volte ci sorprende: sembra troppo bello, forse; per alcuni appare persino ingiusto: se tutto è perdonabile, che senso ha fare degli sforzi? È forse dimenticare troppo in fretta che tutti, senza eccezione, abbiamo bisogno della misericordia di Dio; non lamentiamocene dunque! E non stupiamoci se Dio ci sorprende, poiché, come dice Isaia, «i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri». E proprio Isaia precisa che è soprattutto in materia di perdono che Dio ci sorprende di più. La sola condizione richiesta è riconoscersi peccatori. Quando il figlio prodigo (Lc 15): ritorna dal padre, per motivi peraltro non molto nobili, Gesù gli mette sulle labbra una frase del salmo 50: “Contro di te, contro te solo ho peccato», e questa semplice frase ristabilisce il legame che il giovane ingrato aveva spezzato”. Di fronte a questo annuncio sempre rinnovato della misericordia di Dio, il popolo d’Israele — perché è lui che parla qui, come in tutti i salmi — si riconosce peccatore: la confessione non è dettagliata, non lo è mai nei salmi penitenziali; ma l’essenziale è detto in questa supplica: “Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, secondo la tua grande misericordia cancella il mio peccato…. E Dio, che è tutta misericordia, cioè come attirato dalla miseria, non attende altro che questo semplice riconoscimento della nostra povertà. La parola “pietà” ha la stessa radice della parola “elemosina”: letteralmente, siamo mendicanti davanti a Dio. Restano allora due cose da fare. Anzitutto, ringraziare semplicemente per il perdono accordato senza cessare; la lode che il popolo d’Israele rivolge a Dio è il riconoscimento delle bontà con cui lo ha colmato fin dall’inizio della sua storia. Questo mostra bene che la preghiera più importante in una celebrazione penitenziale è il grazie per i doni e per i perdoni di Dio: bisogna cominciare col contemplare Lui, e solo dopo, quando questa contemplazione ci ha rivelato lo scarto tra Lui e noi, possiamo riconoscerci peccatori. Il rituale della riconciliazione lo dice chiaramente nella sua introduzione: “Confessiamo l’amore di Dio insieme al nostro peccato”. E il canto di riconoscenza sgorgherà spontaneamente dalle nostre labbra: basta lasciare che Dio ci apra il cuore. “Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode”; alcuni riconoscono qui la prima frase della Liturgia delle Ore di ogni mattino; in effetti, essa è tratta dal salmo 50/51. Da sola è una vera lezione: la lode, la riconoscenza possono nascere in noi solo se Dio apre i nostri cuori e le nostre labbra. San Paolo lo dice in altro modo: «Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del Figlio suo, che grida: “Abbà!”, cioè: Padre!» (Gal 4,6). Questo fa irresistibilmente pensare a un gesto di Gesù nel vangelo di Marco: la guarigione di un sordomuto; toccandogli le orecchie e la lingua, Gesù disse: «Effatà», che significa «Apriti». E allora, spontaneamente, coloro che erano presenti applicarono a Gesù una frase che la Bibbia riservava a Dio: «Fa udire i sordi e parlare i muti» (cfr Is 35,5-6). Ancora oggi, in alcune celebrazioni del battesimo, il celebrante ripete questo gesto di Gesù sui battezzati dicendo: “Il Signore Gesù ha fatto udire i sordi e parlare i muti; ti conceda di ascoltare la sua parola e di proclamare la fede, a lode e gloria di Dio Padre”. La seconda cosa da fare, e che Dio attende da noi: perdonare a nostra volta, senza indugio né condizioni… ed è tutto un serio programma della nostra vita
*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (5, 12-19)
Adamo era figura di colui che doveva venire, ci dice Paolo; egli parla di Adamo al passato perché fa riferimento al libro della Genesi e alla storia del frutto proibito, ma per lui il dramma di Adamo non è una storia del passato: questa storia è la nostra, quotidianamente; tutti noi siamo Adamo a volte; i rabbini dicono: “ognuno è Adamo per se stesso”.
E se si dovesse riassumere la storia del giardino dell’Eden (che rileggiamo nella prima lettura di questa domenica), si potrebbe dire questo: ascoltando la voce del serpente piuttosto che il comando di Dio, lasciando che il sospetto sulle intenzioni di Dio invada il loro cuore, credendo di potersi permettere tutto, di poter “conoscere” tutto – come dice la Bibbia – l’uomo e la donna si pongono da soli sotto il dominio della morte. E quando si dice: “ ognuno è Adamo per se stesso “, significa che ogni volta che ci allontaniamo da Dio, lasciamo che le potenze di morte invadano la nostra vita. San Paolo, nella lettera ai Romani, prosegue la stessa meditazione e annuncia che l’umanità ha compiuto un passo decisivo in Gesù Cristo; tutti noi siamo fratelli di Adamo e siamo tutti fratelli di Gesù Cristo; siamo fratelli di Adamo quando lasciamo che il veleno del sospetto infesti il nostro cuore, quando pretendiamo di farci noi stessi la legge. Siamo invece fratelli di Cristo quando confidiamo abbastanza in Dio da lasciargli guidare le nostre vite. Siamo sotto il dominio della morte quando ci comportiamo alla maniera di Adamo; quando invece ci comportiamo come Gesù, cioè come lui “obbedienti” (cioè fiduciosi), siamo risorti già nel regno della vita, quella di cui parla Giovanni : “Colui che crede in me, anche se muore, vivrà”, vita che la morte biologica non interrompe. Torniamo al racconto del libro della Genesi: Il Signore Dio plasmò l’uomo con la polvere del suolo; soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente. Questo soffio di Dio che fa dell’uomo un essere vivente – come dice il testo – gli animali non l’hanno ricevuto: eppure sono ben vivi in senso biologico; se ne può dunque dedurre che l’uomo gode di una vita diversa dalla vita biologica. San Paolo afferma che a causa di Adamo la morte ha regnato: utilizza più volte i termini “regno”, “regnare” mostrando che ci sono due regni che si affrontano: il regno del peccato quando l’umanità agisce come Adamo, che porta morte, giudizio, condanna. C’è poi il regno di Cristo cioè con lui l’umanità nuova, che è il regno della grazia, della vita, dono gratuito, della giustificazione. Nessuno uomo è però interamente nel regno di Cristo e Paolo stesso lo riconosce: “Non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio” (Rm 7,19). Adamo, cioè l’umanità, è creata per essere re per coltivare e custodire il giardino, come leggiamo nel libro della Genesi, ma, mal consigliata dal serpente, vuole fare tutto da sé stessa, con le proprie forze, tagliandosi fuori da Dio. Gesù Cristo, al contrario, non “rivendica” questa regalità: gli è data. Come scrive Paolo nella lettera ai Filippesi: “pur essendo di natura divina, non considerò un privilegio l’essere come Dio, ma si fece obbediente » (2,6 trad. TOB). Il racconto del giardino dell’Eden dice la stessa cosa in immagini: prima della colpa, l’uomo e la donna potevano mangiare il frutto dell’albero della vita; dopo la colpa, non vi hanno più accesso. Ciascuno a modo suo, questi due testi – quello della Genesi da una parte e quello della lettera ai Romani dall’altra – ci dicono la verità più profonda della nostra vita: con Dio tutto è grazia, tutto è dono gratuito; e Paolo qui insiste sull’abbondanza, sulla profusione della grazia, parla persino della “sproporzione” della grazia: Non è come per la caduta il dono gratuito… molto più la grazia di Dio si è riversata in abbondanza sulla moltitudine, questa grazia data in un solo uomo, Gesù Cristo. Tutto è dono e non c’è da stupirsi poiché, come dice san Giovanni, Dio è Amore. Non perché Cristo si è ben comportato che ha ricevuto una ricompensa e Adamo a causa di una cattiva condotta ha ricevuto il castigo. Il discorso di Paolo è più profondo: Cristo vive nella totale fiducia che in Dio tutto gli sarà dato… e tutto gli è dato nella Risurrezione. Adamo, cioè ciascuno di noi, spesso vuole impadronirsi da solo di ciò che può essere accolto solamente come dono e per questo si ritrova “nudo”, cioè privo di tutto. Potremmo dire che per nascita siamo cittadini del regno di Adamo; mediante il battesimo abbiamo chiesto di essere naturalizzati nel regno di Cristo. Obbedienza e disobbedienza nel senso di Paolo potrebbero sostituirsi così: “obbedienza” con fiducia e “disobbedienza” con diffidenza; come dice Kierkegaard: “Il contrario del peccato non è la virtù; il contrario del peccato è la fede”. Se rileggiamo il racconto della Genesi, possiamo notare che, intenzionalmente, l’autore non aveva dato nomi propri all’uomo e alla donna; parlava di Adamo (deriva da adamah che significa terra, polvere) che significa “essere umano tratto dalla terra”, mentre Eva (deriva da Chavah che indica vita) è colei che dà la vita. Non dando loro dei nomi, voleva farci capire che il dramma di Adamo ed Eva non è la storia di individui particolari, ma è la storia di ogni essere umano e questo da sempre.
*Dal Vangelo secondo Matteo (4, 1-11)
Ogni anno, la Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto: bisogna credere che si tratti di un testo davvero fondamentale! Quest’anno lo leggiamo secondo san Matteo. Dopo aver raccontato il battesimo di Gesù, Matteo continua subito: “Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo”. L’evangelista ci invita quindi a fare un collegamento tra il battesimo di Gesù e le tentazioni che seguono immediatamente. Matteo aveva detto qualche versetto prima: Gesù “salverà il suo popolo dai suoi peccati”, che è proprio il senso del nome Gesù. Giovanni Battista battezza Gesù nel Giordano anche se lui non era d’accordo e aveva detto: “Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me!”(Mt 3,14)… E accadde che quando dopo il battesimo Gesù risalì dall’acqua i cieli si aprirono: vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. E dai cieli si udì una voce: “Questi è il Figlio mio diletto, in lui mi sono compiaciuto”.
Questa frase, da sola, annuncia pubblicamente che Gesù è davvero il Messia: perché l’espressione “Figlio di Dio” era sinonimo di Re-Messia e la frase “l’amato, in lui ho posto il mio compiacimento”(3,17) si riferisce a uno dei canti del Servo in Isaia. In poche parole, Matteo ci ricorda tutto il mistero della persona di Gesù; ed è lui, precisamente, il Messia, il salvatore,il servo che affronterà il Tentatore. Come il suo popolo, qualche secolo prima, è condotto nel deserto; come il suo popolo, conosce la fame; come il suo popolo, deve scoprire quale sia la volontà di Dio sui suoi figli; come il suo popolo, deve scegliere davanti a chi prostrarsi. “Se tu sei Figlio di Dio”, ripete il Tentatore, manifestando così qual è il vero problema; e Gesù vi è confrontato, non solo tre volte, ma per tutta la sua vita terrena. Essere il Messia, concretamente, cosa significa? La questione prende varie forme: risolvere i problemi degli uomini a colpi di miracoli, come trasformare le pietre in pane? Provocare Dio per verificare le sue promesse? … Lanciandosi dal tempio, ad esempio, perché il Salmo 91 prometteva che Dio avrebbe soccorso il suo Messia… Possedere il mondo, dominare, regnare a qualunque prezzo, persino adorando qualsiasi idolo? Persino smettendo di essere Figlio? va notato che alla terza tentazione, il Tentatore non ripete più “Se tu sei Figlio di Dio”.
Il culmine di queste tentazioni è che esse mirano a promesse di Dio: non promettono altro che ciò che Dio stesso ha promesso al suo Messia. E i due interlocutori, Tentatore e Gesù, lo sanno bene. Ma ecco… le promesse di Dio sono nell’ordine dell’amore; esse possono essere ricevute solo come doni; l’amore non si esige, non ci si impadronisce, si riceve in ginocchio, con gratitudine. In fondo, succede la stessa cosa del Giardino della Genesi: Adamo sa, e ha ragione, di essere creato per essere re, per essere libero, per essere padrone della creazione; ma invece di accogliere i doni come doni, con gratitudine e riconoscenza, esige, rivendica, si pone alla pari di Dio… Esce dall’ordine dell’amore e non può più ricevere l’amore offerto… si ritrova povero e nudo. Gesù fa la scelta opposta: “Vattene Satana!” come dirà una volta a Pietro aggiungendo “I tuoi pensieri non sono quelli di Dio, ma quelli degli uomini” (Mt 16,23. Inoltre, più volte in questo testo, Matteo chiama il Tentatore “diavolo”, che in greco significa colui che divide. Satana è per ciascuno di noi, come lo è per Gesù stesso, colui che tende a separarci da Dio, a vedere le cose alla maniera di Adamo e non alla maniera di Dio. A ben vedere tutto sta nello sguardo: quello di Adamo è falsato; per mantenere lo sguardo chiaro, Gesù scruta la Parola di Dio: le tre risposte al Tentatore sono citazioni dal libro del Deuteronomio (cap. 8), in un passo che è proprio una meditazione sulle tentazioni del popolo d’Israele nel deserto. Allora, precisa Matteo, il diavolo (il divisore) lo lascia; non è riuscito a dividere, a distogliere il cuore del Figlio. Questo richiama ila frase di san Giovanni nel Prologo (Gv 1,1): “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio (pros ton Theon, che significa rivolto a Dio), e il Verbo era Dio”. Il diavolo non è riuscito a distogliere il cuore del Figlio, e questi è allora tutto disponibile per accogliere i doni di Dio: ”Ecco degli angeli si avvicinarono e lo servivano”.
NB Su richiesta di qualcuno mi permetto anche di presentarvi l’omelia che io sto preparando per questa prima domenica di Quaresima
Omelia – I Domenica di Quaresima
Ogni anno, la Quaresima si apre con il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto: bisogna credere che si tratti di un testo davvero fondamentale! Quest’anno lo leggiamo secondo san Matteo. Dopo aver raccontato il battesimo di Gesù, Matteo continua subito: “Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo”. L’evangelista ci invita quindi a fare un collegamento tra il battesimo di Gesù e le tentazioni che seguono immediatamente. Quando Gesù risalì dall’acqua i cieli si aprirono: vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. E dai cieli si udì una voce: “Questi è il Figlio mio diletto, in lui mi sono compiaciuto”. Gesù è il “Figlio di Dio”, il Messia, il salvatore, il servo di Dio che affronterà il Tentatore. Satana dirà proprio così: “Se tu sei Figlio di Dio” mostrando così qual è il vero problema; e cioè il tentativo di separare in Gesù la sua identità divina dal suo modo di viverla o meglio ancora spingere Gesù a utilizzare la sua potenza divina senza la fiducia di figlio e la sua umanità senza l’obbedienza. Per capire meglio , dobbiamo tornare alla prima Lettura tratta libro della Genesi dove il serpente tentatore promette a Eva: “Sarete come Dio” (Gen 3,5). La tentazione non riguarda solo un frutto da non mangiare, ma l’autonomia da Dio, il desiderio di decidere da soli ciò che è bene e male, senza fidarsi del Padre. Adamo ed Eva si lasciarono convincere e si ritrovarono nudi. Hanno perso tutto!
Nel deserto, il diavolo trenta ora con Gesù, nuovo Adamo, vero uomo come noi eccetto il peccato e lancia tre provocazioni: 1. “Di’ che queste pietre diventino pane”. La tentazione di vivere senza dipendere da Dio, di cercare soddisfazione immediata. C’è una fame che va oltre il pane e che solo Dio può soddisfare. Ma questo significa fidarsi di Dio e Gesù risponde: “Sta scritto: Non di solo pane vivrà l’uomo” (Mt 4,4). 2a tentazione. Il diavolo rilancia: “Gettati giù” dal tempio e gli angeli ti accoglieranno. Ecco la tentazione di manipolare Dio, di chiedere segni spettacolari per confermare la propria fede. Una tentazione oggi molto sottile ma assai frequente quando si crede di spettacolarizzare la liturgia, l’evangelizzazione e gli eventi ecclesiali. Gesù insegna a diffondere il vangelo come lievito nella pasta e piccolo seme nel terreno: tutto avviene nel silenzio perché. non bisogna credere di essere protagonisti ma vite sempre nascoste in Dio anche quando si agisce pubblicamente. Non è opera nostra convertire il mondo. Ascoltiamo Gesù che ribatte: “Sta scritto: Non tenterai il Signore Dio tuo” (Mt 4,7). 3. Alla terza tentazione va notato che il Tentatore non ripete più “Se tu sei Figlio di Dio” e questo perché satana si crede lui il padrone del mondo e allora può dirgli: “Ti darò tutto se ti prostri” E’ la tentazione del potere e del compromesso, di piegare la propria vita ai vantaggi immediati. Molto pericolosa perché assai spesso passa attraverso l’idea di credere che si può accettare tutto pur di evangelizzare, ma non siamo noi i padroni! . Gesù risponde: “Sta scritto: Adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo renderai culto” (Mt 4,10).
Notiamo qualcosa di decisivo: Gesù non risponde con la propria intelligenza o forza, ma sempre rifacendosi alla Parola di Dio, che è l’unica vera luce che può guidare il cammino dell’uomo nel deserto della vita, cammino spesso buio e pieno di insidie. Questo perché la Parola di Dio è luce di verità che non si spegne mai. San Giovanni Crisostomo ci ricorda: «Nella Scrittura non troviamo solo parole, ma la forza che serve per vincere il male; essa è il nutrimento dell’anima e la luce che guida chi cammina tra le tenebre» (Omelie su Matteo, IV secolo). Anche quando il mondo rifiuta Dio, anche quando le scelte giuste sembrano scomode o perdenti, la Scrittura resta la guida sicura. Come applicare questo alla nostra vita? Oggi, essere cristiani è spesso difficile:la fede può essere derisa o ignorata, il Vangelo sembra inutile, Cristo è combattuto e talora tollerato, ma non accolto. La Quaresima ci invita a fare una scelta quotidiana: chi guida la nostra vita? Vogliamo fare tutto da soli, come Eva e Adamo nell’Eden scegliendo ciò che ci sembra più comodo? Oppure ci affidiamo a Dio, lasciando che la sua Parola illumini le nostre decisioni e dia senso anche alle difficoltà? Seguire Cristo significa scegliere la fedeltà, anche quando il mondo va contro. Significa vivere la propria vita da cristiani senza compromessi, basandoci non sulla forza personale, ma sulla Parola viva di Dio. Ci sostiene sempre una speranza certa e concreta: Il Vangelo termina con una promessa silenziosa: “Allora il diavolo lo lasciò” (Mt 4,11). Chi si affida a Dio non resta solo nelle prove. La tentazione può apparire potente, ma chi cammina alla luce della Parola non è mai vinto. Gesù, il nuovo Adamo, vince là dove Adamo ed Eva cedettero. Il tempo della Quaresima ci invita a tornare all’essenziale: a non allontanarci mai da Dio, a non piegare la vita al potere o al piacere immediato, a lasciarci guidare dalla Parola di Dio, che è la vera luce nel deserto. Chiediamo oggi la grazia di rispondere sempre con fedeltà alla Scrittura, come Gesù. Essere testimoni del Vangelo non è facile, ma è sorgente di coraggio e di pace nel cuore.
+Giovanni D’Ercole
Primo debito: una Giustizia maggiore
(Mt 5,20-26)
«Vi dico infatti che se la vostra giustizia non abbonderà di più [quella] degli scribi e farisei, non entrerete nel Regno dei cieli»
Nelle chiese di Galilea e Siria serpeggiavano opinioni differenti e conflittuali circa la Legge di Mosè: per alcuni un assoluto da adempiere persino nei dettagli, per altri ormai un orpello senza senso (v.22).
I contendenti giungevano all’insulto, per ridicolizzare la parte avversa.
Ma come dice il Tao Tê Ching (xxx): «Là dove stanziano le milizie nascono sterpi e rovi». Il maestro Wang Pi commenta: «Colui che si fa promotore suscita disordini, perché si sforza di affermare i suoi meriti».
Mt aiuta tutti i fratelli di comunità a comprendere il contenuto delle Scritture antiche e capire l’atteggiamento di ‘continuità e taglio’ dato ad esse dal Signore: «Avete udito che [...] Ora io vi dico» (vv.21-22).
La ‘freccia’ dei codici antichi è stata scoccata nella direzione giusta, ma solo capirne la portata nello spirito di concordia ne sostiene il tragitto sino a fornire l’energia necessaria per cogliere il “bersaglio”.
L’ideale della religiosità antica era presentarsi puri davanti a Dio, e in tal senso gli scribi teologi ufficiali del sinedrio sottolineavano il valore delle norme che ritenevano si annidassero nella ‘prigione della lettera’ del Primo Testamento.
I sadducei - classe sacerdotale - puntavano sulle osservanze sacrificali della sola Torah.
I farisei, leaders della religiosità popolare, accentuavano il rispetto di ogni consuetudine tradizionale.
L’insegnamento dei professionisti del sacro produceva nel popolo un senso di oppressione legalista che oscurava lo spirito della Parola di Dio e della stessa Tradizione.
Gesù ne fa emergere l’obbiettivo: la Giustizia maggiore dell’Amore.
Lo splendore, la bellezza e ricchezza della Gloria del Dio vivente non si produce nell’osservare, bensì nella capacità di manifestarlo Presente.
L’assetto giusto davanti al Padre diventa - nella proposta di Gesù - giusta posizione davanti alla propria storia e a quella del prossimo.
Il primo «debito» è dunque una ‘comprensione globale’: qui si svela l’Eterno.
Giustizia non è prodotto dell’accumulare azioni rette, in vista del merito: ciò manifesterebbe grettezza, distacco e supponenza (un tipo di uomo dal pensiero indiscutibile).
La nuova Giustizia insegue le complicità col male sino alle radici segrete del cuore e delle idee. Ma non per accentuare il senso di colpa, né per farci inseguire sogni esterni.
L’osservanza che non permanesse nell’amicizia, nella tolleranza anche di se stessi, in Cristo che orienta, sorgerebbe da un rapporto ambiguo con la norma e le dottrine.
Possiamo trascurare il bisogno infantile di approvazione.
La Vita di Dio trapela in un mondo non di puri e flemmatici sterilizzati o unilaterali, ma in una convivialità delle differenze che gli somiglia.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Dove trovi il nutrimento emotivo che ti è necessario?
Cosa pensi delle comitive esclusive e della loro idea di tribunale risolutivo?
[Venerdì 1.a sett. Quaresima, 27 febbraio 2026]
Discordia anche con la creazione
Se l’uomo non è riconciliato con Dio, è in discordia anche con la creazione. Non è riconciliato con se stesso, vorrebbe essere un altro da quel che è ed è pertanto non riconciliato neppure con il prossimo. Fa inoltre parte della riconciliazione la capacità di riconoscere la colpa e di chiedere perdono – a Dio e all’altro. E infine appartiene al processo della riconciliazione la disponibilità alla penitenza, la disponibilità a soffrire fino in fondo per una colpa e a lasciarsi trasformare. E ne fa parte la gratuità, di cui l’Enciclica “Caritas in veritate” parla ripetutamente: la disponibilità ad andare oltre il necessario, a non fare conti, ma ad andare al di là di ciò che richiedono le semplici condizioni giuridiche. Ne fa parte quella generosità di cui Dio stesso ci ha dato l’esempio. Pensiamo alla parola di Gesù: “Se tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono” (Mt 5, 23s.). Dio che sapeva che non siamo riconciliati, che vedeva che abbiamo qualcosa contro di Lui, si è alzato e ci è venuto incontro, benché Egli solo fosse dalla parte della ragione. Ci è venuto incontro fino alla Croce, per riconciliarci. Questa è gratuità: la disponibilità a fare il primo passo. Per primi andare incontro all’altro, offrirgli la riconciliazione, assumersi la sofferenza che comporta la rinuncia al proprio aver ragione. Non cedere nella volontà di riconciliazione: di questo Dio ci ha dato l’esempio, ed è questo il modo per diventare simili a Lui, un atteggiamento di cui sempre di nuovo abbiamo bisogno nel mondo. Dobbiamo oggi apprendere nuovamente la capacità di riconoscere la colpa, dobbiamo scuoterci di dosso l’illusione di essere innocenti. Dobbiamo apprendere la capacità di far penitenza, di lasciarci trasformare; di andare incontro all’altro e di farci donare da Dio il coraggio e la forza per un tale rinnovamento.
[Papa Benedetto, Discorso alla Curia Romana 21 dicembre 2009]
La differenza che ristabilisce
1. Nei Vangeli troviamo un altro fatto che attesta la coscienza di Gesù di possedere un’autorità divina, e la persuasione che di tale autorità ebbero gli evangelisti e la prima comunità cristiana. Infatti i Sinottici sono concordi nel dire che gli ascoltatori di Gesù “erano stupiti del suo insegnamento, perché insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi” (Mc 1, 22; Mt 7, 29; Lc 4, 32). È un’informazione preziosa che Marco ci dà fin dall’inizio del suo Vangelo. Essa ci attesta che la gente aveva colto subito la differenza tra l’insegnamento di Cristo e quello degli scribi israeliti, e non solo nel modo, ma nella stessa sostanza: gli scribi poggiavano il loro insegnamento sul testo della Legge mosaica, della quale erano interpreti e chiosatori; Gesù non seguiva affatto il metodo di un “insegnante” o di un “commentatore” della Legge antica, ma si comportava come un legislatore e, in definitiva, come uno che aveva autorità sulla Legge. Si noti: gli ascoltatori sapevano bene che si trattava della Legge divina, data da Mosè in forza di in potere che Dio stesso gli aveva concesso come a suo rappresentante e mediatore presso il popolo di Israele.
Gli evangelisti e la prima comunità cristiana che riflettevano su quell’osservazione degli ascoltatori circa l’insegnamento di Gesù, si rendevano conto ancor meglio del suo significato integrale, perché potevano confrontarla con tutto il successivo ministero di Cristo. Per i Sinottici e per i loro lettori era quindi logico il passaggio dall’affermazione di un potere sulla Legge mosaica e su tutto l’Antico Testamento a quella della presenza di un’autorità divina in Cristo. E non solo come in un Inviato o Legato di Dio come era stato nel caso di Mosè: Cristo attribuendosi il potere di completare e interpretare autorevolmente o addirittura di dare in modo nuovo la Legge di Dio, mostrava la sua coscienza di essere “uguale a Dio” (cf. Fil 2, 6).
2. Che il potere attribuitosi da Cristo sulla Legge comporti un’autorità divina, lo dimostra il fatto che egli non crea un’altra Legge abolendo l’antica: “Non pensate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti; non sono venuto per abolire ma per dare compimento” (Mt 5, 17). È chiaro che Dio non potrebbe “abolire” la Legge che egli stesso ha dato. Può invece - come fa Gesù Cristo - chiarire il suo pieno significato, far capire il suo giusto senso, correggere le false interpretazioni e le arbitrarie applicazioni, a cui il popolo e i suoi stessi maestri e dirigenti, cedendo alle debolezze e limitazioni della condizione umana, l’hanno piegata.
Per questo Gesù annunzia, proclama e richiede una “giustizia” superiore a quella degli scribi e dei farisei (cf. Mt 5, 20), la “giustizia” che Dio stesso si è proposto ed esige con l’osservanza fedele della Legge in ordine al “regno dei cieli”. Il Figlio dell’uomo opera dunque come un Dio che ristabilisce ciò che Dio ha voluto e posto una volta per sempre.
3. Difatti della Legge di Dio egli anzitutto proclama: “In verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà neppure un iota o un segno della legge, senza che tutto sia compiuto” (Mt 5, 18). È una dichiarazione drastica, con la quale Gesù vuole affermare sia l’immutabilità sostanziale della Legge mosaica, sia il compimento messianico che essa riceve nella sua parola. Si tratta di una “pienezza” dell’Antica Legge, che egli, insegnando “come uno che ha autorità” sulla Legge, fa vedere che si manifesta soprattutto nell’amore di Dio e del prossimo. “Da questi due comandamenti dipende tutta la Legge e i Profeti” (Mt 22, 40). Si tratta di un “compimento” corrispondente allo “spirito” della Legge, che già traspare dalla “lettera” dell’Antico Testamento, che Gesù coglie, sintetizza, e propone con l’autorità di uno che è Signore anche della Legge. I precetti dell’amore, e anche della fede generatrice di speranza nell’opera messianica, che egli aggiunge alla Legge antica esplicitandone il contenuto e sviluppandone le virtualità nascoste, sono pure un compimento.
La sua vita è un modello di questo compimento, sicché Gesù può dire ai suoi discepoli non solo e non tanto: Seguite la mia Legge, ma: Seguite me, imitate me, camminate nella luce che viene da me.
4. Il Discorso della montagna, come è riportato da Matteo, è il luogo del Nuovo Testamento dove si vede affermato chiaramente ed esercitato decisamente da Gesù il potere sulla Legge che Israele ha ricevuto da Dio come cardine dell’alleanza. È là che, dopo avere dichiarato il valore perenne della Legge e il dovere di osservarla (Mt 5, 18-19), Gesù passa ad affermare la necessità di una “giustizia” superiore a “quella degli scribi e dei farisei”, ossia di una osservanza della Legge animata dal nuovo spirito evangelico di carità e di sincerità.
Le esemplificazioni concrete sono note. La prima consiste nella vittoria sull’ira, il risentimento, il malanimo che si annidano facilmente nel cuore umano, anche quando si può esibire un’esteriore osservanza dei precetti mosaici, tra i quali quello di non uccidere: “Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio” (Mt 5, 21-22). La stessa cosa vale per chi avrà offeso un altro con parole ingiuriose, con scherzi e derisioni. È la condanna di ogni cedimento all’istinto dell’avversione, che potenzialmente è già un atto di lesione e persino di uccisione, almeno spirituale, perché viola l’economia dell’amore nei rapporti umani e fa del male agli altri e a questa condanna Gesù intende contrapporre la Legge della carità che purifica e riordina l’uomo fin nei più intimi sentimenti e movimenti del suo spirito. Della fedeltà a questa Legge Gesù fa una condizione indispensabile della stessa pratica religiosa: “Se dunque presenti la tua offerta all’altare e là ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono” (Mt 5, 23-24). Trattandosi di una legge d’amore, è persino irrilevante chi sia ad avere in cuore qualcosa contro l’altro: l’amore predicato da Gesù parifica e unifica tutti nel volere il bene, nello stabilire o ristabilire l’armonia nei rapporti col prossimo, persino in casi di contese e di procedimenti giudiziari (cf. Mt 5, 25).
5. Un’altra esemplificazione di perfezionamento della Legge è quella circa il sesto comandamento del Decalogo, nel quale Mosè proibiva l’adulterio. Con un linguaggio iperbolico e persino paradossale, atto a richiamare l’attenzione e a scuotere lo stato d’animo degli ascoltatori, Gesù annuncia. “Avete inteso che fu detto: Non commettere adulterio, ma io vi dico . . .” (Mt 5, 27); e condanna anche gli sguardi e i desideri impuri, mentre raccomanda la fuga delle occasioni, il coraggio della mortificazione, la subordinazione di tutti gli atti e i comportamenti alle esigenze della salvezza dell’anima e di tutto l’uomo (cf. Mt 5, 29-30).
A questo caso se ne ricollega in certo modo un altro che Gesù affronta subito: “Fu anche detto: Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto di ripudio; ma io vi dico . . .” e dichiara decaduta la concessione fatta dall’antica Legge al popolo di Israele “per la durezza del cuore” (cf. Mt 19, 8), proibendo anche questa forma di violazione della legge dell’amore in armonia con il ristabilimento della indissolubilità del matrimonio (cf. Mt 19, 9).
6. Con lo stesso procedimento Gesù contrappone all’antico divieto di spergiurare, quello di non giurare affatto (Mt 5, 33-38), e la ragione che emerge abbastanza chiaramente è ancora fondata nell’amore: non si deve essere increduli o diffidenti col prossimo, quando è abitualmente schietto e leale, e piuttosto occorre da una parte e dall’altra seguire questa legge fondamentale del parlare e dell’agire: “Il vostro linguaggio sia sì, se è sì; no, se è no. Il di più viene dal maligno” (Mt 5, 37).
7. E ancora: “Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al malvagio..” (Mt 5, 38-39), e con linguaggio metaforico Gesù insegna a porgere l’altra guancia, a cedere non solo la tunica ma anche il mantello, a non rispondere con violenza alle angherie altrui, e soprattutto: “Da’ a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle” (Mt 5, 42). Radicale esclusione della legge del taglione nella vita personale del discepolo di Gesù, qualunque sia il dovere della società di difendere i propri membri dai malfattori e di punire i colpevoli di violazione dei diritti dei cittadini e dello stesso Stato.
8. Ed ecco il perfezionamento definitivo, nel quale trovano il centro dinamico tutti gli altri: “Avete inteso che fu detto: Amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico; ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, affinché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti . . .” (Mt 5, 43-45). All’interpretazione volgare dell’antica Legge che identificava il prossimo con l’israelita e anzi col pio israelita, Gesù oppone l’interpretazione autentica del comandamento di Dio e vi aggiunge la dimensione religiosa del riferimento al Padre celeste clemente e misericordioso, che benefica tutti ed è quindi l’esemplare supremo dell’amore universale.
Conclude infatti Gesù: “Siate.. perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste” (Mt 5, 48). Egli chiede ai suoi seguaci la perfezione dell’amore. La nuova legge da lui portata ha la sua sintesi nell’amore. Quest’amore farà superare all’uomo nei suoi rapporti con gli altri la classica contrapposizione amico-nemico, e tenderà dall’interno dei cuori a tradursi in corrispondenti forme di solidarietà sociale e politica, anche istituzionalizzata. Sarà dunque molto ampia, nella storia l’irradiazione del “comandamento nuovo” di Gesù.
9. In questo momento ci preme soprattutto rilevare che nei brani importanti del “Discorso della montagna”, si ripete la contrapposizione: “Avete inteso che fu detto . . . Ma io vi dico”; e questo non per “abolire” la Legge divina dell’antica alleanza, ma per indicarne il “perfetto compimento”, secondo il senso inteso da Dio-Legislatore, che Gesù illumina di luce nuova e spiega in tutto il suo valore realizzativo di nuova vita e generatore di nuova storia: e lo fa attribuendosi un’autorità che è quella stessa del Dio-Legislatore. Si può dire che in quella sua espressione ripetuta sei volte: Io vi dico, risuona l’eco di quell’autodefinizione di Dio, che Gesù si è pure attribuita: “Io Sono” (cf. Gv 8, 58).
10. Deve infine essere ricordata la risposta che Gesù diede ai farisei, i quali rimproveravano ai suoi discepoli di strappare le spighe dai campi ricolmi di grano per mangiarle in giorno di sabato, violando così la legge mosaica. Gesù dapprima cita loro l’esempio di Davide e dei suoi compagni che non esitarono a mangiare i “pani dell’offerta” per sfamarsi, e quello dei sacerdoti che in giorno di sabato non osservano la legge del riposo perché svolgono le loro funzioni nel tempio. Poi conclude con due affermazioni perentorie, inaudite per i farisei: “Ora io vi dico che qui c’è qualcosa più grande del tempio . . .”, e: “Il Figlio dell’Uomo è signore anche del sabato” (Mt 12, 6.8; cf. Mc 2, 27-28). Sono dichiarazioni che rivelano chiaramente la coscienza che Gesù aveva della sua autorità divina. Il definirsi “uno al di sopra del tempio” era un’allusione abbastanza chiara alla sua divina trascendenza. Proclamarsi poi “signore del sabato”, ossia di una Legge data da Dio stesso a Israele, era l’aperta proclamazione della propria autorità come capo del regno messianico e promulgatore della nuova Legge. Non si trattava dunque di semplici deroghe alla legge mosaica, ammesse anche dai rabbini in casi molto ristretti, ma di una reintegrazione, di un completamento e di un rinnovamento che Gesù enuncia come intramontabili: “Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno” (Mt 24, 35). Ciò che viene da Dio è eterno, come è eterno Dio.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 14 ottobre 1987]
Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)
Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)
You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]
Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]
In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)
In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)
Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)
Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)
In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)
Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))
Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.