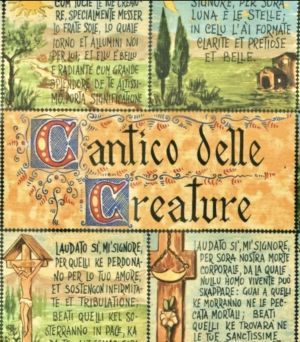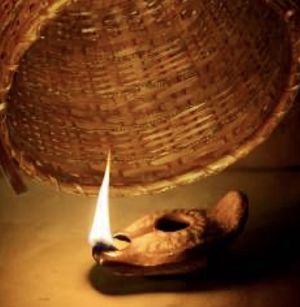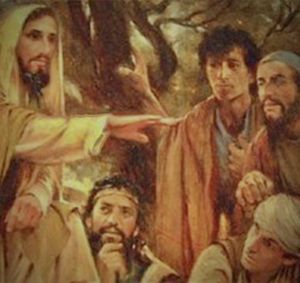Teresa Girolami
Teresa Girolami è laureata in Materie letterarie e Teologia. Ha pubblicato vari testi, fra cui: "Pellegrinaggio del cuore" (Ed. Piemme); "I Fiammiferi di Maria - La Madre di Dio in prosa e poesia"; "Tenerezza Scalza - Natura di donna"; co-autrice di "Dialogo e Solstizio".
Credere e Guarigioni. Grazia e Fede, felice binomio
La Liturgia ci dona il racconto della guarigione dell’emorroissa, una povera donna malata - e la rianimazione della figlia di Giairo, capo della sinagoga.
Il denominatore comune di questi episodi è la fiducia sincera che il Signore chiede e trova in alcune persone.
Animato da indomita Fede, Francesco divenuto Alter Christus ebbe dal Signore l’Energia Divina per la guarigione, testimoniando che Dio era in lui e con lui.
Già in vita compì molti prodigi: ad esempio, quello avvenuto a Nardi. Una donna riacquistò la vista nel momento in cui Francesco fece il segno della croce.
Oppure quello che ritrae Francesco in pena per un frate colpito da epilessia. Si recò da lui e, dopo averlo benedetto, lo guarì.
Nel processo di canonizzazione sono stati riconosciuti dalle Autorità più di 40 miracoli.
Ne riportiamo uno, tratto dalle Fonti e relativo a dopo la sua morte.
“Il figlioletto appena settenne d’un notaio di Roma, si era messo in testa, come usano i bambini, di seguire la mamma che stava andando alla chiesa di S. Marco.
Siccome la mamma lo aveva costretto a restare a casa, si buttò dalla finestra del palazzo […] La madre, vedendo che aveva improvvisamente perduto il figlio […] incominciò a straziarsi con le proprie mani […]
Ma un frate dell’Ordine dei Minori, di nome Rao, che si stava recando in quel luogo a predicare, si avvicinò al bambino e poi, pieno di fede, disse al padre:
«Credi tu che Francesco, il santo di Dio, può risuscitare dai morti tuo figlio, in forza di quell’amore che ha sempre avuto verso Gesù Cristo, morto in croce per ridare la vita agli uomini?».
Il padre rispose che lo credeva fermamente. Quel frate si prostrò in orazione con il frate suo compagno e incitò tutti i presenti a pregare.
Come fu terminata la preghiera, il bambino incominciò a sbadigliare un poco, aprì gli occhi e sollevò le braccia, finalmente si alzò da solo e subito, alla presenza di tutti, si mise a camminare, sano e salvo, restituito alla vita e, insieme, alla salvezza per la mirabile potenza del Santo” (FF 1266).
Preghiera di Francesco davanti al Crocifisso (FF 276).
«Altissimo glorioso Dio,
illumina le tenebre de lo core mio.
Et dame fede dricta
speranza certa e carità perfecta,
senno e cognoscemento,
Signore,
che faccia lo tuo santo e verace comandamento.
Amen».
Martedì 4.a sett. T.O. (Mc 5,21-43)
Gesù Luce e Specchio: in Lui i suoi intimi
Il passo di Lc narra della Presentazione di Gesù al Tempio - quale Luce autentica delle nazioni e salvezza dei popoli, rivelata alle moltitudini.
Raccontano le Fonti che Francesco aveva, fra l’altro, uno straordinario riguardo per le lucerne, lampade e candele, e non voleva mai spegnerne di sua mano lo splendore, perché simbolo della Luce eterna.
Parimenti Chiara, in una lettera alla Beata Agnese da Praga:
«E poiché questa visione di Lui è splendore dell’eterna gloria, chiarore della luce perenne e specchio senza macchia, ogni giorno porta l’anima tua, o regina, sposa di Gesù Cristo, in questo specchio e scruta in esso continuamente il tuo volto […]» (FF 2902).
Il Santo, uomo fatto preghiera, sempre riceveva dallo Spirito del Signore che lo guidava, tutta la luce necessaria per essere scrutatore di coscienze, smantellatore di pseudo verità.
Infatti, l’episodio che riprendiamo sempre dalle Fonti, lo attesta:
“C’era un frate, a giudicare dal di fuori più che santo.
I confratelli parlarono a lungo di lui a Francesco, che era di passaggio.
Ma il Poverello rispose così alle loro lodi:
«Smettetela, fratelli, di lodarmi in costui le finzioni del diavolo. Sappiate che si tratta di tentazione diabolica e d’inganno fraudolento».
Male accolsero i frati questa risposta: secondo loro era impossibile che la falsità e la frode potessero imbellettarsi sotto tanti indizi di perfezione.
Ma, di lì a non molti giorni, quando quel tale se ne andò dall’Ordine, fu ben chiaro a tutti che l’uomo di Dio aveva letto, col suo sguardo luminoso, nell’intimo segreto di quel cuore.
Era questo il modo in cui egli prevedeva infallibilmente anche la caduta di tanti, che sembravano star dritti; come pure la conversione a Cristo di molti peccatori.
Perciò sembrava che egli contemplasse ormai da vicino lo specchio della luce eterna, nel cui mirabile splendore l’occhio del suo spirito poteva vedere le cose fisicamente lontane come se fossero presenti" (FF 1198).
Francesco aveva incontrato la Luce nella sua esistenza, ne era stato compenetrato al punto da divenire, in Cristo, lui stesso "segno" per molti.
«Ecco, questi è posto a rovina e risurrezione di molti in Israele e a segno contraddetto […] affinché siano rivelati da molti cuori i pensieri» (Lc 2,34-35)
2 febbraio, Presentazione del Signore (Lc 2,22-40)
Presentazione al Tempio: Festa della Luce
Beati perché ricchi del Regno
In questa domenica la liturgia propone lo splendido brano delle Beatitudini di Matteo.
Il passo inizia con quella della povertà in spirito e conclude con la beatitudine dei perseguitati, di quanti cioè vogliono vivere il Vangelo e l’amore sino in fondo.
Per Francesco e Chiara d’Assisi l’umiltà del cuore, la povertà interiore ed esteriore costituiva la chiave di volta di tutte le altre beatitudini, identikit di Gesù e di ogni discepolo che vuole camminare sulle sue orme.
Incantevole è un passo del «Sacrum Commercium» (operetta allegorica di autore ignoto) contenuto nelle Fonti e che qui riportiamo, a riguardo della povertà.
«Così, innamorato della tua bellezza, il Figlio dell’Altissimo Padre a te sola si unì strettamente nel mondo e ti conobbe per prova fedelissima in ogni cosa.
Prima ancora che dallo splendore della sua patria Egli venisse sulla terra, tu gli preparasti un’abitazione degna, un trono su cui assidersi e un talamo dove riposare, cioè la Vergine poverissima, dalla quale Egli nacque a risplendere su questo mondo.
A lui appena nato con sollecitudine corresti incontro, perché egli trovasse in te, e non nelle mollezze, un posto che gli fosse gradito.
Fu deposto, dice l’evangelista, in una mangiatoia, perché non c’era posto per lui nell’albergo.
Allo stesso modo, senza mai separarti da lui, l’hai sempre accompagnato, tanto che in tutta la sua vita, quando apparve sulla terra e visse fra gli uomini, mentre le volpi avevano le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, egli però non aveva dove posare il capo.
E in seguito quando egli, che un tempo aveva dischiuso la bocca dei profeti, aprì la sua bocca per insegnare, te per prima volle lodare, te per prima esaltò con le parole: Beati i poveri in ispirito, perché di essi è il Regno dei cieli» (FF 1977).
Francesco poi, nelle sue Ammonizioni, fra l’altro esalta il cuore puro, appunto povero, quando dice:
«Beati i puri di cuore, poiché essi vedranno Dio. Veramente puri di cuore sono coloro che disdegnano le cose terrene e cercano le cose celesti, e non cessano mai di adorare e vedere il Signore Dio, vivo e vero, con cuore e animo puro» (FF 165).
Gli fa eco Chiara, nel suo Testamento:
«Se vivremo secondo la predetta forma di vita, lasceremo alle altre un nobile esempio e, attraverso una fatica di brevissima durata, ci guadagneremo il palio della beatitudine eterna» (FF 2830).
«Beati i poveri per lo Spirito poiché di essi è il Regno dei cieli» (Mt 5,3)
4.a domenica T.O. A (Mt 5,12a)
«Chi è costui?»
In questo brano del Vangelo di Marco viene narrato l’episodio della tempesta sedata dal Signore della storia e della gloria.
Gesù comanda ai venti e dice al mare: «Taci, sta’ zitto!» (Mc 4,39) e, dinanzi alla paura dei suoi, chiama in causa la loro fede.
Francesco, Araldo del Vangelo, dopo pochi anni dalla sua conversione, guidato dallo Spirito che spinge la vela dell’esistenza umana, desiderava morire per Cristo nell’annuncio della Parola, oltremare.
L’incontro con Gesù lo avevo reso coraggioso e tenace, tanto da esortare i suoi stessi frati ad abbandonare ogni timore navigando nei marosi del mondo.
Interessante è fermarsi a meditare su un brano riportato dalle Fonti e che ritrae Francesco nell’esperienza dei venti contrari.
"A sei anni dalla sua conversione, infiammato dal desiderio del martirio, decise di passare il mare e recarsi nelle parti della Siria, per predicare la fede cristiana e la penitenza ai saraceni e agli altri infedeli.
Ma la nave su cui si era imbarcato, per raggiungere quel paese, fu costretto dai venti contrari a sbarcare dalle parti della Schiavonia.
Vi rimase per qualche tempo; ma poi, non riuscendo a trovare una nave che andasse nei paesi d’oltremare, defraudato nel suo desiderio, pregò alcuni marinai, diretti ad Ancona, di prenderlo con sé, per amore di Dio. Ne ebbe un netto rifiuto, perché non aveva il denaro necessario.
Allora l’uomo di Dio, riponendo tutta la sua fiducia nella bontà del Signore, salì ugualmente, di nascosto, sulla nave, col suo compagno.
Si presentò un tale - certo mandato da Dio in soccorso del suo poverello - portando con sé il vitto necessario.
Chiamò uno dei marinai, che aveva timor di Dio, e gli parlò così: «Tutta questa roba tienila per i poveri frati che sono nascosti sulla nave: gliela darai quando ne avranno bisogno».
Se non che, capitò che, per la violenza, i marinai, per moltissimi giorni, non poterono sbarcare e così consumarono tutte le provviste.
Era rimasto solo il cibo offerto in elemosina, dall’alto, a Francesco poverello.
Era molto scarso, in verità; ma la potenza divina lo moltiplicò in modo tale che bastò per soddisfare pienamente le necessità di tutti, per tutti quei giorni di tempesta, finché poterono raggiungere il porto di Ancona.
I marinai, vedendo che erano scampati molte volte alla morte, per i meriti del servo di Dio, resero grazie a Dio onnipotente, che si mostra sempre mirabile e amabile nei suoi amici e nei suoi servi.
Ben a ragione, perché avevano provato da vicino gli spaventosi pericoli del mare e avevano visto le ammirabili opere di Dio nelle acque profonde" (FF 1170).
Leggiamo ancora del Poverello:
"Lasciato il mare, incominciò a pellegrinare sulla terra spargendovi il seme della salvezza e raccogliendo una messe abbondante di buoni frutti" (FF 1171).
“Confortandosi nel Signore, pregava fiducioso e ripeteva cantando quella parola del profeta: infatti anche se dovessi camminare in mezzo all’ombra di morte, non temerò alcun male, perché tu sei con me" (FF 1172).
La sua fede nel Cristo gli faceva superare ogni timore, dormendo a poppa delle situazioni incresciose, sapendo in Chi aveva posto ogni speranza.
«Perché siete paurosi? Non avete ancora Fede?»
Sabato 3.a sett.T.O. (Mc 4,35-41)
Beatitudine dei poveri e derelitti, per lo Spirito: Letizia Francescana
Granelli di senapa e crescita esponenziale
Gesù narra parabole sul Regno di Dio, prendendo lo spunto dagli elementi della natura: seme, spiga, granello di senape e altro.
Con agganci naturali e reali spiega la fisionomia del Regno.
Francesco e Chiara d’Assisi sono stati due granelli di senapa che crescendo nell’umiltà e nascondimento sono divenuti alberi talmente grandi che sui loro rami hanno trovato riparo molteplici creature.
Nello specifico, di Chiara così parla la Bolla papale di canonizzazione ‘Clara Claris praeclara’:
«Questo fu l’albero alto, proteso verso il cielo, dai rami dilatati, che nel campo della Chiesa produsse soavi frutti […] e alla cui ombra piacevole e amena molte seguaci accorsero da ogni parte, e tuttora accorrono per gustarne i frutti» (FF 3294).
Il Regno di Dio trova sviluppo in queste singolari metafore di cui il Povero d’Assisi e Chiara reclusa sono testimonianze plastiche e concrete.
Ma pure Francesco, come Gesù, parlava ai suoi frati in parabole. Le Fonti lo attestano in vari passi.
Quando voleva far intendere loro il cammino che li attendeva per accogliere il Regno di Dio, richiamava alla mente varie parabole, attraversate dal tessuto evangelico.
Ne ricordiamo una fra le tante, con le quali annunciava la Parola che il Signore gli affidava.
Presentandosi al Papa Gesù gli aveva fatto comprendere come doveva esprimersi.
"Egli, infatti, raccontò al Pontefice come Dio gliel’aveva suggerita, la parabola di un ricco re che con gran gioia aveva sposato una donna bella e povera e ne aveva avuto dei figli che avevano la stessa fisionomia del re, loro padre e che, perciò, vennero allevati alla mensa stessa del re.
Diede, poi, l’interpretazione della parabola, giungendo a questa conclusione:
«Non c’è da temere che muoiano di fame i figli ed eredi dell’eterno Re; perché essi, a somiglianza di Cristo, sono nati da una madre povera, per virtù dello Spirito Santo e sono stati generati, per virtù dello spirito di povertà, in una religione poverella.
Se, infatti, il Re del cielo promette ai suoi imitatori il Regno eterno, quanto più provvederà per loro quelle cose che elargisce senza distinzione ai buoni e ai cattivi».
Il Vicario di Cristo ascoltò attentamente questa parabola e la sua interpretazione e, pieno di meraviglia, riconobbe senza ombra di dubbio che, in quell’uomo, aveva parlato Cristo.
Ma si sentì rassicurato anche da una visione, da lui avuta in quella circostanza, nella quale lo Spirito di Dio gli aveva mostrato la missione a cui Francesco era destinato.
Infatti, come egli raccontò, in sogno vedeva che la Basilica del Laterano ormai stava per rovinare e che, un uomo poverello, piccolo e di aspetto spregevole, la sosteneva, mettendoci sotto le spalle, perché non cadesse.
«Veramente - concluse il Pontefice - questi è colui che con la sua opera e la sua dottrina sosterrà la Chiesa di Cristo» (FF1064).
"Contando sulla grazia divina e sull’autorità papale, Francesco, pieno di fiducia, si diresse verso la valle Spoletana, pronto a praticare e insegnare il Vangelo" (FF 1065).
Anche queste parabole sono la narrazione dell’avvento del Regno di Dio, la sua espansione nel chicco di senapa di Francesco e di Chiara, e i loro incredibili sviluppi.
«E diceva: Come paragoneremo il Regno di Dio? O in quale parabola lo metteremo? Come a un granello di senapa che quando è seminato sulla terra è più piccolo di tutti i semi sulla terra» (Mc 4,30-31)
Venerdì 3.a sett.T.O. (Mc 4,26-34)
Lampada sotto al moggio?
Premesso che Francesco considerava i predicatori della Parola «lampada del mondo» e che lo Spirito di Dio lo rendeva tale, meraviglioso è quanto leggiamo nelle Fonti, raccolta esimia delle realtà francescane.
“Irradiato dagli splendori della luce eterna, scrutava le profondità delle Scritture con intelletto limpido e acuto.
Il suo ingegno, puro da ogni macchia, penetrava il segreto dei misteri, e dove la scienza dei maestri resta esclusa, egli entrava con l’affetto dell’amante.
Leggeva, di tanto in tanto, i libri sacri e riteneva tenacemente impresso nella memoria quanto aveva una volta assimilato: giacché ruminava continuamente con affettuosa devozione ciò che aveva ascoltato con mente attenta” (FF 1187).
Allo stesso modo Chiara, serafica pianticella, viene riconosciuta nella
Leggenda come colei in cui “Dio misericordioso […] fece splendere alle donne una chiarissima lampada: e tu, Padre beatissimo*, ascrivendola al novero dei Santi, spinto dalla forza e dall’evidenza dei miracoli, hai posto questa lampada sul candelabro, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa” (FF 3151).
“Dunque Chiara, mentre era in vita, rifulgeva per la luce dei suoi meriti: e ora, che é inabissata nella chiarità senza fine, non di meno risplende tuttora, per la meravigliosa luce dei miracoli, fino alle estremità della terra” (FF 3262).
Era un miracolo vederla (quando viveva fra le mura damianite che trasudavano santità):
"[…] per Mattutino, prevenire le giovinette e, svegliandole senza rumore con cenni, le invitava alle lodi di Dio. Spesso, mentre tutte dormivano ancora, accendeva le lampade, spesso suonava lei stessa, con le sue mani la campana" (FF 3200).
“Certamente, nella sua dolcezza, Dio aveva dato convito alla poverella e, dopo averle inondato l’animo nell’orazione con la sua Luce eterna, lo manifestava al di fuori sensibilmente” (FF 3199).
«Viene forse la lucerna perché sia messa sotto il moggio o sotto il letto?» (Mc 4,21)
- La canonizzazione di S. Chiara avvenne ad Anagni per opera di Papa Alessandro IV in una data imprecisata, che oscilla tra l’agosto, il 26 settembre e il 19 ottobre 1255.
Giovedì 3.a sett.T.O. (Mc 4,21-25)
Seminatore e Terreno
Nella Parabola del Seminatore Gesù evidenzia la diversa ricezione ed assimilazione della Parola di Dio e di conseguenza il diverso frutto, a seconda della rispondenza del terreno.
Il nuovo Evangelista di questo ultimo tempo, Francesco, era innamorato della Parola di Dio e il suo ascolto era costante, tanto da averla impressa nella sua memoria.
Era terreno buono che produceva il cento per uno.
Le Fonti c’informano:
”Irradiato dagli splendori della Luce eterna, scrutava le profondità delle Scritture con intelletto limpido e acuto.
Il suo ingegno, puro da ogni macchia, penetrava il segreto dei misteri […]
Leggeva di tanto in tanto i libri sacri e riteneva tenacemente impresso nella memoria quanto aveva una volta assimilato: giacché ruminava continuamente con affettuosa devozione ciò che aveva ascoltato con mente attenta” (FF 1188).
“Con altrettanta cura e devozione si impegnava a compiere gli altri insegnamenti uditi.
Egli infatti non era mai stato ascoltatore sordo del Vangelo, ma, affidando ad una encomiabile memoria tutto quello che ascoltava, cercava con ogni diligenza di eseguirlo alla lettera” (FF 357).
Come lo chiama il Celano, nella Vita prima - «fiume di Paradiso» - Francesco, “il nuovo evangelista di questo ultimo tempo ha diffuso con amorosa cura le acque del Vangelo per il mondo intero, e con le opere ha additato la via e la vera dottrina del Figlio di Dio” (FF 475).
Nella Regola non bollata (1221):
«Manteniamoci dunque Fedeli alle parole, alla vita, alla dottrina e al Santo Vangelo di Colui che si è degnato di pregare per noi il Padre» (FF 62).
E «guardiamoci bene dall’essere la terra lungo la strada, o la terra sassosa, o quella invasa dalle spine secondo quanto dice il Signore nel Vangelo:
«Il seme è la Parola di Dio […] il seme affidato alla terra buona, sono coloro che, ascoltando la parola con buone, anzi ottime disposizioni, la intendono e la custodiscono e portano frutti con la perseveranza»” (FF 58).
Il Poverello fu, per il suo tempo, incarnazione concreta e fruttuosa del Vangelo.
«E altri semi caddero sulla terra buona e davano frutto salendo e crescendo e portavano uno trenta e uno sessanta e uno cento» (Mc 4,8)
Mercoledì 3.a sett. T.O. (Mc 4,1-20)
La volontà di Dio, spartiacque della parentela spirituale
Con un colpo di mano stupefacente, Gesù spiega chi sono sua madre e i suoi fratelli: quanti incarnano la volontà di Dio.
Dopo la conversione, Francesco e Chiara cercarono sempre la volontà di Dio guardando a Maria, la serva del Signore, colei che aveva trovato favore presso l’Onnipotente, divenendo la Madre di Gesù.
Francesco, fin dagli inizi della sua vocazione-missione rivolse alla Vergine speciale e devota attenzione.
Le Fonti ci mettono al corrente dello straordinario amore per Lei, sintetizzato da un’antifona ieratica del Poverello:
«Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te, nata nel mondo, tra le donne, figlia e ancella dell’altissimo sommo Re il Padre celeste, madre del santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo; prega per noi con san Michele arcangelo e con tutte le potenze dei cieli e con tutti i santi, presso il tuo santissimo diletto Figlio, Signore e maestro» (FF 281).
Francesco "Circondava di un amore indicibile la Madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello il Signore della maestà" (FF 786).
Ma Chiara stessa, considerata ‘altera Maria’, quando giunse alla Porziuncola, dove Francesco con i frati l’aspettavano per la sua totale dedizione a Dio:
"Dopo che ebbe prese le insegne della santa penitenza davanti all’altare di Santa Maria e, quasi davanti al talamo nuziale della Vergine, l’umile ancella si fu sposata a Cristo, subito San Francesco la condusse alla chiesa di San Paolo*, con l’intenzione che rimanesse in quel luogo finché la Volontà dell’Altissimo non disponesse diversamente" (FF 3172).
Come Maria, Chiara pronunciò il suo "Fiat" alla volontà del Padre.
Oh quanto hanno amato la volontà di Dio entrambe!
Dimentiche di sé hanno aderito al progetto divino su di loro, ognuna nel suo tempo, ognuna nel suo solco.
Nelle Fonti ancora:
«A quel modo, dunque, che la gloriosa Vergine delle vergini portò Cristo materialmente nel suo grembo, tu pure, seguendo le sue vestigia, specialmente dell’umiltà e povertà di lui, puoi sempre, senza alcun dubbio, portarlo spiritualmente nel tuo corpo casto e verginale.
E conterrai in te Colui dal quale tu e tutte le creature sono contenute, e possederai ciò che è bene più duraturo e definitivo anche a paragone di tutti gli altri possessi transeunti di questo mondo» (FF 2893 - Lettera terza alla Beata Agnese di Praga).
Francesco e Chiara, sull’esempio dell’umile Maria di Nazareth, hanno amato la volontà di Dio su di loro in modo solare e duraturo.
Infatti, in una preghiera conclusiva di Francesco, contempliamo il suo costante anelito a ricercarla e assecondarla con abbandono.
«Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi miseri di fare, per la forza del tuo amore, ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, interiormente purificati, interiormente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo seguire le orme del tuo Figlio diletto, il Signore nostro Gesù Cristo, e, con l’aiuto della tua sola grazia, giungere a te, o Altissimo, che nella Trinità perfetta e nella Unità semplice vivi e regni glorioso, Dio onnipotente per tutti i secoli dei secoli. Amen» (FF 234 - Lettera a tutto l’Ordine).
«E rispondendo dice loro: Chi è mia madre e i fratelli? […] Chi fa la volontà di Dio, questi è mio fratello e sorella e madre» (Mc 3,33.35)
*La chiesa e il monastero benedettino di San Paolo delle Abbadesse, dove Chiara viene condotta dopo la sua consacrazione in Porziuncola, sorgevano nei pressi di Bastìa Umbra, a 4 km da Assisi.
Martedì 3.a sett. T.O. (Mc 3,31-35)
Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)
Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)
You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]
Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]
In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)
In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)
Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)
Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)
In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)
Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))
Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.