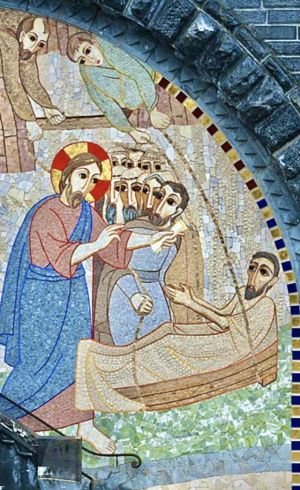don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Nel Vangelo di questa seconda domenica di Avvento risuona l’invito di Giovanni Battista: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!» (Mt 3,2). Con queste stesse parole Gesù darà inizio alla sua missione in Galilea (cfr Mt 4,17); e tale sarà anche l’annuncio che dovranno portare i discepoli nella loro prima esperienza missionaria (cfr Mt 10,7). L’evangelista Matteo vuole così presentare Giovanni come colui che prepara la strada al Cristo che viene, e i discepoli come i continuatori della predicazione di Gesù. Si tratta dello stesso gioioso annuncio: viene il regno di Dio, anzi, è vicino, è in mezzo a noi! Questa parola è molto importante: “Il regno di Dio è in mezzo a voi”, dice Gesù. E Giovanni annuncia quello che Gesù dopo dirà: “Il regno di Dio è venuto, è arrivato, è in mezzo a voi”. Questo è il messaggio centrale di ogni missione cristiana. Quando un missionario va, un cristiano va ad annunciare Gesù, non va a fare proselitismo, come se fosse un tifoso che cerca per la sua squadra più aderenti. No, va semplicemente ad annunciare: “Il regno di Dio è in mezzo a voi!”. E così il missionario prepara la strada a Gesù, che incontra il suo popolo.
Ma che cos’è questo regno di Dio, questo regno dei cieli? Sono sinonimi. Noi pensiamo subito a qualcosa che riguarda l’aldilà: la vita eterna. Certo, questo è vero, il regno di Dio si estenderà senza fine oltre la vita terrena, ma la bella notizia che Gesù ci porta – e che Giovanni anticipa – è che il regno di Dio non dobbiamo attenderlo nel futuro: si è avvicinato, in qualche modo è già presente e possiamo sperimentarne fin da ora la potenza spirituale. “Il regno di Dio è in mezzo a voi!”, dirà Gesù. Dio viene a stabilire la sua signoria nella nostra storia, nell’oggi di ogni giorno, nella nostra vita; e là dove essa viene accolta con fede e umiltà germogliano l’amore, la gioia e la pace.
La condizione per entrare a far parte di questo regno è compiere un cambiamento nella nostra vita, cioè convertirci, convertirci ogni giorno, un passo avanti ogni giorno… Si tratta di lasciare le strade, comode ma fuorvianti, degli idoli di questo mondo: il successo a tutti i costi, il potere a scapito dei più deboli, la sete di ricchezze, il piacere a qualsiasi prezzo. E di aprire invece la strada al Signore che viene: Egli non toglie la nostra libertà, ma ci dona la vera felicità. Con la nascita di Gesù a Betlemme, è Dio stesso che prende dimora in mezzo a noi per liberarci dall’egoismo, dal peccato e dalla corruzione, da questi atteggiamenti che sono del diavolo: cercare il successo a tutti i costi; cercare il potere a scapito dei più deboli; avere la sete di ricchezze e cercare il piacere a qualsiasi prezzo.
Il Natale è un giorno di grande gioia anche esteriore, ma è soprattutto un avvenimento religioso per cui è necessaria una preparazione spirituale. In questo tempo di Avvento, lasciamoci guidare dall’esortazione del Battista: «Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!», ci dice (v. 3). Noi prepariamo la via del Signore e raddrizziamo i suoi sentieri, quando esaminiamo la nostra coscienza, quando scrutiamo i nostri atteggiamenti, per cacciare via questi atteggiamenti peccaminosi che ho menzionato, che non sono da Dio: il successo a tutti i costi; il potere a scapito dei più deboli; la sete di ricchezze; il piacere a qualsiasi prezzo.
Ci aiuti la Vergine Maria a prepararci all’incontro con questo Amore-sempre-più-grande, che è quello che porta Gesù, e che nella notte di Natale si è fatto piccolo piccolo, come un seme caduto nella terra. E Gesù è questo seme: il seme del Regno di Dio.
[Papa Francesco, Angelus 4 dicembre 2016]
OSSESSIONE E COMPULSIONE - (di Francesco Giovannozzi, psicologo e psicoterapeuta)
Ossessione e Compulsione
Un signore mi confida che da tempo ha bisogno di controllare se ha chiuso il portone della sua casa. Una signora invece deve essere certa che ha chiuso il gas in cucina.
Dopo aver controllato, sia il gas che il portone stavano bene e in ordine.
Un altro signore di mezza età sente il bisogno di dover vedere se la sua auto è a posto, poi deve andare a controllarla, deve fare un giro intorno alla stessa, toccarla in diversi punti, e solo dopo aver compiuto queste sequenze comportamentali, può rientrare tranquillamente. A volte sente il bisogno di farlo più volte in una giornata.
Nel vocabolario Treccani al termine «ossessione» si legge: «rappresentazione mentale che la volontà non riesce ad eliminare accompagnata da ansia».
Alla voce «compulsione»: «costrizione, l’essere spinto da necessità a fare qualcosa».
Molte persone hanno dei pensieri verso i quali non hanno alcun interesse; spesso sono delle idee senza alcun senso, ma che richiedono loro un notevole sforzo mentale.
Senza volerlo queste idee ci invadono, e fanno “lambiccare” il cervello come se fossero questioni fondamentali.
Possono trattarsi di pensieri, immagini che generano preoccupazione - e di solito vengono seguiti da costrizioni che la persona deve compiere per calmare l’inquietudine.
Tra l’idea ”fissa” e il bisogno di compiere qualche atto, gesto per far sì che non succeda nulla di male, insorge spesso un dubbio, che intacca le nostre convinzioni più certe .
Il tutto sfocia in una indecisione sempre più grande che limita la propria libertà di azione: per fare una scelta anche semplice si impiega tanto tempo.
A volte ci fa giungere a non saper prendere una decisione. Il dubbio può riguardare un pensiero, un ricordo, un’azione, ecc. e può sconfinare da un contenuto all’altro.
Una persona con questi problemi, uscendo di casa a volte si sente costretta a tornarci per essere certa di non aver lasciato la luce accesa, e per essere sicura a volte lo deve fare parecchie volte.
In letteratura vengono citati esempi di persone che nello spedire una lettera sentivano poi il bisogno di riaprirla per controllare ciò che avevano scritto.
In quadri psicologici come questo si parla anche di «ruminazione», che è sempre associato al dubbio.
In campo biologico essa si configura quale processo digestivo di alcuni animali, tipo i bovini. Il cibo ingerito viene riportato in bocca per essere masticato nuovamente, in maniera migliore; quindi inghiottito di nuovo per ultimare la digestione.
In campo psicologico la «ruminazione» descrive un pensiero ripetitivo e durevole focalizzato su eventi passati, diverso dal «rimuginio» che invece riguarda più gli eventi futuri.
Vengono descritti anche dei cerimoniali. In essi l’individuo deve fare una sequenza di atti come lavarsi sovente le mani, pulire tante volte oggetti della vita quotidiana.
Interviene qui un aspetto del quadro psicologico descritto: la «rupofobia» e contaminazione. La rupofobia è la paura morbosa dello sporco e di poter essere infettati. Può riguardare qualsiasi aspetto della nostra vita: sia oggetti che persone, o luoghi pubblici. È un aspetto che può nuocere anche all’intimità.
Il periodo del Covid ha aumentato la paura del contagio, ma questo era un evento reale. Anche tanti anni fa intorno agli anni 1986 ci fu il fenomeno di Chernobyl e lì veramente dovevamo essere attenti a ciò che si mangiava poiché il cibo e soprattutto le verdure potevano essere state contaminate.
Chiunque ha queste idee, passeggiando potrà contare le auto nel parcheggio, o toccare i pali dei lampioni, oppure cercare di evitare le fenditure dei pavimenti, ecc.
Nei casi gravi queste persone possono sentire di far del male a qualcuno; così questi pensieri lo fanno “indietreggiare”. Costoro devono darsi uno “scossone” onde cercare di scacciare tali idee che terrorizzano.
Le persone con queste caratteristiche generalmente sono delle persone rigorose, si preoccupano dei particolari, osservano minuziosamente regole e formalità.
Tuttavia dando importanza ai dettagli, spesso trascurano l’essenziale.
Quanta gente nel loro ambito lavorativo sente il bisogno di mettere in fila e in eccessivo ordine i loro oggetti.
Ordine e controllo sono strettamente interconnessi, perché l’ordine esterno può essere una modalità per raggiungere un ordine interno che può ridurre lo stress.
Parliamo però di ordine eccessivo. Un minimo di ordine è necessario per non creare confusione e poter ritrovare le nostre cose
Anche la balbuzie è un’alterazione del linguaggio collegata a questo quadro psicologico.
La persona che balbetta si impegna all’inizio, alla prima lettera o sillaba, e la ripete finché non finisce la parola.
Come si sa, il suo linguaggio è sciolto quando è solo o quando recita, quando canta.
Altrimenti mortificato dal suo difetto tenderà a isolarsi e a parlare il meno possibile. Oppure insisterà ostinatamente a parlare con intensi sforzi fisici.
La balbuzie «è un conflitto tra la tendenza erotico uretrale all’espulsione e la tendenza erotico-anale alla ritenzione, spostata alla bocca» (Manuale di Psichiatria, Arieti, vol. I pag.353).
Dott. Francesco Giovannozzi, Psicologo-Psicoterapeuta.
Preghiera-presentimento, unitiva. Per non perdere la magia del Mistero
Gratuitamente: il Regno vicino e la Preghiera Incarnata
(Mt 9,35-10,1.6-8)
Gesù si distingue dai Rabbi del suo tempo, perché non attende che sia la gente spossata e prostrata (v.36) ad andare da lui: la cerca.
E il gruppo dei suoi dev’essere partecipe, sia nelle opere di guarigione che di liberazione - fraternità motivata da disinteresse luminoso.
Il Signore entra nelle assemblee di preghiera con ansia pastorale: per insegnare, non per disquisire. Non fa lezioni di analisi logica, ma lascia emergere Chi lo abita.
Proclama un Regno totalmente diverso da come veniva inculcato dai manipolatori delle coscienze - stracolmo di convinzioni dettagliate, che producevano intima coercizione, anonimato, solitudine, passività.
Ancora oggi cerchiamo un Dio da sperimentare, amabile, ‘non invisibile’.
Così l’Evangelo (v.35) annuncia Grazia: il volto del Padre - che non vuole nulla per sé, bensì dona tutto per trasmetterci la sua stessa Vita.
Un Amico che Viene, che non costringe a “salire” [in astratto] né imprigiona dentro sensi di colpa, sfiancando le creature già sottomesse - rendendole ancor più desolate di prima.
Qui si rivela un Cielo che fa sentire adeguati, non castiga né impressiona, bensì promuove e mette a proprio agio.
Il Padre prodigo accoglie le persone come fa il Figlio nei Vangeli - così come sono; non indagando. Piuttosto dilatando.
La sua Parola-evento non solo riattiva: reintegra gli squilibri e li valorizza in prospettiva di percorsi da persona reale - senza giudicare o disperdere, né spezzare nulla.
Per una tale opera di sapiente ricomposizione dell’essere, il Maestro invita alla Preghiera (v.38) - prima forma d’impegno dei discepoli.
L’accesso a diverse sintonie nello Spirito c’insegna a stimolare lo sguardo dell’anima, a valorizzare e capire tutto e tutti.
Quindi - dopo averli resi meno ignari - Gesù invita i suoi a coinvolgersi nell’opera missionaria; non a fare i dotti o lezioni di morale.
Sarebbero sceneggiate senza premure, che fanno sentire i malfermi ancor più sperduti.
La Missione cresce a partire da una dimensione piccola ma sconfinata - quella della percezione intima, che si accorge delle necessità e del mistero d’una Presenza favorevole.
Nuove configurazioni d’intesa, in spirito: scoperte appieno solo nell’orazione profonda (v.38). Preghiera Incarnata.
Essa non vuole distoglierci dalla realizzazione interiore; al contrario, fa da guida, e ricolloca l’anima dispersa nelle tante pratiche comuni da svolgere, al proprio centro.
Ci fa provare lo struggimento del desiderio e del capire la condizione perfetta: il Padre non intende assorbire le nostre attitudini, bensì potenziarle. Perché ciascuno ha un intimo progetto, una Chiamata per Nome, un proprio posto nel mondo.
Sembra paradossale, ma la Chiesa in uscita è anzitutto un problema di formazione e coscienza interna.
Insomma, ci si riconosce e si diventa non ignari delle cose attraverso la Preghiera-presentimento, unitiva.
In Cristo essa non è prestazione o espressione devota, bensì intesa e anzitutto Ascolto del Dio che in mille forme sottili si rivela e chiama.
Così la lotta contro le infermità (Mt 9,35-10,1): ci si ristabilisce e si vince acuendo lo sguardo e reinvestendo l’energia e il carattere anche dei nostri stessi lati ancora offuscati.
Tutto il Gratis (Mt 10,8) che potrà scaturirne per edificare la vita in favore dei fratelli, sprizzerà non come puerile contraccambio.
Il senso di prossimità (v.7) a se stessi, agli altri e alla realtà sarà un portato autentico - non programmatico, né alienato - del Regno che si rivela: Accanto.
[Sabato 1.a sett. Avvento, 6 dicembre 2025]
Preghiera-presentimento, unitiva. Per non perdere la magia del Mistero
Gratuitamente: il Regno vicino e la Preghiera Incarnata
(Mt 9,35-10,1.6-8)
Gesù si distingue dai Rabbi del suo tempo, perché non attende che sia la gente spossata e prostrata (v.36) ad andare da lui: la cerca.
E il gruppo dei suoi dev’essere partecipe, sia nelle opere di guarigione che di liberazione - fraternità motivata da disinteresse luminoso.
Entra nelle assemblee di preghiera con ansia pastorale: per insegnare, non per disquisire. Non fa lezioni di analisi logica, ma lascia emergere Chi lo abita.
Proclama un Regno totalmente diverso da come veniva inculcato dai manipolatori delle coscienze (stracolmo di convinzioni dettagliate) - i quali non esercitavano certo in modo gratuito.
Le dottrine antiche e i suoi protagonisti smorzavano ogni dissonanza e producevano il peggio: intima coercizione, anonimato, solitudine, passività.
Inculcavano che fosse decisivo acquisire le loro piatte sicurezze, non certo aprirsi al Mistero personale, al carattere innato - fecondamente non conforme al contesto.
Di fatto, cercavano di disturbare i viaggi dell’anima, che talora vaga per ritrovarsi, e che al solito modo di vedere - paludoso, stagnante - preferisce nuovi scorci.
Non ammettevano che in ciascun fedele potesse dimorare una opzione fondamentale non omologata alla loro ideologia e maniera di scendere in campo.
Tutto della vita altrui doveva funzionare alla perfezione, secondo i loro obbiettivi. Quindi non predicavano turbamenti, ma staticità.
Nulla di nuovo doveva capitare, che potesse mettere in dubbio gli equilibri sociali, il loro influsso autoritario… e i loro proventi.
Nulla di diverso doveva esserci da esplorare e trovare.
Eppure, ieri come oggi, dentro ciascuna donna e uomo risiede un vulcano di energie potenziali - le quali secondo l’ideologia dominante dovevano solo essere soffocate e allineate.
Per tutto questo che ancora si trascina cerchiamo viceversa un Dio da sperimentare, amabile, non costruito “ad arte”… né invisibile o lontano dalla nostra condizione.
Vogliamo Colui che doni respiro, e ci comprenda.
Lo si coglie nitidamente: ciò che coviamo non è una misera illusione, da spegnere in favore di equilibri esterni.
Infatti l’Evangelo (v.35) annuncia Grazia: il volto del Padre - che non vuole nulla per sé, bensì dona tutto per trasmetterci la sua stessa Vita. E lo fa non per mortificare la nostra intima energia.
La Lieta Novella proclama un Amico che Viene, che non costringe a “salire” [in astratto] né imprigiona dentro sensi di colpa, sfiancando le creature già sottomesse - rendendole ancor più desolate di prima.
Qui si rivela un Cielo che fa sentire adeguati, non castiga e neppure impressiona, bensì promuove e mette tutti a proprio agio; un Misericordioso non solo buono: esclusivamente buono.
Il Padre prodigo accoglie le persone come fa il Figlio nei Vangeli - così come sono; non indagando. Piuttosto dilatando.
Anche la sua Parola-evento non solo riattiva: reintegra gli squilibri e li valorizza in prospettiva di percorsi da persona reale - senza giudicare o disperdere, né spezzare nulla.
Per una tale opera di sapiente ricomposizione dell’essere, il Maestro invita alla Preghiera (v.38) - prima forma d’impegno dei discepoli.
L’accesso a diverse sintonie nello Spirito c’insegna a stimolare lo sguardo dell’anima, a valorizzare e capire tutto e tutti.
Quindi - dopo averli resi meno ignari - Gesù invita i suoi a coinvolgersi nell’opera missionaria; non a fare i dotti o lezioni di morale.
Sarebbero sceneggiate senza premure, che fanno sentire i malfermi ancor più sperduti.
La Missione cresce a partire da una dimensione piccola ma sconfinata - quella della percezione intima, che si accorge delle necessità e del mistero d’una Presenza favorevole.
Nuove configurazioni d’intesa, in spirito: scoperte appieno solo nell’orazione profonda (v.38). Preghiera Incarnata.
Essa non vuole distoglierci dalla realizzazione interiore; al contrario, fa da guida, e ricolloca l’anima dispersa nelle tante pratiche comuni da svolgere, al proprio centro.
Ci fa provare lo struggimento del desiderio e del capire la condizione perfetta: il Padre non intende assorbire le nostre attitudini, bensì potenziarle. Perché ciascuno ha un intimo progetto, una Chiamata per Nome, un proprio posto nel mondo.
Sembra paradossale, ma la Chiesa in uscita - quella che non specula, né impegnata in proselitismi di massa per impressionare il mainstream - è anzitutto un problema di formazione e coscienza interna.
Insomma, ci si riconosce e si diventa non ignari delle cose attraverso la Preghiera-presentimento, unitiva.
In Cristo essa non è prestazione o espressione devota, bensì intesa e anzitutto Ascolto del Dio che in mille forme sottili si rivela e chiama.
L’impegno per sanare il mondo non si vince senza consapevolezze di vocazione, né lasciandosi plagiare e andando a casaccio.
Piuttosto, acuendo lo sguardo, e reinvestendo la virtù e il carattere anche dei nostri stessi lati ancora in ombra.
Né poi rimane essenziale valicare sempre ogni confine (Mt 10,5-6) con una logica di fuga.
Perché non di rado - purtroppo - solo chi ama la forza comincia dal troppo scostato da sé [dal tanto remoto e fuori mano].
Le “pecore” perdute e stanche di provare e riprovare - gli esclusi, i considerati persi, gli emarginati - non mancano. Sono a portata di mano, e non c’è urgenza di estraniarsi immediatamente. Quasi per volersi esonerare dai più prossimi.
L’orizzonte si espande da solo, se si è convinti e non si amano maschere o sotterfugi.
Il senso di prossimità a se stessi, agli altri e alla realtà è un portato autentico del Regno che si rivela: quello Vicino.
Intesa la natura delle creature e conformandovisi in modo crescente, tutti vengono ispirati a mutare e completarsi, arricchendo anche la sclerosi culturale, senza forzature alienanti.
Esercitando una pratica di bontà anche con se stessi.
Alcuni fra i più citati aforismi tratti dalla cultura del Tao recitano: “La via del fare è l’essere”; “chi conosce gli altri è sapiente, chi conosce se stesso è illuminato”; “un lungo viaggio di mille miglia inizia da un solo passo”; “il maestro osserva il mondo, ma si fida della sua visione interiore”; “se correggi la mente, il resto della tua vita andrà a posto”; “quando si accetta se stessi, il mondo intero ti accetta”.
Così nella lotta contro le infermità (Mt 9,35-10,1): ci si ristabilisce e si vince acuendo lo sguardo e reinvestendo l’energia e il carattere anche dei nostri stessi lati ancora offuscati.
Tutto il Gratis (Mt 10,8) che potrà scaturirne per edificare la vita in favore dei fratelli, sprizzerà non come puerile contraccambio [isterico] o ingaggio.
Sarà Dialogo d’Amore spontaneo, solido e allietante, perché privo di quegli squilibri che covano sotto la cenere dei condizionamenti di facciata.
Il senso di prossimità (v.7) a se stessi, agli altri e alla realtà sarà un portato autentico - non programmatico, né alienato - del Regno che si rivela: Accanto.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
La Preghiera in Cristo scuote la tua coscienza?
Quale consolazione attendi dal Dio che Viene?
Forse un compenso?
O una gratuità che innesca - qui e ora - il vero Amore-intesa, attento ai richiami di ogni Voce sottile?
Mosso a compassione: non più soli ad annunciare
Tema: « Le vocazioni al servizio della Chiesa-missione»
Cari fratelli e sorelle!
1. Per la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, che sarà celebrata il 13 aprile 2008, ho scelto il tema: Le vocazioni al servizio della Chiesa-missione. Agli Apostoli Gesù risorto affidò il mandato: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19), assicurando: “Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20). La Chiesa è missionaria nel suo insieme e in ogni suo membro. Se in forza dei sacramenti del Battesimo e della Confermazione ogni cristiano è chiamato a testimoniare e ad annunciare il Vangelo, la dimensione missionaria è specialmente e intimamente legata alla vocazione sacerdotale. Nell’alleanza con Israele, Dio affidò a uomini prescelti, chiamati da Lui ed inviati al popolo in suo nome, la missione di essere profeti e sacerdoti. Così fece, ad esempio, con Mosè: “Ora va’! - gli disse Jahvé - Io ti mando dal faraone. Fa’ uscire dall’Egitto il mio popolo ... quando tu avrai fatto uscire il popolo dall’Egitto, servirete Dio su questo monte” (Es 3,10.12). Ugualmente avvenne con i profeti.
2. Le promesse fatte ai padri si realizzarono appieno in Gesù Cristo. Afferma in proposito il Concilio Vaticano II: “È venuto quindi il Figlio, mandato dal Padre, il quale in Lui prima della fondazione del mondo ci ha eletti e ci ha predestinati ad essere adottati come figli ... Perciò Cristo, per adempiere la volontà del Padre, ha inaugurato in terra il regno dei cieli e ce ne ha rivelato il mistero, e con la sua obbedienza ha operato la redenzione” (Cost. dogm. Lumen gentium, 3). E Gesù si scelse, come stretti collaboratori nel ministero messianico, dei discepoli già nella vita pubblica, durante la predicazione in Galilea. Ad esempio, in occasione della moltiplicazione dei pani, quando disse agli Apostoli: “Date loro voi stessi da mangiare” (Mt 14,16), stimolandoli così a farsi carico del bisogno delle folle, a cui voleva offrire il cibo per sfamarsi, ma anche rivelare il cibo “che dura per la vita eterna” (Gv 6,27). Era mosso a compassione verso la gente, perché mentre percorreva le città ed i villaggi, incontrava folle stanche e sfinite, “come pecore senza pastore” (cfr Mt 9,36). Da questo sguardo di amore sgorgava il suo invito ai discepoli: “Pregate dunque il padrone della messe, perché mandi operai nella sua messe” (Mt 9,38), e inviò i Dodici prima “alle pecore perdute della casa d’Israele”, con precise istruzioni. Se ci soffermiamo a meditare questa pagina del Vangelo di Matteo, che viene solitamente chiamata “discorso missionario”, notiamo tutti quegli aspetti che caratterizzano l’attività missionaria di una comunità cristiana, che voglia restare fedele all’esempio e all’insegnamento di Gesù. Corrispondere alla chiamata del Signore comporta affrontare con prudenza e semplicità ogni pericolo e persino le persecuzioni, giacché “un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone” (Mt 10,24). Diventati una cosa sola con il Maestro, i discepoli non sono più soli ad annunciare il Regno dei cieli, ma è lo stesso Gesù ad agire in essi: “Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato” (Mt 10,40). Ed inoltre, come veri testimoni, “rivestiti di potenza dall’alto” (Lc 24,49), essi predicano “la conversione e il perdono dei peccati” (Lc 24,47) a tutte le genti.
3. Proprio perché inviati dal Signore, i Dodici prendono il nome di “apostoli”, destinati a percorrere le vie del mondo annunciando il Vangelo come testimoni della morte e risurrezione di Cristo. Scrive san Paolo ai cristiani di Corinto: “Noi – cioè gli Apostoli – predichiamo Cristo crocifisso” (1 Cor 1,23). Il Libro degli Atti degli Apostoli attribuisce un ruolo molto importante, in questo processo di evangelizzazione, anche ad altri discepoli, la cui vocazione missionaria scaturisce da circostanze provvidenziali, talvolta dolorose, come l’espulsione dalla propria terra in quanto seguaci di Gesù (cfr 8,1-4). Lo Spirito Santo permette di trasformare questa prova in occasione di grazia, e di trarne spunto perché il nome del Signore sia annunciato ad altre genti e si allarghi in tal modo il cerchio della Comunità cristiana. Si tratta di uomini e donne che, come scrive Luca nel Libro degli Atti, “hanno votato la loro vita al nome del Signore nostro Gesù Cristo” (15,26). Primo tra tutti, chiamato dal Signore stesso sì da essere un vero Apostolo, è senza dubbio Paolo di Tarso. La storia di Paolo, il più grande missionario di tutti i tempi, fa emergere, sotto molti punti di vista, quale sia il nesso tra vocazione e missione. Accusato dai suoi avversari di non essere autorizzato all’apostolato, egli fa appello ripetutamente proprio alla vocazione ricevuta direttamente dal Signore (cfr Rm 1,1; Gal 1,11-12.15-17).
4. All’inizio, come in seguito, a “spingere” gli Apostoli (cfr 2 Cor 5,14) è sempre “l’amore di Cristo”. Quali fedeli servitori della Chiesa, docili all’azione dello Spirito Santo, innumerevoli missionari, nel corso dei secoli, hanno seguito le orme dei primi discepoli. Osserva il Concilio Vaticano II: “Benché l'impegno di diffondere la fede cada su qualsiasi discepolo di Cristo in proporzione delle sue possibilità, Cristo Signore chiama sempre dalla moltitudine dei suoi discepoli quelli che egli vuole, perché siano con lui e per inviarli a predicare alle genti (cfr Mc 3,13-15)” (Decr. Ad gentes, 23). L’amore di Cristo, infatti, va comunicato ai fratelli con gli esempi e le parole; con tutta la vita. “La vocazione speciale dei missionari ad vitam – ebbe a scrivere il mio venerato Predecessore Giovanni Paolo II - conserva tutta la sua validità: essa rappresenta il paradigma dell'impegno missionario della Chiesa, che ha sempre bisogno di donazioni radicali e totali, di impulsi nuovi e arditi” (Enc. Redemptoris missio, 66).
5. Tra le persone che si dedicano totalmente al servizio del Vangelo vi sono in particolar modo sacerdoti chiamati a dispensare la Parola di Dio, amministrare i sacramenti, specialmente l’Eucaristia e la Riconciliazione, votati al servizio dei più piccoli, dei malati, dei sofferenti, dei poveri e di quanti attraversano momenti difficili in regioni della terra dove vi sono, talora, moltitudini che ancora oggi non hanno avuto un vero incontro con Gesù Cristo. Ad esse i missionari recano il primo annuncio del suo amore redentivo. Le statistiche testimoniano che il numero dei battezzati aumenta ogni anno grazie all’azione pastorale di questi sacerdoti, interamente consacrati alla salvezza dei fratelli. In questo contesto, speciale riconoscenza va data “ai presbiteri fidei donum, che con competenza e generosa dedizione edificano la comunità annunciandole la Parola di Dio e spezzando il Pane della vita, senza risparmiare energie nel servizio alla missione della Chiesa. Occorre ringraziare Dio per i tanti sacerdoti che hanno sofferto fino al sacrificio della vita per servire Cristo … Si tratta di testimonianze commoventi che possono ispirare tanti giovani a seguire a loro volta Cristo e a spendere la loro vita per gli altri, trovando proprio così la vita vera” (Esort. ap. Sacramentum caritatis, 26). Attraverso i suoi sacerdoti, Gesù dunque si rende presente fra gli uomini di oggi, sino agli angoli più remoti della terra.
6. Da sempre nella Chiesa ci sono poi non pochi uomini e donne che, mossi dall'azione dello Spirito Santo, scelgono di vivere il Vangelo in modo radicale, professando i voti di castità, povertà ed obbedienza. Questa schiera di religiosi e di religiose, appartenenti a innumerevoli Istituti di vita contemplativa ed attiva, ha “tuttora una parte importantissima nell’evangelizzazione del mondo” (Decr. Ad gentes, 40). Con la loro preghiera continua e comunitaria, i religiosi di vita contemplativa intercedono incessantemente per tutta l’umanità; quelli di vita attiva, con la loro multiforme azione caritativa, recano a tutti la testimonianza viva dell’amore e della misericordia di Dio. Quanto a questi apostoli del nostro tempo, il Servo di Dio Paolo VI ebbe a dire: “Grazie alla loro consacrazione religiosa, essi sono per eccellenza volontari e liberi per lasciare tutto e per andare ad annunziare il Vangelo fino ai confini del mondo. Essi sono intraprendenti, e il loro apostolato è spesso contrassegnato da una originalità, una genialità che costringono all’ammirazione. Sono generosi: li si trova spesso agli avamposti della missione, ed assumono i più grandi rischi per la loro salute e per la loro stessa vita. Sì, veramente, la Chiesa deve molto a loro” (Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 69).
7. Inoltre, perché la Chiesa possa continuare a svolgere la missione affidatale da Cristo e non manchino gli evangelizzatori di cui il mondo ha bisogno, è necessario che nelle comunità cristiane non venga mai meno una costante educazione alla fede dei fanciulli e degli adulti; è necessario mantenere vivo nei fedeli un attivo senso di responsabilità missionaria e di partecipazione solidale con i popoli della terra. Il dono della fede chiama tutti i cristiani a cooperare all’evangelizzazione. Questa consapevolezza va alimentata attraverso la predicazione e la catechesi, la liturgia e una costante formazione alla preghiera; va incrementata con l’esercizio dell’accoglienza, della carità, dell’accompagnamento spirituale, della riflessione e del discernimento, come pure con una progettazione pastorale, di cui parte integrante sia l’attenzione alle vocazioni.
8. Solo in un terreno spiritualmente ben coltivato fioriscono le vocazioni al sacerdozio ministeriale ed alla vita consacrata. Infatti, le comunità cristiane, che vivono intensamente la dimensione missionaria del mistero della Chiesa, mai saranno portate a ripiegarsi su se stesse. La missione, come testimonianza dell’amore divino, diviene particolarmente efficace quando è condivisa in modo comunitario, “perché il mondo creda” (cfr Gv 17,21). Quello delle vocazioni è il dono che la Chiesa invoca ogni giorno dallo Spirito Santo. Come ai suoi inizi, raccolta attorno alla Vergine Maria, Regina degli Apostoli, la Comunità ecclesiale apprende da lei ad implorare dal Signore la fioritura di nuovi apostoli che sappiano vivere in sé quella fede e quell’amore che sono necessari per la missione.
9. Mentre affido questa riflessione a tutte le Comunità ecclesiali, affinché le facciano proprie e soprattutto ne traggano spunto per la preghiera, incoraggio l’impegno di quanti operano con fede e generosità al servizio delle vocazioni e di cuore invio ai formatori, ai catechisti e a tutti, specialmente ai giovani in cammino vocazionale, una speciale Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 3 dicembre 2007
[Papa Benedetto, Messaggio per la XLV Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni]
La Quaresima, occasione provvidenziale di conversione, ci aiuta a contemplare questo stupendo mistero d'amore. Essa costituisce un ritorno alle radici della fede, perché, meditando sul dono di grazia incommensurabile che è la Redenzione, non possiamo non renderci conto che tutto ci è stato dato per amorevole iniziativa divina. Proprio per meditare su questo aspetto del mistero salvifico, ho scelto quale tema del Messaggio quaresimale di quest'anno le parole del Signore: « Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date » (Mt 10, 8).
Sì! Gratuitamente abbiamo ricevuto. La nostra esistenza non è forse tutta segnata dalla benevolenza di Dio? È dono lo sbocciare della vita e il suo prodigioso svilupparsi. E proprio perché è dono, l'esistenza non può essere considerata un possesso o una privata proprietà, anche se le potenzialità, di cui oggi disponiamo per migliorarne la qualità, potrebbero far pensare che l'uomo sia di essa « padrone ». In effetti, le conquiste della medicina e della biotecnologia a volte potrebbero indurre l'uomo a pensarsi creatore di se stesso, e a cedere alla tentazione di manipolare « l'albero della vita » (Gn 3, 24).
È bene anche qui ribadire che non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche moralmente lecito. Se ammirevole è lo sforzo della scienza per assicurare una qualità di vita più conforme alla dignità dell'uomo, non deve però essere mai dimenticato che la vita umana è un dono, e che essa rimane un valore anche quando è segnata dalla sofferenza e dal limite. Un dono da accogliere e amare sempre: gratuitamente ricevuto e gratuitamente da porre al servizio degli altri.
[Papa Giovanni Paolo II, Messaggio per la Quaresima 2002]
«Servizio» e «gratuità»: sono le due parole chiave attorno alle quali Papa Francesco ha costruito la meditazione della messa celebrata a Santa Marta la mattina di martedì 11 giugno. Sono le caratteristiche fondamentali che devono accompagnare il cristiano «strada facendo», ha detto il Pontefice, lungo quel cammino, quell’«andare» che sempre contraddistingue la vita, «perché un cristiano non può rimanere fermo».
L’insegnamento viene direttamente dal Vangelo: è lì che si ritrovano — come evidenziato dal brano di Matteo proposto dalla liturgia del giorno (10, 7-13) — le indicazioni di Gesù per gli apostoli che vengono inviati. Una missione che, ha detto il Papa, è anche quella «dei successori degli apostoli» e di «ognuno dei cristiani, se inviato». Quindi, innanzi tutto, «la vita cristiana è fare strada, sempre. Non rimanere fermo». E in questo andare, cosa raccomanda il Signore ai suoi? «Guarite gli infermi, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni». Cioè: «una vita di servizio».
Ecco il primo dato fondamentale evidenziato dal Pontefice: «La vita cristiana è per servire». Ed è molto triste, ha aggiunto, vedere «cristiani che all’inizio della loro conversione o della loro consapevolezza di essere cristiani, servono, sono aperti per servire, servono il popolo di Dio», e poi, invece, «finiscono per servirsi del popolo di Dio. Questo fa tanto male, tanto male al popolo di Dio». La vocazione del cristiano quindi è «servire» e mai «servirsi di».
Proseguendo nella riflessione, Francesco è quindi passato a un concetto che, ha sottolineato, «va proprio al nocciolo della salvezza: “Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. La vita cristiana è una vita di gratuità». Dalla raccomandazione di Gesù agli apostoli inviati si comprende chiaramente che «la salvezza non si compra; la salvezza ci è data gratuitamente. Dio ci ha salvato, ci salva gratis. Non ci fa pagare». Si tratta, ha spiegato il Papa, di un principio «che Dio ha usato con noi» e che noi dobbiamo usare «con gli altri». Ed è «una delle cose più belle» sapere «che il Signore è pieno di doni da darci» e che all’uomo è chiesta solo una cosa: «che il nostro cuore si apra». Come nella preghiera del Padre nostro, dove «preghiamo, apriamo il cuore, perché questa gratuità venga. Non c’è rapporto con Dio fuori dalla gratuità».
Considerando questo caposaldo della vita cristiana, il Pontefice ha quindi evidenziato dei possibili e pericolosi fraintendimenti. Così, ha detto, «delle volte, quando abbiamo bisogno di qualcosa di spirituale o di una grazia, diciamo: “Mah, io adesso farò digiuno, farò una penitenza, farò una novena...”». Tutto ciò va bene, ma «stiamo attenti: questo non è per “pagare “la grazia, per “acquistare” la grazia; questo è per allargare il tuo cuore perché la grazia venga». Sia ben chiaro, infatti: «La grazia è gratuita. Tutti i beni di Dio sono gratuiti. Il problema è che il cuore si rimpiccolisce, si chiude e non è capace di ricevere tanto amore, tanto amore gratuito». Perciò «ogni cosa che noi facciamo per ottenere qualcosa, anche una promessa — “Se io avrò questo, farò quell’altro” — questo è allargare il cuore, non è entrare mercanteggiare con Dio... No. Con Dio non si tratta». Con Dio vale «soltanto il linguaggio dell’amore e del Padre e della gratuità».
E se questo vale nel rapporto con Dio, vale anche per i cristiani — «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» — e, ha sottolineato Francesco, specialmente per i «pastori della Chiesa». La grazia «non si vende» ha ribadito, aggiungendo: «Fa tanto male quando si trovano dei pastori che fanno affari con la grazia di Dio: “Io farò questo, ma questo costa tanto, questo tanto...“. E la grazia di Dio rimane là e la salvezza è un affare». Tutto questo, ha ribadito con forza, «non è il Signore. La grazia del Signore è gratuita e tu devi darla gratuitamente». Purtroppo, ha spiegato, nella vita spirituale c’è «sempre il pericolo di scivolare sul pagamento, sempre, anche parlando con il Signore, come se noi volessimo dare una tangente al Signore». Ma il rapporto con il Signore non può percorrere «quella strada».
Quindi, ha ribadito il Pontefice, no alla dinamiche del tipo: «Signore se tu mi fai questo, io ti darò questo»; ma, eventualmente, sì a una promessa affinché con essa si allarghi il proprio cuore «per ricevere» ciò che «è gratuito per noi». E «questo rapporto di gratuità con Dio è quello che ci aiuterà poi ad averlo con gli altri sia nella testimonianza cristiana sia nel servizio cristiano sia nella vita pastorale di coloro che sono pastori del popolo di Dio».
«Strada facendo»: così il Papa, al termine dell’omelia ha riassunto il suo ragionamento». «La vita cristiana — ha detto — è andare. Predicate, servite, non “servirsi di”. Servite e date gratis quello che gratis avete ricevuto». E ha concluso: «La vita nostra di santità sia questo allargare il cuore, perché la gratuità di Dio, le grazie di Dio che sono lì, gratuite, che Lui vuole donare, possano arrivare al nostro cuore».
[Papa Francesco, s. Marta, in L’Osservatore Romano 11.06.19]
Illuminatore di ciechi: quale guarigione, Attesa, definitività?
(Mt 9,27-31)
L’enciclica Fratelli Tutti invita a un piglio prospettico che suscita decisione e azione: un occhio nuovo, colmo di Speranza [n.55].
Eppure gli esperti - sicuri di sé - non colgono la dignità (rovesciata) del Mistero di Dio e dell’umanità.
Conoscono le ambizioni, la legge, i dettati altrui, le mode, o le loro idee; non i rivolgimenti dell’anima e della vita.
Quindi ci fanno permanere come in una foresta gelida e dedicata ai forti, sterilizzata o fantasiosa ma paradossalmente selvaggia.
La competizione non manca, anzi ne sarà conseguenza ancor più subdola, come nel caso delle pretese (proprio!) di una ‘coppia di apostoli’ eminenti.
Si tratta dei due figli di Zebedeo, i quali - come gli altri - ambiscono al primato.
La guarigione di coloro che hanno difetti di vista era uno dei beni recati dal Messia atteso (Is 29,18; 35,5).
Tutto sarebbe stato trasformato in meglio.
Ma nei suoi incontri, Gesù opera una guarigione spirituale, non parziale o frivola ed esterna.
L’opera divina nell’uomo è prodigiosa, ma nel senso che si fa molto più profonda di una sanazione fisica.
L’azione di suscitare la Fede e un nuovo acume dell’anima consentono di cogliere lo stesso progetto del Signore.
Ciò rende docili per lasciarlo realizzare da Dio stesso in noi.
L’allusione è alla Casa [Chiesa] in cui tutti i personaggi entrano come fosse cosa normale e in un contesto non polemico (v.28).
Anche il richiamo al fatto che lì si radunano coloro che hanno bisogno di una ‘illuminazione’, induce a leggere in filigrana l’eco di antiche liturgie battesimali.
Intorno a Gesù, ecco illustrato il senso globale dell’incontro del Cristo coi credenti.
L’insegnamento cui anche noi sempre ‘difettosi di vista’ veniamo introdotti dal contatto col Maestro nella comunità riunita è espresso nel passaggio dal titolo figlio di David (v.27) a quello di Signore (v.28).
I ciechi cui viene corretta la miopia sono i capi e i catecumeni, ora credenti.
Nella loro esperienza di Fede essi passano dall’idea di Messia glorioso - somigliante a un sovrano - a quella dell’Amico vicino e Fratello.
Per questo la sua Persona spalanca alla Percezione un panorama che prorompe quale rinascita e capovolgimento dei valori sulla base dei quali s’investe la vita pratica.
Il motivo della fitta oscurità esterna è appunto l’ideologia di potere. Essa deve sparire nella considerazione e nell’universo dei discepoli.
Questo il motivo del cosiddetto silenzio messianico (v.30). E tutto scaturisce «da» un altro sguardo, penetrante.
Tale l’intervento definitivo di Dio che eleva la visione, i sogni, e lo spirito, e in tal guisa attiva percorsi che non sappiamo.
Una nuova maturità sta arrivando.
[Venerdì 1.a sett. Avvento, 5 dicembre 2025]
Due oscurità nella Speranza: esterna e interna
Illuminatore di ciechi: quale guarigione, Attesa, definitività?
(Mt 9,27-31)
L’enciclica Fratelli Tutti invita a un piglio prospettico che suscita decisione e azione: un occhio nuovo, colmo di Speranza.
Essa «ci parla di una realtà che è radicata nel profondo dell’essere umano, indipendentemente dalle circostanze concrete e dai condizionamenti storici in cui vive. Ci parla di una sete, di un’aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un misurarsi con ciò che è grande, con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi, come la verità, la bontà e la bellezza, la giustizia e l’amore. [...] La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l’orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa» [n.55; da un Saluto ai giovani de L’Avana, settembre 2015].
Eppure gli esperti - sicuri di sé - non colgono la dignità (rovesciata) del Mistero di Dio e dell’umanità.
Conoscono le ambizioni, la legge, i dettati altrui, le mode, o le loro idee; non i rivolgimenti dell’anima e della vita.
Quindi ci fanno permanere come in una foresta gelida e dedicata ai forti, sterilizzata o fantasiosa ma paradossalmente selvaggia.
La competizione non manca, anzi ne sarà conseguenza ancor più subdola, come nel caso delle pretese (proprio!) di una coppia di apostoli eminenti.
Si tratta dei due figli di Zebedeo, i quali - come gli altri - ambiscono al primato [Mt 20,20-28; Mc 10,35-45 e paralleli Lc 22,24-27; Gv 12,26; 13,3-17].
La guarigione di coloro che hanno difetti di vista era uno dei beni recati dal Messia atteso (Is 29,18; 35,5).
Tutto sarebbe stato trasformato in meglio.
Ma nei suoi incontri, Gesù opera una guarigione spirituale, non parziale o frivola ed esterna.
Malinteso fatale è stato vederlo come operatore di cose strabilianti (v.31).
L’opera divina nell’uomo è prodigiosa, ma nel senso che si fa molto più profonda di una sanazione fisica.
L’azione di suscitare la Fede e un nuovo acume dell’anima consentono di cogliere lo stesso progetto del Signore.
Ciò rende docili per lasciarlo realizzare da Dio stesso in noi.
L’allusione è alla Casa [Chiesa] in cui tutti i personaggi entrano come fosse cosa normale e in un contesto non polemico (v.28).
Anche il richiamo al fatto che lì si radunano coloro che hanno bisogno di una illuminazione, induce a leggere in filigrana l’eco di antiche liturgie battesimali.
Intorno a Gesù, ecco illustrato il senso globale dell’incontro del Cristo coi credenti.
L’insegnamento cui anche noi sempre difettosi di vista veniamo introdotti dal contatto col Maestro nella comunità riunita è espresso nel passaggio dal titolo figlio di David (v.27) a quello di Signore (v.28).
I ciechi cui viene corretta la miopia sono i capi e i catecumeni, ora credenti.
Nella loro esperienza di Fede essi passano dall’idea di Messia glorioso - somigliante a un sovrano - a quella dell’Amico vicino, Fratello di ciascuno, Prossimo ed eminente allo stesso modo [due ciechi].
Per questo la sua Persona spalanca alla percezione un panorama alternativo della mente e del cuore.
In tal guisa, Mt dona i tratti della personalità dell’uomo riuscito secondo Dio, nonché la cifra più intima della comunità.
Il cambiamento del punto di vista normale innesca un’altra vita.
Non si tratta di un dono accessorio, bensì essenziale. Indispensabile non solo per la realizzazione personale, ma anche per la Comunione [Mt 20,24; Mc 10,41; Lc 9,46. 22,24; Gv 13,12-17. 20,4. 21,20-22].
Anche qui, per estrarre perle è opportuno andare oltre la prospettiva conformista e “a posto” - babelica, alla moda o di branco, e banale.
Bisogna imparare a scandagliare meglio la nostra Chiamata e quel che reca, perché esiste un altro equilibrio delle cose - forse ancora tutto da esplorare.
Armonia superiore che sta dentro la vita… ma sotto le facciate: si deve scavare in ogni relazione, vicenda o sensazione; esaminare meglio.
E accorgersi di ciò che si affaccia.
Occhio: anche e soprattutto negli scuotimenti delle bufere.
Talora è d’uopo fare un salto nel buio, per contattare il proprio Seme vocazionale; per guarire lo sguardo dell’anima, e riconoscersi; fiorire.
I disagi vengono per avvisare: ci stiamo allontanando da noi stessi.
Le amarezze oscure diventano qui occasioni di strappo dagli sfondi e dalle rappresentazioni conformiste.
I luoghi comuni ci sono stati inoculati (goccia a goccia) da scorci meschini, nei quali forse siamo già introdotti. E magari interpretiamo con senso di permanenza.
Avendo acquisito altra angolazione, saremo ben contenti di accorgerci da cosa siamo liberati e quali differenti configurazioni attendono la crescita delle nostre stesse risorse innate.
L’esistenza tormentata è spesso come intossicata, ma solo quando non indaga né nota differenti soluzioni all’idea ad es. di dover arricchire con beni materiali, fare carriera, doversi affermare subito e ribattere colpo su colpo, farsi rispettare, apparire a ogni costo - perché no, usando la vita ecclesiale.
Non sarà questa la nostra realizzazione e tranquillità; tutt’altro. Piuttosto, le brame, gli intimismi, e altre situazioni che conosciamo, non sono che una fuga dalla propria essenza.
Il nostro nucleo intimo prende respiro e slancio - si attiva - paradossalmente dai traumi e dai lati in ombra.
Tutto ciò accade assecondando i segnali della Provvidenza naturale.
Tale onda vitale si esprime con “parole” o scorci (appunto) dell’inconscio che si esprime, contestandoci.
Il motivo della fitta oscurità esterna è qui l’ideologia di potere che trae la propria realizzazione sociale dalle tenebre reali.
Essa deve sparire nella considerazione e nell’universo dei discepoli.
Questo il motivo del cosiddetto silenzio messianico (v.30) imposto da Gesù - anche se non di rado i seguaci di ogni tempo poi ci ricascano e annunciano il Figlio di Dio al contrario (v.31).
Nel Messaggio dei famigliari «illuminati» la saggezza del cuore nuovo prorompe quale rigenerazione, rinascita e capovolgimento dei valori sulla base dei quali s’investe la vita pratica.
Adesso però non proclamiamo Cristo come forsennati (v.27), perché il nostro “dire” è tutto «da» un altro sguardo, penetrante.
I testimoni cui è stata corretta la Visione, la lettura delle cose, e i sogni, non sono chiamati a entrare con violenza e ri-proclamare il vecchio piccolo mondo di mode istrioniche, di nebbie procurate, o malversazioni ambigue, di aggressività poco radiose, e angosce subdole.
Piuttosto essi correggono gli errori e cercano di spalancare pertugi per dissipare il buio, operando brecce e allargando fessure di luce.
Non perché abbiamo un’attitudine “positiva” - come si dice oggi - ma perché intendiamo noi stessi: perché cogliamo il senso delle cose nei solchi della storia, e per Grazia siamo abilitati a leggere il segno dei tempi.
Uscire da schemi e meccanismi convenzionali consentirà di correggere le convinzioni, di fare Esodo dalle amarezze di superficie.
Non: facendo finta di nulla, bensì rigenerando insieme ad esse - dall’interno.
Per questo nella Fede evitiamo di farci trascinare da tensioni inutili, dannose, perché devianti la nostra Vocazione.
Ma queste eccentricità le penetriamo, affinché da esse possano partire altri Sogni, diverse Attese, Immagini uniche (davvero vicine a noi).
Questa la Venuta che svela l’essenziale, e supera il vuoto.
Presenza che ci aiuta a dare un’eccentricità di Raggio - e spazio anche disarmonico. Senza il solito serbatoio di fissazioni conformiste, idolatriche, personali, o di club [che fanno impallidire gli orizzonti].
Tale l’intervento definitivo di Dio nel tempo, che eleva la visione e lo spirito, e in tal guisa attiva percorsi che non sappiamo.
Una nuova maturità sta arrivando.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Durante il tempo d’Avvento, cosa attendi dalla Venuta divina, e quale intervento “definitivo” desideri?
La Chiesa stessa ha sempre bisogno di essere evangelizzata
LEGAMI RECIPROCI TRA LA CHIESA E L'EVANGELIZZAZIONE
15. Chiunque rilegge, nel Nuovo Testamento, le origini della Chiesa, seguendo passo passo la sua storia e considerandola nel suo vivere e agire, scorge che è legata all'evangelizzazione da ciò che essa ha di più intimo: - La Chiesa nasce dall'azione evangelizzatrice di Gesù e dei Dodici. Ne è il frutto normale, voluto, più immediato e più visibile: «Andate dunque, fate dei discepoli in tutte le nazioni». Ora, «coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e circa tremila si unirono ad essi . . . E il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati».
- Nata, di conseguenza, della missione, la Chiesa è, a sua volta, inviata da Gesù. La Chiesa resta nel mondo, mentre il Signore della gloria ritorna al Padre. Essa resta come un segno insieme opaco e luminoso di una nuova presenza di Gesù, della sua dipartita e della sua permanenza. Essa la prolunga e lo continua. Ed è appunto la sua missione e la sua condizione di evangelizzatore che, anzitutto, è chiamata a continuare. Infatti la comunità dei cristiani non è mai chiusa in se stessa. In essa la vita intima - la vita di preghiera, l'ascolto della Parola e dell'insegnamento degli Apostoli, la carità fraterna vissuta, il pane spezzato - non acquista tutto il suo significato se non quando essa diventa testimonianza, provoca l'ammirazione e la conversione, si fa predicazione e annuncio della Buona Novella. Così tutta la Chiesa riceve la missione di evangelizzare, e l'opera di ciascuno è importante per il tutto.
- Evangelizzatrice, la Chiesa comincia con l'evangelizzare se stessa. Comunità di credenti, comunità di speranza vissuta e partecipata, comunità d'amore fraterno, essa ha bisogno di ascoltare di continuo ciò che deve credere, le ragioni della sua speranza, il comandamento nuovo dell'amore. Popolo di Dio immerso nel mondo, e spesso tentato dagli idoli, essa ha sempre bisogno di sentir proclamare «le grandi opere di Dio», che l'hanno convertita al Signore, e d'essere nuovamente convocata e riunita da lui. Ciò vuol dire, in una parola, che essa ha sempre bisogno d'essere evangelizzata, se vuol conservare freschezza, slancio e forza per annunziare il Vangelo. Il Concilio Vaticano II ha ricordato e il Sinodo del 1974 ha fortemente ripreso questo tema della Chiesa che si evangelizza mediante una conversione e un rinnovamento costanti, per evangelizzare il mondo con credibilità.
- La Chiesa è depositaria della Buona Novella che si deve annunziare. Le promesse della Nuova Alleanza in Gesù Cristo, l'insegnamento del Signore e degli Apostoli, la Parola di vita, le fonti della grazia e della benignità di Dio, il cammino della salvezza: tutto ciò le è stato affidato. Il contenuto del Vangelo, e quindi dell'evangelizzazione, essa lo conserva come un deposito vivente e prezioso, non per tenerlo nascosto, ma per comunicarlo.
- Inviata ed evangelizzata, la Chiesa, a sua volta, invia gli evangelizzatori. Mette nella loro bocca la Parola che salva, spiega loro il messaggio di cui essa stessa è depositaria, dà loro il mandato che essa stessa ha ricevuto e li manda a predicare: ma non a predicare le proprie persone o le loro idee personali, bensì un Vangelo di cui né essi, né essa sono padroni e proprietari assoluti per disporne a loro arbitrio, ma ministri per trasmetterlo con estrema fedeltà.
[Papa Paolo VI, Evangelii Nuntiandi]
Il profeta Isaia (35,4-7) incoraggia gli “smarriti di cuore” e annuncia questa stupenda novità, che l’esperienza conferma: quando il Signore è presente si riaprono gli occhi del cieco, si schiudono gli orecchi del sordo, lo zoppo “salta” come un cervo. Tutto rinasce e tutto rivive perché acque benefiche irrigano il deserto. Il “deserto”, nel suo linguaggio simbolico, può evocare gli eventi drammatici, le situazioni difficili e la solitudine che segna non raramente la vita; il deserto più profondo è il cuore umano, quando perde la capacità di ascoltare, di parlare, di comunicare con Dio e con gli altri. Si diventa allora ciechi perché incapaci di vedere la realtà; si chiudono gli orecchi per non ascoltare il grido di chi implora aiuto; si indurisce il cuore nell’indifferenza e nell’egoismo. Ma ora – annuncia il Profeta – tutto è destinato a cambiare; questa “terra arida” di un core chiuso sarà irrigata da una nuova linfa divina. E quando il Signore viene, agli smarriti di cuore di ogni epoca dice con autorità: “Coraggio, non temete”! ( v. 4).
[Papa Benedetto, omelia Valle Faul Viterbo 6 settembre 2009]
We will not find a wall, no. We will find a way out […] Let us not fear the Lord (Pope Francis)
Non troveremo un muro, no, troveremo un’uscita […] Non abbiamo paura del Signore (Papa Francesco)
Raw life is full of powers: «Be grateful for everything that comes, because everything was sent as a guide to the afterlife» [Gialal al-Din Rumi]
La vita grezza è colma di potenze: «Sii grato per tutto quel che arriva, perché ogni cosa è stata mandata come guida dell’aldilà» [Gialal al-Din Rumi]
It is not enough to be a pious and devoted person to become aware of the presence of Christ - to see God himself, brothers and things with the eyes of the Spirit. An uncomfortable vision, which produces conflict with those who do not want to know
Non basta essere persone pie e devote per rendersi conto della presenza di Cristo - per vedere Dio stesso, i fratelli e le cose con gli occhi dello Spirito. Visione scomoda, che produce conflitto con chi non ne vuol sapere
An eloquent and peremptory manifestation of the power of the God of Israel and the submission of those who did not fulfill the Law was expected. Everyone imagined witnessing the triumphal entry of a great ruler, surrounded by military leaders or angelic ranks...
Ci si attendeva una manifestazione eloquente e perentoria della potenza del Dio d’Israele e la sottomissione di coloro che non adempivano la Legge. Tutti immaginavano di assistere all’ingresso trionfale d’un condottiero, circondato da capi militari o schiere angeliche…
May the Holy Family be a model for our families, so that parents and children may support each other mutually in adherence to the Gospel, the basis of the holiness of the family (Pope Francis)
La Santa Famiglia possa essere modello delle nostre famiglie, affinché genitori e figli si sostengano a vicenda nell’adesione al Vangelo, fondamento della santità della famiglia (Papa Francesco)
John is the origin of our loftiest spirituality. Like him, ‘the silent ones' experience that mysterious exchange of hearts, pray for John's presence, and their hearts are set on fire (Athinagoras)
Giovanni è all'origine della nostra più alta spiritualità. Come lui, i ‘silenziosi’ conoscono quel misterioso scambio dei cuori, invocano la presenza di Giovanni e il loro cuore si infiamma (Atenagora)
Stephen's story tells us many things: for example, that charitable social commitment must never be separated from the courageous proclamation of the faith. He was one of the seven made responsible above all for charity. But it was impossible to separate charity and faith. Thus, with charity, he proclaimed the crucified Christ, to the point of accepting even martyrdom. This is the first lesson we can learn from the figure of St Stephen: charity and the proclamation of faith always go hand in hand (Pope Benedict)
La storia di Stefano dice a noi molte cose. Per esempio, ci insegna che non bisogna mai disgiungere l'impegno sociale della carità dall'annuncio coraggioso della fede. Era uno dei sette incaricato soprattutto della carità. Ma non era possibile disgiungere carità e annuncio. Così, con la carità, annuncia Cristo crocifisso, fino al punto di accettare anche il martirio. Questa è la prima lezione che possiamo imparare dalla figura di santo Stefano: carità e annuncio vanno sempre insieme (Papa Benedetto)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.