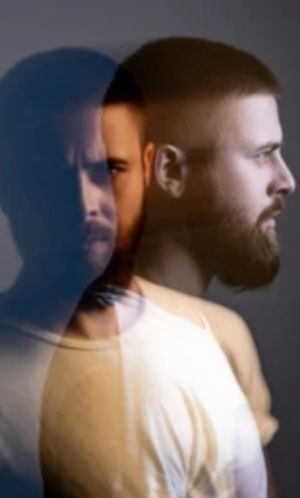don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Cananei di ogni tempo per chiedere comprensione e aiuto
6. Particolarmente toccante è l’episodio della donna cananea, che non cessava di chiedere l’aiuto di Gesù per sua figlia “crudelmente tormentata da un demonio”. Quando la cananea si prostrò dinanzi a Gesù per chiedergli aiuto, egli rispose: “Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini” (era un richiamo alla diversità etnica tra israeliti e cananei, che Gesù figlio di Davide, non poteva ignorare nel suo comportamento pratico, ma alla quale accennava in funzione metodologica per provocare la fede). Ed ecco la donna pervenire d’intuito a un atto insolito di fede e di umiltà. Dice: “È vero, Signore . . . ma anche i cagnolini si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni”. Dinanzi a questa parola così umile, garbata e fiduciosa, Gesù replica: “Donna, davvero grande è la tua fede! Ti sia fatto come desideri” (cf. Mt 15, 21-28).
È un avvenimento difficile da dimenticare, soprattutto se si pensa agli innumerevoli “cananei” di ogni tempo, paese, colore e condizione sociale, che tendono la mano per chiedere comprensione e aiuto nelle loro necessità!
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 16 dicembre 1987]
Svelta, e il coraggio di portare la propria storia. Senza trucco
Il Vangelo […] (cfr Mt 15,21-28) descrive l’incontro tra Gesù e una donna cananea. Gesù si trova a nord della Galilea, in territorio straniero per stare con i suoi discepoli un po’ lontano dalle folle, che lo cercano sempre più numerose. Ed ecco avvicinarsi una donna che implora aiuto per la figlia malata: «Pietà di me, Signore!» (v. 22). È il grido che nasce da una vita segnata dalla sofferenza, dal senso di impotenza di una mamma che vede la figlia tormentata dal male e non può guarirla. Gesù inizialmente la ignora, ma questa madre insiste, insiste, anche quando il Maestro dice ai discepoli che la sua missione è rivolta soltanto alle «pecore perdute della casa d’Israele» (v. 24) e non ai pagani. Lei continua a supplicarlo, e Lui, a questo punto, la mette alla prova citando un proverbio - sembra quasi un po’ crudele questo -: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini» (v. 26). E la donna subito, svelta, angosciata risponde: «È vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni» (v. 27).
Con queste parole questa madre dimostra di aver intuito che la bontà del Dio Altissimo, presente in Gesù, è aperta ad ogni necessità delle sue creature. Questa saggezza piena di fiducia colpisce il cuore di Gesù e gli strappa parole di ammirazione: «Donna, grande è la tua fede! Avvenga per te come desideri» (v. 28). Quale è la fede grande? La fede grande è quella che porta la propria storia, segnata anche dalle ferite, ai piedi del Signore domandando a Lui di guarirla, di darle un senso. Ognuno di noi ha la propria storia e non sempre è una storia pulita; tante volte è una storia difficile, con tanti dolori, tanti guai e tanti peccati. Cosa faccio, io, con la mia storia? La nascondo? No! Dobbiamo portarla davanti al Signore: “Signore, se Tu vuoi, puoi guarirmi!”. Questo è quello che ci insegna questa donna, questa brava madre: il coraggio di portare la propria storia di dolore davanti a Dio, davanti a Gesù; toccare la tenerezza di Dio, la tenerezza di Gesù. Facciamo, noi, la prova di questa storia, di questa preghiera: ognuno pensi alla propria storia. Sempre ci sono delle cose brutte in una storia, sempre. Andiamo da Gesù, bussiamo al cuore di Gesù e diciamoGli: “Signore, se Tu voi, puoi guarirmi!”. E noi potremo fare questo se abbiamo sempre davanti a noi il volto di Gesù, se noi capiamo come è il cuore di Cristo: un cuore che ha compassione, che porta su di sé i nostri dolori, che porta su di sé i nostri peccati, i nostri sbagli, i nostri fallimenti.
Ma è un cuore che ci ama così, come siamo, senza trucco. “Signore, se Tu vuoi, puoi guarirmi!”. E per questo è necessario capire Gesù, avere familiarità con Gesù. E torno sempre al consiglio che vi do: portate sempre un piccolo Vangelo tascabile e leggete ogni giorno un passo. Portate il Vangelo: nella borsa, nella tasca e anche nel telefonino, per vedere Gesù. E lì troverete Gesù come Lui è, come si presenta; troverete Gesù che ci ama, che ci ama tanto, che ci vuole tanto bene. Ricordiamo la preghiera: “Signore, se Tu vuoi, puoi guarirmi!”. Bella preghiera. Il Signore ci aiuti, tutti noi, a pregare queste bella preghiera che ci insegna una donna pagana: non cristiana, non ebrea, ma pagana.
La Vergine Maria interceda con la sua preghiera, perché cresca in ogni battezzato la gioia della fede e il desiderio di comunicarla con la testimonianza di una vita coerente, che ci dia il coraggio di avvicinarci a Gesù e dirGli: “Signore, se Tu vuoi, puoi guarirmi!”.
[Papa Francesco, Angelus 16 agosto 2020]
L’origine del male non è in una causa esteriore
Purezza, impudicizie e santità travisate
(Mc 7,14-23)
Il Signore è per una umanizzazione a tutto campo. Ma nelle culture antiche la visione mitica del mondo portava la gente ad apprezzare qualsiasi realtà partendo dalla categoria della ‘santità’ come ‘distacco’.
Le leggi sulla purezza indicavano le condizioni necessarie per mettersi davanti a Dio e sentirsi bene alla sua presenza - ma di fatto sempre sgomenti, perché [ovvio] non totalmente ottemperanti.
All’epoca di Mc alcuni giudei convertiti ritenevano di poter abbandonare gli antichi costumi e avvicinarsi ai pagani; altri erano di opinione opposta: sarebbe stato come rigettare parti consistenti della Torah.
Infatti l’evangelista sottolinea che il problema è «in Casa» (v.17) ossia nella Chiesa. Fraternità dove ancora non si capiva il Maestro, venuto per liberare da ossessioni artificiose.
Cristo deve insistere nel suo insegnamento, ora non rivolto a degli estranei ma proprio ai discepoli [appunto] incapaci di «comprendere» (vv.14.18).
In tal guisa, il Vangelo rigetta la distinzione tra la sfera religiosa della vita e un assetto quotidiano “contaminato”; fonte di corruzione. Ma normale, spicciolo, sommario - per questo valutato distante dal ‘divino’.
Quintessenza che viceversa non intende soggiogare nessuno.
La presenza attiva di un Ordine nuovo abolisce le prescrizioni legali e sposta il centro della moralità dei nostri atti.
Qui si richiama l’insegnamento di Gesù: l’impurità non viene dall’esterno [ossia da fuori a dentro]. Non è quella la minaccia.
Le realtà del mondo non sono mai scellerate e inadatte - neanche al culto.
Diventano obbrobrio solo passando attraverso decisioni queste sì sacrileghe, perché bloccano la vita. E distacchi che imbarbariscono.
Non vi è sacro e profano in sé.
Mistero e Beatitudine vengono al mondo esclusivamente attraverso il canale del dialogo e dell’incontro nel rispetto dell’intelligenza, dell’anima personale, e delle culture difformi. Non percorrendo entità di meriti, né strettoie travisate.
Qui il legalismo formale uccide il dilatarsi della vita e degli ideali: “impuro” è ciò che avvelena l'esistenza e la realizzazione spontanea delle persone, le loro relazioni, e la creazione stessa.
Gesù libera la folla dei senza voce e smarriti dall’ossessione di tormenti e timori, dallo stare sempre sulla difensiva.
Siamo chiamati a voler bene ai limiti: sono il terreno di energie preparatorie della reale fioritura - impulsi e segni del nostro ‘compito nel mondo’ secondo la Novità di Dio.
Ogni Esodo valorizza le alternative.
E troviamo la realizzazione, il senso della vita, nonché via via maggiore completezza, incontrando appunto i nostri lati opposti.
Non siamo chiamati a fissarci in una direzione. Ce ne sono altre.
Chiunque intimorisce il fratello “inadeguato” minaccia la vita del cosmo e rende sfiduciate proprio le persone più sensibili e attente.
Sono le imperfezioni a renderci nuovi, eccezionali, unici!
Impariamo dunque a non provare sgomento per il fatto che ‘non siamo’ religiosamente “riusciti” - bensì Primizia!
[Mercoledì 5.a sett. T.O. 11 febbraio 2026]
L’origine del male non è in una causa esteriore
Purezza, impudicizie e santità travisate
(Mc 7,14-23)
La Chiesa ha conservato la fede nella bontà del creato; non vede di malocchio la natura, la società, e l’opera concreta del Padre, come purtroppo si propugna in certe mentalità schizzinose (in chiave devota).
Neppure ritiene che per sentirsi salvi esistano strumenti o zone di rifugio che basterebbe usare, fruire o raggiungere, e rifrequentare. Il Signore è per una umanizzazione a tutto campo.
Nelle culture antiche la visione religiosa e mitica del mondo portava la gente ad apprezzare qualsiasi realtà partendo dalla categoria della santità come distacco e separatezza - persino inaccessibilità.
Le leggi sulla purezza indicavano le condizioni necessarie per mettersi davanti a Dio e sentirsi bene alla sua presenza - ma di fatto sempre sgomenti, perché (ovvio) non totalmente ottemperanti.
Non ci si poteva presentare nel punto in cui la persona era, o in qualsiasi occasione e modo - bensì secondo norme legate al cibo, al contatto, al vestito, ai tempi raccomandati di preghiera; così via.
Nel contesto della dominazione achemenide, per valorizzare l’identità, ricostruire il Tempio di Gerusalemme e mantenere la propria classe, i sacerdoti accentuarono le norme di purità e gli obblighi sacrificali, manipolando più volte il senso, i contesti, e le postille della Scrittura.
Ovviamente, parte consistente delle offerte così gonfiate rimanevano al ceto che si occupava dei riti.
Tutto ciò, a spese d’una concezione appiattita sullo stile cultuale propiziatorio e (supposto) taumaturgico, il quale investiva ogni aspetto della vita ordinaria della gente.
Moltitudine resa schiava dalla visione imposta - in sé infantile - algida forse, ma paludosa e irritante.
All’epoca di Mc alcuni giudei convertiti ritenevano di poter abbandonare gli antichi costumi e avvicinarsi ai pagani; altri erano di opinione opposta: sarebbe stato come rigettare parti consistenti della Torah [es: Lv 11-16 e 17ss].
Infatti Mc sottolinea che il problema è «in Casa» (v.17 testo greco: dentro casa) ossia nella Chiesa e fra i suoi intimi [la traduzione CEI recita in “una” casa].
Un posto dove paradossalmente ancora non si capisce il Maestro [!] venuto per liberarci dalle ossessioni inventate e artificiose.
Cristo deve insistere nel suo insegnamento, ora non rivolto a degli estranei, ma proprio agli habitué, incapaci - al contrario delle folle - di «comprendere» (v.14) perfino i rudimenti delle cose spirituali.
Per educare i testardi ancora «privi d’intelletto» (v.18) che si ritengono maestri, non si dirige in una dimora qualsiasi, ma esattamente nel posto dove purtroppo si coltivano aspettative talora ben lontane dal popolo (vv.14.17).
L’evangelista rigetta la distinzione tra la sfera religiosa della vita e un assetto quotidiano “contaminato”; fonte di corruzione. Ma normale, spicciolo, sommario - per questo valutato distante dal “divino”.
Quintessenza che viceversa non intende soggiogare nessuno.
Le prescrizioni restano insufficienti a darci accesso a Dio: esse non sono che simboli, traiettorie, e immagini.
La presenza attiva di un Ordine nuovo abolisce le prescrizioni legali, e sposta il centro della moralità dei nostri atti.
Qui si richiama l’insegnamento di Gesù: l’impurità non viene dall’esterno [ossia da fuori a dentro].
Non è quella la minaccia per la vita della donna, dell’uomo, e della comunità, secondo il disegno senza trucchi di Dio.
Le realtà del mondo non sono mai scellerate e inadatte - neanche al culto.
Diventano obbrobrio solo passando attraverso decisioni queste sì sacrileghe, perché bloccano la vita. E distacchi che imbarbariscono.
La canonicità del bigotto e talare non c’entra nulla con la divinizzazione, la quale viceversa fa rima con ciò che è concretamente umanizzante.
Il dibattito sul puro e impuro non va collocato sul piano delle cose [ad es. dei cibi che vanno fino allo stomaco] bensì del comportamento, che parte e va fino al cuore. Luogo non sempre sereno e ben “ordinato”.
Non vi sono apriorismi sacri: non basta che un luogo, una casa, degli oggetti, una persona... siano stati legittimati da cerimonie o addirittura scambi, perché diventino intoccabili, onesti ed eminenti.
In tal guisa, non vi è sacro e profano in sé.
Mistero e Beatitudine vengono al mondo esclusivamente attraverso il canale del dialogo e dell’incontro nel rispetto dell’intelligenza, dell’anima personale, e delle culture difformi. Non percorrendo entità di meriti, né strettoie travisate.
La santificazione è legata alla condotta. E nei casi di coerenza, persino all’insuccesso, all’angoscia, alle frustrazioni, che derivano da scelte di campo impegnative.
Sono decisioni le quali mettono a repentaglio, e talora ci ridicolizzano nel paragone con il costume delle autenticazioni obbligate - ove talora sembra che sia necessario eludere la vita. O non sei “nessuno”.
Qui il legalismo formale purtroppo uccide qualsivoglia dilatarsi delle risorse e degli ideali.
Insomma, impuro è ciò che avvelena l'esistenza e la realizzazione spontanea delle persone, le loro relazioni, e la creazione stessa.
Eppure sono le imperfezioni a renderci nuovi, eccezionali, unici!
Gesù apre una nuova Via per far avvicinare tutti noi malfermi a Dio, agli altri persino lontani, e a se stessi - senza esclusioni puritane.
Quando ad es. non ci accettiamo così come siamo - dentro, o in campo, non accogliendo il diverso e l’opposto - perché nell’opinione comune “non va bene”, rischiamo di trasformare l’insoddisfazione in un clima d’intimo assillo.
Perfino il religioso senso d’impurezza ci porterà dall’agitazione al disastro.
Ma fuori dall’impegno per l’amicizia con noi stessi, con le cose create, e lo spirito di fraternità, di convivialità dei contrari, la paura di contaminarsi è infondata.
Anzi, siamo chiamati a voler bene ai limiti: sono il terreno anche scomposto e impudico di energie preparatorie della reale fioritura.
Sono impulsi e segni primordiali del nostro compito nel mondo secondo la Novità di Dio.
Ogni Esodo valorizza le alternative.
E troviamo la realizzazione, il senso della vita, nonché via via maggiore completezza, incontrando appunto i nostri lati opposti.
Chiunque intimorisce il fratello “inadeguato” minaccia la vita del cosmo e rende sfiduciate proprio le persone più sensibili e attente.
Gesù libera la folla dei senza voce, degli smarriti, dall’ossessione di apprensioni e timori, dallo stare sempre sulla difensiva.
Non siamo chiamati a fissarci in una direzione. Ce ne sono altre.
Impariamo dunque a non provare sgomento per il fatto che non siamo religiosamente “riusciti” - bensì Primizia!
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Cosa ritieni ti renda presentabile in società? In che senso sei impeccabile - perché imbellettato e conforme all’opinione?
Essere “figlio” e “primizia” ti fa stare sulla difensiva o restituisce voglia di vivere in pienezza?
L’ingiustizia non ha radici esclusivamente esterne
L’evangelista Marco riporta le seguenti parole di Gesù, che si inseriscono nel dibattito di allora circa ciò che è puro e ciò che è impuro: “Non c'è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro... Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male” (Mc 7,14-15.20-21). Al di là della questione immediata relativa al cibo, possiamo scorgere nella reazione dei farisei una tentazione permanente dell’uomo: quella di individuare l’origine del male in una causa esteriore. Molte delle moderne ideologie hanno, a ben vedere, questo presupposto: poiché l’ingiustizia viene “da fuori”, affinché regni la giustizia è sufficiente rimuovere le cause esteriori che ne impediscono l’attuazione. Questo modo di pensare - ammonisce Gesù - è ingenuo e miope. L’ingiustizia, frutto del male, non ha radici esclusivamente esterne; ha origine nel cuore umano, dove si trovano i germi di una misteriosa connivenza col male. Lo riconosce amaramente il Salmista: “Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre” (Sal 51,7). Sì, l’uomo è reso fragile da una spinta profonda, che lo mortifica nella capacità di entrare in comunione con l’altro. Aperto per natura al libero flusso della condivisione, avverte dentro di sé una strana forza di gravità che lo porta a ripiegarsi su se stesso, ad affermarsi sopra e contro gli altri: è l’egoismo, conseguenza della colpa originale. Adamo ed Eva, sedotti dalla menzogna di Satana, afferrando il misterioso frutto contro il comando divino, hanno sostituito alla logica del confidare nell’Amore quella del sospetto e della competizione; alla logica del ricevere, dell’attendere fiducioso dall’Altro, quella ansiosa dell’afferrare e del fare da sé (cfr Gen 3,1-6), sperimentando come risultato un senso di inquietudine e di incertezza. Come può l’uomo liberarsi da questa spinta egoistica e aprirsi all’amore?
[Papa Benedetto, Messaggio per la Quaresima 2010]
Nuovo significato di Purezza
Tradizione anticotestamentaria e nuovo significato di “purezza”
1. Un indispensabile completamento delle parole pronunziate da Cristo nel Discorso della montagna sulle quali abbiamo centrato il ciclo delle nostre presenti riflessioni, dovrà essere l’analisi della purezza. Quando Cristo, spiegando il giusto significato del comandamento "Non commettere adulterio", fece richiamo all’uomo interiore, specificò al tempo stesso la dimensione fondamentale della purezza, con cui vanno contrassegnati i reciproci rapporti tra l’uomo e la donna nel matrimonio e fuori del matrimonio. Le parole: "Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore" (Mt 5,27-28) esprimono ciò che contrasta con la purezza. Ad un tempo, queste parole esigono la purezza che nel Discorso della montagna è compresa nell’enunciato delle beatitudini: "Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio" (Mt 5,8). In tal modo Cristo rivolge al cuore umano un appello: lo invita, non lo accusa, come già abbiamo precedentemente chiarito.
2. Cristo vede nel cuore, nell’intimo dell’uomo la sorgente della purezza - ma anche dell’impurità morale - nel significato fondamentale e più generico della parola. Ciò è confermato, ad esempio, dalla risposta data ai farisei, scandalizzati per il fatto che i suoi discepoli "trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo" (Mt 15,2). Gesù disse allora ai presenti: "Non quello che entra nella bocca rende impuro l’uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l’uomo" (Mt 15,11). Ai suoi discepoli, invece, rispondendo alla domanda di Pietro, così spiegò queste parole: "...ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l’uomo. Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l’uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende immondo l’uomo" (cf. Mt 15,18-20; cf. Mc 7,20-23).
Quando diciamo "purezza", "puro", nel significato primo di questi termini, indichiamo ciò che contrasta con lo sporco. "Sporcare" significa "rendete immondo", "inquinare". Ciò si riferisce ai diversi ambiti del mondo fisico. Si parla, ad esempio, di una "strada sporca", di una "stanza sporca", si parla anche dell’"aria inquinata". È così pure, anche l’uomo può essere "immondo", quando il suo corpo non è pulito. Per togliere le lordure del corpo, bisogna lavarlo. Nella tradizione dell’Antico Testamento si attribuiva una grande importanza alle abluzioni rituali, ad esempio il lavarsi le mani prima di mangiare, di cui parla il testo citato. Numerose e particolareggiate prescrizioni riguardavano le abluzioni del corpo in rapporto all’impurità sessuale, intesa in senso esclusivamente fisiologico, a cui abbiamo accennato in precedenza (cf. Lv 15 ). Secondo lo stato della scienza medica del tempo, le varie abluzioni potevano corrispondere a prescrizioni igieniche. In quanto erano imposte in nome di Dio e contenute nei Libri Sacri della legislazione anticotestamentaria, l’osservanza di esse acquistava, indirettamente, un significato religioso; erano abluzioni rituali e, nella vita dell’uomo dell’Antica Alleanza, servivano alla "purezza" rituale.
3. In rapporto alla suddetta tradizione giuridico-religiosa dell’Antica Alleanza si è formato un modo erroneo di intendere la purezza morale(1). La si capiva spesso in modo esclusivamente esteriore e "materiale". In ogni caso, si diffuse una tendenza esplicita ad una tale interpretazione. Cristo vi si oppone in modo radicale: nulla rende l’uomo immondo "dall’esterno", nessuna sporcizia "materiale" rende l’uomo impuro in senso morale, ossia interiore. Nessuna abluzione, neppure rituale, è idonea di per sé a produrre la purezza morale. Questa ha la sua sorgente esclusiva nell’interno dell’uomo: essa proviene dal cuore. È probabile che le rispettive prescrizioni dell’Antico Testamento (quelle, ad esempio, che si trovano nel Levitico) ( Lv 15,16-24 ; 18,1ss ; 12,1-5 ) servissero, oltre che a fini igienici, anche ad attribuire una certa dimensione di interiorità a ciò che nella persona umana è corporeo e sessuale. In ogni caso Cristo si è ben guardato dal collegare la purezza in senso morale (etico) con la fisiologia e con i relativi processi organici. Alla luce delle parole di Matteo 15,18-20, sopra citate, nessuno degli aspetti dell’"immondezza" sessuale, nel senso strettamente somatico, biofisiologico, entra di per sé nella definizione della purezza o della impurità in senso morale (etico).
4. Il suddetto enunciato ( Mt 15,18-20 ) è soprattutto importante per ragioni semantiche. Parlando della purezza in senso morale, cioè della virtù della purezza, ci serviamo di un’analogia, secondo la quale il male morale viene paragonato appunto alla immondezza. Certamente tale analogia è entrata a far parte, fin dai tempi più remoti, dell’ambito dei concetti etici. Cristo la riprende e la conferma in tutta la sua estensione: "Ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l’uomo". Qui Cristo parla di ogni male morale, di ogni peccato, cioè di trasgressioni dei vari comandamenti, ed enumera "i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie", senza limitarsi ad uno specifico genere di peccato. Ne deriva che il concetto di "purezza" e di "impurità" in senso morale è anzitutto un concetto generale, non specifico: per cui ogni bene morale è manifestazione di purezza, ed ogni male morale è manifestazione di impurità. L’enunciato di Matteo 15,18-20 non restringe la purezza ad un unico settore della morale, ossia a quello connesso al comandamento "Non commettere adulterio" e "Non desiderare la moglie del tuo prossimo", cioè a quello che riguarda i rapporti reciproci tra l’uomo e la donna, legati al corpo e alla relativa concupiscenza. Analogamente possiamo anche intendere la beatitudine del Discorso della montagna, rivolta agli uomini "puri di cuore", sia in senso generico, sia in quello più specifico. Soltanto gli eventuali contesti permetteranno di delimitare e di precisare tale significato.
5. Il significato più ampio e generale della purezza è presente anche nelle lettere di San Paolo, in cui gradualmente individueremo i contesti che, in modo esplicito, restringono il significato della purezza all’ambito "somatico" e "sessuale", cioè a quel significato che possiamo cogliere dalle parole pronunziate da Cristo nel Discorso della montagna sulla concupiscenza, che si esprime già nel "guardare la donna", e viene equiparata ad un "adulterio commesso nel cuore" (cf. Mt 5,27-28 ).
Non è San Paolo l’autore delle parole sulla triplice concupiscenza. Esse, come sappiamo, si trovano nella prima lettera di Giovanni. Si può, tuttavia, dire che analogamente a quella che per Giovanni ( 1Gv 2,16-17 ) è contrapposizione all’interno dell’uomo tra Dio e il mondo (tra ciò che viene "dal Padre" e ciò che viene "dal mondo") - contrapposizione che nasce nel cuore e penetra nelle azioni dell’uomo come"concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne e superbia della vita" - San Paolo rileva nel cristiano un’altra contraddizione: l’opposizione e insieme la tensione tra la "carne" e lo "Spirito" (scritto con la maiuscola, cioè lo Spirito Santo): "Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne; la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste" ( Gal 5,16-17 ). Ne consegue che la vita "secondo la carne" è in opposizione alla vita "secondo lo Spirito". "Quelli infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito" ( Rm 8,5 ).
Nelle successive analisi cercheremo di mostrare che la purezza - la purezza di cuore, di cui ha parlato Cristo nel Discorso della montagna - si realizza propriamente nella vita "secondo lo Spirito".
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 10 dicembre 1980]
Riportare la Fede al suo centro. Non trucchiamo l’anima
Il Vangelo della Liturgia di oggi mostra alcuni scribi e farisei stupiti dall’atteggiamento di Gesù. Sono scandalizzati perché i suoi discepoli prendono cibo senza compiere prima le tradizionali abluzioni rituali. Pensano tra sé: “Questo modo di fare è contrario alla pratica religiosa” (cfr Mc 7,2-5).
Anche noi potremmo chiederci: perché Gesù e i suoi discepoli trascurano queste tradizioni? In fondo non sono cose cattive, ma buone abitudini rituali, semplici lavaggi prima di prendere cibo. Perché Gesù non ci bada? Perché per Lui è importante riportare la fede al suo centro. Nel Vangelo lo vediamo continuamente: questo riportare la fede al centro. Ed evitare un rischio, che vale per quegli scribi come per noi: osservare formalità esterne mettendo in secondo piano il cuore della fede. Anche noi tante volte ci “trucchiamo” l’anima. La formalità esterna e non il cuore della fede: questo è un rischio. È il rischio di una religiosità dell’apparenza: apparire per bene fuori, trascurando di purificare il cuore. C’è sempre la tentazione di “sistemare Dio” con qualche devozione esteriore, ma Gesù non si accontenta di questo culto. Gesù non vuole esteriorità, vuole una fede che arrivi al cuore.
Infatti, subito dopo, richiama la folla per dire una grande verità: «Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro» (v. 15). Invece, è «dal di dentro, dal cuore» (v. 21) che nascono le cose cattive. Queste parole sono rivoluzionarie, perché nella mentalità di allora si pensava che certi cibi o contatti esterni rendessero impuri. Gesù ribalta la prospettiva: non fa male quello che viene da fuori, ma quello che nasce da dentro.
Cari fratelli e sorelle, questo riguarda anche noi. Spesso pensiamo che il male provenga soprattutto da fuori: dai comportamenti altrui, da chi pensa male di noi, dalla società. Quante volte incolpiamo gli altri, la società, il mondo, per tutto quello che ci accade! È sempre colpa degli “altri”: è colpa della gente, di chi governa, della sfortuna, e così via. Sembra che i problemi arrivino sempre da fuori. E passiamo il tempo a distribuire colpe; ma passare il tempo a incolpare gli altri è perdere tempo. Si diventa arrabbiati, acidi e si tiene Dio lontano dal cuore. Come quelle persone del Vangelo, che si lamentano, si scandalizzano, fanno polemica e non accolgono Gesù. Non si può essere veramente religiosi nella lamentela: la lamentela avvelena, ti porta alla rabbia, al risentimento e alla tristezza, quella del cuore, che chiude le porte a Dio.
Chiediamo oggi al Signore che ci liberi dal colpevolizzare gli altri – come i bambini: “No, io non sono stato! È l’altro, è l’altro…” –. Domandiamo nella preghiera la grazia di non sprecare tempo a inquinare il mondo di lamentele, perché questo non è cristiano. Gesù ci invita piuttosto a guardare la vita e il mondo a partire dal nostro cuore. Se ci guardiamo dentro, troveremo quasi tutto quello che detestiamo fuori. E se, con sincerità, chiederemo a Dio di purificarci il cuore, allora sì che cominceremo a rendere più pulito il mondo. Perché c’è un modo infallibile per vincere il male: iniziare a sconfiggerlo dentro di sé. I primi Padri della Chiesa, i monaci, quando si domandava loro: “Qual è la strada della santità? Come devo incominciare?”, il primo passo, dicevano, era accusare sé stessi: accusa te stesso. L’accusa di noi stessi. Quanti di noi, nella giornata, in un momento della giornata o in un momento della settimana, sono capaci di accusare sé stessi dentro? “Sì, questo mi ha fatto questo, quell’altro… quello una barbarità…”. Ma io? Io faccio lo stesso, o io lo faccio così... È una saggezza: imparare ad accusare sé stessi. Provate a farlo, vi farà bene. A me fa bene, quando riesco a farlo, ma fa bene, a tutti farà bene.
La Vergine Maria, che ha cambiato la storia attraverso la purezza del suo cuore, ci aiuti a purificare il nostro, superando anzitutto il vizio di colpevolizzare gli altri e di lamentarci di tutto.
[Papa Francesco, Angelus 29 agosto 2021]
Purezza dell’avvantaggiare, non del modello di perfezione
Tradizioni o idee ipocrite, e ordine ideale
(Mc 7,1-13)
La religiosità può ingannare l’ordine ideale; la vita di Fede lo promuove, facendo leva su una perfezione e purezza derivate dalla dimensione umana - del buon senso e dell’accorgersi.
È così che si migliora e si redime il mondo: unendosi con la Shekhinah del Padre; non arroccandosi in un fortino, come fossimo in una tana.
E l’avventura piena, oltre i confini, nello Spirito, ci fa sentire belli dentro, invece che malati da curare; anzi, capaci di dare spazio alla magia del Divino in noi stessi e nelle relazioni.
Senza mai sentirsi assediati, i ‘figli’ reagiscono spontaneamente agli accadimenti - con innumerevoli iniziative benefiche personalizzanti, estranee a qualsiasi abitudine, concatenazione, nomenclatura.
Sotto la dinastia degli Erode il senso del clan e della comunità si stavano sgretolando.
Causa problemi di sopravvivenza, le famiglie erano costrette a chiudersi in se stesse, allentare i legami, pensare a proprie necessità.
Tale chiusura era rafforzata dalla devozione dell’epoca sotto ogni aspetto. Ai vv.10-12 ne vediamo un esempio incredibile: chi dedicava la propria eredità al Tempio poteva lasciare i genitori privi d’aiuto!
Offesa e offerta: ingiustizia e comportamento normativo - strano legame, nell’apparente forma dall’accento esemplare.
L’osservanza delle norme di purità era fattore di ordinaria emarginazione per molte persone.
Proprio i miseri venivano considerati in specie ignoranti e maledetti, perché impossibilitati all’adempimento globale; di conseguenza manchevoli a ricevere la consolante benedizione promessa ad Abramo.
Uno stillicidio quotidiano che minava il significato profondo dell’esistere assieme.
In particolare, le abluzioni erano una sorta di rito durante il quale si celebrava un’appagante divaricazione tra sacro e profano - nel distacco da persone e situazioni considerate impure.
Stando fuori dalle supposte sozzure, mai nessuno dei malfermi poteva essere risollevato.
Quindi le norme non erano fonte di pace, bensì di schiavitù. Porgere una mano caritatevole sarebbe stato perfino sacrilego.
Insomma, si anteponevano inezie disumane alla stessa Legge, vanificandone lo spirito comprensivo [fraternità che avrebbe accentuato l’entusiasmo di esistere].
Calate in quel contesto, le persone abbracciavano solo percorsi che già conoscevano.
La donna e l’uomo smarrivano il senso del loro esistere poliedrico. E la vita senza i “contrari” affievoliva l’Esodo del popolo tutto.
«Bellamente annullate il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione» (Mc 7,9).
Gesù non sopporta che il mondo chiuso della religiosità conformista venga piegato e usato per annientare i rapporti.
Per questo al controllo dei farisei si oppone la libertà dei discepoli (v.2), che rifiutano di obbedire a ciò che non ha senso per la vita concreta - dove passa l’amore visibile che alimenta l’amore ideale.
Il Maestro e Signore insegna che il vero culto è Vicinanza. In tal guisa, nel solco della Parola c’è una tappa e un intero ordine nuovo, che conquista all’interiorità tutti i nessi esterni.
Autentica ‘estasi’ è la ‘purezza dell’avvantaggiare tutti’ - non l’autocompiacimento del modello di perfezione.
[Martedì 5.a sett. T.O. 10 febbraio 2026]
Purezza dell’avvantaggiare, non del modello di perfezione
Tradizioni o idee ipocrite, e ordine ideale
(Mc 7,1-13)
«Non è troppo piccolo il cuore del credente per Colui al quale non bastò il tempio di Salomone. Noi infatti siamo il tempio del Dio vivo. Come è scritto: “Abiterò in mezzo a loro”.
Se un personaggio importante ti dicesse: “Verrò ad abitare da te”, che cosa faresti? Se la tua casa è piccola, non c’è dubbio che rimarresti sconcertato, ti spaventeresti, preferiresti che la cosa non avvenisse. Ma tu non temere la venuta di Dio, non temere il desiderio del tuo Dio. Non ti riduce lo spazio, quando viene. Al contrario, venendo sarà lui a dilatarti» (S. Agostino, Discorso 23,7).
La religiosità può ingannare l’ordine ideale; la vita di Fede lo promuove, facendo leva su una perfezione e purezza derivate semplicemente dalla dimensione umana - del buon senso e dell’accorgersi.
È così che si migliora e si redime il mondo: unendosi con la Shekhinah del Padre; non arroccandosi in un fortino, come fossimo in una tana.
E l’avventura piena, oltre i confini, nello Spirito, ci fa sentire belli dentro, invece che malati da curare; anzi, capaci di dare spazio alla magia del Divino in noi stessi e nelle relazioni.
Senza mai sentirsi assediati, i figli reagiscono spontaneamente agli accadimenti - con innumerevoli iniziative benefiche personalizzanti, estranee a qualsiasi abitudine, concatenazione, nomenclatura.
Sotto la dinastia degli Erode il senso del clan e della comunità si stavano sgretolando.
Pur sentendo il costante richiamo del Tempio, a motivo delle necessità impellenti non si era più aperti alla comunione.
Troppe le tasse da pagare, sia al governo che alla Casa di Dio.
Così i debiti aumentavano, accentuando problemi di sopravvivenza e sfilacciando la fraternità di parentela e la solidarietà di stirpe.
Le famiglie erano costrette a chiudersi in se stesse, allentare i legami, diradare la partecipazione alle riunioni e pensare alle proprie necessità.
Tale chiusura era rafforzata dalla devozione dell’epoca sotto ogni aspetto, e qui (vv.9-13) ne vediamo un esempio incredibile: chi dedicava la propria eredità al Tempio poteva lasciare i propri genitori privi d’aiuto!
Foto di un credo che rinnegava il comandamento di Dio in nome di Dio: korbàn [offerta fatta a Dio] senza pietà.
Spietatezza rituale priva di qualsiasi barlume di cordialità - però religiosamente connesse.
Offesa e offerta: ingiustizia e comportamento normativo.
Strano legame reciproco, tra due bussole poco affini - nell’apparente forma dall’accento esemplare, devoto, perbenista, longanime, confidente e pio.
«Bellamente annullate il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione» (Mc 7,9).
L’osservanza delle norme di purità era fattore di ordinaria emarginazione per molte persone: donne, bambini, malati, stranieri, poveri.
Era la situazione reale più sgradevole per la (vera) sacralità della vita, per il suo incanto - sottoposto a una specie di scuola dell’obbligo, tutta distante dai malfermi.
Proprio i miseri venivano considerati in specie ignoranti e maledetti, perché impossibilitati all’adempimento globale. Di conseguenza, manchevoli a ricevere la consolante benedizione promessa ad Abramo.
Uno stillicidio quotidiano che minava il significato profondo dell’esistere assieme.
In particolare, le abluzioni erano una sorta di rito durante il quale si celebrava un’appagante divaricazione tra sacro e profano - la Santità - nel distacco da persone e situazioni considerate impure.
Stando fuori dalle supposte sozzure, mai nessuno poteva essere risollevato.
Quindi le norme non erano fonte di pace, bensì di schiavitù: come sopra accennato, coloro che non potevano osservarle venivano considerati ignobili, non-persone.
Porgere una mano caritatevole sarebbe stato perfino sacrilego.
Insomma, si anteponevano inezie disumane alla stessa Legge, vanificandone lo spirito comprensivo [fraternità che avrebbe accentuato l’entusiasmo di esistere].
Poi, sia i limiti stretti che le posizioni estreme portavano all’incoerenza di chi svuotava il contenuto della Parola e impediva di attivare un percorso diverso per raggiungere l’autenticità della purezza.
“Perfezione” doveva essere: immersione nel dialogo, invece che quel precipitare in una ideologia eticista esterna. E in tal guisa lasciarsi sprofondare da lacciuoli sacrali che accentuassero stati esclusivi, di autocompiacimento, esaltazione - o assuefazione.
Calati in quel contesto sterilizzato e umiliante ogni iniziativa, l’identificazione prevaleva su qualsivoglia vocazione o destino missionario.
Ingannate e ingabbiate da cappe unidirezionali, le persone abbracciavano solo percorsi che già conoscevano.
La donna e l’uomo smarrivano il senso del loro esistere poliedrico. E la vita senza i “contrari” affievoliva l’Esodo del popolo tutto.
Gesù non sopportava che il mondo chiuso della religiosità potesse esser piegato e usato per controllare, dividere e discriminare - annientare il cammino e i rapporti.
I soddisfatti in tal senso diventavano fonte di mediocrità, ovunque - mentre come anche noi sappiamo, la Gioia è frutto di Liberazione; non di percorsi unilaterali.
Il senso di completezza è legato alla valorizzazione delle differenze. Ciò riguarda sia le vicende personali che sociali.
Lo sappiamo infallibilmente, per sapienza di Natura.
Dice infatti il Tao Tê Ching (LXXXI): «La Via del Cielo è di avvantaggiare, e di non danneggiare».
Dappertutto incontriamo i nostri allarmi personali, o crucci materiali; mille occupazioni che distraggono. Anche progetti per la qualità delle relazioni - forse ancora mescolate con l’imparaticcio di usi venerandi o la page [espedienti senza correlazione] che ci debilitano.
Per questo, al controllo dei farisei si oppone la libertà dei discepoli (v.2), che rifiutano di obbedire a ciò che non ha senso per la vita reale - dove passa l’amore visibile che alimenta l’amore ideale.
Gesù insegna che il vero culto è vicinanza e autenticità pratica, non osservanza letterale ai modelli o alle dottrine cerebrali.
Nel solco della Parola c’è una tappa e un intero ordine nuovo, che conquista all’interiorità tutti i nessi esterni.
Egli collega rito e azione, fede e amore, prescrizione consuetudinaria e obbligo intimo.
Unico comando in grado di purificare e farci immagine e somiglianza di Persona che sa incontrare il suo opposto, secondo l’unità in Spirito del culto.
Quando accogliamo l’appello dei Vangeli riconoscendolo quale stimolo che corrisponde e costruisce convivialità delle differenze, ci sentiamo meno duri e orgogliosi.
Se viceversa restiamo distanti, andremo in chiesa inciampando con le tradizioni o con idee nuove pur grandi, ma senza rapportarci col disegno di salvezza del Padre.
L’Eterno non vuole scippare le nostre capacità, ma spalancare al bene e all’autentica estasi.
Purezza dell’avvantaggiare - non del modello di perfezione.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Qual è il senso della purezza insegnata da Gesù?
La tua fede è vicina o lontana dalla vita?
Ed ecco il problema
Ed ecco il problema: quando il popolo si stabilisce nella terra, ed è depositario della Legge, è tentato di riporre la sua sicurezza e la sua gioia in qualcosa che non è più la Parola del Signore: nei beni, nel potere, in altre ‘divinità’ che in realtà sono vane, sono idoli. Certo, la Legge di Dio rimane, ma non è più la cosa più importante, la regola della vita; diventa piuttosto un rivestimento, una copertura, mentre la vita segue altre strade, altre regole, interessi spesso egoistici individuali e di gruppo. E così la religione smarrisce il suo senso autentico che è vivere in ascolto di Dio per fare la sua volontà - che è la verità del nostro essere - e così vivere bene, nella vera libertà, e si riduce a pratica di usanze secondarie, che soddisfano piuttosto il bisogno umano di sentirsi a posto con Dio. Ed è questo un grave rischio di ogni religione, che Gesù ha riscontrato nel suo tempo, ma che si può verificare, purtroppo, anche nella cristianità. Perciò le parole di Gesù nel Vangelo di oggi contro gli scribi e i farisei devono far pensare anche noi.
[Papa Benedetto, Angelus 2 settembre 2012]
Due carte d’identità
Per conoscere la nostra vera identità non possiamo essere «cristiani seduti» ma dobbiamo avere il «coraggio di metterci sempre in cammino per cercare il volto del Signore», perché noi siamo «immagine di Dio». Nella messa celebrata a Santa Marta martedì 10 febbraio, Papa Francesco, commentando la prima lettura liturgica — il racconto della creazione nel libro della Genesi (1, 20 - 2, 4) — ha riflettuto su una domanda essenziale per ogni persona: «Chi sono io?».
La nostra «carta d’identità», ha detto il Papa, si ritrova nel fatto che gli uomini sono stati creati «all’immagine, secondo la somiglianza di Dio». Ma allora, ha aggiunto, «la domanda che noi possiamo farci è: Come conosco, io, l’immagine di Dio? Come so com’è lui per sapere come sono io? Dove trovo l’immagine di Dio?». La risposta si trova «certamente non sul computer, non nelle enciclopedie, non nei libri», perché «non c’è un catalogo dove c’è l’immagine di Dio». C’è solo un modo «per trovare l’immagine di Dio, che è la mia identità» ed è quello di mettersi in cammino: «Se non ci mettiamo in cammino, mai potremo conoscere il volto di Dio».
Questo desiderio di conoscenza si ritrova anche nell’Antico testamento. I salmisti, ha fatto notare Francesco, «tante volte dicono: io voglio conoscere il tuo volto»; e «anche Mosè una volta l’ha detto al Signore». Ma in realtà «non è facile, perché mettersi in cammino significa lasciare tante sicurezze, tante opinioni di come è l’immagine di Dio, e cercarlo». Significa, in altri termini, «lasciare che Dio, la vita, ci metta alla prova», significa «rischiare», perché «soltanto così si può arrivare a conoscere il volto di Dio, l’immagine di Dio: mettendosi in cammino».
Il Papa ha attinto ancora all’Antico testamento per ricordare che «così ha fatto il popolo di Dio, così hanno fatto i profeti». Per esempio «il grande Elia: dopo aver vinto e purificato la fede di Israele, lui sente la minaccia di quella regina e ha paura e non sa cosa fare. Si mette in cammino. E a un certo punto, preferisce morire». Ma Dio «lo chiama, gli dà da mangiare, da bere e dice: continua a camminare». Così Elia «arriva al monte e lì trova Dio». Il suo è stato dunque «un lungo cammino, un cammino penoso, un cammino difficile», ma ci insegna che «chi non si mette in cammino, mai conoscerà l’immagine di Dio, mai troverà il volto di Dio». È una lezione per tutti noi: «i cristiani seduti, i cristiani quieti — ha affermato il Pontefice — non conosceranno il volto di Dio». Hanno la presunzione di dire: «Dio è così, così...», ma in realtà «non lo conoscono».
Per camminare, invece, «è necessaria quella inquietudine che lo stesso Dio ha messo nel nostro cuore e che ti porta avanti a cercarlo». La stessa cosa, ha spiegato il Pontefice, è successa «a Giobbe che, con la sua prova, ha incominciato a pensare: ma come è Dio, che permette questo a me?». Anche i suoi amici «dopo un grande silenzio di giorni, hanno incominciato a parlare, a discutere con lui». Ma tutto ciò non è stato utile: «con questi argomenti, Giobbe non ha conosciuto Dio». Invece «quando lui si è lasciato interpellare dal Signore nella prova, ha incontrato Dio». E proprio da Giobbe si può ascoltare «quella parola che ci aiuterà tanto in questo cammino di ricerca della nostra identità: “Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto”». È questo il cuore della questione secondo Francesco: «l’incontro con Dio» che può avvenire «soltanto mettendosi in cammino».
Certo, ha continuato, «Giobbe si è messo in cammino con una maledizione», addirittura «ha avuto il coraggio di maledire la vita e la sua storia: “Maledetto il giorno che sono nato...”». In effetti, ha riflettuto il Papa, «a volte, nel cammino della vita, non troviamo un senso alle cose». La stessa esperienza è stata vissuta dal profeta Geremia, il quale «dopo essere stato sedotto dal Signore, sente quella maledizione: “Ma perché a me?”». Egli voleva «restarsene seduto tranquillo» e invece «il Signore voleva fargli vedere il suo volto».
Questo vale per ognuno di noi: «per conoscere la nostra identità, conoscere l’immagine di Dio, bisogna mettersi in cammino», essere «inquieti, non quieti». Proprio questo «è cercare il volto di Dio».
Papa Francesco si è quindi riferito anche al passo del Vangelo di Marco (7, 1-13), nel quale «Gesù incontra gente che ha paura di mettersi in cammino» e che costruisce una sorta di «caricatura di Dio». Ma quella «è una falsa carta d’identità» perché, ha spiegato il Pontefice, «questi non-inquieti hanno fatto tacere l’inquietudine del cuore: dipingono Dio con i comandamenti» ma così facendo «si dimenticano di Dio» per osservare solo «la tradizione degli uomini». E «quando hanno un’insicurezza, inventano o fanno un altro comandamento». Gesù dice a scribi e farisei che accumulano comandamenti: «Così voi annullate la Parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi, e di cose simili ne fate molte». Proprio questa «è la falsa carta d’identità, quella che possiamo avere senza metterci in cammino, quieti, senza l’inquietudine del cuore».
In proposito il Papa ha messo in evidenza un particolare «curioso»: il Signore infatti «li loda ma li rimprovera dove c’è il punto più dolente. Li loda: “Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per osservare la vostra tradizione”», ma poi «li rimprovera lì dove è il punto più forte dei comandamenti con il prossimo». Gesù ricorda infatti che Mosè disse: «Onora tuo padre e tua madre, e chi maledice il padre o la madre sia messo a morte». E prosegue: «Voi invece dite: se uno dichiara al padre o alla madre che “ciò con cui dovrei aiutarti, cioè darti da mangiare, darti da vestire, darti per comprare le medicine, è Korbàn, offerta a Dio”, non consentite loro di fare più nulla per il padre e la madre». Così facendo «si lavano le mani con il comandamento più tenero, più forte, l’unico che ha una promessa di benedizione». E così «sono tranquilli, sono quieti, non si mettono in cammino». Questa dunque «è l’immagine di Dio che loro hanno». In realtà il loro è un cammino «fra virgolette»: ossia «un cammino che non cammina, un cammino quieto. Rinnegano i genitori, ma compiono le leggi della tradizione che loro hanno fatto».
Concludendo la sua riflessione il vescovo di Roma ha riproposto il senso dei due testi liturgici come «due carte d’identità». La prima è «quella che tutti noi abbiamo, perché il Signore ci ha fatto così», ed è «quella che ci dice: mettiti in cammino e tu avrai conoscenza della tua identità, perché tu sei immagine di Dio, sei fatto a somiglianza di Dio. Mettiti in cammino e cerca Dio». L’altra invece ci rassicura: «No, stai tranquillo: compi tutti questi comandamenti e questo è Dio. Questo è il volto di Dio». Da qui l’auspicio che il Signore «dia a tutti la grazia del coraggio di metterci sempre in cammino, per cercare il volto del Signore, quel volto che un giorno vedremo ma che qui, sulla terra, dobbiamo cercare».
[Papa Francesco, s. Marta, in L’Osservatore Romano 11/02/2015]
Quando il popolo si stabilisce nella Terra
Cari fratelli e sorelle!
Nella Liturgia della Parola […] emerge il tema della Legge di Dio, del suo comandamento: un elemento essenziale della religione ebraica e anche di quella cristiana, dove trova il suo pieno compimento nell’amore (cfr Rm 13,10). La Legge di Dio è la sua Parola che guida l’uomo nel cammino della vita, lo fa uscire dalla schiavitù dell’egoismo e lo introduce nella «terra» della vera libertà e della vita. Per questo nella Bibbia la Legge non è vista come un peso, una limitazione opprimente, ma come il dono più prezioso del Signore, la testimonianza del suo amore paterno, della sua volontà di stare vicino al suo popolo, di essere il suo Alleato e scrivere con esso una storia di amore. Così prega il pio israelita: «Nei tuoi decreti è la mia delizia, / non dimenticherò la tua parola. (…) Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, / perché in essi è la mia felicità» (Sal 119,16.35). Nell’Antico Testamento, colui che a nome di Dio trasmette la Legge al popolo è Mosè. Egli, dopo il lungo cammino nel deserto, sulla soglia della terra promessa, così proclama: «Ora, Israele, ascolta le leggi e le norme che io vi insegno, affinché le mettiate in pratica, perché viviate ed entriate in possesso della terra che il Signore, Dio dei vostri padri, sta per darvi» (Dt 4,1).
Ed ecco il problema: quando il popolo si stabilisce nella terra, ed è depositario della Legge, è tentato di riporre la sua sicurezza e la sua gioia in qualcosa che non è più la Parola del Signore: nei beni, nel potere, in altre ‘divinità’ che in realtà sono vane, sono idoli. Certo, la Legge di Dio rimane, ma non è più la cosa più importante, la regola della vita; diventa piuttosto un rivestimento, una copertura, mentre la vita segue altre strade, altre regole, interessi spesso egoistici individuali e di gruppo. E così la religione smarrisce il suo senso autentico che è vivere in ascolto di Dio per fare la sua volontà - che è la verità del nostro essere - e così vivere bene, nella vera libertà, e si riduce a pratica di usanze secondarie, che soddisfano piuttosto il bisogno umano di sentirsi a posto con Dio. Ed è questo un grave rischio di ogni religione, che Gesù ha riscontrato nel suo tempo, ma che si può verificare, purtroppo, anche nella cristianità. Perciò le parole di Gesù nel Vangelo di oggi contro gli scribi e i farisei devono far pensare anche noi. Gesù fa proprie le parole del profeta Isaia: «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini» (Mc 7,6-7; cfr Is 29,13). E poi conclude: «Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini» (Mc 7,8).
Anche l’apostolo Giacomo, nella sua Lettera, mette in guardia dal pericolo di una falsa religiosità. Egli scrive ai cristiani: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi» (Gc 1,22). La Vergine Maria, alla quale ora ci rivolgiamo in preghiera, ci aiuti ad ascoltare con cuore aperto e sincero la Parola di Dio, perché orienti i nostri pensieri, le nostre scelte e le nostre azioni, ogni giorno.
[Papa Benedetto, Angelus 2 settembre 2012]
Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)
Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)
You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]
Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]
In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)
In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)
Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)
Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)
In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)
Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))
Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.