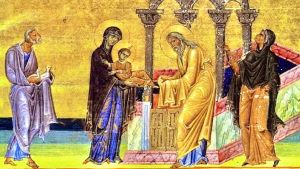don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
III Domenica del Tempo Ordinario (anno A) [25 Gennaio 2026]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Si chiude oggi la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. La parola di Dio offre spunti per alcune considerazioni, specialmente la seconda lettura (narra la situazione della comunità a Corinto con le divisioni dovute alla presenza di vari predicatori).
Il vangelo mostra l’avvio della predicazione di Gesù con i discepoli, che lo accompagneranno lungo tutto il cammino fino a Gerusalemme.
*Prima Lettura dal libro del profeta Isaia (8, 23b - 9, 3)
Al tempo di Isaia, il regno di Israele era diviso in due: il Nord (Israele, capitale Samaria) e il Sud (Giuda, capitale Gerusalemme), legittimo perché erede della dinastia di Davide. Isaia predica a Gerusalemme ma parla soprattutto di luoghi del Nord, come Zabulon, Nephtali, la Galilea e la Transgiordania, territori che furono conquistati dall’impero assiro tra il 732 e il 721 a.C.Il profeta annuncia che Dio trasformerà la situazione: le regioni inizialmente umiliate saranno onorate, come un segno di liberazione e rinascita. Queste promesse interessano anche il Sud, perché la vicinanza geografica fa sì che le minacce sull’uno pesino sull’altro, e perché il Sud spera in una futura riunificazione sotto la propria guida. Isaia descrive la nascita di un re, associando la sua venuta a formule reali di incoronazione: “Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato”(Is.9,5-6). Si tratta del giovane Ezechia, associato al regno del padre, re Achaz, e considerato il «principe della pace». La certezza del profeta si fonda sulla fedeltà di Dio: anche nelle prove e nell’oppressione, Dio non abbandonerà mai la dinastia di Davide. La vittoria promessa ricorda quella di Gedeone sui Madianiti: pur con pochi mezzi, la fede in Dio porta alla liberazione. Il messaggio finale è di speranza: Non temere, Dio non abbandona il suo progetto d’amore sull’umanità, anche nei momenti più oscuri.
*Salmo responsoriale (26/(27)
“Il Signore è la mia luce e la mia salvezza” non è solo un’espressione individuale: riflette la fiducia invincibile del popolo d’Israele in Dio, in ogni circostanza della vita, dalle gioie alle difficoltà. Il salmo utilizza immagini concrete per raccontare la storia collettiva di Israele, un procedimento frequente nei Salmi chiamato rivestimento: il popolo è paragonato a un malato guarito da Dio, a un innocente ingiustamente condannato, a un bambino abbandonato o a un re assediato. Dietro queste immagini individuali si riconoscono situazioni storiche precise: minacce esterne, assedi di città e crisi interne del regno, come l’attacco degli Amaleciti nel deserto, i re di Samaria e Damasco contro Achaz, o il celebre assedio di Gerusalemme da parte di Sennacherib. Il popolo può reagire come Davide, uomo normale e peccatore, ma saldo nella fede, o come Achaz, che cede al panico e perde la fiducia in Dio. In ogni caso, il salmo mostra che la fede collettiva si nutre della fiducia in Dio e della memoria delle sue opere. Un’altra immagine chiave è quella del levita, servo del Tempio: così come i leviti servono Dio quotidianamente, tutto il popolo d’Israele è consacrato al servizio del Signore e appartiene a Lui. Infine, il salmo si conclude con una promessa di speranza: “Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi”; la fiducia è radicata nella memoria delle azioni di Dio e si traduce in coraggio e speranza attiva: “Spera nel Signore, sii forte si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore”. Questa speranza è come la “memoria del futuro”, cioè la certezza che Dio interverrà anche nelle circostanze più oscure. Il salmo è perciò molto adatto alle celebrazioni funebri, perché rinvigorisce la fede e la speranza dei fedeli anche nei momenti di dolore, ricordando loro che Dio non abbandona mai il suo popolo e sostiene sempre coloro che confidano in Lui.
*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Corinti (1, 10 - 13. 17)
Il porto di Corinto, per la sua posizione strategica tra i due mari e per la vivacità dei traffici, era un vero crocevia di culture, idee e popoli. Questo spiega perché i cristiani appena convertiti reagivano in modi diversi agli insegnamenti dei predicatori: ogni viaggiatore portava testimonianze della fede cristiana secondo la propria esperienza, e i Corinzi erano molto sensibili, forse troppo, alle parole belle e alle argomentazioni persuasive. In questo contesto nacquero divisioni nella comunità: alcuni si richiamavano a Paolo, altri ad Apollos, altri a Pietro, e infine un gruppo si diceva “del Cristo”. Paolo non condanna solo i comportamenti sbagliati, ma vede nel fenomeno il rischio di compromettere il senso stesso del battesimo. Apollos, ebreo di Alessandria, è un esempio emblematico: intellettuale, colto nelle Scritture, eloquente e fervente, è stato battezzato con il solo battesimo di Giovanni e perfezionato da Priscilla e Aquila a Efeso. Giunto a Corinto, ottenne un grande successo, ma non cercò mai di diventare un leader personale e, per non alimentare le divisioni, si spostò poi a Efeso. Questo episodio mostra come la passione e le competenze non devono diventare fonte di divisione, ma essere messe al servizio della comunità. Paolo richiama i Corinzi alla verità del battesimo: essere battezzati significa appartenere a Cristo, non a un predicatore umano. Il battesimo è una unione reale e definitiva con Cristo, che agisce attraverso il sacramento: come dice il Concilio Vaticano II, “quando il sacerdote battezza, è Cristo che battezza”. Paolo sottolinea inoltre che la predicazione non deve basarsi sull’eloquenza o su argomenti persuasivi, perché la croce di Cristo e l’amore non si impongono con la forza della parola, ma si vivono e si testimoniano. L’immagine dell’innesto, chiarisce bene questo punto: l’importante è il risultato – l’unione a Cristo – non chi ha amministrato il battesimo. Ciò che conta è la fedeltà al messaggio e all’amore di Cristo, non la competenza retorica o il prestigio personale. In definitiva, il messaggio di Paolo ai Corinzi è universale e attuale: l’unità della comunità cristiana si fonda sulla fede comune in Cristo, non su leader o eloquenze umane, e la vera grandezza della Chiesa sta nella sua coesione spirituale, fondata sul battesimo e sull’appartenenza a Cristo.
*Dal Vangelo secondo Matteo (4, 12-23)
Siamo al capitolo 4 del Vangelo di Matteo. Nei tre capitoli precedenti, Matteo ci ha presentato: prima una lunga genealogia che colloca Gesù nella storia del suo popolo, in particolare nella discendenza di Davide; poi l’annuncio dell’angelo a Giuseppe: “Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio e gli sarà dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi”, citazione di Isaia, con la precisazione che tutto ciò avvenne perché si adempisse ciò che il Signore aveva detto per mezzo del profeta, sottolineando che le promesse sono finalmente compiute e il Messia è arrivato. Gli episodi successivi ribadiscono questo messaggio di compimento: la visita dei Magi, la fuga in Egitto, il massacro dei bambini di Betlemme, il ritorno dall’Egitto e l’installazione a Nazareth, la predicazione di Giovanni Battista, il battesimo di Gesù e le Tentazioni. Tutti questi racconti sono pieni di citazioni e allusioni bibliche. Ora siamo pronti ad ascoltare il testo di oggi, anch’esso ricco di riferimenti: fin dall’inizio, Matteo cita Isaia per mostrare l’importanza dell’insediamento di Gesù a Cafarnao. Cafarnao si trova in Galilea, sulle rive del lago di Tiberiade. Matteo precisa che appartiene ai territori di Zabulon e Neftali: nomi antichi, non più di uso comune, legati alla promessa di Isaia secondo cui queste terre, un tempo umiliate, sarebbero state illuminate dalla gloria della Galilea, «crocevia dei pagani» (Is 8,23). Il profeta continua: “Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto sorgere una grande luce”, formula che ricordava il sacro rituale dell’incoronazione di un re, simbolo di una nuova era. Matteo applica queste parole all’arrivo di Gesù: il vero Re del mondo è venuto; la luce è sorta su Israele e sull’umanità. La Galilea, crocevia delle nazioni, diventa porta aperta al mondo, da cui il Messia diffonderà la salvezza. Inoltre, Matteo prefigura già gli eventi futuri: Gesù si dirige verso la Galilea dopo l’arresto di Giovanni Battista, mostrando che la vita di Cristo sarà segnata dalla persecuzione, ma anche dalla vittoria finale sul male: da ogni ostacolo, Dio farà nascere il bene. Giunto a Cafarnao, Matteo usa l’espressione “Da allora” unica nel Vangelo insieme a un’altra al capitolo 16, segnalando un grande punto di svolta. Qui indica l’inizio della predicazione pubblica: “Convertitevi perché il Regno dei cieli è vicino”. L’altro riferimento al capitolo 16 riguarderà la passione e la risurrezione. Questo episodio segna il passaggio dal tempo della promessa al tempo del compimento. Il Regno è presente, non solo a parole, ma in azione: “Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando inelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo la del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo”. La profezia di Isaia si realizza pienamente: il Regno di Dio è tra noi. Per diffondere questa Buona Novella, Gesù sceglie dei testimoni, uomini comuni, da associare alla missione salvifica. Li chiama “pescatori di uomini”, cioè colui che salva dall’annegamento, simbolo del loro compito di salvezza. Così gli apostoli diventano partecipi della missione del Salvatore.
+ Giovanni D’Ercole
Presentazione a contrasto: Benedizione di Stelle improbabili
Il Signore vuole nuova gente, che ascolta
(Mc 3,31-35)
Nella vita di chi è interpellato dalla relazione di Fede, per diventare consanguinei del Padre secondo lo Spirito è fondamentale Percepire [nel senso profondo di Ascoltare - non tanto materialmente ‘vedere’].
Neppur vale lo «stare fuori», o voler direttamente ‘parlare’, per ‘convincere’ il Signore (vv.31-32).
È necessario intuire e cogliere: un cammino per incontrare i propri strati profondi dell’essere, la verità delle inclinazioni, e della vita.
Decisivo è accogliere una Parola saziante, che si fa linguaggio e cultura, che ha forza creatrice: data alle orecchie e scoperta dentro. Colta nella storia personale e nella realtà, e trasmessa di nuovo.
Allontanarsi da tale Verbo ed Eros fondante significa distaccarsi da se stessi, disperdersi in rivoli che non ci appartengono, precipitare nel vuoto [‘vuoto’ non inteso come stato energetico profondo, che prepara i nuovi sviluppi].
Paradossalmente, sia la nostra Libertà che la Salvezza del mondo sono frutto di una Obbedienza - ma non esteriore, o altrui.
È piuttosto sintonizzarsi sulla parte del Logos in noi che sta fiorendo; davvero “perfetta”. Nessun modello condizionante.
Nessuna correzione a priori, né forzatura secondo pregiudizio: piuttosto, un’eterna Metamorfosi - accompagnata dal Verbo, che misteriosamente guida di Esodo in Esodo.
Nessuna aspettativa culturale configurata congiungerebbe alla piena comunione con la grande scintilla e pienezza divina in ciascuno e tutti.
Realizzazione del Regno e di ogni giorno - anche fuori dal tempo.
Per conoscere Cristo da vicino non basta guardarlo e farsi prendere dalla simpatia o dalla commozione religiosa.
È l’Ascolto che allaccia e instaura legami intimi, che non si spengono - di coinvolgente sintonia col Maestro.
Attorno a Gesù la Parola di Dio crea Famiglia nuova, con vincoli di parentela spirituale più stretti di ciò che offriva il legame di clan.
Il Signore vuole altra gente, che nasca appunto dalla Percezione-presentimento.
Il connubio non è più riservato ed esclusivo; diventa accessibile a chiunque - in qualsiasi condizione si trovi - anche fosse “cieco” esteriore, incapace di scorgere quel che è a portata di mano.
Ciascuno è Chiesa, Casa del Padre, e così può realizzare il Sogno di Dio di abitare con gli uomini e passeggiare affianco.
Egli dimora in mezzo a noi e in noi. Nel suo Verbo, senza più ‘distanze’.
In tal guisa, tutte le nostre azioni devono tendere a questo scopo: formare il Tempio di Dio, la sua casata, il Corpo del Cristo vivente.
Per giungere a tale meta compiuta, mezzo essenziale è ospitare la Vocazione che ci trasforma, fondamento assai più profondo di qualsiasi legame o emozione.
Indispensabile non è un’esperienza (iniziale) di entusiasmo, bensì la custodia della Chiamata che interpreta la vita e diventa mentalità, dinamismo dentro che guida [e sfocia in percorsi di periferia].
C’è ben altro Tempio da edificare.
[Martedì 3.a sett. T.O. 27 gennaio 2026]
Il Signore vuole nuova gente, che ascolta
(Mc 3,31-35)
Nella vita di chi è interpellato dalla relazione di Fede, per diventare consanguinei del Padre secondo lo Spirito è fondamentale farsi discepolo, non «stare fuori» (vv.31-32).
Siamo chiamati a Percepire, nel senso profondo di Ascoltare - non tanto materialmente “vedere” in modo diretto, per poi “convincere” il Signore.
È necessario intuire e cogliere: un cammino per incontrare i propri strati profondi dell’essere, la verità delle inclinazioni, e della vita.
Decisivo è accogliere una Parola saziante, che si fa linguaggio e cultura, che ha forza creatrice: data alle orecchie e scoperta dentro. Colta nella storia personale e nella realtà, e trasmessa di nuovo.
Allontanarsi da tale Verbo ed Eros fondante significa distaccarsi da se stessi, disperdersi in rivoli che non ci appartengono, precipitare nel vuoto [“vuoto” non inteso come stato energetico profondo, che prepara i nuovi sviluppi].
Paradossalmente, sia la nostra Libertà che la Salvezza del mondo sono frutto di una Obbedienza - ma non esteriore, o altrui.
È piuttosto sintonizzarsi sulla parte del Logos in noi che sta fiorendo; davvero “perfetta”. Nessun modello condizionante.
Nessuna correzione a priori, né forzatura secondo pregiudizio: piuttosto, un’eterna Metamorfosi - accompagnata dal Verbo, che misteriosamente guida di Esodo in Esodo.
Nessuna aspettativa “culturale” configurata congiungerebbe alla piena comunione con la grande scintilla e pienezza divina in ciascuno e tutti.
Realizzazione del Regno e di ogni giorno - anche fuori dal tempo.
Per conoscere Cristo non basta guardarlo esteriormente e farsi prendere dalla simpatia o dalla commozione religiosa.
È l’Ascolto, la consuetudine di vita, il coinvolgimento, che allacciano e instaurano legami intimi, d’autentica sintonia col Maestro.
Attorno a Gesù si crea Famiglia nuova, con vincoli di parentela spirituale più saldi di ciò che offriva il legame angusto dei congiunti.
Il Signore vuole altra gente, che nasca appunto dalla Percezione-presentimento.
Il connubio non è più riservato ed esclusivo; diventa accessibile a chiunque e in qualsiasi condizione si trovi - anche fosse “cieco” esteriore, incapace di scorgere quel che è a portata di mano.
Ciascuno è Chiesa, Casa del Padre, e così può realizzare il Sogno di Dio di abitare con gli uomini e passeggiare affianco.
Egli dimora in mezzo a noi e in noi. Nel suo Verbo, senza più “distanze”.
In tal guisa, tutte le nostre azioni devono tendere a questo scopo: formare il Tempio di Dio, la sua casata, il Corpo del Cristo vivente.
Per giungere a tale meta compiuta, mezzo essenziale è ospitare la Vocazione che ci trasforma, fondamento assai più profondo di qualsiasi legame o emozione.
Indispensabile non è un’esperienza (iniziale) di entusiasmo, bensì la custodia della Chiamata che interpreta la vita e diventa mentalità, dinamismo dentro che guida e sfocia in percorsi di periferia.
Nell’antico Israele la base della convivenza sociale era la grande famiglia. Clan e comunità erano garanzia di protezione sia dei focolari particolari che delle persone.
Quel legame di solidarietà reale assicurava il possesso della terra - che dava senso di libertà - e si faceva veicolo della trasmissione culturale, del modo di sentirsi popolo, e della spiritualità stessa.
Difendere la convivenza che garantiva l'identità globale era lo stesso che difendere la Prima Alleanza.
Ma in Palestina al tempo di Gesù la vita del clan e quella comunitaria - più ampia - stavano subendo un declino.
L’eccesso di tasse da pagare ai governi collaborazionisti e al Tempio, l’inevitabile aumento dei ceti che dovevano vendersi come schiavi per debito, forse la mentalità più individualista del mondo ellenista, le minacce imperiali e l’obbligo di accogliere, foraggiare e ospitare le truppe romane [che spesso approfittavano anche dei suoi componenti più deboli], accentuavano i problemi di sopravvivenza.
Oltre a ciò, la severità delle norme di purità era un ulteriore fattore di emarginazione, accanto all’idea crescente - tipica delle religioni - che ci fosse un legame tra maledizione celeste e condizione di miseria.
Le preoccupazioni materiali e di tutela della singola famiglia accentuava il distacco dai momenti collettivi.
Gesù voleva allargare di nuovo i limiti stretti della piccola fraternità del focolare, e allargarli alla grande casata del Regno di Dio.
Dal confronto con i brani paralleli dell’episodio, risulta che Gesù ebbe problemi coi suoi congiunti naturali.
Essi tendevano a riassorbirlo nei parametri della tradizione, per timore di ritorsioni e perché lo consideravano estremista (forse squilibrato).
Il Risorto allarga l’idea di Famiglia e contesta i vincoli che allontanano dalla nostra identità-carattere, e missione - si tratti degli impedimenti posti dai suoi, da Pietro, dai discepoli, da potenti, o leaders della religione ufficiale.
Come accennato sopra, in un momento di soggezione politica e di rigida ideologia religiosa legalista, i valori centrali del clan e della comunità si andavano indebolendo a causa della situazione di collasso sociale ed economico.
La situazione di controllo estrinseco - schiavitù sociale e delle coscienze - impediva alle persone di unirsi e condividere, costringendole a limitarsi ai problemi individuali, e di dinastia esclusiva.
[Situazione del tempo di Gesù, eppure non sono aspetti a noi del tutto estranei, anche dal punto di vista di alcuni “carismi” configurati troppo in dettaglio, e delle realtà già affermate sul territorio].
Anche durante la guerra civile di fine anni 60 i valori centrali della società romana si andavano indebolendo.
Affinché il nuovo Regno potesse manifestarsi era necessario che l’idea di convivenza superasse gli stretti limiti del singolo e del minuscolo focolare domestico - anche dal punto di vista culturale.
C’era bisogno di uno stimolo che aprisse alla vita comunitaria - intesa secondo lo spirito delle Beatitudini, per una convivialità delle differenze; anche nella coabitazione reale, perfino cruda.
Ancora oggi nel tempo della crisi globale, la meta è un’esistenza non più sfigurata da ripiegamenti, né pregiudicata da necessità immediate, fantasie disincarnate, o schemi radicati.
Sorge impellente il bisogno d’una nuova idea di Famiglia universale, che superi la sorte delle micro-relazioni abituali [appunto, del gruppo, del movimento o persino della denominazione].
Il mondo che prepariamo non renderà più così difficile la libera partecipazione, lo scambio indulgente e concreto, nonché il sorpasso delle domesticazioni.
Una nuova idea di Parentela universale, che favorisca lo scambio e il superamento.
C’è ben altro Tempio da edificare.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
La tua famiglia si rinchiude in se stessa? Il tuo gruppo ecclesiale è esclusivo e si impossessa o favorisce la convivenza coi fuori del giro?
Ti concedono solo pillole già pronte e confezionate? Ti aiutano o chiudono nell’apertura al confronto d’idee, all’accorgersi di te stesso, dei lontani e della dovizia di risorse in essere (personali e altrui)?
Questo Santuario, costruito attorno alla sua casa terrena, custodisce la memoria del momento in cui l’Angelo del Signore venne da Maria con il grande annuncio dell’Incarnazione, ed ella diede la sua risposta. Questa umile abitazione è una testimonianza concreta e tangibile dell’avvenimento più grande della nostra storia: l’Incarnazione; il Verbo si è fatto carne, e Maria, la serva del Signore, è il canale privilegiato attraverso il quale Dio è venuto ad abitare in mezzo a noi (cfr Gv 1,14). Maria ha offerto la propria carne, ha messo tutta se stessa a disposizione della volontà di Dio, diventando «luogo» della sua presenza, «luogo» in cui dimora il Figlio di Dio. Qui possiamo richiamare le parole del Salmo con le quali, secondo la Lettera agli Ebrei, Cristo ha iniziato la sua vita terrena dicendo al Padre: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato…Allora ho detto: “Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà”» (10,5.7). Maria dice parole simili di fronte all’Angelo che le rivela il piano di Dio su di lei: «Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1,38). La volontà di Maria coincide con la volontà del Figlio nell’unico progetto di amore del Padre e in lei si uniscono cielo e terra, Dio creatore e la sua creatura. Dio diventa uomo, Maria si fa «casa vivente» del Signore, tempio dove abita l’Altissimo. Il Beato Giovanni XXIII cinquant’anni fa, qui a Loreto, invitava a contemplare questo mistero, a «riflettere su quel congiungimento del cielo con la terra, che è lo scopo dell’Incarnazione e della Redenzione», e continuava affermando che lo stesso Concilio aveva come scopo di estendere sempre più il raggio benefico dell’Incarnazione e Redenzione di Cristo in tutte le forme della vita sociale (cfr AAS 54 [1962], 724). E’ un invito che risuona oggi con particolare forza. Nella crisi attuale che interessa non solo l’economia, ma vari settori della società, l’Incarnazione del Figlio di Dio ci dice quanto l’uomo sia importante per Dio e Dio per l’uomo. Senza Dio l’uomo finisce per far prevalere il proprio egoismo sulla solidarietà e sull’amore, le cose materiali sui valori, l’avere sull’essere. Bisogna ritornare a Dio perché l’uomo ritorni ad essere uomo. Con Dio anche nei momenti difficili, di crisi, non viene meno l’orizzonte della speranza: l’Incarnazione ci dice che non siamo mai soli, Dio è entrato nella nostra umanità e ci accompagna.
Ma il dimorare del Figlio di Dio nella «casa vivente», nel tempio, che è Maria, ci porta ad un altro pensiero: dove abita Dio, dobbiamo riconoscere che tutti siamo «a casa»; dove abita Cristo, i suoi fratelli e le sue sorelle non sono più stranieri. Maria, che è madre di Cristo è anche nostra madre, ci apre la porta della sua Casa, ci guida ad entrare nella volontà del suo Figlio. È la fede, allora, che ci dà una casa in questo mondo, che ci riunisce in un’unica famiglia e che ci rende tutti fratelli e sorelle. Contemplando Maria, dobbiamo domandarci se anche noi vogliamo essere aperti al Signore, se vogliamo offrire la nostra vita perché sia una dimora per Lui; oppure se abbiamo paura che la presenza del Signore possa essere un limite alla nostra libertà, e se vogliamo riservarci una parte della nostra vita, in modo che possa appartenere solo a noi. Ma è proprio Dio che libera la nostra libertà, la libera dalla chiusura in se stessa, dalla sete di potere, di possesso, di dominio, e la rende capace di aprirsi alla dimensione che la realizza in senso pieno: quella del dono di sé, dell’amore, che si fa servizio e condivisione.
La fede ci fa abitare, dimorare, ma ci fa anche camminare nella via della vita. Anche a questo proposito, la Santa Casa di Loreto conserva un insegnamento importante. Come sappiamo, essa fu collocata sopra una strada. La cosa potrebbe apparire piuttosto strana: dal nostro punto di vista, infatti, la casa e la strada sembrano escludersi. In realtà, proprio in questo particolare aspetto, è custodito un messaggio singolare di questa Casa. Essa non è una casa privata, non appartiene a una persona o a una famiglia, ma è un’abitazione aperta a tutti, che sta, per così dire, sulla strada di tutti noi. Allora, qui a Loreto, troviamo una casa che ci fa rimanere, abitare, e che nello stesso tempo ci fa camminare, ci ricorda che siamo tutti pellegrini, che dobbiamo essere sempre in cammino verso un’altra abitazione, verso la casa definitiva, verso la Città eterna, la dimora di Dio con l’umanità redenta (cfr Ap 21,3).
C’è ancora un punto importante del racconto evangelico dell’Annunciazione che vorrei sottolineare, un aspetto che non finisce mai di stupirci: Dio domanda il «sì» dell’uomo, ha creato un interlocutore libero, chiede che la sua creatura Gli risponda con piena libertà. San Bernardo di Chiaravalle, in uno dei suoi Sermoni più celebri, quasi «rappresenta» l’attesa da parte di Dio e dell’umanità del «sì» di Maria, rivolgendosi a lei con una supplica: «L’angelo attende la tua risposta, perché è ormai tempo di ritornare a colui che lo ha inviato… O Signora, da’ quella risposta, che la terra, che gli inferi, anzi, che i cieli attendono. Come il Re e Signore di tutti desiderava vedere la tua bellezza, così egli desidera ardentemente la tua risposta affermativa… Alzati, corri, apri! Alzati con la fede, affrettati con la tua offerta, apri con la tua adesione!» (In laudibus Virginis Matris, Hom. IV, 8: Opera omnia, Edit. Cisterc. 4, 1966, p. 53s). Dio chiede la libera adesione di Maria per diventare uomo. Certo, il «sì» della Vergine è frutto della Grazia divina. Ma la grazia non elimina la libertà, al contrario, la crea e la sostiene. La fede non toglie nulla alla creatura umana, ma ne permette la piena e definitiva realizzazione.
Cari fratelli e sorelle, in questo pellegrinaggio che ripercorre quello del Beato Giovanni XXIII - e che avviene, provvidenzialmente, nel giorno in cui si fa memoria di san Francesco di Assisi, vero «Vangelo vivente» - vorrei affidare alla Santissima Madre di Dio tutte le difficoltà che vive il nostro mondo alla ricerca di serenità e di pace, i problemi di tante famiglie che guardano al futuro con preoccupazione, i desideri dei giovani che si aprono alla vita, le sofferenze di chi attende gesti e scelte di solidarietà e di amore. Vorrei affidare alla Madre di Dio anche questo speciale tempo di grazia per la Chiesa, che si apre davanti a noi. Tu, Madre del «sì», che hai ascoltato Gesù, parlaci di Lui, raccontaci il tuo cammino per seguirlo sulla via della fede, aiutaci ad annunciarlo perché ogni uomo possa accoglierlo e diventare dimora di Dio. Amen!
[Papa Benedetto, omelia Loreto 4 ottobre 2012]
La Chiesa ha costantemente riconosciuto Maria santa ed immune da ogni peccato o imperfezione morale. Il Concilio di Trento esprime tale convinzione affermando che nessuno "può evitare, nella sua vita intera, ogni peccato anche veniale, se non in virtù di un privilegio speciale, come la Chiesa ritiene nei riguardi della beata Vergine" (DS 1573). La possibilità di peccare non risparmia neppure il cristiano trasformato e rinnovato dalla grazia. Questa infatti non preserva da ogni peccato per tutta la vita, a meno che, come afferma il Concilio tridentino, uno speciale privilegio assicuri tale immunità dal peccato. È quanto è avvenuto in Maria.
Il Concilio tridentino non ha voluto definire questo privilegio, ha però dichiarato che la Chiesa lo afferma con vigore: "Tenet", cioè lo ritiene fermamente. Si tratta di una scelta che, lungi dal relegare tale verità tra le pie credenze o le opinioni devozionali, ne conferma il carattere di solida dottrina, ben presente nella fede del Popolo di Dio. Del resto, tale convinzione si fonda sulla grazia attribuita a Maria dall’angelo, al momento dell’Annunciazione. Chiamandola "piena di grazia", kecharitoméne, l’angelo riconosce in lei la donna dotata di una perfezione permanente e di una pienezza di santità, senza ombra di colpa, né d’imperfezione d’ordine morale o spirituale.
Alcuni Padri della Chiesa dei primi secoli, non avendo ancora acquisito la convinzione della sua perfetta santità hanno attribuito a Maria delle imperfezioni o dei difetti morali. Anche qualche recente autore ha fatto propria tale posizione. Ma i testi evangelici citati per giustificare queste opinioni non permettono in nessun caso di fondare l’attribuzione di un peccato, o anche solo di una imperfezione morale, alla Madre del Redentore.
La risposta di Gesù a sua madre, all’età di 12 anni: "Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?" (Lc 2, 49), è stata, talvolta, interpretata come un velato rimprovero. Un’attenta lettura dell’episodio fa invece capire che Gesù non ha rimproverato sua madre e Giuseppe di cercarlo, dal momento che avevano la responsabilità di vegliare su di lui.
Incontrando Gesù dopo una sofferta ricerca, Maria si limita a chiedergli soltanto il "perché" del suo comportamento: "Figlio, perché ci hai fatto così?" (Lc 2, 48). E Gesù risponde con un altro "perché", astenendosi da ogni rimprovero e riferendosi al mistero della propria filiazione divina.
Neppure le parole pronunciate a Cana: "Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora" (Gv 2, 4), possono essere interpretate come un rimprovero. Di fronte al probabile disagio che avrebbe provocato agli sposi la mancanza di vino, Maria si rivolge a Gesù con semplicità, affidandogli il problema. Gesù, pur cosciente di essere il Messia tenuto ad obbedire solo al volere del Padre, accede alla richiesta implicita della Madre. Soprattutto, risponde alla fede della Vergine e dà in tal modo inizio ai miracoli, manifestando la sua gloria.
Alcuni poi hanno interpretato in senso negativo la dichiarazione fatta da Gesù, quando, all’inizio della vita pubblica, Maria e i parenti chiedono di vederlo. Riferendoci la risposta di Gesù a chi gli diceva: "Tua madre e i tuoi fratelli sono qui fuori e desiderano vederti", l’evangelista Luca ci offre la chiave di lettura del racconto, che va compreso a partire dalle disposizioni intime di Maria, ben diverse da quelle dei "fratelli" (cf. Gv 7, 5 ). Gesù rispose: "Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica" ( Lc 8, 21 ). Nel racconto dell’Annunciazione, infatti, Luca ha mostrato come Maria è stata il modello dell’ascolto della Parola di Dio e della generosa docilità. Interpretato secondo tale prospettiva, l’episodio propone un grande elogio di Maria, che ha compiuto perfettamente nella propria vita il disegno divino. Le parole di Gesù, mentre si oppongono al tentativo dei fratelli, esaltano la fedeltà di Maria alla volontà di Dio e la grandezza della sua maternità, da lei vissuta non solo fisicamente ma anche spiritualmente.
Nel tessere questa lode indiretta, Gesù usa un metodo particolare: evidenzia la nobiltà del comportamento di Maria, alla luce di affermazioni di portata più generale, e mostra meglio la solidarietà e la vicinanza della Vergine all’umanità nel difficile cammino della santità.
Infine, le parole: "Beati piuttosto coloro che ascoltano la Parola di Dio e la osservano!" ( Lc 11, 28 ), pronunciate da Gesù per rispondere alla donna che dichiarava beata sua Madre, lungi dal mettere in dubbio la perfezione personale di Maria, mettono in risalto il suo adempimento fedele della Parola di Dio: così le ha intese la Chiesa, inserendo tale espressione nelle celebrazioni liturgiche in onore di Maria.
Il testo evangelico, infatti, suggerisce che con questa dichiarazione Gesù ha voluto rivelare proprio nell’intima unione con Dio, e nell’adesione perfetta alla Parola divina, il motivo più alto della beatitudine di sua Madre.
Lo speciale privilegio concesso da Dio alla "tutta santa", ci conduce ad ammirare le meraviglie operate dalla grazia nella sua vita. Ci ricorda inoltre che Maria è stata sempre e tutta del Signore, e che nessuna imperfezione ha incrinato la perfetta armonia tra Lei e Dio.
La sua vicenda terrena, pertanto, è caratterizzata dallo sviluppo costante e sublime della fede, della speranza e della carità. Per questo, Maria è per i credenti il segno luminoso della Misericordia divina e la guida sicura verso le alte vette della perfezione evangelica e della santità.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 19 giugno 1996]
Mc 3,20-35 ci mostra due tipi di incomprensione che Gesù ha dovuto affrontare: quella degli scribi e quella dei suoi stessi familiari.
La prima incomprensione. Gli scribi erano uomini istruiti nelle Sacre Scritture e incaricati di spiegarle al popolo. Alcuni di loro vengono mandati da Gerusalemme in Galilea, dove la fama di Gesù cominciava a diffondersi, per screditarlo agli occhi della gente: per fare l’ufficio di chiacchieroni, screditare l’altro, togliere l’autorità, questa cosa brutta. E quelli sono stati inviati per fare questo. E questi scribi arrivano con un’accusa precisa e terribile – questi non risparmiano mezzi, vanno al centro e dicono così: «Costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni» (v. 22). Cioè il capo dei demoni è quello che spinge Lui; che equivale a dire più o meno: “Questo è un indemoniato”. Infatti Gesù guariva molti malati, e loro vogliono far credere che lo faccia non con lo Spirito di Dio – come faceva Gesù –, ma con quello del Maligno, con la forza del diavolo. Gesù reagisce con parole forti e chiare, non tollera questo, perché quegli scribi, forse senza accorgersene, stanno cadendo nel peccato più grave: negare e bestemmiare l’Amore di Dio che è presente e opera in Gesù. E la bestemmia, il peccato contro lo Spirito Santo, è l’unico peccato imperdonabile – così dice Gesù –, perché parte da una chiusura del cuore alla misericordia di Dio che agisce in Gesù.
Ma questo episodio contiene un ammonimento che serve a tutti noi. Infatti, può capitare che una forte invidia per la bontà e per le opere buone di una persona possa spingere ad accusarla falsamente. Qui c’è un vero veleno mortale: la malizia con cui in modo premeditato si vuole distruggere la buona fama dell’altro. Dio ci liberi da questa terribile tentazione! E se, esaminando la nostra coscienza, ci accorgiamo che questa erba cattiva sta germogliando dentro di noi, andiamo subito a confessarlo nel sacramento della Penitenza, prima che si sviluppi e produca i suoi effetti malvagi, che sono inguaribili. Siate attenti, perché questo atteggiamento distrugge le famiglie, le amicizie, le comunità e perfino la società.
Il Vangelo di oggi ci parla anche di un’altra incomprensione, molto diversa, nei confronti di Gesù: quella dei suoi familiari. Questi erano preoccupati, perché la sua nuova vita itinerante sembrava loro una pazzia (cfr v. 21). Infatti, Egli si mostrava così disponibile per la gente, soprattutto per i malati e i peccatori, al punto da non avere più nemmeno il tempo di mangiare. Gesù era così: prima la gente, servire la gente, aiutare la gente, insegnare alla gente, guarire la gente. Era per la gente. Non aveva tempo neppure per mangiare. I suoi familiari, dunque, decidono di riportarlo a Nazareth, a casa. Arrivano nel posto dove Gesù sta predicando e lo mandano a chiamare. Gli viene detto: «Ecco, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle stanno fuori e ti cercano» (v. 32). Egli risponde: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?», e guardando le persone che stavano intorno a Lui per ascoltarlo aggiunge: «Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chi fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre» (vv. 33-34). Gesù ha formato una nuova famiglia, non più basata sui legami naturali, ma sulla fede in Lui, sul suo amore che ci accoglie e ci unisce tra noi, nello Spirito Santo. Tutti coloro che accolgono la parola di Gesù sono figli di Dio e fratelli tra di loro. Accogliere la parola di Gesù ci fa fratelli tra noi, ci rende la famiglia di Gesù. Sparlare degli altri, distruggere la fama degli altri, ci rende la famiglia del diavolo.
Quella risposta di Gesù non è una mancanza di rispetto verso sua madre e i suoi familiari. Anzi, per Maria è il più grande riconoscimento, perché proprio lei è la perfetta discepola che ha obbedito in tutto alla volontà di Dio. Ci aiuti la Vergine Madre a vivere sempre in comunione con Gesù, riconoscendo l’opera dello Spirito Santo che agisce in Lui e nella Chiesa, rigenerando il mondo a vita nuova.
[Papa Francesco, Angelus 10 giugno 2018]
«Bestemmiare contro il Santo Spirito»
(Mc 3,22-30)
Spirito Santo è un termine che traduce l’ebraico Ruah haQodesh: Vento impetuoso, non un’aria stagnante.
«Spirito»: energia che butta all’aria la vicenda personale, comunitaria ed ecclesiale... al fine di farla maturare e rinnovarla.
Non per confermare lo standard, ma per dilatare i confini.
Lo fa introducendo nella realtà una sorta di qualità sublime, (soprattutto) irrompendo con un’Azione che discerne l’evoluzione e la capovolge, ne fa un tutt’Altro.
«Santo» perché distingue la sfera della Vita - Santità - da quella paludosa dei germi mortiferi, che volgono al ripiegamento e all’autodistruzione.
Il Vangelo di oggi è nato come appello alle chiese e ai fedeli esposti alle ostilità, affinché non si lascino scoraggiare nella testimonianza reale e genuina.
I credenti non devono mollare quel sentirsi attratti dalla potenza critica della Parola.
Nel tempo essa ha la forza di spogliare gli intriganti dalle loro manie di vanitosa grandezza o perversione, e far emergere la Luce che ci accomuna, attrae spontaneamente, senz’artificio.
Insomma, i membri di chiesa che vivono di Fede-amore non possono identificarsi con stili di vita vantaggiosi, interpretazioni della realtà tipiche, non cruciali.
Altro che piccole trasgressioni! È nel momento delle minacce di fondo, che si legge la portata della nostra scelta per il Signore.
Mc allude in specie a scuse di circostanza, particolari, nella ricerca dell’appoggio: favori di paradigmi “culturali”, o di gente che conta. Ad es. agevolando le proprie vicende grazie a un servilismo ideologico e codino alle autorità, con annesse garanzie di via d’uscita.
Qui si affaccia il pericolo della ‘bestemmia contro il Santo Spirito’: allontanarsi dal Vangelo, ritenendo che Gesù indichi cammini di rovina e morte, invece che d’autentica Vita.
Oggi gli impulsi dello Spirito che rinnova la faccia della terra sconvolgono il panorama, non per abbandonare l’umanità ai puri limiti e a un inesorabile oblio.
Il percorso di colui che cammina sulla Via della Libertà dev’essere senza timori, perché l’Esodo ci rende a noi stessi; riscattati e santificati.
Restituiti al nostro Nucleo e per la potenza della Fede che intreccia la nostra vicenda al Cristo, vedremo realizzare l’impossibile Promessa; ‘cose che non sappiamo’, sovranamente efficaci.
Vogliamo esistere completamente, perché non siamo degli “alterati”.
Per questo ci sono le crisi, i rivolgimenti, e tagli: riconducono alla nostra fragranza, che - questa sì - potremmo smarrire.
Il pericolo e i tempi concitati vengono per ricordarci il nostro lato eterno. Esso può esprimersi solo quando la matrice del nostro stare in campo deflette, per predisporci ad accogliere la soluzione inattesa.
Ciò anche quando agli altri sembrerà che la nostra vita sia perduta.
In realtà, ce la stiamo giocando senza esteriorità di contenuto, per innescare la Beltà integrale della nuova Giovinezza che non sappiamo, ma incede.
[Lunedì 3.a sett. T.O. 26 gennaio 2026]
«Bestemmiare contro il Santo Spirito»
(Mc 3,22-30)
«Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno, ma è colpevole di eterno peccato» (v.29).
Spirito Santo è un termine che traduce l’ebraico Ruah haQodesh: un Vento impetuoso, non un’aria stagnante.
Quest’ultima, sarebbe un’atmosfera senza onda vitale, priva d’una fucina di relazioni; che non fa crescere: rende piatta la situazione.
«Spirito»: energia che butta all’aria la vicenda personale, comunitaria ed ecclesiale... al fine di farla maturare e rinnovarla.
Non per confermare lo standard, ma per dilatare i confini.
Basta scorrere i punti trattati nella recente enciclica sull’amicizia sociale per rendersi conto: frontiere, le ombre del mondo chiuso, sogni che vanno in frantumi, fine della coscienza storica, senza un progetto per tutti, lo scarto mondiale, gli sprechi anche alimentari... etc.
Lo Spirito introduce nella realtà una sorta di qualità sublime, (soprattutto) irrompendo con un’Azione che discerne l’evoluzione e la capovolge, ne fa un tutt’Altro rispetto allo spirito stagnante - ben disposto solo a ribadire, celebrare e diffondere se stesso.
«Santo» perché distingue la sfera della Vita - Santità - da quella paludosa dei germi mortiferi, che ci volgono al ripiegamento e all’autodistruzione.
Un tempo anche la «missionarietà» cattolica [persino la preziosa attività di promozione umana, immaginata estranea alla «evangelizzazione» - ideale dal sapore “protestante”] era concepita in termini di proselitismo interno.
Fratelli Tutti invece denuncia la realtà e il richiamo dei flagelli complessivi: le carenze di un progetto comune, la persistenza di uno «scarto mondiale» e l’insufficienza universale dei diritti umani; le situazioni di conflitto e paura, un progresso «senza rotta comune»... così via.
Il Vangelo stesso di oggi è nato come appello alle chiese e ai fedeli esposti alle ostilità, affinché non deflettano né si lascino scoraggiare nella testimonianza reale e genuina del Cristo nel mondo.
Appello da non tralasciare, malgrado la profonda miseria e i confini che continuano a celarsi nei cuori.
I credenti non devono mollare quel sentirsi attratti dalla potenza critica della Parola.
Nel tempo essa ha la forza di spogliare gli intriganti dalle loro manie di vanitosa grandezza o perversione, e far emergere la Luce che ci accomuna, attrae spontaneamente, senz’artificio.
I membri di chiesa che vivono di Fede-amore non possono identificarsi con stili di vita vantaggiosi, interpretazioni della realtà ormai datate e non cruciali, sebbene siano tipiche delle “religioni dottrina-disciplina” - o delle varie denominazioni storiche.
Come tristemente sottolinea Fratelli Tutti circa l’incontro tra le diverse confessioni cristiane:
«Non possiamo dimenticare il desiderio espresso da Gesù: che tutti siano Uno (Gv 17,21). Ascoltando il suo invito, riconosciamo con dolore che al processo di globalizzazione manca ancora il contributo profetico e spirituale dell’unità tra tutti i cristiani» (n.280).
Questo sì è un «imperdonabile peccato» - in tutti i sensi - non un peccatuccio da ridere.
Come affermava Giovanni Paolo II: «La “bestemmia” [di cui si tratta] non consiste propriamente nell’offendere con le parole lo Spirito Santo; consiste, invece, nel rifiuto di accettare la salvezza che Dio offre all’uomo mediante lo Spirito Santo, e che opera in virtù del sacrificio della croce [Esso] non permette all’uomo di uscire dalla sua autoprigionia e di aprirsi alle fonti divine della purificazione» (Udienza Generale 25 luglio 1990).
Solo l’opera colma di speranze incontra gl’insegnamenti di Gesù.
È il Crocifisso che rivela l’intimità di Dio e dell’uomo, nonché le distorsioni di quell’ipocrisia devota che privilegia lo spirito d’interesse e di frontiera, il potere, l’accumulo di qualsiasi risorsa, e i disvalori.
In simbiosi col passo di Lc e il nuovo Magistero, possiamo ribadire che è appunto nel momento delle minacce in situazione - oggi purtroppo anche globali - che si legge la portata della nostra scelta per il Signore.
C’è chi si affida alla fraternità trasparente, allo spirito dei figli, all’amore che «integra e raduna» (FT 190-192)... viceversa chi cerca fiducia in sé o tenta di rifarsi ai soliti calcoli mondani (vv.11-12), badando ai risultati più che alla fecondità dell’avviare processi (cf. FT 193-197).
Altro che piccole trasgressioni!
È nel momento delle minacce di fondo, che si legge la portata della nostra scelta per il Signore.
Mc allude in specie a scuse di circostanza, particolari, nella ricerca dell’appoggio: favori di paradigmi “culturali”, o di gente che conta. Ad es. agevolando le proprie vicende grazie a un servilismo ideologico e codino alle autorità, con annesse garanzie di via d’uscita.
Tutto ciò senza mai «pensare e generare un universo aperto» (cf. FT 87-127) che sappia andare oltre il «mondo di soci» e cordate - perfino ecclesiali, come ribadito in diverse occasioni dall’attuale pontefice [alludendo appunto agli stessi prelati].
Qui si affaccia il pericolo della bestemmia contro il Santo Spirito: allontanarsi dal Vangelo ritenendo che oggi Gesù sia per l’esclusivismo, o un estraneo che indichi cammini di rovina e morte, invece che d’autentica Vita.
Beninteso, non sono pochi coloro che forse negano esternamente il Cristo, ma non rigettano il senso di Gesù: vivono del suo stesso Spirito [amore del prossimo, vittoria sul male, speranza in un regno più autentico: v.10; FT 271ss].
Il Maestro e il nuovo impegno magisteriale - che suonano all’unisono - intendono scuotere le coscienze e farci capire la gravità di scelte contrarie al disegno di Dio.
Oggi gli impulsi dello Spirito che rinnova la faccia della terra sconvolgono il panorama, ma non per abbandonare l’umanità ai puri limiti e a un inesorabile oblio.
Scrive il Tao Tê Ching (xxxiv) circa il nostro confidare nel Perfetto:
«Come è universale il gran Tao! Può stare a sinistra come a destra». E il maestro Wang Pi commenta: «Non v’è nulla che l’universalità e la sovrabbondanza del Tao non raggiunga: a sinistra e a destra, in alto e in basso. Se ovunque conferisce e s’adopra, non v’è nulla cui non giunga». Ribadisce il maestro Ho-shang Kung: «Non v’è luogo che non gli convenga».
Il percorso di colui che cammina sulla Via della Libertà dev’essere senza timori, perché l’Esodo ci rende a noi stessi; riscattati e santificati.
Con un «cuore aperto al mondo intero» (FT 128-153): stabiliti nel «sapore locale» con «orizzonte universale».
Restituiti al nostro Nucleo e per la potenza della Fede che intreccia la nostra vicenda al Cristo personale e cosmico, vedremo realizzare l’impossibile Promessa; cose che non sappiamo, sovranamente efficaci.
Solo lo Spirito non va contro la nostra natura eminente, quindi è impermeabile, definitivo - pur non essendolo. Perché ci chiama a confidare: per questo non lascia attaccati a ombre, ricordi, antiche sicurezze e commemorazioni che non guidano lo sguardo altrove.
Fomentare il museo dei dettagli vintage [o abbandonarsi all’onda delle mode, anche di pensiero] significa incagliare la mente sul passato, sui vissuti che forse neanche sono stati mai posti in essere.
Semplici ideali d’un tempo altrui, modelli; teologizzazioni arcaiche, o viceversa edoniste.
Vogliamo esistere completamente, perché non siamo degli alterati.
Per questo ci sono le crisi, i rivolgimenti, i tagli: riconducono alla nostra fragranza, che - questa sì - potremmo smarrire.
Se viceversa permanessimo ancora identificati, rischieremmo di non metterci in posizione di scatto; di non cambiare i rapporti, e far sbiadire le energie presenti ora a tutto tondo (anche dentro).
Non facciamole come scivolar via - togliendo smalto alle emergenze inedite che ci chiamano.
Abbiamo lati dell’anima che altrimenti non si esprimerebbero, se non nei pericoli che frastornano, nelle relazioni difficili e a tutto campo, o nei rifiuti più dolorosi e finalmente stravolgenti, i quali ci costringono a spostare lo sguardo.
Ma bisogna deporre la mente precipitosa e opportunista, che cerca subito di rimediare e riparare secondo stereotipi.
Il pericolo e i tempi concitati vengono per ricordarci il nostro lato eterno. Esso può esprimersi solo quando la matrice del nostro stare in campo deflette, per predisporci ad accogliere la soluzione inattesa.
L’imprevista pena o sconfitta non ci farà “piacere per forza” in società anche ecclesiale, concatenata, ma consentirà di essere ciò che siamo. E diventare noi stessi, scoprire altre visuali - secondo Firma d’Autore.
Ciò anche quando agli altri sembrerà che la nostra vita sia perduta.
In realtà, ce la stiamo giocando senza esteriorità di contenuto, per innescare la Beltà integrale della nuova Giovinezza che non sappiamo, ma incede.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Come vivi la persecuzione? Maledizione ovvero Occasione?
Sotto minaccia, insulto, calunnia, processo, derisione, violenza, emergenza, hai mai pensato che Gesù ti avesse condotto in cammini di morte?
E facendo proprio il nuovo Magistero, quale taglio con le indecenze del passato, quale orizzonte giovane, quale beltà e relazioni difformi hai gustato?
Il male non è una forza anonima.
Limite delle liberazioni umane
Dobbiamo essere ben coscienti che il male non è una forza anonima che agisce nel mondo in modo impersonale o deterministico. Il male, il demonio, passa attraverso la libertà umana, attraverso l’uso della nostra libertà. Cerca un alleato, l’uomo. Il male ha bisogno di lui per diffondersi. È così che, avendo offeso il primo comandamento, l’amore di Dio, viene a pervertire il secondo, l’amore del prossimo. Con lui, l’amore del prossimo sparisce a vantaggio della menzogna e dell’invidia, dell’odio e della morte. Ma è possibile non lasciarsi vincere dal male e vincere il male con il bene (cfr Rm 12, 21). È a questa conversione del cuore che siamo chiamati. Senza di essa, le «liberazioni» umane tanto desiderate deludono, perché si muovono nello spazio ridotto concesso dalla ristrettezza di spirito dell’uomo, dalla sua durezza, dalle sue intolleranze, dai suoi favoritismi, dai suoi desideri di rivincita e dalle sue pulsioni di morte. La trasformazione in profondità dello spirito e del cuore è necessaria per ritrovare una certa chiaroveggenza e una certa imparzialità, il senso profondo della giustizia e quello del bene comune. Uno sguardo nuovo e più libero renderà capaci di analizzare e di mettere in discussione sistemi umani che conducono a vicoli ciechi, per andare avanti tenendo conto del passato, per non ripeterlo più con i suoi effetti devastanti. Questa conversione richiesta è esaltante perché apre delle possibilità facendo appello alle innumerevoli risorse che abitano il cuore di tanti uomini e donne desiderosi di vivere in pace e pronti ad impegnarsi per la pace. Ora essa è particolarmente esigente: si tratta di dire no alla vendetta, di riconoscere i propri torti, di accettare le scuse senza cercarle, e infine di perdonare. Perché solo il perdono dato e ricevuto pone le fondamenta durevoli della riconciliazione e della pace per tutti (cfr Rm 12,16b.18).
[Papa Benedetto, Discorso all’Incontro in Baabda Libano 15 settembre 2012]
In one of his most celebrated sermons, Saint Bernard of Clairvaux “recreates”, as it were, the scene where God and humanity wait for Mary to say “yes”. Turning to her he begs: “[…] Arise, run, open up! Arise with faith, run with your devotion, open up with your consent!” [Pope Benedict]
San Bernardo di Chiaravalle, in uno dei suoi Sermoni più celebri, quasi «rappresenta» l’attesa da parte di Dio e dell’umanità del «sì» di Maria, rivolgendosi a lei con una supplica: «[…] Alzati, corri, apri! Alzati con la fede, affrettati con la tua offerta, apri con la tua adesione!» [Papa Benedetto]
«The "blasphemy" [in question] does not really consist in offending the Holy Spirit with words; it consists, instead, in the refusal to accept the salvation that God offers to man through the Holy Spirit, and which works by virtue of the sacrifice of the cross [It] does not allow man to get out of his self-imprisonment and to open himself to the divine sources of purification» (John Paul II, General Audience July 25, 1990)
«La “bestemmia” [di cui si tratta] non consiste propriamente nell’offendere con le parole lo Spirito Santo; consiste, invece, nel rifiuto di accettare la salvezza che Dio offre all’uomo mediante lo Spirito Santo, e che opera in virtù del sacrificio della croce [Esso] non permette all’uomo di uscire dalla sua autoprigionia e di aprirsi alle fonti divine della purificazione» (Giovanni Paolo II, Udienza Generale 25 luglio 1990)
Seen from the capital Jerusalem, that land is geographically peripheral and religiously impure because it was full of pagans, having mixed with those who did not belong to Israel. Great things were not expected from Galilee for the history of salvation. Instead, right from there — precisely from there — radiated that “light” on which we meditated in recent Sundays: the light of Christ. It radiated right from the periphery (Pope Francis)
Vista dalla capitale Gerusalemme, quella terra è geograficamente periferica e religiosamente impura perché era piena di pagani, per la mescolanza con quanti non appartenevano a Israele. Dalla Galilea non si attendevano certo grandi cose per la storia della salvezza. Invece proprio da lì - proprio da lì - si diffonde quella “luce” sulla quale abbiamo meditato nelle scorse domeniche: la luce di Cristo. Si diffonde proprio dalla periferia (Papa Francesco)
Christ and his intimates tried to strengthen the sense of sharing, returning to the profound spirit of what once the clan, the family, the community were - expressions of God's love that manifests itself...
Cristo e i suoi intimi tentavano di rafforzare il senso di condivisione, tornando allo spirito profondo di ciò che un tempo erano appunto il clan, la famiglia, la comunità - espressioni dell’amore di Dio che si manifesta…
The Church was built on the foundation of the Apostles as a community of faith, hope and charity. Through the Apostles, we come to Jesus himself. Therefore, a slogan that was popular some years back: "Jesus yes, Church no", is totally inconceivable with the intention of Christ (Pope Benedict)
La Chiesa è stata costituita sul fondamento degli Apostoli come comunità di fede, di speranza e di carità. Attraverso gli Apostoli, risaliamo a Gesù stesso. È pertanto del tutto inconciliabile con l'intenzione di Cristo uno slogan di moda alcuni anni fa: "Gesù sì, Chiesa no" (Papa Benedetto)
Intimidated by the nightmare of demons and concrete dangers, the crowds could not see the possibility of emancipation from an existence of obsessions - slavish, frightened, lost, overwhelmed...
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.