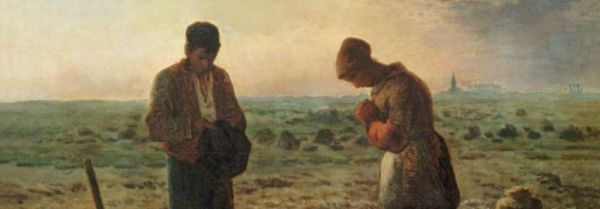Chi sono per voi, e le Chiavi della comunità aperta
(Mt 16,13-20)
A oltre metà della sua vita pubblica Gesù non ha ancora dato formule, ma fa una domanda impegnativa - che ha la pretesa di chiederci molto più delle usuali espressioni con struttura di legge.
Globalmente la folla può averlo accostato a personaggi eminenti come il Battista (colui che ha dimostrato di essere estraneo alle cortigianerie) o Elia (per la sua attività di denuncia degli idoli) o Geremia (l’oppositore della compravendita di benedizioni).
Ma Egli non è venuto - come i profeti antichi - a migliorare la situazione o rabberciare devozioni, né a purificare il Tempio, bensì a sostituirlo!
Le immagini della tradizione raffigurano Cristo in molti modi (per gli atei un filantropo), il più diffuso dei quali è ancora quello di un Signore antico, garante di comportamenti convenzionali.
Egli invece - per farci riflettere - porta i discepoli in un ambiente di cantiere [a nord della Palestina, Cesarea di Filippo era in costruzione], lontano dalla nomenclatura interessata della Città “santa”.
La mentalità comune valutava la riuscita della vita - e la verità di una religione - sulla base del successo, del dominio, dell’arricchimento, delle sicurezze in genere.
Il quesito che Gesù pone ai suoi fa trapelare una novità che soppianta tutto il sistema: la Chiamata si rivolge a ogni singola persona.
È una proposta di confine, al pari del luogo geografico simbolico della capitale del regno di Filippo (uno dei tre figli eredi di Erode il Grande): in alta Galilea, il punto più lontano dal centro della religiosità riconosciuta.
Il Volto del Figlio dell’uomo è riconoscibile solo ponendo la massima distanza da schemi veterani - altrimenti anche noi non saremmo in grado di percepirne la luce personale.
Nella comunità di Mt si stava appunto facendo esperienza di una sempre più larga partecipazione di pagani, che prima si sentivano degli esclusi e man mano si integravano.
Per la nostra mentalità, le “chiavi di casa” servono a chiudere e serrare il portone, per non far entrare i malintenzionati. In quella semitica, erano invece icona dell’apertura dell’uscio.
Nel celebre capolavoro del Perugino sulla parete nord della Cappella Sistina, Gesù consegna al capo della Chiesa due chiavi: quella d’oro del Paradiso e quella d’argento del Purgatorio.
Ma il senso del brano non è l’Aldilà - anzi, non è neppure istituzionale [come indicherebbero le fastose architetture degli archi trionfali e del tempio sul fondo, nell’affresco].
In ebraico il termine «chiave» - maftéach - è derivante dal verbo patàch, che significa aprire: massimo compito missionario dei responsabili di comunità è tenere il Regno dei Cieli spalancato, ossia garantire una Chiesa accogliente!
Pietro non deve ricalcare il tipo del monarca arrogante, immagine dell’autorità [sostitutiva dell’imperatore].
Simone deve farsi primo responsabile dell’accettazione di coloro che sono fuori.
Sembra strano per qualsiasi proposta del passato, ove si supponeva che Dio temesse di rendersi impuro nel contatto col mondo.
Il Padre è Colui che osa di più.
La Fede non è un paracadute [come fosse un “credere dottrinale”] ma una Relazione d’amore che non intasa la mentalità e ci permette di affrontare il flusso arricchente della vita.
La Provvidenza creativa - a tutto tondo e senza confini, oggi particolarmente sconvolgente ogni assetto abitudinario - è reale espressione e autentica Rivelazione del Mistero.
Questo il motivo per cui Gesù impone severamente un totale silenzio messianico (v.20) alle labbra e al cervello antico degli Apostoli.
Pietro e i discepoli volevano tornare all’idea consueta de «il» Messia (cf. testo greco) atteso da tutti: un canovaccio troppo normale, incapace di rigenerarci.
La Fede di Pietro
Come accennato sopra, Gesù guida i suoi lontano dal territorio dell’ideologia di potere e dal centro sacro dell’istituzione religiosa ufficiale - la Giudea - affinché prendano distanza da limitazioni e apprezzamenti.
[Il relativo successo ottenuto dal Maestro in Galilea aveva ravvivato le speranze di gloria unilaterale degli apostoli].
Il territorio di Cesarea di Filippo, all’estremo nord della Palestina, era incantevole; celebre per fertilità e pascoli rigogliosi - zona famosa per la bellezza del contesto e la fecondità di greggi e armenti.
Anche i discepoli restano affascinati dal paesaggio e dalla vita agiata degli abitanti della regione; per non dire della magnificenza dei palazzi.
Il richiamo del contesto allude alle agiatezze che la religione pagana in genere propone; prosperità eccessiva, che imbambolava i Dodici.
Cristo chiede agli apostoli - in pratica - cosa la gente si aspettasse da Lui - e così vuole si rendano conto degli effetti nefasti della loro stessa predicazione, che volentieri confondeva benedizioni materiali e spirituali.
Mentre gli Dei mostrano di saper colmare di beni i loro devoti - e una sfarzosa vita di corte che [appunto] ammaliava tutti - Cristo cosa offre?
Il Maestro si accorge che i discepoli erano ancora fortemente condizionati dalla propaganda del governo politico e religioso (vv.6.11) che assicurava benessere (vv.5-12; cf. Mt 15,32-38).
E Gesù li istruisce ancora, affinché almeno i suoi più intimi possano superare la cecità e la crisi prodotta dalla sua Croce (v.21), dall’impegno richiesto nell’ottica del dono di sé.
Egli non è solo un continuatore dell’atteggiamento limpido del Battista, mai incline al compromesso nei confronti delle corti e dell’opulenza; né uno dei tanti restauratori della legge di Mosè, con lo zelo di Elia.
Neppure voleva limitarsi a purificare la religione da elementi spuri, ma addirittura sostituirsi al Tempio (Mt 21,12-17.18-19.42; 23,2.37-39; 24,30) - luogo dell’incontro tra il Padre e i suoi figli.
Su tale questione, in quel momento erano particolarmente vive le distanze non solo col paganesimo, ma anche le contrapposizioni tra giudei convertiti al Signore e osservanti secondo tradizione.
Infatti, nei libri sacri del giudaismo tardivo si parlava di grandi personaggi che avevano lasciato un’impronta nella storia d’Israele, e avrebbero dovuto riapparire per inaugurare i tempi messianici.
Anche all’interno delle comunità perseguitate di Galilea e Siria, Mt constata una scarsa capacità di comprensione, e tutta la difficoltà di abbracciare la nuova proposta - la quale non garantiva successo e riconoscimenti, né traguardi immediati.
[Sin dalle prime generazioni ci si rendeva conto che la Fede non si accorda facilmente con i primi impulsi umani: è invece sconcertante, per le vedute ovvie e le sue pulsioni].
Così il Maestro contraddice lo stesso Pietro (vv.20.23), la cui opinione restava legata all’idea conformista e popolaresca de «il» (vv.16.20: «quel») Messia atteso.
Insomma, il capo degli apostoli - così debole nella Fede - deve smetterla di indicare a Cristo quale strada percorrere «dietro» a lui (v.23), deviandoLo!
Simone deve ricominciare a fare l’allievo; piantarla di tracciare a tutti vie riconosciute e opportuniste, non umanizzanti; élitarie o unilaterali - sequestrando Dio in nome di Dio.
Una speciale nota sul tema del Nome:
Mentre per la nostra cultura è spesso un’etichetta, fra i popoli orientali il nome è tutt’uno con la persona, e la designa in modo speciale.
Per quanto si evince ad es. nel “secondo” comandamento, la forza del Nome ha un grande peso: è un conoscere il Soggetto (divino) nell’essenza e nel senso dell’agire; quasi un impossessarsi del suo potere.
Anche nella nostra tradizione orante, spirituale e mistica, il Nome proprio [es. Gesù] è stato spesso considerato quasi un’icona acustica della persona, comprensiva delle sue virtù; evocativa della sua presenza e potenza.
Nelle culture antiche, pronunciare il nome significava riuscire a cogliere il seme, il nucleo pregnante e globale della figura di riferimento.
Non di rado, anche nella nostra mentalità ha voluto esprimere un presagio, un mandato, un augurio, una benedizione, una vocazione, un destino, un compito, una chiamata, una missione (nomen est omen).
Ma qui si misura la differenza tra mentalità sacrale e Fede. Nelle religioni il nome proprio che il maestro o fondatore dona al discepolo è una sorta di cartello: colui il quale non avesse acume o fortuna, forza e coraggio di realizzarlo, sminuirebbe in dignità.
Invece Cristo coi suoi appellativi ci chiama a percorrere una strada, ma profondamente commisurata all’essenza. Egli stimola all’esodo - non secondo modelli - perché prima fa rientrare la persona in se stessa. Affinché tutti ci mettiamo in gioco nel profondo e sino all’estremo che corrisponde.
Primo passo: incontrarci a tutto tondo; nei diversi versanti, anche sorprendenti, inespressi o sconosciuti - in genere, caratteri inimmaginabili secondo regola e nomenclature.
Persino i nostri modi di essere eccentrici, ambigui, in ombra o addirittura rifiutati in prima persona: si riveleranno lungo la Via i lati migliori di noi stessi.
Solo in questo binario plurale troviamo la strada per un’avventura densa di senso; non meccanica, né ripetitiva - bensì somigliante alla vita: sempre nuova e autentica. Non a partire dalle esteriorità di facciata o di calcolo: c’è una firma d’Autore che precede, nella edificazione di noi stessi e del mondo.
Passando fra i diversi cantieri della città di Filippo, Gesù ha invece voluto paragonare Simone ai materiali inerti e accatastati (in modo anche confusionario) che si trovava di fronte.
Quella condizione coglieva la radice delle aspettative apostoliche! I discepoli non davano ancora spazio al Mistero in loro stessi, all’idea di una salvezza segreta, che erompe con energia propria, innata; che supera i sogni comuni.
Cefa deriva infatti dall’aramaico Kefas: pietra da costruzione; qualcosa di duro: praticamente, un testardo come tanti; nulla di speciale, anzi. Gesù affibbia a Simone un soprannome negativo!
Infatti il termine greco petros (v.18) non è nome proprio: indica un sasso (raccolto da terra) che può essere sì utile a una costruzione - se ovviamente si lascia compaginare - e che non solo sostiene, ma è sostenuto; che non solo aggrega, ma viene aggregato.
E il termine greco petra (v.18) non è il femminile di petros: indica roccia, e si riferisce alla Persona di Cristo unica sicurezza (assieme alla Fede in Lui), appellativo che cambia imprevedibilmente tutta una vita. Solo l’Amico interiore infatti trae dal nostro cattivo bagaglio l’imprevedibile che sgorga.
Ciascuno di noi viene cesellato dal Signore secondo il nome Pietro, nel senso di tassello particolare, elemento individuo e speciale - collocato in modo singolare ma in un grande mosaico: quello della storia della salvezza, dove ciascuno è contemporaneamente se stesso e in continua fase di rigenerazione.
Unico sentimento di appartenenza delle molte pietre da costruzione tutte viventi: la convivialità delle differenze, la comunione delle disparate membra fraterne nella Chiesa ministeriale; nessuna per sempre, ma ovunque [incessantemente] nuclei pulsanti di un’istituzione tutta raccolta da terra... e liberata gratis.