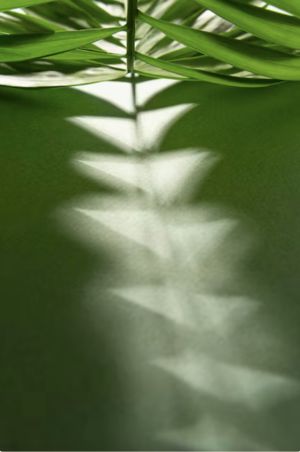don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Incarnazione: ricca Dimora dei poveri Semi
La potenza della vita grezza
(Gv 1,1-18)
Gialal al-Din Rumi, mistico e lirico persiano del XIII sec. scrive nel suo componimento «La Locanda»:
L’essere umano è una locanda,
ogni mattina arriva qualcuno di nuovo.
Una gioia, una depressione, una meschinità,
qualche momento di consapevolezza arriva di tanto in tanto,
come un visitatore inatteso.
Dài il benvenuto a tutti, intrattienili tutti!
Anche se c’è una folla di dispiaceri
che devasta violenta la casa
spogliandola di tutto il mobilio,
lo stesso, tratta ogni ospite con onore:
potrebbe darsi che ti stia liberando
in vista di nuovi piaceri.
Ai pensieri tetri, alla vergogna, alla malizia,
vai incontro sulla porta ridendo,
e invitali a entrare.
Sii grato per tutto quel che arriva,
perché ogni cosa è stata mandata
come guida dell’aldilà.
Riconosciamo in questa poesia-emblema alcune chiavi di volta del discernimento, sottese ai paradossi esistenziali della teologia dell’Incarnazione.
Un mistico sufi aiuta a comprendere le colonne portanti del nostro Cammino, meglio di tante dottrine evasive a senso unico.
Sono identiche leggi dell’anima già espresse nel celebre Prologo del quarto Vangelo: la vita grezza è colma di potenze.
Incarnazione: i nostri fulcri più intimi distinguono l’avventura della Fede dall’esistenza unilaterale del credente in Dio.
L’esperienza della pienezza nel mondo è lanciata dai nostri stessi bassifondi. Come suggerisce un aforisma Zen [raccolto in Ts’ai Ken T’an]: «L’acqua troppo pura non ha pesci».
Gv scrive che il Logos divenne «carne» nell’accezione semitica di un essere pieno di limiti, incompiuto; per questo votato alla ricerca incessante di senso (parziale sino alla morte).
La debolezza di tutti noi non è redenta ammirando un modello eroico e imitandolo fuori scala, ma in un processo di recupero di tutto l’essere e della nostra storia.
Insomma, non esistono Doni dello Spirito che non passino per la dimensione umana.
Già qui e ora prosperiamo d’una preziosa semente del Verbo. La sua Tenda autentica è in-noi e in tutti i moventi.
Più riusciamo a portare al massimo la nostra realtà creaturale e umanizzante, più saremo sul cammino verso la condizione divina - radicati sulla terra dell’inestimabile stirpe generata dal Logos.
Sapientemente, non lo faremo diventando vincenti, bensì ospitando quel che giunge dalla Provvidenza, dalle persone e dalle emozioni (perfino dai disagi) senza pregiudizio.
Non le Dieci Parole - tipica categoria semitica - ma l’Unica Parola inclusiva (Sogno e Senso della Creazione) è a fondamento dell’Opera del Padre.
Il Logos che attecchisce è qualitativo, non parziale, né incentrato su un unico nome: Uno perché Unitario.
Le religioni non accolgono tutti gli ospiti [essi si riveleranno assai più fertili di come immaginiamo] che bussano all’albergo interiore.
La vicenda di Gesù di Nazaret suggerisce che il peccato è stato invece stracciato, ossia: l’imperfezione non è un ostacolo alla comunione col Cielo, bensì una molla.
I malesseri non ci rendono inadeguati: mettono in cammino.
Il Signore ha annientato il senso d’insufficienza della condizione carnale e l’umiliazione delle distanze incolmabili.
«Parola» Fine sull’univocità.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Come inizi le giornate? Accogli i tuoi ospiti (perfino il vuoto)? O li affronti con eccesso di giudizio?
[31 dicembre, settimo giorno fra l’Ottava di Natale]
Incarnazione: ricca Dimora dei poveri Semi
La potenza della vita grezza
(Gv 1,1-18)
Gialal al-Din Rumi, mistico e lirico persiano del XIII sec. (fondatore della confraternita sufi dei dervisci) scrive nel suo componimento «La Locanda»:
L’essere umano è una locanda,
ogni mattina arriva qualcuno di nuovo.
Una gioia, una depressione, una meschinità,
qualche momento di consapevolezza arriva di tanto in tanto,
come un visitatore inatteso.
Dài il benvenuto a tutti, intrattienili tutti!
Anche se c’è una folla di dispiaceri
che devasta violenta la casa
spogliandola di tutto il mobilio,
lo stesso, tratta ogni ospite con onore:
potrebbe darsi che ti stia liberando
in vista di nuovi piaceri.
Ai pensieri tetri, alla vergogna, alla malizia,
vai incontro sulla porta ridendo,
e invitali a entrare.
Sii grato per tutto quel che arriva,
perché ogni cosa è stata mandata
come guida dell’aldilà.
Riconosciamo in questa poesia-emblema alcune chiavi di volta del discernimento, sottese ai paradossi esistenziali della teologia dell’Incarnazione.
Un mistico sufi aiuta a comprendere le colonne portanti del nostro Cammino, assai meglio di tante dottrine evasive a senso unico.
Sono identiche leggi dell’anima già espresse nel celebre Prologo del quarto Vangelo: la vita grezza è colma di potenze.
Sintesi di tematiche di fondo che specificano la Vita nello Spirito a paragone dell’esperienza religiosa comune.
Incarnazione: i nostri fulcri più intimi distinguono l’avventura della Fede dall’esistenza unilaterale del credente in Dio.
Svegliandoci al mattino, ecco nel nostro “albergo” spuntare un nuovo arrivo - non sempre palesemente edificante.
Ma nella reception di locanda a molte stanze dev’esserci accoglienza, affinché l’incontro non programmato possa aprirci, divenire un aspetto, o motivo e motore dell’Incontro decisivo - forse anch’esso inatteso.
Accadimenti, situazioni, intuizioni, consigli, relazioni, emozioni anche strampalate, nuove consapevolezze, altri progetti che non avevamo prima immaginato o semplicemente inespressi, vengono a trovarci e ci lasciano stupiti.
Gli ospiti vanno accolti, hanno la loro dignità e tutti esprimono lati di noi stessi: siamo tenuti a dare a ciascuno di loro un benvenuto; persino alle rabbie, alle tristezze, alle paure.
I missionari sanno bene che i dubbi sono più fecondi delle certezze, e che l’insicurezza è più sicura di tutte le “sicurezze“.
La folla degli ospiti può rimettere in discussione quanto c’è nella nostra dimora o locanda, e spazzare via tutto o in parte - persino le fondamenta.
Avendo pazienza di onorare ogni inquilino - fossero ricordi antichi o utopie da scapicollo - prepareremo l'anima a un’esperienza di pienezza di essere, lanciata dai nostri stessi bassifondi (letame divenuto territorio di germogli).
A partire dal rispetto dei nostri confini diversi e a motivo di essi, ogni presenza nuova o che si riaffaccia ci concentra sull’ascolto di tutto il marasma che siamo - caos che prepara le delizie che ci appartengono, e solo così coinvolgono.
Il nostro lato eterno - che ha piantato tenda in noi - manda le cose affinché percependo, accogliendo, diventando consapevoli, possiamo preparare lo sviluppo dell’anima, della nostra Casa.
Evoluzione i cui principi [e occasioni di scatto in avanti verso il completamento della nostra personalità piena e divina] semplicemente troviamo innati, dentro, e non in adesioni estrinseche - tipiche della civiltà dell’esterno e di non poche espressioni di fede ridotta a religione.
Il Prologo di Gv non fa che ribadire i pilastri eterni di una Sapienza rivelata ma naturale, alla portata di tutti perché narra l’amore, anche nel cammino interiore; difficile da capire solo per chi si lascia influenzare da opinioni e catechismi a codice, abbreviati.
Il Vangelo rassicura: è Notizia a nostro favore, perché dona coscienza che i “signori” che sopraggiungono sono Doni che ripuliscono la dimora, e se la buttano all’aria è solo per rinforzare la nostra essenza, cesellando una irripetibile Vocazione: quella in grado di recuperare ogni brandello della nostra storia e farne un capolavoro.
Sarebbe impossibile imboccare la strada della Felicità piena se non raggranellassimo e assumessimo ogni briciola del nostro essere sparso nel mondo e nel tempo, rendendo significativi e divini ogni attesa, qualsiasi istante, tutte le oscillazioni anche infrante.
Il Logos ha innumerevoli Semi già piantati in noi: sono tutte polarità energetiche plasmabili; non cristalline. Punti di tensione. Molti di essi apparentemente malfermi, ma che riavviano alla destinazione della completezza.
Provvisorietà chiamate a divenire punti fermi - poi di nuovo traballanti, perché solo attraverso processi di fluttuazione s’innescano le dinamiche che guideranno alla crescita totale - con altri momenti di Esodo.
Come suggerisce un aforisma Zen [raccolto in Ts’ai Ken T’an]: «L’acqua troppo pura non ha pesci».
Gv non scrive che il Logos divenne “uomo”, bensì «carne» nell’accezione semitica di un essere pieno di limiti, incompiuto; per questo votato alla ricerca incessante di senso, parziale sino alla morte.
La debolezza di donne e uomini non è redenta ammirando un modello eroico e imitandolo fuori scala, ma in un processo di recupero di tutto l’essere e della nostra storia.
Non esistono Doni dello Spirito che non passino per la dimensione umana.
Già qui e ora prosperiamo sulla terra d’una preziosa semente del Verbo. La sua Tenda autentica è in-noi e in tutti i moventi.
Più riusciamo a portare al massimo la nostra realtà creaturale e umanizzante, più saremo sul cammino verso la condizione divina. Radicati sulla terra dell’inestimabile stirpe generata dal Logos.
Per farci coscienti e dilatare la vita, l’Eterno chiede che ospitiamo le proposte con cui irrompe, all’unico scopo non di condizionare ma di completarci, e incrementare l’autostima con cui affrontiamo il presente e attiviamo futuro, faccia a faccia.
Non lo faremo diventando vincenti, ma accogliendo quel che viene dalla Provvidenza, dalle persone e dalle emozioni (perfino dai disagi) senza pregiudizio - neppure quello del sembrare sempre accompagnati da molta gente, facendosi vedere all’esterno sicuri, forti, performanti.
Sceneggiate che invadono la vita e tolgono la Percezione essenziale dell’essere presenti agli atti minimi e alle relazioni, al guardare dentro e fuori. Coscienza nitida di sé, dell’umano, del mondo che guida verso la nostra direzione e la nostra vera natura.
Non le Dieci Parole - tipica categoria semitica - ma l’Unica Parola inclusiva, Sogno e Senso della Creazione, sono a fondamento dell’Opera del Padre.
Il Logos che attecchisce è qualitativo, non parziale, né incentrato su un unico nome: Uno perché Unitario.
La vicenda di Gesù di Nazaret suggerisce che il peccato è stato stracciato, ossia: l’imperfezione non è un ostacolo alla comunione col Cielo, bensì una molla.
I malesseri non ci rendono inadeguati: mettono in cammino.
Il Signore ha annientato il senso d’insufficienza della condizione carnale e l’umiliazione delle distanze incolmabili.
Il progetto “iniziale” del Creatore è di partecipare la sua stessa Vita a tutta l'umanità. In tal guisa, il Signore s’introduce nel mondo con fiducia, senza timore di contaminarsi, né tagli e separazioni - pregiudizio tipico della mentalità arcaica.
Il Disegno di Salvezza si concretizza e ha la sua vetta nella difesa, promozione, espansione della nostra qualità di vita relazionale.
Dunque: «Luce degli uomini» (v.4) non sarà più - secondo i convincimenti del tempo - l’arida normativa della Legge, bensì la «Vita» nella sua completa pienezza. Spontanea, reale e poco rifinita: cruda, perciò colma di potenze.
Scrive il Tao Tê Ching (xix), che reputa esteriori le più celebrate virtù: «Insegna che v’è altro cui attenersi: mostrati semplice e mantieniti grezzo».
Commenta il maestro Wang Pi: «Le qualità formali sono del tutto insufficienti».
E il maestro Ho-shang Kung aggiunge: «Tralascia il regolare e il creare dei santi; torna a quel che era al Principio».
Così nei percorsi di Fede non sarà più l’esteriorità o la convenzione a dettare il cammino e il senno, nel discernimento degli spiriti.
Ciascuno ha il suo desiderio innato di realizzazione e totalità di espressione: questo l’unico criterio del nostro sentiero.
Tale resterà la Luce intima che guida i nostri passi; questa la Parola dell’Amico invisibile che ci conduce e fa da canone.
«E la Luce splende nella tenebra» (v.5)!
Proprio come una pianta, che non attecchisce né espande in ambiente distillato.
Dunque ciò che non ha o limita la vita non procede da Dio, il Vivente, promotore di tutto quanto esprime e dispiega esuberanza.
Nostra Vocazione è porsi al fianco della vita integrale, coi suoi lati opposti che fanno Alleanza.
Le religioni non accolgono tutti gli ospiti [essi si riveleranno assai più fertili di come immaginiamo] che bussano all’albergo interiore.
Ma non è coi parametri del pensiero consolidato che si può capire o scoprire cosa è Vita completa, perché la vita è sempre espansiva, rigogliosa e nuova, colma di sfaccettature.
Ecco la necessità di un cambio continuo, dall’antico.
Insomma, Principio unico non negoziabile è il bene reale dell’uomo concreto; il resto sfugge alle nostre previsioni.
Rischio classico è che: nel nome di un Dio del passato [dottrina, vezzi, discipline, consuetudini, modi di pensare e fare] non ci si accorga e non si riconosca l’invito, l’energia empatica; la virtù divina che sporge Presente.
Per accogliere il sempre nuovo e spumeggiante, bisogna consentire l’accesso a tutti i nostri “ospiti” dell’anima - che ci faranno incontrare noi stessi; persino le nevrosi.
Colui che Vive propone un Esodo profondo, per diventare sempre rinati. L’andare dell’uomo non è sottomesso a un Padrone, neppure celeste.
Non esistiamo “per” Dio, come si crede e predica nelle vetuste devozioni. Esse c’intasano di forme esterne o intimiste; bloccano lo sviluppo della personalità.
Non lasciano attingere alle “nostre” stesse forze.
Il Padre chiede di essere accolto, non obbedito. Così vivremo di Lui, e con Lui e come Lui andremo a incontrare i fratelli, riuscendo a farci anche Alimento in favore del prossimo - senza forzature irrequiete che spersonalizzano.
Ecco all’opera i nuovi Santuari di carne e sangue che hanno sostituito, soppiantato, quello di pietra.
Presenze, Luoghi d’incontro fra storia, gioia e vertigine; tra natura umana e divina. Centri d’irradiazione dell’Amore senza condizioni - né riduzioni.
Non più alture precisamente denominate, luoghi inaccessibili e lontani dove andare - pena l’esclusione - bensì immagini e somiglianza di un Dio che giunge a trovarci in Casa, lì dove siamo.
Saranno le stesse marginalità incontrate dentro - ormai senza isterismi - a indicarci infallibilmente le periferie esistenziali altrui, che siamo chiamati a frequentare, rigenerare, sublimare, spostare, far risorgere.
La nuova relazione con Dio non è più fondata sulla purità discrepante e sull’obbedienza, profusa verso precetti rigidi e conformismi indiscutibili.
Piuttosto, nelle vicende personali e nella convivialità delle differenze subentrerà la Somiglianza al Verbo.
Confessava il patriarca Atenagora:
«Noi abbiamo bisogno del Cristo, senza di lui non siamo niente. Ma lui ha bisogno di noi per agire nella storia. L’intera storia dell’umanità dalla risurrezione in poi, e persino dalle origini in poi, costituisce una sorta di pan-cristianesimo. L’antica alleanza comporta tutta una serie di alleanze che ancor oggi sussistono l’una a fianco dell’altra. E così l’alleanza di Adamo, o meglio di Noè, sussiste nelle religioni arcaiche, quelle dell’India in special modo, con il loro simbolismo cosmico [...]
Noi sappiamo che la luce irradia da un volto. Ci voleva l’alleanza di Abramo, ed era necessario che si rinnovasse nell’Islam. Quella di Mosè sussiste nel giudaismo [...]
Ma il Cristo ha ricapitolato tutto. Il Logos che si è fatto carne è colui che crea l’universo e vi si manifesta, ed è pure la Parola che guida la storia attraverso i profeti [...]
Per questo io considero il cristianesimo la religione delle religioni, e mi capita di dire che appartengo a tutte le religioni».
È il Sogno di ciascuno e tutti, in Cristo già introdotti nel Seno dell’Eterno convincente e amabile, perché Comprensivo [non nel senso del paternalismo alla fine bonariamente elargito, ma dell’Essere].
Come ha sottolineato Papa Francesco:
«Nella vita porta frutto non chi ha tante ricchezze, ma chi crea e mantiene vivi tanti legami, tante relazioni, tante amicizie attraverso le diverse “ricchezze”, cioè i diversi Doni di cui Dio l’ha dotato».
Solo così diverremo - noi tutti nel Figlio - speciali Eventi del Verbo-carne: pesci piccoli, ma con pieno diritto alla sopreminenza del Logos... corifei di recuperi impossibili.
Abbiamo in comune lo spostamento. «Parola» Fine sull’univocità.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Come inizi le giornate? Accogli i tuoi ospiti (perfino il vuoto)? O li affronti con eccesso di giudizio?
Luce e Tesoro
Scintilla di bellezza e umanesimo, o senza futuro
(Gv 8,12-20)
In tutte le religioni il termine Luce viene usato come metafora delle forze del bene.
Sulla bocca di Gesù [presente nei suoi intimi] il medesimo vocabolo sta a indicare un compimento dell'umanità (persino dell’istituzione religiosa) secondo il progetto divino, riconoscibile nella sua stessa Persona.
La distinzione fra Luce e tenebra in Cristo non è in qualche modo paragonabile al binomio dualista più convenzionale - circa il bene e il male. L'attività del Creatore è poliedrica.
Il termine evangelico dunque non designa alcuna staticità di giudizio fisso su quanto viene usualmente valutato come “fiaccola” oppure “ombra”, “corretto” o “sbagliato” e così via.
C’è spazio per nuove percezioni e rielaborazioni. Né siamo chiamati sempre a lottare contro tutto il resto, e le passioni.
Le classiche valutazioni morali, devote o religiose generali vanno superate, perché restano in superficie e non colgono il nocciolo dell’essere e del divenire umanizzante.
Non di rado le cose più preziose sorgono proprio da ciò che disturba il pensiero omologato.
La stessa mente che crede di stare solo nella luce è una mente unilaterale, parziale, malata; legata a un’idea, quindi scadente.
Dio sa che sono le incompletezze a lanciare l’Esodo, possono essere le insicurezze a non farci sbattere contro i modelli… i quali ci fanno perdere ciò che siamo.
Le energie che investono la realtà creata hanno infatti una radice potenziale del tutto positiva.
I tramonti preparano altri percorsi, le ambivalenze danno il “la” a recuperi e crescite impossibili.
«Luce» era nel giudaismo il termine che designava il cammino retto dell'umanità secondo Legge, senza eccentricità né declino.
Ma con Gesù non è più la Torah che fa da guida, bensì la vita stessa [Gv 1,4: «La Vita era la Luce degli uomini»] che si caratterizza per la sua difforme complessità.
Così, anche il «mondo» - ossia (in Gv) anzitutto il complesso dell’istituzione (tanto pia e devota) ormai installata e corrotta: essa deve tornare a una Guida più sapiente, che rischiari l’esistenza reale.
L’appello che la Scrittura ci rivolge è molto pratico e concreto.
Ma nei contesti dotati di una forte struttura di mediazione fra Dio e l’uomo, la spiritualità spesso inclina al legalismo degli adempimenti consueti.
Gesù non è per le grandi parate, né per soluzioni che ammantino la vita della gente di misticismo, fughe, riti o astinenze.
Tutto questo è stato forse anche il tessuto di buona parte della spiritualità medievale - e quella assidua, rituale e beghina dei tempi andati.
Ma nella Bibbia i servitori di Dio non hanno l’aureola. Sono donne e uomini inseriti normalmente nella società, persone che conoscono i problemi del quotidiano: il lavoro, la famiglia, l’educazione dei figli...
I professionisti del sacro invece cercano di mettere un bel vestitino a cose assai poco nobili - talora a menti astute e cuori perversi. Coltivati dietro il magnificente perbenismo dei paraventi e degli incensi.
Per fare ciò, Gesù capisce di dover cacciare fuori sia mercanti che clienti (Gv 2,13-25) e soppiantare i bagliori fatui del grande Santuario.
Durante la festa delle Capanne, nei cortili del Tempio di Gerusalemme si accendevano enormi lampioni.
Uno dei riti principali consisteva nell’allestire una mirabile processione notturna con le faci accese - e nel far rifulgere le grandi lampade (esse sopravanzavano le mura e illuminavano tutta Gerusalemme).
Era il contesto adeguato per proclamare la Persona stessa del Cristo quale autentica Parola sacra e umanizzante, luogo dell’incontro con Dio e fiaccola della vita. Nulla di esterno e retorico-tutto-apparenza.
Ma in quel “mondo santo” segnato dall’intreccio fra epopea, religione, potere e interesse, il Maestro si staglia - con evidenza contraria - proprio nel luogo del Tesoro (baricentro reale del Tempio, v.20) come vero e unico Punto estremo che squarcia le tenebre.
Il Signore invita a fare nostro il suo stesso cammino acutamente missionario: dal sacrario di pietra al cuore di carne, gratuito come quello del Padre.
Appello limpido e Domanda intima che mai si spegne: la sentiamo ardere viva senza consumarsi.
Non c’è da temere: l’Inviato non è solo. Non testimonia se stesso, né le proprie manie o squilibri utopici: la sua Chiamata per Nome si fa Presenza divina - Origine, Cammino, “Ritorno” autentico.
Sembriamo dei pellegrini ed esiliati che non sanno stare al “mondo”? Ma ciascuno di noi è (nella Fede) come Lui-e-il-Padre: Maggioranza schiacciante.
Per Fede, nella Luce autentica: Aurora, Sostegno, Amicizia e balzo inequivocabile, invincibile, che squarcia le caligini.
Sprizza dal nucleo, assumendo le stesse ombre e rinascendo; portando i nostri lati oscuri accanto alle radici.
Luogo intimo e tempo (fuori di ogni età) da cui scatta la Chiesa in uscita: eccola dai monili e dalle sagrestie, alle periferie... Scintilla di bellezzza e umanesimo, o senza futuro
E dalla società sacrale dell’esterno, alla Perla nascosta che genuinamente connette il presente col “senza tempo” del Gratis - anche se qua e là mette in crisi tanta teologia dal significato precettistico, avido e furbetto, non plurale né trasparente.
In fondo, tutto semplice: il benessere pieno e l’integrità dell’uomo sono più importanti del “bene” unilaterale della dottrina e dell’istituzione - che la propugna senza neanche crederci.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
In quali situazioni mi considero “Testimone”?
Cosa è fiaccola ai miei passi? Chi è la mia Luce Presente?
Mistica della Coversione-Luce: gli spazi inediti della crescita
Attendere e accogliere (il gusto di Dio, nella Rinascita)
(Gv 12,44-50)
«Chi disprezza me e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica: la Parola che ho detto, quella lo giudicherà nell’ultimo giorno» (v.48).
«E conosco che il suo Comandamento è Vita dell’Eterno. Le cose dunque che io annuncio, come mi ha dette il Padre, così annuncio» (v.50).
Siamo al termine del Libro dei Segni (Gv 2-12) cui segue il tempo cosiddetto de l’Ora.
Il passo di Vangelo particolare di Gv 12 fa come da inclusione al Prologo, e introduce al dramma finale di Cristo - con tutto il peso dell’incredulità già percepita.
Ma è un’impronta primordiale, anche per noi, generati alla vita dall’animazione nello Spirito del Figlio, per essere inviati all’Annuncio (della somiglianza, non dell’obbedienza).
Come Lui siamo in Dio, e insieme... per le donne e gli uomini di ogni tempo e cultura.
Dunque il «grido» di Gesù (v.44) è un «clamore» privilegiato, di autopresentazione decisiva, nonché d’inaudita rivelazione della stessa Vita dell’Eterno già qui presente (v.50) dentro noi stessi.
Colui che agisce in nome dell’Amore sorgivo, fa trapelare la Novella lieta di risurrezione e liberazione, e l’approvazione definitiva del Padre.
Non siamo più al mondo in funzione di Dio (come nelle religioni) bensì viviamo con Lui e di Lui - per il Messaggio e la Missione: completa umanizzazione, emancipazione, redenzione degli uomini.
Padre e Figlio sono Uno. Gesù riflette Dio, lo avvicina a noi; ce lo svela e comunica, senza divario.
Così per noi «Vedere» Cristo significa credergli, ossia cogliere l’esito glorioso di una vita che sembrava destinata all’insignificanza.
La Luce imprescindibile del Signore non solo dirada le tenebre, ma le scopre, le incontra e trasforma dal di dentro. E l’incredulità diventa Fede - come un Grembo di gestazioni, doni di nuova Creazione.
La nostra sorte e qualità di vita credente si decide in modo serrato nel confronto tra due moti: vita pia, o Visione-Fede. Quest’ultima in grado di sprigionare dilatazioni e imperativi ministeriali.
Tale dilemma fa da discrimine: tra vita da salvati fin d’ora, e dubbio sul destino futuro. Interrogativo tipico della spiritualità vuota - o di visioni romantiche che dopo i primi entusiasmi portano a brancolare nel buio, nell’insoddisfazione.
L’adesione originale a Cristo è in stato di Compito, germinato in seno - non progettato a tavolino né preparato in disparte senza i volti, le vie, e con la sola storia nazionale o locale - ovvero i manierismi.
In Cristo non ci teniamo avidamente aggrappati a noi stessi, all’ambiente conforme, ai saperi antichi o alla moda più rassicuranti. Siamo disposti a un itinerario di continui inizi, come sulla scia d’immagini-guida (cangianti, ma che sanno dove andare).
Incontreremo l’Azione di Dio che salva... proprio nei territori inattesi, i quali trasbordano fuori del santuario delle abitudini. E nei modi che sorvolano i nostri vecchi propositi - pur in se stessi confessanti, plausibili, o addirittura nobili.
La Legge zeppa di verdetti cesellati nei minimi dettagli è superata (v.47). Cristo non è venuto per accusare d’inadeguatezza e mettere in castigo: al contrario, per farci diventare inventori di strade - e inaudite Fiaccole.
Criterio di “giudizio” è la Parola e la sua Persona, trasparenza del Padre - coincidenza assoluta, genuina e libera. Egli come l’Eterno viene per la Vita eccedente; e nuova Luce.
Non considerarlo come sigillo d’eccezione, passo e ritmo da reinterpretare, e non dargli spazio come tratto intrinseco, motivo e motore, significa disperdere invano le migliori energie - che ci fanno sì vagare, ma per guidare a pienezza.
Il mondo non è tutto qui: c’è un Chiarore (v.46) che fa sentire a casa e può diradare ogni disturbo, chiusura e tenebra.
Questa la grande “conversione”, la mentalità da rinnovare, godendo appieno della Chiamata.
La vita in Cristo non è - come in varie forme religiose arcaiche - ristretta contro se stessi e il mondo.
Essa è far valere l’Azione del Padre (vv.43-44.49-50) il quale ha disposto che persino le eccentricità, le fatiche, i disagi possano veicolarci l’idea, il gusto, d’una diversa realizzazione; aprire spazi di crescita inespressa.
L’Amico interiore conduce misteriosamente a sgretolare l’io orgoglioso che si precipita ad aggiustare secondo opinione convenzionale e altrui - affinché ci lasciamo irraggiare.
È tale Sé eminente e intenso d’unicità che farà cogliere la strabiliante (impossibile) fecondità della vittoria nella sconfitta, del trionfo attraverso la perdita, della vita fra segni di morte.
Smagrendo l’Appello del buio rischiamo di allontanarne la nuova Luce, un’ulteriore genesi di noi stessi, una evoluzione differente dalle solite attese - che davvero ci conforterebbe e realizzerebbe con efficacia.
Smarrendo la percezione delle ferite rischiamo di annientare il processo di guarigione e rinascita dell’anima.
Questa la nuova decisiva Conversione: il vero svuotarsi dei propri piani, idee e gusti, per ispirarsi all’impensabile Opera divina in noi - che non vuole indebolire l’io ma rafforzarlo con altre capacità.
La pienezza di Luce straordinaria è in Cristo un’abnegazione semplice (ma a rovescio): concedere spazio e tempo a quella Totalità che non prende il sopravvento sulla Persona.
Come in Gesù, poi consentirà di donare autenticità e assai più di minime luci vacillanti, prodotti d’un piccolo cervello (che non evolve).
Spicciarsi a lottare coi sintomi finisce per cronicizzarli - con la droga dei rimedi antichi o immediatamente a portata di mano.
Ci farebbe diventare esterni e spegnere la Genesi interiore, che tintinna con l’Opera che Viene.
In Cristo conosciamo il segreto della conversione accogliente: il regno che non vediamo può prendersi cura di noi e del mondo (vv.47-48).
È questo rimando al Mistero (che chiama) quel Seme congenito che realizza l’evoluzione del cosmo e di ciascuno, perché possiede il Senso dell’autenticità sorgiva - ed essa farà il suo Frutto.
Nella Fede «favilla, / che si dilata in fiamma poi vivace / e come stella in cielo in me scintilla» (Dante, Paradiso c.XXIV).
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Quale luce prevedevi ti curasse e viceversa ha cronicizzato la tua situazione? Quale stampella esterna ti ha assuefatto e reso zoppo?
Il Senso eterno e il Bambino
Iniziano proprio oggi i giorni dell’Avvento che ci preparano immediatamente al Natale del Signore: siamo nella Novena di Natale che in tante comunità cristiane viene celebrata con liturgie ricche di testi biblici, tutti orientati ad alimentare l’attesa per la nascita del Salvatore. La Chiesa intera in effetti concentra il suo sguardo di fede verso questa festa ormai vicina predisponendosi, come ogni anno, ad unirsi al cantico gioioso degli angeli, che nel cuore della notte annunzieranno ai pastori l’evento straordinario della nascita del Redentore, invitandoli a recarsi nella grotta di Betlemme. Là giace l’Emmanuele, il Creatore fattosi creatura, avvolto in fasce e adagiato in una povera mangiatoia (cfr Lc 2,13-14).
Per il clima che lo contraddistingue, il Natale è una festa universale. Anche chi non si professa credente, infatti, può percepire in questa annuale ricorrenza cristiana qualcosa di straordinario e di trascendente, qualcosa di intimo che parla al cuore. E’ la festa che canta il dono della vita. La nascita di un bambino dovrebbe essere sempre un evento che reca gioia; l’abbraccio di un neonato suscita normalmente sentimenti di attenzione e di premura, di commozione e di tenerezza. Il Natale è l’incontro con un neonato che vagisce in una misera grotta. Contemplandolo nel presepe come non pensare ai tanti bambini che ancora oggi vengono alla luce in una grande povertà, in molte regioni del mondo? Come non pensare ai neonati non accolti e rifiutati, a quelli che non riescono a sopravvivere per carenza di cure e di attenzioni? Come non pensare anche alle famiglie che vorrebbero la gioia di un figlio e non vedono colmata questa loro attesa? Sotto la spinta di un consumismo edonista, purtroppo, il Natale rischia di perdere il suo significato spirituale per ridursi a mera occasione commerciale di acquisti e scambi di doni! In verità, però, le difficoltà, le incertezze e la stessa crisi economica che in questi mesi stanno vivendo tantissime famiglie, e che tocca l’intera l’umanità, possono essere uno stimolo a riscoprire il calore della semplicità, dell’amicizia e della solidarietà, valori tipici del Natale. Spogliato delle incrostazioni consumistiche e materialistiche, il Natale può diventare così un’occasione per accogliere, come regalo personale, il messaggio di speranza che promana dal mistero della nascita di Cristo.
Tutto questo però non basta per cogliere nella sua pienezza il valore della festa alla quale ci stiamo preparando. Noi sappiamo che essa celebra l’avvenimento centrale della storia: l’Incarnazione del Verbo divino per la redenzione dell’umanità. San Leone Magno, in una delle sue numerose omelie natalizie, così esclama: «Esultiamo nel Signore, o miei cari, ed apriamo il nostro cuore alla gioia più pura. Perché è spuntato il giorno che per noi significa la nuova redenzione, l’antica preparazione, la felicità eterna. Si rinnova infatti per noi nel ricorrente ciclo annuale l’alto mistero della nostra salvezza, che, promesso, all’inizio e accordato alla fine dei tempi, è destinato a durare senza fine» (Homilia XXII). Su questa verità fondamentale ritorna più volte san Paolo nelle sue lettere. Ai Galati, ad esempio, scrive: «Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge…perché ricevessimo l’adozione a figli» (4,4). Nella Lettera ai Romani evidenzia le logiche ed esigenti conseguenze di questo evento salvifico: «Se siamo figli (di Dio), siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria» (8,17). Ma è soprattutto san Giovanni, nel Prologo del quarto Vangelo, a meditare profondamente sul mistero dell’Incarnazione. Ed è per questo che il Prologo fa parte della liturgia del Natale fin dai tempi più antichi: in esso si trova infatti l’espressione più autentica e la sintesi più profonda di questa festa e del fondamento della sua gioia. San Giovanni scrive: «Et Verbum caro factum est et habitavit in nobis / E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14).
A Natale dunque non ci limitiamo a commemorare la nascita di un grande personaggio; non celebriamo semplicemente ed in astratto il mistero della nascita dell’uomo o in generale il mistero della vita; tanto meno festeggiamo solo l’inizio della nuova stagione. A Natale ricordiamo qualcosa di assai concreto ed importante per gli uomini, qualcosa di essenziale per la fede cristiana, una verità che san Giovanni riassume in queste poche parole: “il Verbo si è fatto carne”. Si tratta di un evento storico che l’evangelista Luca si preoccupa di situare in un contesto ben determinato: nei giorni in cui fu emanato il decreto per il primo censimento di Cesare Augusto, quando Quirino era già governatore della Siria (cfr Lc 2,1-7). E’ dunque in una notte storicamente datata che si verificò l’evento di salvezza che Israele attendeva da secoli. Nel buio della notte di Betlemme si accese realmente una grande luce: il Creatore dell’universo si è incarnato unendosi indissolubilmente alla natura umana, sì da essere realmente “Dio da Dio, luce da luce” e al tempo stesso uomo, vero uomo. Quel che Giovanni, chiama in greco “ho logos” – tradotto in latino “Verbum” e in italiano “il Verbo” - significa anche “il Senso”. Quindi potremmo intendere l’espressione di Giovanni così: il “Senso eterno” del mondo si è fatto tangibile ai nostri sensi e alla nostra intelligenza: ora possiamo toccarlo e contemplarlo (cfr 1Gv 1,1). Il “Senso” che si è fatto carne non è semplicemente un’idea generale insita nel mondo; è una “Parola” rivolta a noi. Il Logos ci conosce, ci chiama, ci guida. Non è una legge universale, in seno alla quale noi svolgiamo poi qualche ruolo, ma è una Persona che si interessa di ogni singola persona: è il Figlio del Dio vivo, che si è fatto uomo a Betlemme.
A molti uomini, ed in qualche modo a noi tutti, questo sembra troppo bello per essere vero. In effetti, qui ci viene ribadito: sì, esiste un senso, ed il senso non è una protesta impotente contro l’assurdo. Il Senso ha potere: è Dio. Un Dio buono, che non va confuso con un qualche essere eccelso e lontano, a cui non sarebbe mai dato di arrivare, ma un Dio che si è fatto nostro prossimo e ci è molto vicino, che ha tempo per ciascuno di noi e che è venuto per rimanere con noi. E’ allora spontaneo domandarsi: “E’ mai possibile una cosa del genere? E’ cosa degna di Dio farsi bambino?”. Per cercare di aprire il cuore a questa verità che illumina l’intera esistenza umana, occorre piegare la mente e riconoscere la limitatezza della nostra intelligenza. Nella grotta di Betlemme, Dio si mostra a noi umile “infante” per vincere la nostra superbia. Forse ci saremmo arresi più facilmente di fronte alla potenza, di fronte alla saggezza; ma Lui non vuole la nostra resa; fa piuttosto appello al nostro cuore e alla nostra libera decisione di accettare il suo amore. Si è fatto piccolo per liberarci da quell’umana pretesa di grandezza che scaturisce dalla superbia; si è liberamente incarnato per rendere noi veramente liberi, liberi di amarlo.
Cari fratelli e sorelle, il Natale è un’opportunità privilegiata per meditare sul senso e sul valore della nostra esistenza. L’approssimarsi di questa solennità ci aiuta a riflettere, da una parte, sulla drammaticità della storia nella quale gli uomini, feriti dal peccato, sono perennemente alla ricerca della felicità e di un senso appagante del vivere e del morire; dall’altra, ci esorta a meditare sulla bontà misericordiosa di Dio, che è venuto incontro all’uomo per comunicargli direttamente la Verità che salva, e per renderlo partecipe della sua amicizia e della sua vita. Prepariamoci, pertanto, al Natale con umiltà e semplicità, disponendoci a ricevere in dono la luce, la gioia e la pace, che da questo mistero si irradiano. Accogliamo il Natale di Cristo come un evento capace di rinnovare oggi la nostra esistenza. L’incontro con il Bambino Gesù ci renda persone che non pensano soltanto a se stesse, ma si aprono alle attese e alle necessità dei fratelli. In questa maniera diventeremo anche noi testimoni della luce che il Natale irradia sull’umanità del terzo millennio. Chiediamo a Maria Santissima, tabernacolo del Verbo incarnato, e a san Giuseppe, silenzioso testimone degli eventi della salvezza, di comunicarci i sentimenti che essi nutrivano mentre attendevano la nascita di Gesù, in modo che possiamo prepararci a celebrare santamente il prossimo Natale, nel gaudio della fede e animati dall’impegno di una sincera conversione.
Buon Natale a tutti!
[Papa Benedetto, Udienza Generale 17 dicembre 2008]
Preesistenza del Figlio
5. La sintesi più piena di questa verità è contenuta nel Prologo del quarto Vangelo. Si può dire che in tale testo la verità sulla preesistenza divina del Figlio dell’uomo acquista un’ulteriore esplicitazione, quella in certo senso definitiva: “In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui . . . In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” (Gv 1, 1-5).
In queste frasi l’evangelista conferma ciò che Gesù diceva di se stesso, quando dichiarava: “Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo” (Gv 16, 28), oppure quando pregava perché il Padre lo glorificasse con quella gloria che egli aveva preso di lui prima che il mondo fosse (cf. Gv 17, 5). Nello stesso tempo la preesistenza del Figlio nel Padre si collega strettamente con la rivelazione del mistero trinitario di Dio: il Figlio è l’eterno Verbo, è “Dio da Dio”, della stessa sostanza del Padre (come si esprimerà il Concilio di Nicea nel Simbolo della fede). La formula conciliare riflette precisamente il Prologo di Giovanni: “Il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio”. Affermare la preesistenza di Cristo nel Padre equivale a riconoscerne la Divinità. Alla sua sostanza, così come alla sostanza del Padre, appartiene l’eternità. È ciò che viene indicato col riferimento alla preesistenza eterna nel Padre.
6. Il Prologo di Giovanni, mediante la rivelazione della verità sul Verbo, ivi contenuta, costituisce come il definitivo completamento di ciò che già l’Antico Testamento aveva detto della Sapienza. Si vedano, ad esempio, le seguenti affermazioni: “Prima dei secoli, fin dal principio, egli mi creò; per tutta l’eternità non verrò meno” (Sir 24, 9), “Il mio creatore mi fece piantare la tenda e mi disse: fissa la tenda in Giacobbe” (Sir 24, 8). La Sapienza, di cui parla l’Antico Testamento, è una creatura e nello stesso tempo ha attributi che la mettono al di sopra dell’intero creato: “Sebbene unica, essa può tutto; pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova” (Sap 7, 27).
La verità sul Verbo, contenuta nel Prologo di Giovanni, riconferma in un certo senso la rivelazione circa la sapienza presente nell’Antico Testamento, e in pari tempo la trascende in modo definitivo. Il Verbo non soltanto “è presso Dio”, ma “è Dio”. Venendo in questo mondo nella persona di Gesù Cristo, il Verbo “venne fra la sua gente”, poiché “il mondo fu fatto per mezzo di lui” (cf. Gv 1, 10-11). Venne tra “i suoi” perché è “la luce vera, quella che illumina ogni uomo” (cf. Gv 1, 9). L’autorivelazione di Dio in Gesù Cristo consiste in questa “venuta” nel mondo del Verbo, che è l’eterno Figlio.
7. “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Gv 1, 14). Diciamolo ancora una volta: il Prologo di Giovanni è l’eco eterna delle parole con cui Gesù dice: “Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo” (Gv 16, 28), e di quelle con cui prega che il Padre lo glorifichi con quella gloria che Egli aveva presso di lui prima che il mondo fosse (cf. Gv 17, 5). L’Evangelista ha davanti agli occhi la rivelazione veterotestamentaria circa la Sapienza, e nello stesso tempo l’intero avvenimento pasquale: la dipartita mediante la croce e la risurrezione, in cui la verità su Cristo, Figlio dell’uomo e vero Dio, si è resa completamente chiara a quanti sono stati i suoi testimoni oculari.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 2 settembre 1987]
Desidera comunicare, e condividere tutto
La Parola di Dio non ci offre un episodio della vita di Gesù, ma ci parla di Lui prima che nascesse. Ci porta indietro, per svelarci qualcosa su Gesù prima che venisse tra noi. Lo fa soprattutto nel prologo del Vangelo di Giovanni, che inizia così: «In principio era il Verbo» (Gv 1,1). In principio: sono le prime parole della Bibbia, le stesse con cui comincia il racconto della creazione: «In principio Dio creò il cielo e la terra» (Gen 1,1). Oggi il Vangelo dice che Colui che abbiamo contemplato nel suo Natale, come bambino, Gesù, esisteva prima: prima dell’inizio delle cose, prima dell’universo, prima di tutto. Egli è prima dello spazio e del tempo. «In Lui era la vita» (Gv 1,4) prima che la vita apparisse.
San Giovanni lo chiama Verbo, cioè Parola. Che cosa vuole dirci con ciò? La parola serve per comunicare: non si parla da soli, si parla a qualcuno. Sempre si parla a qualcuno. Quando noi per la strada vediamo gente che parla da sola, diciamo: “Questa persona, qualcosa le succede…”. No, noi parliamo sempre a qualcuno. Ora, il fatto che Gesù sia fin dal principio la Parola significa che dall’inizio Dio vuole comunicare con noi, vuole parlarci. Il Figlio unigenito del Padre (cfr v. 14) vuole dirci la bellezza di essere figli di Dio; è «la luce vera» (v. 9) e vuole allontanarci dalle tenebre del male; è «la vita» (v. 4), che conosce le nostre vite e vuole dirci che da sempre le ama. Ci ama tutti. Ecco lo stupendo messaggio di oggi: Gesù è la Parola, la Parola eterna di Dio, che da sempre pensa a noi e desidera comunicare con noi.
E per farlo, è andato oltre le parole. Infatti, al cuore del Vangelo di oggi ci viene detto che la Parola «si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (v. 14). Si fece carne: perché san Giovanni usa questa espressione, “carne”? Non poteva dire, in modo più elegante, che si fece uomo? No, utilizza la parola carne perché essa indica la nostra condizione umana in tutta la sua debolezza, in tutta la sua fragilità. Ci dice che Dio si è fatto fragilità per toccare da vicino le nostre fragilità. Dunque, dal momento che il Signore si è fatto carne, niente della nostra vita gli è estraneo. Non c’è nulla che Egli disdegni, tutto possiamo condividere con Lui, tutto. Caro fratello, cara sorella, Dio si è fatto carne per dirci, per dirti che ti ama proprio lì, che ci ama proprio lì, nelle nostre fragilità, nelle tue fragilità; proprio lì, dove noi ci vergogniamo di più, dove tu ti vergogni di più. È audace questo, è audace la decisione di Dio: si fece carne proprio lì dove noi tante volte ci vergogniamo; entra nella nostra vergogna, per farsi fratello nostro, per condividere la strada della vita.
Si fece carne e non è tornato indietro. Non ha preso la nostra umanità come un vestito, che si mette e si toglie. No, non si è più staccato dalla nostra carne. E non se ne separerà mai: ora e per sempre Egli è in cielo con il suo corpo di carne umana. Si è unito per sempre alla nostra umanità, potremmo dire che l’ha “sposata”. A me piace pensare che quando il Signore prega il Padre per noi, non soltanto parla: gli fa vedere le ferite della carne, gli fa vedere le piaghe che ha sofferto per noi. Questo è Gesù: con la sua carne è l’intercessore, ha voluto portare anche i segni della sofferenza. Gesù, con la sua carne è davanti al Padre. Il Vangelo dice infatti che venne ad abitare in mezzo a noi. Non è venuto a farci una visita e poi se n’è andato, è venuto ad abitare con noi, a stare con noi. Che cosa desidera allora da noi? Desidera una grande intimità. Vuole che noi condividiamo con Lui gioie e dolori, desideri e paure, speranze e tristezze, persone e situazioni. Facciamolo, con fiducia: apriamogli il cuore, raccontiamogli tutto. Fermiamoci in silenzio davanti al presepe a gustare la tenerezza di Dio fattosi vicino, fattosi carne. E senza timore invitiamolo da noi, a casa nostra, nella nostra famiglia. E anche – ognuno lo sa bene – invitiamolo nelle nostre fragilità. Invitiamolo, che Lui veda le nostre piaghe. Verrà e la vita cambierà.
La Santa Madre di Dio, nella quale il Verbo si fece carne, ci aiuti ad accogliere Gesù, che bussa alla porta del cuore per abitare con noi.
[Papa Francesco, Angelus 3 gennaio 2021]
Senza fermarsi a metà, e senza mode. Nuova Fiaccola
Chiesa dei piccoli: Sfida e corso riconosciuto
Lc 2,36-40 (22-40)
Il passo del Vangelo di Lc narra la risposta sorprendente del Padre alle previsioni d’adempimento circa le profezie messianiche.
Ci si attendeva una manifestazione eloquente e perentoria della potenza del Dio d’Israele e la sottomissione di coloro che non adempivano la Legge.
Tutti immaginavano di assistere all’ingresso trionfale d’un condottiero - circondato da capi militari o schiere angeliche (Mal 3,1) che avrebbe assoggettato i pagani portando nella città santa i loro beni, garantito al popolo eletto molti schiavi, imposto l’osservanza.
Gesù? Eccolo sì nel Tempio, ma indifeso e accompagnato da gente insignificante.
Nessuno si accorge di Lui, sebbene a tutte le ore il luogo sacro brulicasse di visitatori.
Allora sorgono qui Simeone e Anna (vv.25.36-38), uomini e donne corifei del Popolo autentico più sensibile.
Essi colgono un Chiarore che produce conflitto con l’ufficialità abitudinaria, uno Splendore profondo destinato a ogni tempo.
E la «spada» (v.35) che nella Madre Israele realizzerà lacerazioni: fra qualcuno che si apre alla nuova fiaccola, e altri che viceversa si arroccano.
Lc ha presente situazioni di comunità, ove i credenti in Cristo vengono scartati da amici e famiglie di estrazione culturale difforme (cf. Lc 12,51-53).
Ma l’atteso e vero Messia dev’essere consegnato al mondo - sebbene i meglio disposti a riconoscerlo siano i componenti della tribù d’Israele più piccola [Asher, nella figura di Anna: vv.36-38].
Sono gli stessi profeti che nella vita hanno vibrato per un solo grande Amore (vv.36-37), poi hanno vissuto l’assenza dell’Amato - fino ad averlo riconosciuto in Cristo. Trasalendo di sorpresa - cogliendo corrispondenze personalissime dentro sé, in Spirito; gioendo, lodando il Dono di Dio (v.38).
Il brano si conclude col ritorno a Nazaret (vv.39-40) e l’annotazione riguardante la crescita di Gesù stesso «in sapienza, statura e grazia» [testo greco].
Anche noi non siamo al mondo per rimanere avvinghiati a ombre e blocchi, stati d’animo di sempre, soliti pensieri preponderanti, medesimo modo di fare (anche le piccole cose).
Meccanismi e paragoni che chiudono le nostre giornate, la vita intera e lo spazio emotivo delle passioni - tarpando le ali a testimonianze che vogliono sovrastare il ‘corso riconosciuto’.
Spazziamo via gli strati di polvere che ancora ci coprono di conformismi e maniere comprovate, che seguono aspettative di altri, del contorno, di condizioni intrusive esterne!
Proprio questa è la grande Sfida che attiva la rinascita giovane del Sogno di Dio.
Essa può lanciare l’anima nel passaggio dal senso religioso comune a una nuova Fiaccola: la Fede personale, pro-attiva, liberante.
Relazione d’amore che non ci spegne.
[30 dicembre, sesto giorno fra l’Ottava di Natale]
Senza fermarsi a metà, e senza mode. La nuova Fiaccola
Chiesa dei piccoli
Lc 2,36-40 (22-40)
Il passo del Vangelo di Lc narra la risposta sorprendente del Padre alle previsioni d’adempimento circa le profezie messianiche.
Ci si attendeva una manifestazione eloquente e perentoria della potenza del Dio d’Israele e la sottomissione di coloro che non adempivano la Legge.
Tutti immaginavano di assistere all’ingresso trionfale d’un condottiero - circondato da capi militari o schiere angeliche (Mal 3,1) che avrebbe assoggettato i pagani portando nella città santa i loro beni, garantito al popolo eletto molti schiavi e imposto l’osservanza.
Gesù? Eccolo sì nel Tempio, ma indifeso e accompagnato da gente insignificante. Nessuno si accorge di loro, sebbene a tutte le ore il luogo sacro brulicasse di visitatori.
Non basta essere persone pie e devote per rendersi conto della presenza di Cristo - per vedere Dio stesso, i fratelli e le cose con gli occhi del Padre.
Come sfondare il muro delle consuetudini chiuse in sé, come intaccare il mondo artificioso delle apparenze contrarie, per volgersi all’Ignoto creativo?
Lc risponde: con l’aiuto di persone particolarmente sensibili, in grado di comprendere il Nuovo Progetto.
Sono coloro che non contrappongono al Disegno dell’Altissimo i propositi banali, o sogni correnti; le aspettative abituali (altrui)... pretendendo dal Signore solo l’aiutino per realizzarli.
Ecco allora sorgere Simeone e Anna (vv.25.36-38), uomini e donne corifei del Popolo autentico più sensibile, grazie a un ottimo lavoro sull’anima.
Provenendo sia da dentro che da fuori il Tempio - tali profeti tentano di bloccare (vv.28.38 testo greco) il piccolo corteo famigliare, ancora legato alle convenzioni giudaiche (vv.21-23).
Rispetto agli stereotipi cultuali e legalisti, i membri della sacra Famiglia devono intraprendere tutt’altra Via, consapevole.
Percorso che la porterà a una crescita imprevista, in favore di tutti.
Così, il Piccolo Resto sacro di donne e uomini animati dallo Spirito irrompe (sempre) come fosse straniero…
Popolo di minuscoli adoratori, di genuini fuori del coro, i quali tentano addirittura d’impedire il “medesimo” inutile rito di clan!
Gesto che pretendeva - ancora - di trasformare (e ridurre) in ossequioso figlio di Abramo Colui che era stato annunciato come Figlio di Dio.
Insomma, nelle figure di Simeone e Anna, Lc vuole trasmetterci un insegnamento fondamentale.
Se la mèta è il trionfo della vita, la storia passata non deve prevalere sulla Rivelazione inedita.
L’Unicità divina si manifesta in ciò che accade.
L’Eccezionalità dello Spirito si propone (dimessamente) adesso.
Imprevisto cui siamo chiamati a dare voce piena - e farsi eco.
Lo svelamento è ora.
Il “qui” apre immediatamente un arco di esistenza piena.
(Basta col ripetersi “come dovremmo essere” secondo le usanze o i padri…).
Dov’è tutto combinato, non troveremo le risposte che risolvono i veri problemi, né tempi magici - quelli che ci motivano.
Le anime di Dio genuine non si occupano di assecondare obblighi, bensì di vivere intensamente il momento presente con l’energia che traccia futuro, senza esitare con gli eccessi di controllo.
Uscire dalla normalità del modo stabilito - anche attraverso doglie di parto (vv.34-35) - crea lo spazio per accogliere la Novità che salva.
Nel percorso, quei pensieri e doveri che non corrispondono più al destino di ciascuno saranno disinnescati, evaporeranno da sé.
Così in Maria: Madre icona di tutta la Chiesa delle attese vere - tagliata (v.35) dalla folla abitudinaria.
Ella ha deposto tutte le dipendenze.
E l’Innocente è gloria della “nazione”, in Spirito - perché ne viene fuori!
Nella sua figura imprevedibile e sana risiede una Luce che illumina tutti (v.32).
Un tratto d’infanzia e semplice immediatezza che diventa «redenzione di Gerusalemme» (v.38).
È infatti un Chiarore che produce conflitto con l’ufficialità, uno Splendore profondo destinato a ogni tempo - mentre gli astuti non ne vogliono sapere di perdere coordinate, ruoli e posizioni.
Una «spada» (v.35) che nella Madre Israele realizzerà lacerazioni fra qualcuno che si apre alla fiaccola dell’Evangelo e altri che viceversa si arroccano.
Lc ha presente le situazioni di comunità, ove i credenti in Cristo vengono scartati da amici e famiglie di estrazione culturale difforme (cf. Lc 12,51-53).
Ma l’atteso e vero Messia dev’essere consegnato al mondo - sebbene i meglio disposti a riconoscerlo siano i componenti della tribù d’Israele più piccola (Asher, nella figura di Anna: vv.36-38).
Sono gli stessi profeti che nella vita hanno vibrato per un solo grande Amore (vv.36-37), poi hanno vissuto l’assenza dell’Amato - fino ad averlo riconosciuto in Cristo. Trasalendo di sorpresa - cogliendo corrispondenze personalissime dentro sé, in Spirito; gioendo, lodando il Dono di Dio (v.38).
Il brano si conclude col ritorno a Nazaret (vv.39-40) e l’annotazione riguardante la crescita di Gesù stesso «in sapienza, statura e grazia» (testo greco).
Morale: non siamo al mondo per rimanere avvinghiati a ombre e blocchi del passato, con i suoi sentimenti perenni - stati d’animo di sempre, soliti pensieri preponderanti, medesimo modo di fare (anche le piccole cose).
Meccanismi e paragoni che chiudono le nostre giornate, la vita intera e lo spazio emotivo delle passioni - tarpando le ali a testimonianze che vogliono sovrastare il corso riconosciuto sin dagli antenati.
Viceversa, proprio questa è la grande Sfida che attiva la Rinascita giovane del Sogno di Dio. E ci lancia nel passaggio dal senso religioso alla Fede personale.
Tale l’unica energia che sveglia, desta entusiasmo, comunica virtù semplice, spazza via gli strati di polvere che ancora ci coprono di conformismi.
I modi ricalcati e collettivi di scendere in campo (più o meno “morali”) additano, deviano, sovraccaricano la nostra essenza - facendo leva sulla paura di essere rifiutati.
Per infilarci con sforzo nelle convenzioni e nelle maniere della nostra cultura locale, spesso rischiamo di smarrire la Chiamata per Nome, l’irripetibilità del cammino che vibra dentro e ci appartiene davvero.
Rispetto alla guerriglia religiosa portata avanti perfino con se stessi, serve una tregua dalle forme comuni - anche devote, cultuali e puriste.
Una pausa dall’immagine sociale di sé, per consentirci di abbandonare forme esterne e tossiche, recuperare energie taciute.
E lanciarsi verso le esperienze nuove che vogliamo e siamo chiamati a sposare, con entusiasmo, senza prima calarsi in un ruolo.
Smarrimento e ritrovamento: Salvezza in “luogo” giovane e aperto
Già ribelle: Vocazione particolare
(Lc 2,41-51)
La famiglia è nucleo della società e luogo privilegiato del rischio educativo, non l’unico.
È una tappa preziosa della crescita, ma non deve coartare la fioritura nella dimensione universale.
Il movimento della Salvezza familiarizza tutti nelle dinamiche di smarrimento [dalle ristrettezze] e ritrovamento [di una Presenza dentro le difformi presenze] allo scopo di non restringere gli orizzonti.
Il ripiegamento compiaciuto sul mondo degli affetti e interessi di parentela riduce la dimensione delle frontiere vitali, rendendo angusta la vita personale e di casata; culturale, sociale e spirituale.
Il focolare domestico deve integrare nella comunità, e introdurre i giovani alla conoscenza del carattere innato della propria vocazione, affinché crescendo si rendano disponibili e maturino in una realtà sempre più larga.
La famiglia che si fa trampolino prelude il distacco, che nel suo taglio sarà doloroso per tutti - ma diventerà uno spiccare il volo dal nido protetto che rende schiavi; un balzo verso la libertà della vita piena.
Il passo di Vangelo sconcerta, perché sembra ritrarre una famiglia distratta e un Gesù già scontroso e ribelle.
Lc scrive a più di mezzo secolo dalla morte e risurrezione del Signore, e vuol far trasparire la Fede e l’inclinazione delle sue comunità.
La vicenda tragica del Maestro viene compresa e interiorizzata come forse Giuseppe e Maria non avrebbero potuto ancora intuire, nella sua adolescenza.
Riconoscere Gesù Figlio di Dio fin dai dodici anni significava nella letteratura dell’epoca “coprire” tutta la sua vita [cf. Lc 24].
Sembra che la sacra Famiglia salisse a Gerusalemme ogni anno per la Pasqua (v.41).
Prima che in Israele si diventasse adulti e tenuti all’osservanza della Torah (13 anni) già il nostro Adolescente mostra segni di vocazione particolare.
Dal tono della narrazione si nota un Gesù desideroso di abbeverarsi e immergersi nel Mistero ancora inespresso del Padre.
Sognando di scoprire la sua Volontà, si trattiene nella città santa per comprendere a fondo la Parola di Dio - senz’accontentarsi dei catechismi impersonali, abbreviati.
Le prime espressioni di Gesù nel terzo Vangelo segnano il carattere di tutta la sua vicenda. Egli si distacca con decisione dalla religiosità dei padri (v.49).
Inizia a prendere distanza dalle idee comuni anche alla sua famiglia di origine: non appartiene a un clan definito.
La sua sarà una proposta divina in favore di tutte le donne e gli uomini del mondo.
In tal senso, Gesù ha ancor più onorato la fedeltà a Dio dei suoi genitori (vv.51-52) accogliendo l’intero spirito dei loro insegnamenti, e scavando oltre - intuendone il significato ultimo.
Come dire: in Lui le sacre Scritture divengono accessibili, con la chiave di lettura dell’intera sua vicenda e Persona.
Vita per noi (anche prima del Battesimo e della vicenda pubblica).
Lc scrive per incoraggiare i credenti che ancora non comprendevano tutto della vicenda del nuovo Rabbi.
Come Giuseppe e Maria, essi dovevano rendersi conto che non è facile capire il Figlio di Dio e accettarne l’unicità di carattere, sino alla sconfitta terrena.
Nella figura della sacra Famiglia, anche noi siamo invitati a «tornare a Gerusalemme» (v.45).
Qui, osservando l’autonomia di Cristo, gradualmente sapremo aprirci alla vocazione inedita che portiamo dentro - perché “rinati” in Lui.
E di fronte agli accadimenti sconcertanti, impareremo a custodire la Chiamata personale - come Maria.
Perché anche Lei non ha trovato facile introdursi nella sua Pasqua: il “passaggio” dalla religione delle tradizioni e delle attese alla Fede nel Figlio.
Ma «conservava attraverso» Parola ed eventi (v.51b), senza fermarsi a metà.
L’aspetto riflessivo della Casa di Nazaret
La casa di Nazareth è la scuola dove si è iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè la scuola del Vangelo. Qui si impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il significato così profondo e così misterioso di questa manifestazione del Figlio di Dio tanto semplice, umile e bella. Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene, ad imitare.
Qui impariamo il metodo che ci permetterà di conoscere chi è il Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo soggiorno in mezzo a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per manifestarsi al mondo.
Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato. Qui, a questa scuola, certo comprendiamo perché dobbiamo tenere una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la dottrina del Vangelo e diventare discepoli del Cristo. Oh! come volentieri vorremmo ritornare fanciulli e metterci a questa umile e sublime scuola di Nazareth! Quanto ardentemente desidereremmo di ricominciare, vicino a Maria, ad apprendere la vera scienza della vita e la superiore sapienza delle verità divine! Ma noi non siamo che di passaggio e ci è necessario deporre il desiderio di continuare a conoscere, in questa casa, la mai compiuta formazione all’intelligenza del Vangelo. Tuttavia non lasceremo questo luogo senza aver raccolto, quasi furtivamente, alcuni brevi ammonimenti dalla casa di Nazareth.
In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello spirito: mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Oh! silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, l’interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto.
Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro ed inviolabile; ci faccia vedere com’è dolce ed insostituibile l’educazione in famiglia, ci insegni la sua funzione naturale nell’ordine sociale. Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh! dimora di Nazareth, casa del Figlio del falegname! Qui soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge, severa certo ma redentrice della fatica umana; qui nobilitare la dignità del lavoro in modo che sia sentita da tutti; ricordare sotto questo tetto che il lavoro non può essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccellenza, non solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche da ciò che lo volge al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli operai di tutto il mondo e mostrar loro il grande modello, il loro divino fratello, il profeta di tutte le giuste cause che li riguardano, cioè Cristo nostro Signore.
[Papa Paolo VI, Chiesa dell’Annunciazione Nazareth 5 gennaio 1964]
Luce per un cammino che interpreta il senso profondo degli eventi
[L'odierna festa della Presentazione al tempio di Gesù, a quaranta giorni dalla sua nascita] pone davanti ai nostri occhi un momento particolare della vita della santa Famiglia: secondo la legge mosaica, il piccolo Gesù viene portato da Maria e Giuseppe nel tempio di Gerusalemme per essere offerto al Signore (cfr Lc 2, 22). Simeone ed Anna, ispirati da Dio, riconoscono in quel Bambino il Messia tanto atteso e profetizzano su di Lui. Siamo in presenza di un mistero, semplice e solenne al tempo stesso, nel quale la santa Chiesa celebra Cristo, il Consacrato del Padre, primogenito della nuova umanità.
La suggestiva processione dei ceri all'inizio della nostra celebrazione ci ha fatto rivivere il maestoso ingresso, cantato nel Salmo responsoriale, di Colui che è "il re della gloria", "il Signore potente in battaglia" (Sal 23, 7.8). Ma chi è il Dio potente che entra nel tempio? È un Bambino; è il Bambino Gesù, tra le braccia di sua madre, la Vergine Maria. La santa Famiglia compie quanto prescriveva la Legge: la purificazione della madre, l'offerta del primogenito a Dio e il suo riscatto mediante un sacrificio. Nella prima Lettura la Liturgia parla dell'oracolo del profeta Malachia: "Subito entrerà nel suo tempio il Signore" (Mal 3, 1). Queste parole comunicano tutta l'intensità del desiderio che ha animato l'attesa da parte del popolo ebreo nel corso dei secoli. Entra finalmente nella sua casa "l'angelo dell'alleanza" e si sottomette alla Legge: viene a Gerusalemme per entrare in atteggiamento di obbedienza nella casa di Dio.
Il significato di questo gesto acquista una prospettiva più ampia nel brano della Lettera agli Ebrei, proclamato oggi come seconda Lettura. Qui ci viene presentato Cristo, il mediatore che unisce Dio e l'uomo abolendo le distanze, eliminando ogni divisione e abbattendo ogni muro di separazione. Cristo viene come nuovo "sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo" (Eb 2, 17). Notiamo così che la mediazione con Dio non si attua più nella santità-separazione del sacerdozio antico, ma nella solidarietà liberante con gli uomini. Egli inizia, ancora Bambino, a camminare sulla via dell'obbedienza, che percorrerà fino in fondo. Lo pone ben in luce la Lettera agli Ebrei quando dice: "Nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche... a colui che poteva liberarlo da morte ... Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono" (cfr Eb 5, 7-9).
La prima persona che si associa a Cristo sulla via dell'obbedienza, della fede provata e del dolore condiviso è sua madre Maria. Il testo evangelico ce la mostra nell'atto di offrire il Figlio: un'offerta incondizionata che la coinvolge in prima persona: Maria è Madre di Colui che è "gloria del suo popolo Israele" e "luce per illuminare le genti", ma anche "segno di contraddizione" (cfr Lc 2, 32.34). E lei stessa, nella sua anima immacolata, dovrà essere trafitta dalla spada del dolore, mostrando così che il suo ruolo nella storia della salvezza non si esaurisce nel mistero dell'Incarnazione, ma si completa nell'amorosa e dolorosa partecipazione alla morte e alla risurrezione del Figlio suo. Portando il Figlio a Gerusalemme, la Vergine Madre lo offre a Dio come vero Agnello che toglie i peccati del mondo; lo porge a Simeone e ad Anna quale annuncio di redenzione; lo presenta a tutti come luce per un cammino sicuro sulla via della verità e dell'amore.
Le parole che in quest'incontro affiorano sulle labbra del vecchio Simeone - "I miei occhi han visto la tua salvezza" (Lc 2, 30) - trovano eco nell'animo della profetessa Anna. Queste persone giuste e pie, avvolte dalla luce di Cristo, possono contemplare nel Bambino Gesù "il conforto d'Israele" (Lc 2, 25). La loro attesa si trasforma così in luce che rischiara la storia. Simeone è portatore di un'antica speranza e lo Spirito del Signore parla al suo cuore: per questo può contemplare colui che molti profeti e re avevano desiderato vedere, Cristo, luce che illumina le genti. In quel Bambino riconosce il Salvatore, ma intuisce nello Spirito che intorno a Lui si giocheranno i destini dell'umanità, e che dovrà soffrire molto da parte di quanti lo rifiuteranno; ne proclama l'identità e la missione di Messia con le parole che formano uno degli inni della Chiesa nascente, dal quale si sprigiona tutta l'esultanza comunitaria ed escatologica dell'attesa salvifica realizzata. L'entusiasmo è così grande che vivere e morire sono la stessa cosa, e la "luce" e la "gloria" diventano una rivelazione universale. Anna è "profetessa", donna saggia e pia che interpreta il senso profondo degli eventi storici e del messaggio di Dio in essi celato. Per questo può "lodare Dio" e parlare "del Bambino a tutti coloro che aspettavano la redenzione di Gerusalemme" (Lc 2, 38). La lunga vedovanza dedita al culto nel tempio, la fedeltà ai digiuni settimanali, la partecipazione all'attesa di quanti anelavano il riscatto d'Israele si concludono nell'incontro con il Bambino Gesù.
Cari fratelli e sorelle, in questa festa della Presentazione del Signore la Chiesa celebra la Giornata della Vita Consacrata. Si tratta di un'opportuna occasione per lodare il Signore e ringraziarlo del dono inestimabile che la vita consacrata nelle sue differenti forme rappresenta; è al tempo stesso uno stimolo a promuovere in tutto il popolo di Dio la conoscenza e la stima per chi è totalmente consacrato a Dio. Come, infatti, la vita di Gesù, nella sua obbedienza e dedizione al Padre, è parabola vivente del "Dio con noi", così la concreta dedizione delle persone consacrate a Dio e ai fratelli diventa segno eloquente della presenza del Regno di Dio per il mondo di oggi. Il vostro modo di vivere e di operare è in grado di manifestare senza attenuazioni la piena appartenenza all'unico Signore; la vostra completa consegna nelle mani di Cristo e della Chiesa è un annuncio forte e chiaro della presenza di Dio in un linguaggio comprensibile ai nostri contemporanei. È questo il primo servizio che la vita consacrata rende alla Chiesa e al mondo. All'interno del Popolo di Dio essi sono come sentinelle che scorgono e annunciano la vita nuova già presente nella nostra storia.
Mi rivolgo ora in modo speciale a voi, cari fratelli e sorelle che avete abbracciato la vocazione di speciale consacrazione, per salutarvi con affetto e ringraziarvi di cuore per la vostra presenza. Un saluto speciale rivolgo a Mons. Franc Rodé, Prefetto della Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, e ai suoi collaboratori, che concelebrano con me in questa Santa Messa. Il Signore rinnovi ogni giorno in voi e in tutte le persone consacrate la risposta gioiosa al suo amore gratuito e fedele. Cari fratelli e sorelle, come ceri accesi, irradiate sempre e in ogni luogo l'amore di Cristo, luce del mondo. Maria Santissima, la Donna consacrata, vi aiuti a vivere appieno questa vostra speciale vocazione e missione nella Chiesa per la salvezza del mondo.
Amen!
[Papa Benedetto, omelia 2 febbraio 2006]
Lumen ad revelationem gentium
1. Lumen ad revelationem gentium: Luce per illuminare le genti (cfr Lc 2, 32).
Quaranta giorni dopo la nascita, Gesù fu portato da Maria e Giuseppe al Tempio per essere presentato al Signore (cfr Lc 2, 22), secondo quanto è scritto nella Legge di Mosè: “Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore” (Lc 2, 23); e per offrire in sacrificio “una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge” (Lc 2, 24).
Nel ricordare questi eventi, la liturgia segue intenzionalmente e con precisione il ritmo degli avvenimenti evangelici: la scadenza dei quaranta giorni dalla nascita di Cristo. Altrettanto farà in seguito per quanto concerne il periodo che va dalla risurrezione all’ascensione al cielo.
Tre elementi fondamentali emergono nell’evento evangelico che oggi si celebra: il mistero della venuta, la realtà dell’incontro e la proclamazione della profezia.
2. Innanzitutto il mistero della venuta. Le letture bibliche, che abbiamo ascoltato sottolineano la straordinarietà di questa venuta di Dio: lo annuncia con trasporto e gioia il profeta Malachia, la canta il Salmo responsoriale, la descrive il testo del Vangelo secondo Luca. Basta, ad esempio, porsi in ascolto del Salmo responsoriale: “Sollevate, porte, i vostri frontali . . ., ed entri il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Il Signore potente in battaglia . . . Il Signore degli eserciti è il re della gloria” (Sal 23, 7-8.10).
Entra nel Tempio di Gerusalemme l’atteso per secoli, Colui che è il compimento delle promesse dell’Antica Alleanza: il Messia annunziato. Il Salmista lo chiama “Re della gloria”. Solo più tardi diverrà chiaro che il suo Regno non è di questo mondo (cfr Gv 18, 36) e che quanti appartengono a questo mondo stanno preparando per Lui, non una corona regale, ma una corona di spine.
La liturgia, tuttavia, guarda oltre. Vede in quel Bimbo di quaranta giorni la “luce” destinata ad illuminare le nazioni e lo presenta come la “gloria” del popolo d’Israele (cfr Lc 2, 32). Egli è Colui che dovrà sconfiggere la morte, come annuncia la Lettera agli Ebrei, spiegando il mistero dell’Incarnazione e della Redenzione: “Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anch’Egli ne è divenuto partecipe” (Eb 2, 14), avendo assunto la natura umana.
Dopo aver descritto il mistero dell’Incarnazione, l’Autore della Lettera agli Ebrei presenta quello della Redenzione: “Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare sommo sacerdote misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova” (Eb 2, 17-18). Ecco una profonda e toccante presentazione del mistero di Cristo. Il brano della Lettera agli Ebrei ci aiuta a comprendere meglio perché questa venuta a Gerusalemme del neonato Figlio di Maria sia un evento decisivo per la storia della salvezza. Il Tempio fin dalla sua costruzione attendeva in un modo del tutto singolare Colui che era stato promesso. La sua venuta riveste, pertanto, un significato sacerdotale: “Ecce sacerdos magnus”; ecco, il vero ed eterno sommo Sacerdote entra nel Tempio.
3. Il secondo elemento caratteristico dell’odierna Celebrazione è la realtà dell’incontro. Anche se nessuno è ad attendere Giuseppe e Maria che giungono, confusi tra la gente, con il piccolo Gesù, nel Tempio di Gerusalemme avviene qualcosa di molto singolare. Qui essi incontrano delle persone guidate dallo Spirito Santo: l’anziano Simeone, del quale scrive san Luca: “Uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d’Israele; lo Spirito Santo che era sopra di lui gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore” (Lc 2, 25-26), e la profetessa Anna che, avendo vissuto “col marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, era poi rimasta vedova . . . Aveva ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere” (Lc 2, 36-37). L’Evangelista prosegue: “Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme” (Lc 2, 38).
Simeone ed Anna: un uomo e una donna, rappresentanti dell’Antica Alleanza che, in un certo senso, avevano vissuto l’intera loro esistenza in vista del momento in cui il Tempio di Gerusalemme sarebbe stato visitato dall’atteso Messia. Simeone ed Anna comprendono che il momento è finalmente giunto e, rassicurati dall’incontro, possono affrontare con la pace nel cuore l’ultimo tratto della loro vita: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza” (Lc 2, 29-30).
In questo incontro discreto le parole ed i gesti esprimono efficacemente la realtà dell’evento che si compie. La venuta del Messia non è passata inosservata. È stata riconosciuta mediante lo sguardo penetrante della fede, che il vecchio Simeone manifesta nelle sue toccanti parole.
4. Il terzo elemento che emerge in questa festa è la profezia: oggi risuonano parole davvero profetiche. Con il cantico ispirato di Simeone la Liturgia delle Ore conclude ogni giorno la giornata: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza . . ., luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele” (Lc 2, 29-32).
L’anziano Simeone aggiunge rivolto a Maria: “Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima” (Lc 2, 34-35).
Così, dunque, mentre siamo ancora all’alba della vita di Gesù, siamo già orientati al Calvario. È sulla croce che Gesù si confermerà in modo definitivo come segno di contraddizione, ed è là che il cuore della Madre verrà trafitto dalla spada del dolore. Tutto ci è detto fin dall’inizio, nel quarantesimo giorno dopo la nascita di Gesù, nella festa della presentazione di Gesù al Tempio, assai importante nella liturgia della Chiesa.
5. Carissimi Fratelli e Sorelle! L’odierna ricorrenza si arricchisce quest’anno di un nuovo significato. Per la prima volta, infatti, celebriamo la Giornata della Vita Consacrata.
A tutti voi, cari Religiosi e Religiose, ed a voi, cari Fratelli e Sorelle membri degli Istituti Secolari e delle Società di Vita Apostolica, è affidato il compito di proclamare con la parola e con l’esempio il primato dell’Assoluto su ogni realtà umana. È un impegno urgente in questo nostro tempo, che non di rado sembra avere smarrito il senso autentico di Dio. Come ho ricordato nel Messaggio a voi diretto per questa prima Giornata della Vita consacrata, ai nostri giorni “c’è davvero una grande urgenza che la vita consacrata si mostri sempre più “piena di gioia e di Spirito Santo”, si spinga con slancio sulle vie della missione, si accrediti in forza della testimonianza vissuta, giacché “l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni” (Giovanni Paolo II, Messaggio per la I Giornata della Vita consacrata, 6 genn. 1997). Possa la vostra missione nella Chiesa e nel mondo essere luce e sorgente di speranza.
Insieme con l’anziano Simeone e con la profetessa Anna andiamo incontro al Signore nel suo Tempio. Accogliamo la luce della sua Rivelazione, impegnandoci a diffonderla verso i nostri fratelli, in vista dell’ormai prossimo Grande Giubileo del Duemila.
Ci accompagni la Vergine Santa,
Madre della Speranza e della gioia,
e ottenga per tutti i credenti
di essere testimoni della salvezza,
che Dio ha preparato davanti a tutti i popoli
nel suo Figlio incarnato, Gesù Cristo,
luce per illuminare le genti
e gloria del suo popolo Israele.
Amen!
[Papa Giovanni Paolo II, omelia 2 febbraio 1997]
I luoghi della pazienza
Simeone – scrive San Luca – «aspettava la consolazione di Israele» (Lc 2,25). Salendo al tempio, mentre Maria e Giuseppe portano Gesù, accoglie tra le braccia il Messia. A riconoscere nel Bambino la luce venuta a illuminare le genti è un uomo ormai vecchio, che ha atteso con pazienza il compimento delle promesse del Signore. Ha atteso con pazienza.
La pazienza di Simeone. Guardiamo da vicino la pazienza di questo vecchio. Per tutta la vita egli è rimasto in attesa e ha esercitato la pazienza del cuore. Nella preghiera ha imparato che Dio non viene in eventi straordinari, ma compie la sua opera nell’apparente monotonia delle nostre giornate, nel ritmo a volte stancante delle attività, nelle piccole cose che con tenacia e umiltà portiamo avanti cercando di fare la sua volontà. Camminando con pazienza, Simeone non si è lasciato logorare dallo scorrere del tempo. È un uomo ormai carico di anni, eppure la fiamma del suo cuore è ancora accesa; nella sua lunga vita sarà stato a volte ferito, deluso, eppure non ha perso la speranza; con pazienza, egli custodisce la promessa – custodire la promessa –, senza lasciarsi consumare dall’amarezza per il tempo passato o da quella rassegnata malinconia che emerge quando si giunge al crepuscolo della vita. La speranza dell’attesa in lui si è tradotta nella pazienza quotidiana di chi, malgrado tutto, è rimasto vigilante, fino a quando, finalmente, “i suoi occhi hanno visto la salvezza” (cfr Lc 2,30).
E io mi domando: da dove ha imparato Simeone questa pazienza? L’ha ricevuta dalla preghiera e dalla vita del suo popolo, che nel Signore ha sempre riconosciuto il «Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà» (Es 34,6); ha riconosciuto il Padre che anche dinanzi al rifiuto e all’infedeltà non si stanca, anzi “pazienta per molti anni” (cfr Ne 9,30), come dice Neemia, per concedere ogni volta la possibilità della conversione.
La pazienza di Simeone, dunque, è specchio della pazienza di Dio. Dalla preghiera e dalla storia del suo popolo, Simeone ha imparato che Dio è paziente. Con la sua pazienza – afferma San Paolo – Egli ci «spinge alla conversione» (Rm 2,4). Mi piace ricordare Romano Guardini, che diceva: la pazienza è un modo con cui Dio risponde alla nostra debolezza, per donarci il tempo di cambiare (cfr Glaubenserkenntnis, Würzburg 1949, 28). E soprattutto il Messia, Gesù, che Simeone stringe tra le braccia, ci svela la pazienza di Dio, il Padre che ci usa misericordia e ci chiama fino all’ultima ora, che non esige la perfezione ma lo slancio del cuore, che apre nuove possibilità dove tutto sembra perduto, che cerca di fare breccia dentro di noi anche quando il nostro cuore è chiuso, che lascia crescere il buon grano senza strappare la zizzania. Questo è il motivo della nostra speranza: Dio ci attende senza stancarsi mai. Dio ci attende senza stancarsi mai. E questo è il motivo della nostra speranza. Quando ci allontaniamo ci viene a cercare, quando cadiamo a terra ci rialza, quando ritorniamo a Lui dopo esserci perduti ci aspetta a braccia aperte. Il suo amore non si misura sulla bilancia dei nostri calcoli umani, ma ci infonde sempre il coraggio di ricominciare. Ci insegna la resilienza, il coraggio di ricominciare. Sempre, tutti i giorni. Dopo le cadute, sempre, ricominciare. Lui è paziente.
E guardiamo alla nostra pazienza. Guardiamo alla pazienza di Dio e a quella di Simeone per la nostra vita consacrata. E ci chiediamo: che cos’è la pazienza? Certamente, non è la semplice tolleranza delle difficoltà o una sopportazione fatalista delle avversità. La pazienza non è segno di debolezza: è la fortezza d’animo che ci rende capaci di “portare il peso”, di sopportare: sopportare il peso dei problemi personali e comunitari, ci fa accogliere la diversità dell’altro, ci fa perseverare nel bene anche quando tutto sembra inutile, ci fa restare in cammino anche quando il tedio e l’accidia ci assalgono.
Vorrei indicare tre “luoghi” in cui la pazienza si concretizza.
Il primo è la nostra vita personale. Un giorno abbiamo risposto alla chiamata del Signore e, con slancio e generosità, ci siamo offerti a Lui. Lungo il cammino, insieme alle consolazioni, abbiamo ricevuto anche delusioni e frustrazioni. A volte, all’entusiasmo del nostro lavoro non corrisponde il risultato sperato, la nostra semina sembra non produrre i frutti adeguati, il fervore della preghiera si affievolisce e non sempre siamo immunizzati contro l’aridità spirituale. Può capitare, nella nostra vita di consacrati, che la speranza si logori a causa delle aspettative deluse. Dobbiamo avere pazienza con noi stessi e attendere fiduciosi i tempi e i modi di Dio: Egli è fedele alle sue promesse. Questa è la pietra basale: Egli è fedele alle sue promesse. Ricordare questo ci permette di ripensare i percorsi, di rinvigorire i nostri sogni, senza cedere alla tristezza interiore e alla sfiducia. Fratelli e sorelle, la tristezza interiore in noi consacrati è un verme, un verme che ci mangia da dentro. Fuggite dalla tristezza interiore!
Secondo luogo in cui la pazienza si concretizza: la vita comunitaria. Le relazioni umane, specialmente quando si tratta di condividere un progetto di vita e un’attività apostolica, non sono sempre pacifiche, lo sappiamo tutti. A volte nascono dei conflitti e non si può esigere una soluzione immediata, né si deve giudicare frettolosamente la persona o la situazione: occorre saper prendere le giuste distanze, cercare di non perdere la pace, attendere il tempo migliore per chiarirsi nella carità e nella verità. Non lasciarsi confondere dalle tempeste. Nella lettura del breviario c’è un bel passo – per domani – un bel passo di Diadoco di Fotice sul discernimento spirituale, e dice questo: “Quando il mare è agitato non si vedono i pesci, ma quando il mare è calmo si possono vedere”. Mai potremo fare un buon discernimento, vedere la verità, se il nostro cuore è agitato e impaziente. Mai. Nelle nostre comunità occorre questa pazienza reciproca: sopportare, cioè portare sulle proprie spalle la vita del fratello o della sorella, anche le sue debolezze e i suoi difetti. Tutti. Ricordiamoci questo: il Signore non ci chiama ad essere solisti – ce ne sono tanti, nella Chiesa, lo sappiamo –, no, non ci chiama ad essere solisti, ma ad essere parte di un coro, che a volte stona, ma sempre deve provare a cantare insieme.
Infine, terzo “luogo”, la pazienza nei confronti del mondo. Simeone e Anna coltivano nel cuore la speranza annunciata dai profeti, anche se tarda a realizzarsi e cresce lentamente dentro alle infedeltà e alle rovine del mondo. Essi non intonano il lamento per le cose che non vanno, ma con pazienza attendono la luce nell’oscurità della storia. Attendere la luce nell’oscurità della storia. Attendere la luce nell’oscurità della propria comunità. Abbiamo bisogno di questa pazienza, per non restare prigionieri della lamentela. Alcuni sono maestri di lamentele, sono dottori in lamentele, sono bravissimi a lamentarsi! No, la lamentela imprigiona: “il mondo non ci ascolta più” – tante volte ascoltiamo questo –, “non abbiamo più vocazioni, dobbiamo chiudere la baracca”, “viviamo tempi difficili” – “ah, non lo dica a me!...”. Così incomincia il duetto delle lamentele. A volte succede che alla pazienza con cui Dio lavora il terreno della storia, e lavora anche il terreno del nostro cuore, noi opponiamo l’impazienza di chi giudica tutto subito: adesso o mai, adesso, adesso, adesso. E così perdiamo quella virtù, la “piccola” ma la più bella: la speranza. Tanti consacrati e consacrate ho visto che perdono la speranza. Semplicemente per impazienza.
La pazienza ci aiuta a guardare noi stessi, le nostre comunità e il mondo con misericordia. Possiamo chiederci: accogliamo la pazienza dello Spirito nella nostra vita? Nelle nostre comunità, ci portiamo sulle spalle a vicenda e mostriamo la gioia della vita fraterna? E verso il mondo, portiamo avanti il nostro servizio con pazienza o giudichiamo con asprezza? Sono sfide per la nostra vita consacrata: noi non possiamo restare fermi nella nostalgia del passato o limitarci a ripetere le cose di sempre, né nelle lamentele di ogni giorno. Abbiamo bisogno della coraggiosa pazienza di camminare, di esplorare strade nuove, di cercare cosa lo Spirito Santo ci suggerisce. E questo si fa con umiltà, con semplicità, senza grande propaganda, senza grande pubblicità.
Contempliamo la pazienza di Dio e imploriamo la pazienza fiduciosa di Simeone e anche di Anna, perché anche i nostri occhi possano vedere la luce della salvezza e portarla al mondo intero, come l’hanno portata nella lode questi due vecchietti.
[Papa Francesco, omelia 2 febbraio 2020]
Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)
Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)
You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]
Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]
In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)
In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)
Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)
Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)
In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)
Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))
Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.