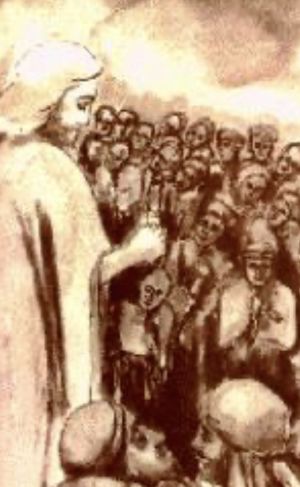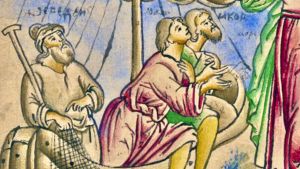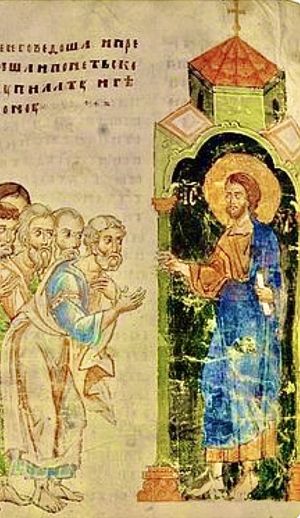don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Inizio della missione pubblica. Apertura, non sforzo
Il Vangelo di oggi (cfr Mt 4,12-23) ci presenta l’inizio della missione pubblica di Gesù. Questo avvenne in Galilea, una terra di periferia rispetto a Gerusalemme, e guardata con sospetto per la mescolanza con i pagani. Da quella regione non ci si aspettava nulla di buono e di nuovo; invece, proprio lì Gesù, che era cresciuto a Nazaret di Galilea, incomincia la sua predicazione.
Egli proclama il nucleo centrale del suo insegnamento sintetizzato nell’appello: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (v. 17). Questo annuncio è come un potente fascio di luce che attraversa le tenebre e fende la nebbia, ed evoca la profezia di Isaia che si legge nella notte di Natale: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che camminavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (9,1). Con la venuta di Gesù, luce del mondo, Dio Padre ha mostrato all’umanità la sua vicinanza e amicizia. Esse ci sono donate gratuitamente al di là dei nostri meriti. La vicinanza di Dio e l’amicizia di Dio non sono un merito nostro: sono un dono gratuito di Dio. Noi dobbiamo custodire questo dono.
L’appello alla conversione, che Gesù rivolge a tutti gli uomini di buona volontà, si comprende in pienezza proprio alla luce dell’evento della manifestazione del Figlio di Dio, su cui abbiamo meditato nelle scorse domeniche. Tante volte risulta impossibile cambiare vita, abbandonare la strada dell’egoismo, del male, abbandonare la strada del peccato perché si incentra l’impegno di conversione solo su sé stessi e sulle proprie forze, e non su Cristo e il suo Spirito. Ma la nostra adesione al Signore non può ridursi ad uno sforzo personale, no. Credere questo anche sarebbe un peccato di superbia. La nostra adesione al Signore non può ridursi ad uno sforzo personale, deve invece esprimersi in un’apertura fiduciosa del cuore e della mente per accogliere la Buona Notizia di Gesù. È questa – la Parola di Gesù, la Buona Notizia di Gesù, il Vangelo – che cambia il mondo e i cuori! Siamo chiamati, pertanto, a fidarci della parola di Cristo, ad aprirci alla misericordia del Padre e lasciarci trasformare dalla grazia dello Spirto Santo.
È da qui che comincia il vero percorso di conversione. Proprio come è capitato ai primi discepoli: l’incontro con il Maestro divino, col suo sguardo, con la sua parola ha dato loro la spinta a seguirlo, a cambiare vita mettendosi concretamente al servizio del Regno di Dio.
L’incontro sorprendente e decisivo con Gesù ha dato inizio al cammino dei discepoli, trasformandoli in annunciatori e testimoni dell’amore di Dio verso il suo popolo. Ad imitazione di questi primi araldi e messaggeri della Parola di Dio, ciascuno di noi possa muovere i passi sulle orme del Salvatore, per offrire speranza a quanti ne sono assetati.
La Vergine Maria, alla quale ci rivolgiamo in questa preghiera dell’Angelus, sostenga questi propositi e li avvalori con la sua materna intercessione.
[Papa Francesco, Angelus 26 gennaio 2020]
Superlavoro Missione Famiglia, da squilibrati
(Mc 3,20-21)
Il breve Vangelo di oggi può essere interpretato secondo diversi piani di lettura: iniziamo con un approccio vocazionale.
La famiglia nucleo della società dovrebbe configurarsi anche come un trampolino di lancio verso l’avventura di Fede che sollecita altri legami.
I consanguinei possono rimanere costernati dal nostro desiderio di darsi interamente a Dio nei fratelli.
E a volte gli affetti e i vincoli naturali possono impedire l’adempimento della Missione cui siamo chiamati.
Talora, anche importanti impegni nell’azione della Chiesa rimangono a metà o del tutto frustrati - causa un “debole” e impedimenti che non riusciamo a ‘tagliare’.
Veniamo al livello storico.
Gesù ha avuto bei problemi anche in casa sua, ma il brano di Vangelo si riferisce alla Chiesa nascente nella dimora di Pietro a Cafarnao, vicinissima alla Sinagoga.
Nel tempo, le due realtà quasi adiacenti si sono trovate a fronteggiarsi aspramente.
Eppure nella Dimora di Pietro a un certo punto esplode il numero dei provenienti dal giudaismo, nonché pagani, che si convertivano alla proposta del Signore.
Il Popolo stesso e la cultura religiosa che hanno generato Cristo [la sua «Famiglia»] faceva fatica a interrogarsi. E la prima reazione è stata di rifiuto.
Quella nuova porzione della stirpe giudaica che riconosceva Gesù Messia sembrava volesse fare sempre più di testa sua.
Aspetto sociale:
Effettivamente il focolare e il clan propri si erano allarmati, perché Gesù adulto non seguiva un comportamento da sottomesso.
Così i parenti decidono di riportarlo a forza (cf. vv.31-35) considerandolo uno squilibrato che logorava i loro rapporti interni e le relazioni con autorità sul territorio.
Ma le convinzioni ormai cristallizzate nella Sinagoga - nonché il portato teologico e ‘cordiale’ di tutta la sua realtà di compromesso - non sembravano più vitali. Perché?
Il sistema imperiale impiantato in Galilea aveva debilitato il senso di condivisione e fraternità. Chiusure rafforzate dalla religiosità dell’epoca.
L’osservanza sempre più accentuata delle norme di purezza era un fattore di grave emarginazione sociale e culturale.
Intere fasce di popolazione erano escluse dal rapporto con Dio: proprio quelle più bisognose di speranza, e di un ‘volto’.
Invece che promuovere accoglienza e partecipazione, le norme devote addirittura favorivano separazioni ed esclusioni.
Struttura politica, economica e sociale, e ideologia sacra, cospiravano a favore dell’indebolimento dei valori centrali dello spirito di comunione.
Nel passo di Vangelo di oggi si nota appunto come i limiti stretti della famiglia andassero a confliggere con la proposta del nuovo Rabbi, di recuperare l’afflato solidale.
Era insomma nella Casa di Pietro che la piccola famiglia acquisiva respiro, aprendosi non solo alla Nazione, bensì alla più ampia Famiglia umana.
Assemblea integrale, anche di donne e malfermi, o incerti e lontani.
Realtà assolutamente nuova; non più radunata per il culto ma incapace di fare ‘convivenza’.
[Sabato 2.a sett. T.O. 24 gennaio 2026]
Superlavoro Missione Famiglia, da squilibrati
(Mc 3,20-21)
«E viene in Casa; e di nuovo si riunisce la folla, così che essi non potevano neppure mangiare Pane. E avendo udito, i suoi [i presso di lui] uscirono per prenderlo, perché dicevano: È fuori di sé».
Il breve Vangelo di oggi può essere interpretato secondo diversi piani di lettura: iniziamo con un approccio vocazionale.
La famiglia è nucleo della società di tutti i tempi, ma Cristo e il credente sanno che essa non deve costituire una gabbia.
Piuttosto dovrebbe configurarsi quale trampolino di lancio verso l’avventura della Fede, che sollecita altri legami.
La vita nello Spirito ci attiva per la costruzione del Centuplo, nella grande famiglia ecclesiale e umana.
I consanguinei possono rimanere costernati dal nostro desiderio di darsi interamente a Dio nei fratelli.
Di fronte all'attività estenuante si mettono in apprensione, perché procediamo sempre controcorrente… quindi i parenti stretti si preoccupano della nostra salute, o dell’onore di casa.
A volte, affetti e vincoli naturali possono impedire l’adempimento della Missione cui siamo chiamati.
Certo, quando a non capire sono proprio coloro da cui ci si aspetta più aiuto, la sofferenza si fa grande.
Talora, anche importanti impegni nell’azione della Chiesa rimangono a metà o del tutto frustrati - causa affetti e impedimenti che non riusciamo a tagliare.
Veniamo al livello storico.
Gesù ha avuto bei problemi anche in casa sua, ma il brano di Vangelo si riferisce alla Chiesa nascente nella dimora di Pietro a Cafarnao.
Realtà più istintiva e meno “qualificata”, però vicinissima alla tradizionale casa di preghiera [sinagoga] del luogo, collocata sulla medesima stradina perpendicolare al lago, appena poco più in alto.
Nel tempo, le due realtà quasi adiacenti si sono trovate a fronteggiarsi aspramente nella teologia - sino a competere perfino sul piano architettonico, come ben sanno gli archeologi.
La più “nobile” e antica delle due accusava l’altra di essere una sradicata - quindi inaccettabile, eccentrica per le sacre consuetudini identitarie del popolo eletto.
Eppure nella Dimora di Pietro a un certo punto esplode il numero dei provenienti dal giudaismo, nonché pagani che si convertono alla proposta del Signore.
Così la prima comunità dei credenti nel Signore inizia a essere forse più più corposa dell’assemblea in Sinagoga, a pochi passi.
Il Popolo stesso e la cultura religiosa che hanno generato Cristo [la sua «Famiglia»] faceva fatica a interrogarsi. E la prima reazione è di rifiuto.
Quella porzione della stirpe giudaica che riconosceva Gesù Messia sembrava volesse fare sempre più di testa sua.
Aspetto sociale:
Effettivamente il focolare e il clan propri si erano allarmati, perché Gesù adulto non seguiva un comportamento da sottomesso.
Comprometteva il nome del suo casato, spendeva energie per gli altri - sino a sfinire… assurdamente in favore di estranei, forse “nemici” della nazione giudaica.
Così i parenti decisero di riportarlo a forza (vv.31-35) considerandolo uno squilibrato che logorava i rapporti interni e le relazioni dell’intera dinastia con le autorità sul territorio.
Ma sappiamo che allargando il legame di “sangue” a coloro che ascoltano, Gesù non permise che fossero valutazioni esterne ad allontanarlo dal suo compito.
Vediamo quale era la situazione.
Nell’antico Israele il senso di comunità e il clan costituivano la base della convivenza. L’obbiettivo della Legge era: «Non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi» (Dt 15,4).
E come i grandi profeti, Cristo e i suoi intimi hanno tentato di rafforzare il senso di condivisione, tornando allo spirito profondo di ciò che un tempo erano articolazioni della coesistenza.
Appunto: clan, focolare, comunità - espressioni dell’amore di Dio che si manifesta.
La “grande Famiglia” assicurava protezione alle famiglie particolari e alle persone meno abbienti.
Essa era garanzia di proprietà della terra; quindi dava senso di libertà - e si faceva veicolo della possibilità di aderire alla propria tradizione.
Oltre che difesa di carattere culturale, era nella vita comunitaria che la gente di quell’epoca esprimeva lo spirito di solidarietà concreta.
Anche per Cristo, difendere il clan, il suo bagaglio spirituale, la sua azione fraterna... era difendere la stessa Alleanza.
Ma la Casa di Pietro [la Chiesa nascente] iniziava a sopravanzare tutta la realtà antica.
Le convinzioni ormai cristallizzate nella Sinagoga, nonché il portato teologico e benevolo di tutta la sua verità di compromesso - non sembravano più vitali. Perché?
Il sistema imperiale impiantato in Galilea aveva debilitato il senso di comunione larga e minuta, appunto di clan e focolare.
Erode il Grande - morto a Gerico nel 4 a.C. - e suo figlio Erode Antipa (37a.C.-39d.C.) avevano portato le famiglie a un livello di crisi tale da dover badare a se stesse e chiudersi nelle necessità più impellenti.
Le imposte da pagare al governo e al tempio erano sempre più esose, il che accentuava l’indebitamento.
Qua e là la mentalità ellenista s’insinuava con tratti d’individualismo prima sconosciuti alla mentalità semitica.
Il dovere imposto di accogliere le soldatesche e dare loro ospitalità in casa dove facevano quello che volevano anche sulle donne, e le frequenti minacce di repressione violenta, obbligavano la gente a dover badare a problemi di sopravvivenza.
Tutto ciò induceva alla chiusura, al ripiegamento sulle proprie necessità immediate.
Si praticava sempre meno l'ospitalità, la condivisione dei beni, quella della mensa, e l’asilo dei marginali. Espressioni di fraternità e cura in cui già i primi cristiani erano campioni.
In tal guisa, le chiusure erano rafforzate dalla religiosità dell’epoca.
L’osservanza sempre più accentuata delle norme di purezza costituiva un fattore di grave emarginazione sociale e culturale.
Intere fasce di popolazione venivano escluse dal rapporto con Dio: proprio quelle più bisognose di speranza, e di un volto.
Invece che promuovere accoglienza e compartecipazione, le norme devote addirittura favorivano separazioni ed esclusioni [in particolare: tutte le donne, i bambini, stranieri, malati o impediti...].
Struttura politica, economica e sociale, e ideologia sacra, cospiravano a favore dell’indebolimento dei valori centrali dello spirito, e la pratica di mettere in comune.
Nel passo di Vangelo di oggi si nota appunto come i limiti stretti della famiglia nucleare andassero a confliggere con la proposta del nuovo Rabbi: di recuperare l’afflato unitivo, sia in senso largo che di dettaglio.
Era insomma nella Casa di Pietro che la piccola famiglia acquisiva respiro, aprendosi non solo alla Nazione, bensì alla più ampia Famiglia della Comunità umana.
Assemblea integrale, anche di donne e malfermi, o incerti e lontani.
Realtà assolutamente nuova, non più radunata per il culto ma incapace di fare convivenza.
Quando Gesù, nel periodo trascorso sulla terra, si spostava di villaggio in villaggio predicando la Buona Novella di verità e di amore, catturava l'attenzione di quanti lo ascoltavano. Diversamente dagli Scribi, che venivano rifiutati a causa della loro ipocrisia, ci viene detto che il Signore stupiva perché "insegnava loro come uno che ha autorità" (Mc, 1, 22). Infatti, ogni comunità umana ha bisogno, e quindi ne va alla ricerca, di responsabili forti ed ispiratori che guidino gli altri lungo un cammino di speranza […]
Nessuno può esimersi da questo processo. Sebbene nessuna cultura possa utilizzare i danni subiti in passato come pretesto per evitare di affrontare le difficoltà insite nel soddisfacimento delle esigenze sociali contemporanee del proprio popolo, è anche vero che solo attraverso la disponibilità ad accettare la verità storica è possibile acquisire una sana comprensione della realtà contemporanea e aderire alla visione di un futuro armonioso […]
L'impegno per la verità apre la via alla riconciliazione duratura attraverso un processo di guarigione che implica il chiedere e il concedere il perdono, due indispensabili elementi di pace. In tal modo, la nostra memoria viene purificata, il nostro cuore reso sereno e il nostro futuro riempito di una speranza ben fondata sulla pace che scaturisce dalla verità.
[Papa Benedetto, Lettera per il XX anniversario della visita di Giovanni Paolo II in Australia, 22 settembre 2006]
Pienezza di Rivelazione, Spirito principio di vita e Maestro interiore
1. La vita spirituale ha bisogno di illuminazione e di guida. Per questo Gesù, nel fondare la Chiesa e nel mandare gli Apostoli nel mondo, ha affidato loro il compito di ammaestrare tutte le genti, come leggiamo nel Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 19-20), ma anche di “predicare il Vangelo a tutta la creazione”, come dice il testo canonico del Vangelo di Marco (Mc 16, 15). Anche San Paolo parla dell’apostolato come di una “illuminazione di tutti” (Ef 3, 9).
Ma quest’opera della Chiesa evangelizzatrice e docente appartiene al ministero degli Apostoli e dei loro successori e, a titolo diverso, a tutti i membri della Chiesa, per continuare per sempre l’opera di Cristo “unico Maestro” (Mt 23, 8), che ha portato all’umanità la pienezza della rivelazione di Dio. Rimane la necessità di un Maestro interiore, che faccia penetrare nello spirito e nel cuore degli uomini l’insegnamento di Gesù. È lo Spirito Santo, che Gesù stesso chiama “Spirito di verità”, e che promette come Colui che guiderà verso tutta la verità (cf. Gv 14, 17; 16, 13). Se Gesù ha detto di sé: “Io sono la verità” (Gv 14, 6), è questa verità di Cristo che lo Spirito Santo fa conoscere e diffonde: “Non parlerà di sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito . . . prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Gv 16, 13-14). Lo Spirito è Luce dell’anima: “Lumen cordium”, come lo invochiamo nella Sequenza di Pentecoste.
2. Lo Spirito Santo è stato Luce e Maestro interiore per gli Apostoli che dovevano conoscere Cristo in profondità per poter assolvere il compito di suoi evangelizzatori. Lo è stato e lo è per la Chiesa, e, nella Chiesa, per i credenti di tutte le generazioni e in modo particolare per i teologi e i maestri di spirito, per i catechisti e i responsabili di comunità cristiane. Lo è stato e lo è anche per tutti coloro che, dentro e fuori dei confini visibili della Chiesa, vogliono seguire le vie di Dio con cuore sincero, e senza loro colpa non trovano chi li aiuti a decifrare gli enigmi dell’anima e a scoprire la verità rivelata. Voglia il Signore concedere a tutti i nostri fratelli - milioni e anzi miliardi di uomini - la grazia del raccoglimento e della docilità allo Spirito Santo in momenti che possono essere decisivi nella loro vita.
Per noi cristiani il magistero intimo dello Spirito Santo è una gioiosa certezza, fondata sulla parola di Cristo circa la venuta dell’“altro Paraclito”, che - diceva - “il Padre manderà nel mio nome. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto” (Gv 14, 26). “Egli vi guiderà verso tutta la verità” (Gv 16, 13).
3. Come risulta da questo testo, Gesù non affida la sua parola soltanto alla memoria dei suoi uditori: questa memoria sarà aiutata dallo Spirito Santo, che ravviverà continuamente negli apostoli il ricordo degli eventi e il senso dei misteri evangelici.
Di fatto, lo Spirito Santo ha guidato gli Apostoli nella trasmissione della parola e della vita di Gesù, ispirando sia la loro predicazione orale e i loro scritti, sia la redazione dei Vangeli, come abbiamo visto a suo tempo nella catechesi sullo Spirito Santo e la rivelazione.
Ma è ancora Lui che ai lettori della Scrittura dà l’aiuto per capire il significato divino incluso nel testo di cui Egli stesso è l’ispiratore e l’autore principale: Lui solo può far conoscere “le profondità di Dio” (1 Cor 2, 10), quali sono contenute nel testo sacro; Lui che è stato mandato per istruire i discepoli sugli insegnamenti del loro Maestro (cf. Gv 16, 13).
4. Di questo intimo magistero dello Spirito Santo ci parlano gli Apostoli stessi, primi trasmettitori della parola di Cristo. Scrive San Giovanni: “Ora voi avete l’unzione ricevuta dal Santo (Cristo) e tutti siete ammaestrati. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità” (1 Gv 2, 20-21). Secondo i Padri della Chiesa e la maggioranza degli esegeti moderni, questa “unzione” (chrisma) designa lo Spirito Santo. San Giovanni afferma anzi che coloro che vivono secondo lo Spirito non hanno bisogno di altri maestri: “Quanto a voi - egli scrive - l’unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri; ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce, così state saldi in Lui, come essa vi insegna” (1 Gv 2, 27).
Anche l’apostolo Paolo parla di una comprensione secondo lo Spirito, che non è frutto di sapienza umana, ma di illuminazione divina: “L’uomo naturale (psichicòs) non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follie per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L’uomo spirituale (pneumaticòs) invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno” (1 Cor 2, 14-15).
Dunque i cristiani, avendo ricevuto lo Spirito Santo, unzione di Cristo, possiedono in se stessi una fonte di conoscenza della verità, e lo Spirito Santo è il Maestro sovrano che li illumina e guida.
5. Se sono docili e fedeli al suo magistero divino, lo Spirito Santo li preserva dall’errore rendendoli vittoriosi nel continuo conflitto tra “spirito della verità” e “spirito dell’errore” (cf. 1 Gv 4, 6). Lo spirito dell’errore, che non riconosce Cristo (cf. 1 Gv 4, 3), viene sparso dai “falsi profeti”, sempre presenti nel mondo, anche in mezzo al popolo cristiano, con un’azione ora scoperta e persino clamorosa, ora subdola e strisciante. Come Satana, anch’essi a volte si rivestono da “angeli di luce” (cf. 2 Cor 11, 14) e si presentano con apparenti carismi di ispirazione profetica e apocalittica. Questo avveniva già nei tempi apostolici. Perciò San Giovanni avverte: “Non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo” (1 Gv 4, 1). Lo Spirito Santo, come ha ricordato il Concilio Vaticano II (cf. Lumen gentium, 12), protegge il cristiano dall’errore facendogli discernere ciò che è genuino da ciò che è spurio. Da parte del cristiano, ci vorranno sempre buoni criteri di discernimento circa le cose che ascolta o legge in materia di religione, di Sacra Scrittura, di manifestazioni del soprannaturale ecc. Tali criteri sono la conformità al Vangelo, perché lo Spirito Santo non può non “prendere da Cristo”; la sintonia con l’insegnamento della Chiesa, fondata e mandata da Cristo a predicare la sua verità; la rettitudine della vita di chi parla o scrive; i frutti di santità derivanti da ciò che viene presentato o proposto.
6. Lo Spirito Santo insegna al cristiano la verità come principio di vita. Mostra l’applicazione concreta delle parole di Gesù nella vita di ognuno. Fa scoprire l’attualità del Vangelo e il suo valore per tutte le situazioni umane. Adatta l’intelligenza della verità ad ogni circostanza, affinché questa verità non rimanga soltanto astratta e speculativa, e liberi il cristiano dai pericoli della doppiezza e dell’ipocrisia.
Per questo lo Spirito Santo illumina ciascuno personalmente, per guidarlo nel suo comportamento, indicandogli la via da seguire, aprendogli almeno qualche spiraglio sul progetto del Padre circa la sua vita. È la grande grazia di luce che San Paolo chiedeva per i Colossesi: “l’intelligenza spirituale”, capace di far loro capire la volontà divina. Li assicurava infatti: “Non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate una piena conoscenza della sua (di Dio) volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona . . .” (Col 1, 9-10). Per noi tutti è necessaria questa grazia di luce, per conoscere bene la volontà di Dio su di noi e per essere in grado di vivere pienamente la nostra vocazione personale.
Non mancano mai i problemi, che a volte sembrano insolubili. Ma lo Spirito Santo soccorre nelle difficoltà ed illumina. Egli può rivelare la soluzione divina, come al momento dell’Annunciazione per il problema della conciliazione della maternità col desiderio di conservare la verginità. Anche quando non si tratti di un mistero unico come quello dell’intervento di Maria nell’Incarnazione del Verbo, si può dire che lo Spirito Santo possiede un’inventiva infinita, propria della mente divina, che sa provvedere a sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse e impenetrabili.
7. Tutto ciò viene concesso e operato nell’anima dallo Spirito Santo mediante i suoi doni, grazie ai quali è possibile praticare un buon discernimento non secondo i criteri della sapienza umana, che è stoltezza davanti a Dio, ma di quella divina, che può sembrare stoltezza agli occhi degli uomini (cf. 1 Cor 1, 18.25). In realtà solo lo Spirito “scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio” (1 Cor 2, 10-11). E se vi è opposizione fra lo spirito del mondo e lo Spirito di Dio, Paolo rammenta ai cristiani: “Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato” (1 Cor 2, 12). A differenza dell’“uomo naturale”, quello “spirituale” (pneumaticòs) è sinceramente aperto allo Spirito Santo, docile e fedele alle sue ispirazioni (cf. 1 Cor 2, 14-16). Perciò egli ha abitualmente la capacità di un retto giudizio sotto la guida della sapienza divina.
8. Un segno del reale contatto con lo Spirito Santo nel discernimento è e sarà sempre l’adesione alla verità rivelata come viene proposta dal magistero della Chiesa. Il Maestro interiore non ispira il dissenso, la disubbidienza, o anche solo la resistenza ingiustificata ai pastori e maestri stabiliti da Lui stesso nella Chiesa (cf. At 20, 29). All’autorità della Chiesa, come dice il Concilio nella costituzione Lumen gentium, spetta “di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cf. 1 Ts 5, 12.19-21)” (Lumen gentium, 12). È la linea di sapienza ecclesiale e pastorale che viene, anch’essa, dallo Spirito Santo.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 24 aprile 1991]
«I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente». Papa Francesco ha ripetuto più volte questo invito al cambiamento, durante la messa celebrata venerdì mattina, 23 ottobre, nella cappella di Casa Santa Marta. Un invito ad agire «senza paura» e «con libertà», tenendosi alla larga dai conformismi tranquillizzanti e restando «saldi nella fede in Gesù» e «nella verità del Vangelo», ma muovendosi «continuamente secondo i segni dei tempi».
Lo spunto per la riflessione è stato offerto al Pontefice dalle letture di questa ultima parte dell’anno liturgico, che propongono in particolare la lettera ai Romani. «Abbiamo sottolineato — ha ricordato in proposito — come Paolo predica con tanta forza, la libertà che noi abbiamo in Cristo». Si tratta, ha spiegato il Papa, di «un dono, il dono della libertà, di quella libertà che ci ha salvato dal peccato, che ci ha fatto liberi, figli di Dio come Gesù; quella libertà che ci porta a chiamare Dio Padre». Quindi Francesco ha aggiunto che «per avere questa libertà dobbiamo aprirci alla forza dello Spirito e capire bene cosa accade dentro di noi e fuori di noi». E se nei «giorni passati, la settimana scorsa», ci si era soffermati «su come distinguere quello che succede dentro di noi: cosa viene dal buono Spirito o cosa non viene da lui», ovvero sul discernimento di quanto «succede dentro di noi», nella liturgia del giorno il brano del Vangelo di Luca (12, 54-59) esorta a «guardare fuori», facendo «riflettere su come noi valutiamo le cose che accadono fuori di noi».
Ecco allora la necessità di interrogarci su «come giudichiamo: siamo capaci di giudicare?». Per il Papa «le capacità le abbiamo» e lo stesso Paolo «ci dice che noi giudicheremo il mondo: noi cristiani giudicheremo il mondo». Anche l’apostolo Pietro dice una cosa analoga quando «ci chiama stirpe scelta, sacerdozio santo, nazione eletta proprio per la santità».
Insomma, ha chiarito il Pontefice, noi cristiani «abbiamo questa libertà di giudicare quello che succede fuori di noi». Ma — ha avvertito — «per giudicare dobbiamo conoscere bene quello che accade fuori di noi». E allora, si è domandato Francesco, «come si può fare questo, che la Chiesa chiama “conoscere i segni dei tempi”?».
In proposito il Papa ha osservato che «i tempi cambiano. È proprio della saggezza cristiana conoscere questi cambiamenti, conoscere i diversi tempi e conoscere i segni dei tempi. Cosa significa una cosa e cosa un’altra». Certo, il Papa è consapevole che ciò «non è facile. Perché noi sentiamo tanti commenti: “Ho sentito che quello che è accaduto là è questo o quello che accade là è l’altro; ho letto questo, mi hanno detto questo...». Però, ha subito aggiunto, «io sono libero, io devo fare il mio proprio giudizio e capire cosa significhi tutto ciò». Mentre «questo è un lavoro che di solito noi non facciamo: ci conformiamo, ci tranquillizziamo con “mi hanno detto; ho sentito; la gente dice; ho letto...”. E così siamo tranquilli». Quando invece dovremmo chiederci: «Qual è la verità? Qual è il messaggio che il Signore vuole darmi con quel segno dei tempi?».
Come di consueto il Papa ha anche proposto suggerimenti pratici «per capire i segni dei tempi». Anzitutto, ha detto, «è necessario il silenzio: fare silenzio e guardare, osservare. E dopo riflettere dentro di noi. Un esempio: perché ci sono tante guerre adesso? Perché è successo qualcosa? E pregare». Dunque «silenzio, riflessione e preghiera. Soltanto così potremo capire i segni dei tempi, cosa Gesù vuol dirci».
E in questo senso non ci sono alibi. Sebbene infatti ognuno di noi possa essere tentato di dire: «Ma, io non ho studiato tanto... Non sono andato all’università e neppure alla scuola media...», le parole di Gesù non lasciano spazio ai dubbi. Egli infatti non dice: «Guardate come fanno gli universitari, guardate come fanno i dottori, guardate come fanno gli intellettuali...». Al contrario, dice: «Guardate ai contadini, ai semplici: loro, nella loro semplicità, sanno capire quando arriva la pioggia, come cresce l’erba; sanno distinguere il grano dalla zizzania». Di conseguenza «quella semplicità — se viene accompagnata dal silenzio, dalla riflessione e dalla preghiera — ci farà capire i segni dei tempi». Perché, ha ribadito, «i tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente. Dobbiamo cambiare saldi nella fede in Gesù Cristo, saldi nella verità del Vangelo, ma il nostro atteggiamento deve muoversi continuamente secondo i segni dei tempi».
Al termine della sua riflessione il Pontefice è ritornato sui pensieri iniziali. «Siamo liberi — ha affermato — per il dono della libertà che ci ha dato Gesù Cristo. Ma il nostro lavoro è esaminare cosa succede dentro di noi, discernere i nostri sentimenti, i nostri pensieri; e analizzare cosa accade fuori di noi, discernere i segni dei tempi». Come? «Col silenzio, con la riflessione e con la preghiera», ha ripetuto a conclusione dell’omelia.
[Papa Francesco, s. Marta, in L’Osservatore Romano 24/10/2015]
Pescatori, Conversione, Regno vicino. Felicità non scadente
Chiama a Sé e ‘fa’ i Dodici: emergenza grande, per piccolo Nome
(Mc 3,13-19)
In Cristo, medico dell'umanità sofferente, le cose dell’anima sembrano diverse, e così le relazioni.
Tutto questo porta il suo gruppo a una differente visione di sé, della storia, del mondo, delle moltitudini (vv.7-9) e dei problemi.
L’asse è stare con Lui (v.14) ossia formare Chiesa in Lui. Infatti è fondamentale prima maturare, ovunque viviamo.
Chi coltiva molte brame, le proietta; procura i suoi stessi influssi torbidi. Per questo è necessaria la riflessone; quella critica, che scava davvero.
Essa trasmette il senso del nostro scendere in campo, e una retta disposizione.
Lo stare con Gesù annienta le infedeltà che non proponendo semplicità di vita e valori dello spirito, allontanano, edificando altri templi e santuari.
La carica di universalità contenuta nel radicamento ai valori trasmesso dal dialogo con Lui, c’interroga; nelle relazioni così come nella conoscenza di sé.
Comprendiamo che… stimoli, flessioni, princìpi virtuosi, lacune, lati nascosti, traguardi e momenti-no sono aspetti energetici complementari.
Sembra un paradosso, ma l’apertura ai bisogni delle moltitudini resta un problema squisitamente non esteriore.
È da se stessi e a partire dalla comunità già variegata che si guarda il mondo, sapendone recuperare i lati opposti.
È la Via dell’Interno che compenetra la via dell’esterno.
È la strada intima a poter combattere il potere del male che soffoca gli aneliti di vita e annienta le personalità.
Bisogna anzitutto guarire ciò ch’è essenziale e prossimo.
Certo, chi non accetta il rischio, non può essere missionario; chi non è inserito fra i poveri, non conosce il loro mondo.
Ma chi non è ‘fatto’ libero [v.14: «fece Dodici»] non può liberare (v.15).
Chi non è formato non può educare; non può ‘rifare la storia dall’inizio’.
Unico modo poi di scrutare lontano e senza confini è ‘attenersi alla ragione delle cose’.
Principio che si conosce in Cristo Logos e solo se non fuorviati dalla superficialità delle riduzioni.
Intesa in Dio la natura delle creature, e conformandovisi, tutti vengono ispirati a trasmutare e completarsi, senza forzature alienanti.
Esercitando una pratica di ‘bontà anche con se stessi’.
Per capire questo e avvicinarsi al senso della loro Unicità missionale, il Figlio stesso deve salire su «‘il’ Monte» (v.13), assimilandosi alla Visione del Padre.
Nessuno degli apostoli era per sé degno della Chiamata.
Gran parte di loro ha nomi tipici del giudaismo, addirittura del tempo dei patriarchi - il che indica un’estrazione culturale e spirituale radicata più nella religione comune che nella Fede personale; non facile da gestire.
Eppure fatti suoi ‘intimi, per Nome’ - catena che ha unito il Cielo con il destino della loro missione sanante, ormai senza steccati.
Annuncio di nuova Luce accolta in Dono: dove appunto non appare una sola forma o un solo colore.
Per un contagio non allarmistico né unilaterale, ma florido, poliedrico, talora “nascosto” - e inquieto.
[Venerdì 2.a sett. T.O. 23 gennaio 2026]
Chiama a Sé e fa i Dodici: emergenza grande, per piccolo Nome
(Mc 3,13-19)
In Cristo, medico dell'umanità sofferente, le cose dell’anima sembrano diverse, e così le relazioni.
Tutto questo porta il suo gruppo a una differente visione di sé, della storia, del mondo, delle moltitudini (vv.7-9) e dei problemi.
Abbiamo già notato che nella Comunità di Gesù è bandito ogni ammiccamento al ripiegamento devoto, malgrado le fatiche, gli sbigottimenti e le inquietudini.
Così resta primario il tema sia della Persona ben configurata che della Comunità: non si prescinde dalla sensibilità o dai bisogni particolari, né dall’elemento ecclesiale - convivialità delle differenze.
Qui Gesù si colloca al centro degli ideali del cammino nello Spirito.
Egli è fulcro, motivo e motore di un’umanità che ovunque chiede risposte non dottrinali o moralistiche, né ridotte o astratte, all’anelito di vita completa che sente pulsare dentro.
Tutto ciò nell’anima di ogni persona come nel genio di qualsiasi civiltà.
L’asse è stare con Lui (v.14) ossia formare Chiesa in Lui.
È fondamentale prima maturare, ovunque viviamo. [Ci sono motivi poco nobili per voler giungere ovunque, correre dappertutto per fare proseliti, e farlo subito].
Chi coltiva molte brame, le proietta; procura i suoi stessi influssi torbidi. Lo vediamo anche in clamorose vicende contemporanee, manipolatorie di grandi realtà - prima insospettabili.
Per questo è necessaria la riflessone; quella critica, che scava davvero.
Essa trasmette il senso del nostro scendere in campo, e una retta disposizione.
Lo stare con Gesù annienta le infedeltà che non proponendo semplicità di vita e valori dello spirito, allontanano, edificando altri templi e santuari.
La carica di universalità contenuta nel radicamento ai valori trasmesso dal dialogo con Lui, c’interroga; nelle relazioni così come nella conoscenza di sé.
Comprendiamo che… stimoli, flessioni, princìpi virtuosi, lacune, lati nascosti, traguardi e momenti no sono aspetti energetici complementari.
Dice il Tao Tê Ching (LXIII): «Considera grande il piccolo, e molto il poco».
Commenta il maestro Ho-shang Kung: «Se vuoi il grande, volgiti al piccolo. Se vuoi il molto, volgiti al poco. È la via della spontaneità».
Sembra un paradosso, ma l’apertura ai bisogni delle moltitudini è un problema squisitamente non esteriore.
È da se stessi e a partire dalla comunità già variegata che si guarda il mondo, sapendone recuperare i lati opposti.
È la Via dell’Interno che compenetra la via dell’esterno.
È la strada intima a poter combattere il potere del male che soffoca gli aneliti di vita e annienta le personalità.
Bisogna anzitutto guarire ciò ch’è essenziale e prossimo.
Certo, chi non accetta il rischio non può essere missionario; chi non è inserito fra i poveri, non conosce il loro mondo.
Ma chi non è fatto libero [v.14: «fece Dodici»] non può liberare (v.15). Chi non è formato non può educare; non può rifare la storia dall’inizio.
Unico modo poi di scrutare lontano e senza confini è attenersi alla ragione delle cose.
Principio che si conosce in Cristo Logos, e solo se non fuorviati dalla superficialità delle riduzioni.
Intesa in Dio la natura delle creature e conformandovisi in modo crescente, tutti vengono ispirati a trasmutare e completarsi, arricchendo anche la sclerosi culturale, senza forzature alienanti.
Esercitando una pratica di bontà anche con se stessi.
Il Tao Tê Ching (xvi) sottolinea:
«Restituire il mandato è eternità [...] Chi conosce l’eternità tutto abbraccia». Passo che invita a volgersi alla Scaturigine anche dopo il rigoglio.
E il maestro Ho-shang Kung commenta:
«Tutte le creature appassiscono e cadono, ma ciascuna, tornando alla radice, ancor più vive».
Solo dalla Fonte dell’essere poliedrico zampilla una vita da salvati; esuberante, a tutto tondo, senza nevrosi.
Allora chiediamoci: siamo segno di dedizione e persone protese?
Certamente, ma senza fare la setta, e solo dopo aver incontrato i nostri stati limite.
E in tal guisa immergendosi in una buona consuetudine col Signore, che ci trasmette anche sapiente tolleranza - a partire dal mondo di dentro.
Non per distinguere il momento della Vocazione da quello dell’Invio ministeriale. Ma per il motivo che la via del Cielo è intrecciata alla strada della Persona - o saremo operatori da strapazzo.
Per capire questo e avvicinarsi al senso della loro unicità missionale, il Figlio stesso deve salire su «il Monte» (v.13), assimilandosi alla visione del Padre.
Nessuno degli apostoli era per sé degno della Chiamata.
Gran parte di loro ha nomi tipici del giudaismo, addirittura del tempo dei patriarchi - il che indica un’estrazione culturale e spirituale radicata più nella religione comune che nella Fede personale; non facile da gestire.
Eppure tutti fatti suoi intimi, per Nome - catena che ha unito il Cielo con il destino della loro missione sanante, senza più steccati.
Pietro smaniava per farsi avanti, pur retrocedendo spesso - marcia indietro - sino a diventare per Gesù un «satàn» [(Mt 16,23; Mc 8,33): nella cultura dell’oriente antico, un funzionario del gran sovrano, inviato a fare il controllore e delatore - praticamente un accusatore].
Giacomo di Zebedeo e Giovanni erano fratelli, accesi fondamentalisti, e in modo iroso volevano il Maestro solo per loro, nonché i primi posti.
Filippo [condizionato forse da un’estrazione ellenista, come indica il suo nome] a prima vista non sembrava un tipo molto pratico, né svelto a cogliere le cose di Dio.
Andrea pare invece se la cavasse bene: persona inclusiva.
Stando a note identificazioni tradizionali, Bartolomeo era forse aperto ma perplesso, perché il Messia non gli corrispondeva granché.
Tommaso sempre un poco dentro e un po’ fuori.
Matteo… un collaborazionista, avido complice del sistema oppressivo, e che volentieri estorceva denaro alla sua gente [il popolo lo condannava in modo spietato].
Simone - lo zelota, il cananeo - una testa calda.
Giuda Iscariota un tormentato, che si autodistrugge per essersi fidato di vecchie guide spirituali - impregnate d’ideologia nazionalista, interesse privato, opportunismo, potere.
Altri due (Giacomo il minore figlio di Alfeo, e Giuda Taddeo) forse semplici discepoli di non grande rilievo o capacità d’iniziativa.
Ma il Regno è «locale e universale» [Fratelli Tutti, nn.142-153], Vicino e per Nome - come si evince dal passo del Vangelo di Mc.
Questa la forza molteplice, graffiante, impareggiabile, prossima e appunto personale, la quale vince ogni possibilità di sabotaggio ideale (a motivo di circostanze avverse).
Potenza attinta dalla preghiera diretta al Padre in Cristo - nel suo Ascolto (v.13a) - nonché dalle opere d’amore (v.10).
Potenze in simbiosi parimenti singolare, sensibile, condivisa.
Non per soli eccellenti - o anche nel tempo dell’emergenza globale non vi sarà opera sanante, bensì solo esterna, accusatoria e finalizzata alla propaganda, al proselitismo.
Ecco: Annuncio e Missione di nuova Luce accolta in Dono; dove appunto non appare una sola forma o un solo colore.
E l’Asse è «stare» con Lui.
Per un contagio non allarmistico né unilaterale, monocromatico, bensì florido, poliedrico, talora “nascosto” - e inquieto.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Nella tua esperienza, quale catena ha unito il Cielo e la terra?
L’elenco (accusatorio) e lo sforzo delle trasgressioni da correggere in modo nevrotico?
O una Chiamata personale, inclusiva dei tuoi molti volti nell’anima - Vocazione sostenuta da una Chiesa fattasi eco e Fonte gratuita di comprensione a tutto tondo?
La Chiesa è stata costituita sul fondamento degli Apostoli come comunità di fede, di speranza e di carità. Attraverso gli Apostoli, risaliamo a Gesù stesso. La Chiesa cominciò a costituirsi quando alcuni pescatori di Galilea incontrarono Gesù, si lasciarono conquistare dal suo sguardo, dalla sua voce, dal suo invito caldo e forte: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini!" (Mc 1, 17; Mt 4, 19). Il mio amato Predecessore, Giovanni Paolo II, ha proposto alla Chiesa, all'inizio del terzo millennio, di contemplare il volto di Cristo (cfr Novo millennio ineunte, 16 ss). Muovendomi nella stessa direzione, nelle catechesi che oggi comincio vorrei mostrare come proprio la luce di quel Volto si rifletta sul volto della Chiesa (cfr Lumen gentium, 1), nonostante i limiti e le ombre della nostra umanità fragile e peccatrice. Dopo Maria, riflesso puro della luce di Cristo, sono gli Apostoli, con la loro parola e la loro testimonianza, a consegnarci la verità di Cristo. La loro missione non è tuttavia isolata, ma si colloca dentro un mistero di comunione, che coinvolge l'intero Popolo di Dio e si realizza a tappe, dall'antica alla nuova Alleanza.
Va detto in proposito che si fraintende del tutto il messaggio di Gesù se lo si separa dal contesto della fede e della speranza del popolo eletto: come il Battista, suo immediato precursore, Gesù si rivolge anzitutto a Israele (cfr Mt 15, 24), per farne la "raccolta" nel tempo escatologico giunto con lui. E come quella di Giovanni, così la predicazione di Gesù è al tempo stesso chiamata di grazia e segno di contraddizione e di giudizio per l'intero popolo di Dio. Pertanto, sin dal primo momento della sua attività salvifica Gesù di Nazaret tende a radunare il Popolo di Dio. Anche se la sua predicazione è sempre un appello alla conversione personale, egli in realtà mira continuamente alla costituzione del Popolo di Dio che è venuto a radunare, a purificare ed a salvare. Risulta perciò unilaterale e priva di fondamento l'interpretazione individualistica, proposta dalla teologia liberale, dell'annuncio che Cristo fa del Regno. Essa è così riassunta nell'anno 1900 dal grande teologo liberale Adolf von Harnack nelle sue lezioni su L'essenza del cristianesimo: "Il regno di Dio viene, in quanto viene in singoli uomini, trova accesso alla loro anima ed essi lo accolgono. Il regno di Dio è la signoria di Dio, certo, ma è la signoria del Dio santo nei singoli cuori" (Lezione Terza, 100s). In realtà, questo individualismo della teologia liberale è un'accentuazione tipicamente moderna: nella prospettiva della tradizione biblica e nell'orizzonte dell'ebraismo, in cui l'opera di Gesù si colloca pur con tutta la sua novità, risulta chiaro che tutta la missione del Figlio fatto carne ha una finalità comunitaria: Egli è venuto proprio per unire l'umanità dispersa, è venuto proprio per raccogliere, per unire il popolo di Dio.
Un segno evidente dell'intenzione del Nazareno di radunare la comunità dell'alleanza, per manifestare in essa il compimento delle promesse fatte ai Padri, che parlano sempre di convocazione, di unificazione, di unità, è l'istituzione dei Dodici. Abbiamo sentito il Vangelo su questa istituzione dei Dodici. Ne leggo ancora una volta la parte centrale: "Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che egli volle ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demòni. Costituì dunque i Dodici..." (Mc 3, 13-16; cfr Mt 10, 1-4; Lc 6, 12-16). Nel luogo della rivelazione, "il monte", Gesù, con iniziativa che manifesta assoluta consapevolezza e determinazione, costituisce i Dodici perché siano con lui testimoni e annunciatori dell'avvento del Regno di Dio. Sulla storicità di questa chiamata non ci sono dubbi, non solo in ragione dell'antichità e della molteplicità delle attestazioni, ma anche per il semplice motivo che vi compare il nome di Giuda, l'apostolo traditore, nonostante le difficoltà che questa presenza poteva comportare per la comunità nascente. Il numero Dodici, che richiama evidentemente le dodici tribù d'Israele, rivela già il significato di azione profetico-simbolica implicito nella nuova iniziativa di rifondare il popolo santo. Tramontato da tempo il sistema delle dodici tribù, la speranza d'Israele ne attendeva la ricostituzione come segno dell'avvento del tempo escatologico (si pensi alla conclusione del libro di Ezechiele: 37, 15-19; 39, 23-29; 40-48). Scegliendo i Dodici, introducendoli ad una comunione di vita con sé e rendendoli partecipi della sua missione di annuncio del Regno in parole ed opere (cfr Mc 6, 7-13; Mt 10, 5-8; Lc 9, 1-6; Lc 6, 13), Gesù vuol dire che è arrivato il tempo definitivo in cui si costituisce di nuovo il popolo di Dio, il popolo delle dodici tribù, che diventa adesso un popolo universale, la sua Chiesa.
Con la loro stessa esistenza i Dodici - chiamati da provenienze diverse - diventano un appello a tutto Israele perché si converta e si lasci raccogliere nell'alleanza nuova, pieno e perfetto compimento di quella antica. L'aver affidato ad essi nella Cena, prima della sua Passione, il compito di celebrare il suo memoriale, mostra come Gesù volesse trasferire all'intera comunità nella persona dei suoi capi il mandato di essere, nella storia, segno e strumento del raduno escatologico, in lui iniziato. In un certo senso possiamo dire che proprio l'Ultima Cena è l'atto della fondazione della Chiesa, perché Egli dà se stesso e crea così una nuova comunità, una comunità unita nella comunione con Lui stesso. In questa luce, si comprende come il Risorto conferisca loro - con l'effusione dello Spirito - il potere di rimettere i peccati (cfr Gv 20, 23). I dodici Apostoli sono così il segno più evidente della volontà di Gesù riguardo all'esistenza e alla missione della sua Chiesa, la garanzia che fra Cristo e la Chiesa non c'è alcuna contrapposizione: sono inseparabili, nonostante i peccati degli uomini che compongono la Chiesa. È pertanto del tutto inconciliabile con l'intenzione di Cristo uno slogan di moda alcuni anni fa: "Gesù sì, Chiesa no". Questo Gesù individualistico scelto è un Gesù di fantasia. Non possiamo avere Gesù senza la realtà che Egli ha creato e nella quale si comunica. Tra il Figlio di Dio fatto carne e la sua Chiesa v'è una profonda, inscindibile e misteriosa continuità, in forza della quale Cristo è presente oggi nel suo popolo. È sempre contemporaneo a noi, è sempre contemporaneo nella Chiesa costruita sul fondamento degli Apostoli, è vivo nella successione degli Apostoli. E questa sua presenza nella comunità, nella quale Egli stesso si dà sempre a noi, è motivo della nostra gioia. Sì, Cristo è con noi, il Regno di Dio viene.[Papa Benedetto, Udienza Generale 15 marzo 2006]
Today, as on the day of our Baptism, we hear the words of Jesus addressed to us: “Ephphatha, be opened!” Open your ears. Jesus, I want to open myself to your Word; Jesus, open myself to listening to you; Jesus, heal my heart from being closed, heal my heart from haste, heal my heart from impatience (Pope Francis)
Sentiamo rivolta a noi oggi, come nel giorno del Battesimo, quella parola di Gesù: “Effatà, apriti”! Apriti le orecchie. Gesù, desidero aprirmi alla tua Parola; Gesù, aprirmi al tuo ascolto; Gesù, guarisci il mio cuore dalla chiusura, guarisci il mio cuore dalla fretta, guarisci il mio cuore dall’impazienza (Papa Francesco)
And this is the problem: when the People put down roots in the land and are the depository of the Law, they are tempted to place their security and joy in something that is no longer the Word of God: in possessions, in power, in other ‘gods’ that in reality are useless, they are idols. Of course, the Law of God remains but it is no longer the most important thing, the rule of life; rather, it becomes a camouflage, a cover-up, while life follows other paths, other rules, interests that are often forms of egoism, both individual and collective. Thus religion loses its authentic meaning, which is to live listening to God in order to do his will — that is the truth of our being — and thus we live well, in true freedom, and it is reduced to practising secondary customs which instead satisfy the human need to feel in God’s place. This is a serious threat to every religion which Jesus encountered in his time and which, unfortunately, is also to be found in Christianity. Jesus’ words against the scribes and Pharisees in today’s Gospel should therefore be food for thought for us as well (Pope Benedict)
Ed ecco il problema: quando il popolo si stabilisce nella terra, ed è depositario della Legge, è tentato di riporre la sua sicurezza e la sua gioia in qualcosa che non è più la Parola del Signore: nei beni, nel potere, in altre ‘divinità’ che in realtà sono vane, sono idoli. Certo, la Legge di Dio rimane, ma non è più la cosa più importante, la regola della vita; diventa piuttosto un rivestimento, una copertura, mentre la vita segue altre strade, altre regole, interessi spesso egoistici individuali e di gruppo. E così la religione smarrisce il suo senso autentico che è vivere in ascolto di Dio per fare la sua volontà - che è la verità del nostro essere - e così vivere bene, nella vera libertà, e si riduce a pratica di usanze secondarie, che soddisfano piuttosto il bisogno umano di sentirsi a posto con Dio. Ed è questo un grave rischio di ogni religione, che Gesù ha riscontrato nel suo tempo, ma che si può verificare, purtroppo, anche nella cristianità. Perciò le parole di Gesù nel Vangelo di oggi contro gli scribi e i farisei devono far pensare anche noi (Papa Benedetto)
Salt, in the cultures of the Middle East, calls to mind several values such as the Covenant, solidarity, life and wisdom. Light is the first work of God the Creator and is a source of life; the word of God is compared to light (Pope Benedict)
Il sale, nella cultura mediorientale, evoca diversi valori quali l’alleanza, la solidarietà, la vita e la sapienza. La luce è la prima opera di Dio Creatore ed è fonte della vita; la stessa Parola di Dio è paragonata alla luce (Papa Benedetto)
Even after his failure even in Nazareth (vv.1-6) - his heralds gladly confused the Servant [who was educating them] with the victorious, sighed, respected and glorious Messiah…
Ancora dopo il suo fallimento persino a Nazareth (vv.1-6) - i suoi banditori hanno ben volentieri confuso il Servo [che li stava educando] col Messia vincitore, sospirato, rispettato e glorioso…
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.