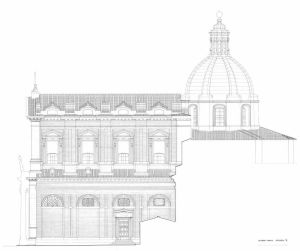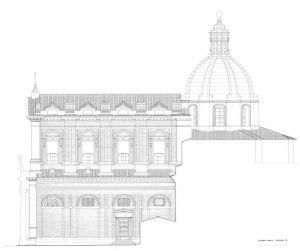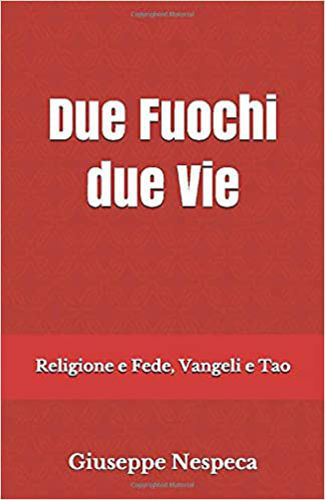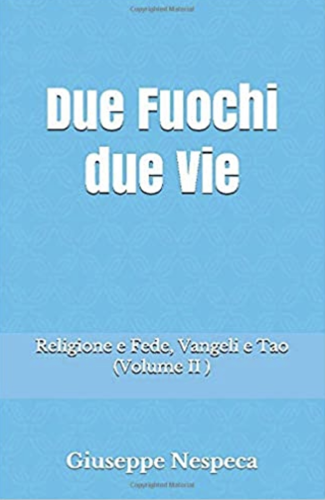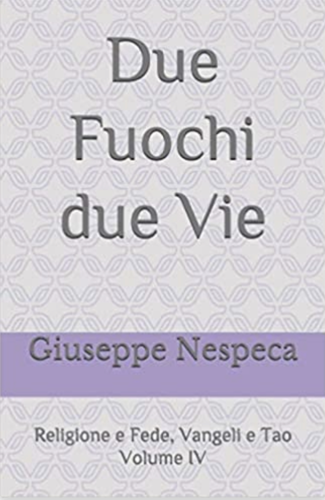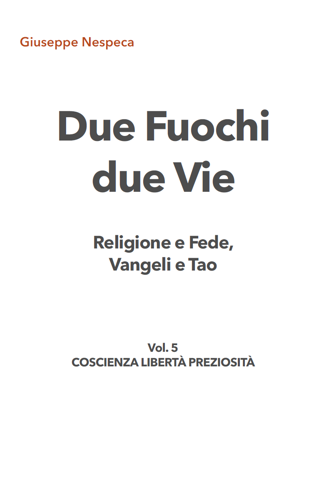don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Ognissanti e Tutti i Fedeli Defunti
Solennità di Tutti i Santi [1° Novembre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. La solennità di Tutti i Santi è occasione importante per riflettere sulla nostra vocazione cristiana: con il Battesimo siamo tutti chiamati ad essere “beati “, cioè in cammino verso la gioia dell’Amore eterno.
Prima Lettura dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni Apostolo (7, 2 - 4. 9 – 14)
Giovanni, nell’Apocalisse, racconta una visione mistica ricevuta a Patmos, non da interpretare letteralmente ma simbolicamente. Egli vede un angelo e una folla immensa, composta da due gruppi distinti: I 144.000 battezzati, segnati dal sigillo del Dio vivente, rappresentano i credenti fedeli, contemporanei di Giovanni, perseguitati dall’imperatore Domiziano. Essi sono i servitori di Dio, protetti e consacrati, il popolo dei battezzati che testimonia la fede nonostante la persecuzione. La folla innumerevole, di tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, vestita di bianco, con palme in mano e in piedi davanti al Trono e all’Agnello, rappresenta l’umanità salvata grazie alla fede e alle sofferenze dei battezzati. La posizione eretta simboleggia la risurrezione, la tunica bianca la purificazione, e le palme la vittoria. Il messaggio centrale è che la sofferenza dei fedeli produce la salvezza degli altri: la prova dei perseguitati diventa mezzo di redenzione per l’umanità, in continuità con il tema del servo sofferente di Isaia e di Zaccaria. Giovanni utilizza un linguaggio simbolico e cifrato, tipico delle Apocalissi, per comunicare segretamente ai credenti perseguitati e incoraggiarli nel perseverare nella fede senza essere scoperto dalle autorità romane. Il testo vuole idunque invitare alla perseveranza: anche se il male sembra trionfare, il Padre celeste con il Cristo hanno già vinto e i fedeli, pur piccoli e oppressi, partecipano a questa vittoria. Il battesimo viene percepito così come un sigillo protettivo, paragonabile al marchio dei soldati romani. Questo testo, con il suo linguaggio mistico e profetico, rivela che la vittoria dei poveri e dei piccoli non è vendetta, ma manifestazione del trionfo di Dio sulle forze del male, portando salvezza e speranza all’umanità intera, grazie alla perseveranza fedele dei giusti.
Salmo Responsoriale (23/24)
Questo salmo ci conduce nel Tempio di Gerusalemme, luogo santo costruito in alto. Una gigantesca processione arriva alle porte del Tempio. Due cori alternati cantano in dialogo: “Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?” I riferimenti biblici di questo salmo sono Isaia (cap.33) che paragona Dio a un fuoco divorante, chiedendo chi può reggere la sua vista. La domanda è retorica: da soli non possiamo sostenere Dio, ma Lui si fa vicino all’uomo e il salmo celebra la scoperta del popolo eletto: Dio è Santo e trascendente, ma anche sempre vicino all’uomo. Oggi questo salmo risuona nella festa di Ognissanti con il canto degli angeli che ci invita a unirci in questa sinfonia di lode verso Dio: “con tutti gli angeli del cielo, vogliamo cantarti”. La condizione necessaria per stare davanti a Dio è qui ben espressa: può soltanto l’uomo dal cuore puro, dalle mani innocenti, che non offre la sua anima agli idoli. Non è una questione di meriti morali: il popolo è ammesso quando ha fede, cioè fiducia totale nel Dio unico e rifiuta decisamente ogni forma di dolatria. Letteralmente, “non ha elevato la sua anima verso dei vuoti “ cioè non prega idoli mentre alzare gli occhi corrisponde a pregare e riconoscere Dio. Il salmo insiste sul cuore puro e le mani innocenti. Il cuore è puro quando è totalmente rivolto a Dio, senza impurità cioè senza mescolare il vero e il falso, Dio e gli idoli. Le mani isono nnocenti quando non hanno offerto sacrifici o pregato falsi dèi. Il parallelismo tra cuore e mani sottolinea che purezza interiore e azione fisica concreta devono andare insieme. Il salmo richiama la lotta dei profeti perché Israele ha dovuto combattere l’idolatria dalla uscita dall’Egitto (vitello d’oro) fino all’Esilio e oltre e il salmo riafferma la fedeltà al Dio unico come condizione per stare davanti a Lui. “Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe”. Ricercare la faccia di Dio è un’espressione usata per cortigiani ammessi alla presenza del re e indica che Dio è l’unico vero Re e la fedeltà a Lui permette di ricevere la benedizione promessa ai patriarchi. Da qui scaturiscono le conseguenze concrete della fedeltà: l’uomo dal cuore puro non conosce odio; l’uomo dalle mani innocenti non compie il male, anzi ottiene da Dio la giustizia vivendo in conformità al progetto divino perché ogni vita ha una missione e ogni vero figlio di Dio ha un impatto positivo nella società. Evidente in questo salmo è anche il collegamento alle Beatitudini del vangelo: “Beati gli affamati e assetati di giustizia… Beati i cuori puri, essi vedranno Dio”. “Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe”: non è questa una semplice definizione di povertà di cuore, condizione fondamentale per entrare nel Regno dei cieli?
Seconda Lettura dalla prima lettera di san Giovanni apostolo (3, 1 – 3)
“Carissimi vedete quale grande amore ci ha dato il Padre”: l’urgenza di aprire gli occhi. San Giovanni invita i credenti a “vedere”, cioè a contemplare con gli occhi del cuore. perché lo sguardo del cuore è la chiave della fede. Anzi l’intera storia umana è un’educazione dello sguardo. Il dramma dell’uomo, secondo i profeti, è proprio “avere occhi e non vedere”. Ciò che occorre imparare a guardare è l’amore di Dio e “il suo disegno di salvezza” (cf. Ef. 1,3-10) per l’umanità. La Bibbia intera insiste su questo: saper guardare bene è riconoscere il volto del Dio, mentre uno sguardo distorto conduce alla menzogna. L’esempio di Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden mostra come il peccato nasca da uno sguardo falsato. L’umanità, ascoltando il serpente, perde di vista l’albero della vita e concentra il suo sguardo sull’albero proibito: è l’inizio del disordine interiore. Lo sguardo diventa sedotto, ingannato, e quando “i loro occhi si aprirono”, gli uomini non videro la divinità promessa, ma la loro nudità, la loro povertà e fragilità. In opposizione a questo sguardo ingannato, Giovanni invita a guardare con il cuore nella verità: “Carissimi vedete quale grande amore ci ha dato il Padre”. Dio non è geloso dell’uomo — come aveva insinuato il serpente — ma lo ama e lo vuole figlio. Tutto il messaggio di Giovanni si riassume in questa rivelazione: “Dio è amore”. La vita vera consiste nel non dubitare mai di questo amore; conoscere Dio, come dice Gesù nel vangelo di Giovanni (17,3), è la vita eterna. Il progetto di Dio, rivelato da Giovanni e da Paolo, è un “disegno benevolo, disegno di salvezza”: fare dell’umanità in Cristo, il Figlio per eccellenza, di cui noi siamo le membra, un solo corpo. Per mezzo del Battesimo, siamo innestati in Cristo e siamo realmente figli di Dio, rivestiti di Lui. Lo Spirito Santo ci fa riconoscere Dio come Padre, mettendo nel nostro cuore la preghiera filiale: “Abbà, Padre!”. Tuttavia, il mondo non conosce ancora Dio, perché non ha aperto gli occhi. Solo chi crede può comprendere la verità dell’amore divino; per gli altri, essa appare incomprensibile o persino scandalosa. Tocca ai credenti testimoniare questo amore con la parola e con la vita, affinché i non credenti possano, a loro volta, aprire gli occhi e riconoscere Dio come Padre. Alla fine dei tempi, quando il Figlio di Dio apparirà, l’umanità sarà trasformata a sua immagine: l’uomo ritroverà lo sguardo puro che aveva perduto alle origini. Così risuona il desiderio di Cristo alla Samaritana (4,1-42): “Se tu conoscessi il dono di Dio!” un invito sempre attuale ad aprire gli occhi per riconoscere l’amore che salva.
Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12a)
Gesù proclama: “Beati quelli che piangono, perché saranno consolati”: è il dono delle lacrime.. Questa beatitudine, apparentemente paradossale, non esalta il dolore ma lo trasforma in via di grazia e speranza. Gesù, che ha sempre cercato di guarire e consolare, non invita a compiacersi nella sofferenza, ma incoraggia a non scoraggiarsi nella prova e a restare fedeli nel pianto, perché chi soffre è già in cammino verso il Regno. Il termine “beati” nell’originale biblico non indica fortuna, ma una chiamata a perseverare: significa “in marcia”, “coraggio, tieni il passo, cammina”. Le lacrime, allora, non sono un male da subire, ma possono diventare luogo d’incontro con Dio. Vi sono lacrime benefiche, come quelle del pentimento di Pietro, dove si sperimenta la misericordia di Dio, o quelle che nascono dalla compassione per la sofferenza altrui, segno che il cuore di pietra sta diventando cuore di carne (Ez 36,26). Anche le lacrime versate davanti alla durezza del mondo partecipano alla compassione divina: esse annunciano che è giunto il tempo messianico, in cui la consolazione promessa diventa realtà. La prima beatitudine “Beati i poveri di cuore, perché di essi è il Regno dei cieli” racchiude tutte le altre e ne rivela il segreto. La povertà evangelica non è miseria materiale, ma apertura del cuore: i poveri (anawim) sono coloro che non si bastano a sé stessi, che non sono orgogliosi né autosufficienti, ma attendono tutto da Dio. Sono gli umili, i piccoli, coloro che hanno “il dorso curvo” davanti al Signore. Come nella parabola del fariseo e del pubblicano, solo chi riconosce la propria povertà può accogliere la salvezza. Il povero di spirito vive nella fiducia totale in Dio, riceve tutto come dono, e prega con semplicità: “Signore, abbi pietà”. Da questo atteggiamento interiore scaturiscono tutte le altre beatitudini: la misericordia, la mitezza, la pace, la sete di giustizia — tutte sono frutti dello Spirito, ricevuti e non conquistati. Essere poveri in spirito significa credere che solo Dio colma, e che le vere ricchezze non sono l’avere, il potere o il sapere, ma la presenza di Dio nel cuore umile. Per questo Gesù proclama una felicità futura e paradossale: “Beati i poveri”, cioè presto vi invidieranno, perché Dio riempirà il vostro vuoto delle sue ricchezze divine. Le beatitudini, dunque, non sono regole morali ma buone notizie: annunciano che lo sguardo di Dio è diverso da quello degli uomini. Dove il mondo vede fallimento — povertà, lacrime, persecuzione — Dio vede la materia prima del suo Regno. Gesù ci insegna a guardare noi stessi e gli altri con gli occhi di Dio, a scoprire la presenza del Regno là dove non l’avremmo mai sospettata. La vera felicità nasce perciò dallo sguardo purificato e dalla debolezza accolta, che diventano luogo della grazia. Chi piange, chi è povero di cuore, chi cerca la giustizia e la pace, sperimenta già ora la consolazione promessa: la gioia dei figli che sanno e si sentono amati dal Padre. Come ricorda Ezechiele, nel giorno del giudizio saranno riconosciuti coloro che hanno pianto sul male del mondo (Ez 9,4): le loro lacrime sono pertanto già il segno del Regno che viene.
+ Giovanni D’Ercole
Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti [2 Novembre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Dopo aver contemplato la gloria del Cielo oggi commemoriamo il destino di luce che ci attende il giorno della nostra morte terrena
1. La commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti fu fissata al 2 novembre solo dall’inizio dell’XI secolo collegandola alla solennità di Tutti i Santi. Del resto la festività del 1° novembre non poteva non richiamare alla memoria anche i fedeli defunti, che la Chiesa ricorda nella sua preghiera ogni giorno. In ogni Messa si prega anzitutto «per tutti coloro che riposano in Cristo» (Preghiera eucaristica I), poi si estende la preghiera a «tutti i defunti, dei quali tu solo conosci la fede» (Preghiera eucaristica IV), a «tutti gli uomini che hanno lasciato questa vita» (Preghiera eucaristica II) e «dei quali tu solo conosci la rettitudine» (Preghiera eucaristica III). E a rendere questa commemorazione ancor più partecipata, oggi si possono celebrare tre sante messe con una vasta gamma di letture che qui mi limito a indicare: A. Prima Messa Prima Lettura Giobbe 19,1.23-27°; Salmo 26/27; Seconda Lettura san Paolo ai Romani 5,5-11; Dal Vangelo secondo Giovanni 6,37—40; B. Seconda Messa: Prima Lettura Is 25,6°-7-9; Salmo 24/25; Seconda Lettura Rom.8,14-23; Dal Vangelo s Matteo 25,31-46); C. Terza Messa: Prima Lettura Libro della Sapienza 3,1-9; Salmo 41/42 2 $2/43; Seconda Lettura Apocalisse 21,1-5°.6b-7; Vangelo secondo Matteo 5,1-12°) .Visto il numero delle letture bibliche, invece di fornire un commento per ciascun brano biblico come ogni domenica, preferisco offrire una riflessione sul significato e il valore dell’odierna celebrazione che affonda le sue origini nella lunga storia della Chies cattolica. Basta leggere le letture bibliche per cominciare a dubitare che il termine “morti” sia il più adatto per l’odierna Commemorazione. Infatti, è nella luce pasquale e nella misericordia del Signore che siamo invitati a meditare e a pregare in questo giorno per tutti coloro che ci hanno preceduti. Essi sono stati chiamati a già vivere nella luce della vita divina, e anche noi, segnati dal sigillo della fede, un giorno li seguiremo. Scrive l’apostolo Paolo “Non vogliamo, fratelli, che siate nell’ignoranza riguardo a quelli che dormono nel Signore, per non essere tristi come coloro che non hanno speranza” (1Ts 4,13-14), I Santi, quando possibile, non sono ricordati nell’anniversario della loro nascita ma sono celebrati nel giorno della loro morte, che la tradizione cristiana chiama in latino “dies natalis”, cioè giorno della nascita al Regno. Per tutti i defunti, cristiani, musulmani, buddisti o di altre fedi, questo è il loro dies natalis come ripetiamo nella santa messa: “Ricordati di tutti gli uomini che hanno lasciato questo mondo e di cui conosci la rettitudine; accoglili nel tuo Regno, dove speriamo di essere colmati della tua gloria insieme per l’eternità” (Preghiera eucaristica III). La liturgia rifiuta di usare l’espressione popolare “giorno dei morti”, poiché questo giorno si apre sulla vita divina. La Chiesa lo chiama: Commemorazione di tutti i fedeli defunti. “Morto” o “defunto” non sono sinonimi: il termine defunto viene dal latino functus, che significa “colui che ha compiuto”, “colui che ha portato a termine”. Il defunto è dunque “colui che ha portato a compimento la vita” ricevuta da Dio. Questa festa liturgica è al tempo stesso giornata di memoria e di intercessione: si fa memoria dei defunti e si prega per essi. Alla luce della solennità di Tutti i Santi, questo giorno offre ai cristiani l’occasione di rinnovare e vivere la speranza della vita eterna, dono della risurrezione di Cristo. Per questo motivo, in occasione di queste celebrazioni, molte persone si recano nei cimiteri per onorare i propri cari defunti e ornare le loro tombe di fiori. Si pensa a tutti coloro che ci hanno lasciato, ma che non abbiamo dimenticato. Si prega per loro perché, secondo la fede cristiana, hanno bisogno di una purificazione per poter essere pienamente con Dio. La nostra preghiera può aiutarli in questo cammino di purificazione, in virtù di ciò che si chiama la “comunione dei santi”, comunione di vita che esiste tra noi e coloro che ci hanno preceduti: nel Cristo esiste un legame reale e una solidarietà tra i vivi e i defunti.
2. Un po’ di storia. Perché la festa di Tutti i Santi (istituita in Francia nell’835) conservasse il suo carattere proprio, e perché non diventasse una giornata dedicata ai morti, sant’Odilone, abate di Cluny, verso l’anno 1000, impose a tutti i suoi monasteri la commemorazione dei defunti mediante una messa solenne il 2 novembre. Questa giornata non fu chiamata “giornata di preghiera per i defunti”, ma “commemorazione dei defunti”. In quel tempo la dottrina del purgatorio non era ancora chiaramente formulata (lo sarà solo verso la fine del XII secolo): si trattava soprattutto di fare memoria dei defunti più che di pregare per loro. Nel XV secolo i Domenicani, in Spagna, introdussero l’uso di celebrare tre messe in questo giorno. Il papa Benedetto XV (+1922) estese poi a tutta la Chiesa la possibilità di celebrare tre messe il 2 novembre, invitando a pregare in particolare per le vittime della guerra. San Giovanni Paolo II in occasione del millenario dell’istituzione della Commemorazione dei fedeli defunti (13 settembre 1998) scrive: «Infatti, il giorno dopo la festa di Tutti i Santi, in cui la Chiesa celebra con gioia la comunione dei santi e la salvezza degli uomini, sant’Odilone volle esortare i suoi monaci a pregare in modo particolare per i defunti, contribuendo così misteriosamente al loro ingresso nella beatitudine. Dall’abbazia di Cluny, questa pratica si diffuse progressivamente, diventando una celebrazione solenne in suffragio dei defunti, che sant’Odilone chiamò Festa dei Morti, oggi universalmente osservata in tutta la Chiesa.» «Pregando per i defunti, la Chiesa contempla anzitutto il mistero della Risurrezione di Cristo, che attraverso la sua Croce ci dona la salvezza e la vita eterna. Con sant’Odilone possiamo ripetere: “La Croce è il mio rifugio, la Croce è la mia via e la mia vita… La Croce è la mia arma invincibile. Essa respinge ogni male e disperde le tenebre”. La Croce del Signore ci ricorda che ogni vita è abitata dalla luce pasquale: nessuna situazione è perduta, perché Cristo ha vinto la morte e ci apre il cammino verso la vera vita.» «La Redenzione si compie mediante il sacrificio di Cristo, attraverso il quale l’uomo è liberato dal peccato e riconciliato con Dio» (Tertio millennio adveniente, n. 7). «In attesa che la morte sia definitivamente vinta, alcuni uomini “continuano il loro pellegrinaggio sulla terra; altri, dopo aver terminato la loro vita, si purificano ancora; altri infine godono già della gloria del cielo e contemplano la Trinità nella piena luce” (Lumen Gentium, n. 49). Unita ai meriti dei santi, la nostra preghiera fraterna viene in aiuto a coloro che sono ancora in attesa della visione beatifica. L’intercessione per i defunti è un atto di carità fraterna, proprio dell’unica famiglia di Dio, mediante la quale “rispondiamo alla più profonda vocazione della Chiesa” (Lumen Gentium, n. 51), cioè “salvare anime che ameranno Dio per l’eternità” (santa Teresa di Lisieux, Preghiere, 6).» «Per le anime del purgatorio, l’attesa del gaudio eterno e dell’incontro con l’Amato è fonte di sofferenza, a causa della pena dovuta al peccato che le tiene lontane da Dio; ma hanno la certezza che, terminato il tempo della purificazione, incontreranno Colui che desiderano (Sal 42; 62).. A più riprese i vari pontefici della storia hanno esortato a pregare con fervore per i defunti, per i propri familiari e per tutti i fratelli e sorelle defunti, affinché ottengano la remissione delle pene dovute ai loro peccati e ascoltino la voce del Signore che li chiama.
3. Perché questo giorno è importante: Istituendo una messa per la commemorazione dei fedeli defunti, la Chiesa ci ricorda il posto che i defunti occupano nella vita familiare e sociale e riconosce la realtà dolorosa del lutto: l’assenza di una persona amata è una ferita costante. Questa celebrazione può essere vista anche come una risposta alla supplica del buon ladrone che, sulla croce, si rivolse a Gesù: «Ricordati di me». Nel ricordare i nostri defunti, rispondiamo simbolicamente a quella stessa supplica: “Ricordatevi di noi”. È un invito a non dimenticarli, a continuare a pregare per loro, mantenendo una memoria viva e operante, segno della nostra speranza nella vita eterna. Quella odierna è dunque Una giornata per tutti: non è solo per le famiglie in lutto, ma per tutti. Essa aiuta a sensibilizzare i fedeli sul mistero della morte e del lutto, ma anche sulla speranza e sulla promessa della vita eterna. Per i cristiani, la morte non è la fine, ma un passaggio. Attraverso la prova del lutto, comprendiamo che la nostra vita terrena non è eterna: i nostri defunti ci precedono sul cammino dell’eternità. Il 2 novembre diventa così anche un insegnamento sulle “ultime cose” (le realtà escatologiche), per prepararci a questo passaggio con serenità, senza paura né tristezza, perché è una tappa verso la vita eterna. La Chiesa non si sente mai dispensata dal pregare: intercede costantemente per la salvezza del mondo, affidando ogni anima alla misericordia e al giudizio di Dio, affinché Egli conceda il perdono e la pace del Regno. Sappiamo bene che “compiere la vita” ha senso solo nella fedeltà al Signore. La preghiera della Chiesa riconosce la nostra fragilità e prega perché nessuno dei suoi figli si perda. Così, il 2 novembre diventa un giorno di fede e di speranza, oltre la separazione che segna la fine della vita terrena — nella pace o nella sofferenza, nella solitudine o in famiglia, nel martirio o nella bontà delle cure amorevoli. La morte è l’ora dell’incontro e resta sempre un luogo di combattimento. La parola “agonia”, infatti, deriva dal greco e significa “lotta”. Per il cristiano, la morte è l’incontro con il Risorto, la speranza nella fede professata: Credo nella risurrezione dei morti e nella vita del mondo che verrà. Il credente entra nella morte con fede, rifiuta la disperazione e ripete con Gesù: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito” (Lc 23,46). Per il cristiano, anche la morte più dura è passaggio in Gesù Risorto, esaltato dal Padre. Assai spesso la civiltà moderna occidentale tende a nascondere la morte: la teme, la traveste, la allontana. Persino nella preghiera, diciamo distrattamente: Adesso e nell’ora della nostra morte. Eppure ogni anno attraversiamo, senza saperlo, la data che sarà un giorno quella della nostra morte. Un tempo, la predicazione cristiana lo ricordava spesso, sebbene a volte con toni di molto accentuati. Oggi, invece, la paura della morte sembra voler spegnere la realtà del morire che fa parte di ogni vita sulla terra. L’odierna Commemorazione di Tutti i Fedeli Defunti è utile occasione per fermarsi a riflettere e soprattutto pregare rinnovando la nostra fedeltà al battesimo e alla nostra vocazione: Insieme invochiamo Maria, che, elevata in cielo, veglia sulla nostra vita e sulla nostra morte. Maria, icona della bontà di Dio e segno sicuro della nostra speranza, Tu hai speso la vita nell’amore e con la tua stessa assunzione al Cielo ci annunci che il Signore non è il Dio dei morti, ma dei viventi, sostienici nel nostro cammino quotidiano e fa’ che viviamo in modo da essere pronti in ogni momento a incontrare il Signore della Vita nell’ultimo istante del nostro pellegrinaggio terreno quando, avendo chiusi gli occhi alle realtà di questo mondo, si apriranno nella visione eterna di Dio.
+ Giovanni D’Ercole
Santità: Uniti, non separati. Defunti, non morti
30a Domenica T.O. (anno C)
XXX Domenica Tempo Ordinario (anno C) [26 Ottobre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Ancora un insegnamento sulla preghiera da Gesù nel vangelo e che insegnamento!
Prima Lettura dal libro del Siracide (35, 15b-17.20-22a)
“Dio non giudica dall’apparenza” (Sir 35) Il libro del Siracide, scritto da Ben Sira verso il 180 a.C. a Gerusalemme, nasce in un tempo di pace e di apertura culturale sotto il dominio greco. Tuttavia, questa apparente serenità nasconde un rischio: il contatto tra cultura ebraica e greca minaccia la purezza della fede, e Ben Sira intende trasmettere l’eredità religiosa d’Israele nella sua integrità. La fede ebraica, infatti, non è una teoria, ma un’esperienza di alleanza con il Dio vivente, scoperto progressivamente attraverso le sue opere. Dio non è un’idea umana, ma una rivelazione sorprendente, perché “Dio è Dio e non un uomo” (Os 11,9). Il testo centrale afferma che Dio non giudica secondo le apparenze: mentre gli uomini guardano l’esterno, Dio guarda il cuore. Egli ascolta la preghiera del povero, dell’oppresso, dell’orfano e della vedova, e – in un’immagine meravigliosa – “le lacrime della vedova scorrono sulle guance di Dio”, segno della sua misericordia che vibra di compassione. Ben Sira insegna che la vera preghiera nasce dalla precarietà: quando l’uomo si scopre povero e senza appoggi, il suo cuore si apre davvero a Dio. La precarietà e la preghiera sono della stessa famiglia: solo chi riconosce la propria debolezza prega con sincerità. Infine, il saggio ammonisce che non sono i sacrifici esteriori a piacere a Dio, ma un cuore puro e disposto al bene: Ciò che piace al Signore è anzitutto che ci si tenga lontano dal male. Il Signore è un giudice giusto, che non fa preferenza di persone, ma guarda alla verità del cuore. In sintesi, Ben Sira ci ricorda che Dio non giudica dall’apparenza ma dal cuore, che la preghiera autentica nasce dalla povertà, e che la misericordia divina si manifesta nella sua vicinanza compassionevole ai piccoli e agli umili.
Salmo Responsoriale (33/34, 2-3, 16.18, 19.23)
Ecco un altro salmo alfabetico, cioè ogni versetto segue l’ordine delle lettere dell’alfabeto ebraico. Questo indica che la vera sapienza consiste nel confidare in Dio in tutto, dalla A alla Z. Il testo fa eco alla prima lettura del Siracide, che incoraggiava gli ebrei del II secolo a mantenere la purezza della fede di fronte alle seduzioni della cultura greca.Il tema centrale è la scoperta di un Dio vicino all’uomo, soprattutto a chi soffre: “Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato.” È una delle rivelazioni più grandi della Bibbia: Dio non è un essere distante o geloso, ma un Padre che ama e partecipa al dolore dell’uomo. Ben Sira diceva poeticamente che “le nostre lacrime scorrono sulle guance di Dio”: immagine della sua misericordia tenera e compassionevole. Questa rivelazione si radica nel cammino di Israele. Al tempo di Mosè, i popoli pagani immaginavano dèi rivali e invidiosi. La Genesi corregge questa visione, mostrando che il sospetto verso Dio è un veleno, simbolizzato dal serpente. Israele, attraverso i profeti, ha compreso progressivamente che Dio è un Padre che accompagna, libera e consola, il “Dio-con-noi” (Emmanuele). Il roveto ardente (Es 3) è il fondamento di questa fede: “Ho visto la miseria del mio popolo, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze” Qui Dio si rivela come Colui che vede, ascolta e agisce. Egli non resta spettatore, ma suscita in Mosè e nei suoi figli la forza di liberare, trasformando la sofferenza in speranza e impegno. Il salmo riflette questa esperienza: il popolo, dopo aver conosciuto la prova, proclama la lode: “Benedirò il Signore in ogni tempo” perché ha fatto esperienza di un Dio che ascolta, libera, guarda, salva e redime. Il nome “YHWH” il “Signore” indica proprio la presenza costante di Dio accanto al suo popolo. Infine, il testo insegna che nella prova non solo è lecito, ma necessario gridare a Dio: Egli è attento al nostro grido e risponde, non sempre eliminando la sofferenza, ma rendendosi presente, risvegliando la fiducia, e donando la forza per affrontare il male. In sintesi, il salmo e la riflessione che lo accompagna ci consegnano tre certezze: Dio è vicino a chi soffre e ascolta il grido dei poveri.La sua presenza non toglie il dolore, ma lo illumina e lo trasforma in speranza. La vera fede nasce dalla fiducia in questo Dio che vede, ascolta, libera e accompagna l’uomo in ogni tempo.
Seconda Lettura dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo (4, 6-8.16-18)
“Il buon combattimento” (2Tm 4,6-18). Il testo presenta l’ultimo testamento spirituale di san Paolo, scritto mentre si trova in prigione a Roma, consapevole che presto sarà giustiziato. Le lettere a Timoteo, anche se forse composte o completate da un discepolo, contengono qui le sue parole autentiche di addio, intrise di fede e di serenità. Paolo descrive la sua imminente morte con il verbo greco analuein, che significa “sciogliere le funi”, “levare l’ancora”, “smontare la tenda”: immagini che evocano la partenza per un nuovo viaggio, quello verso l’eternità. Guardandosi indietro, l’apostolo fa il bilancio della sua vita usando la metafora sportiva della corsa e del combattimento: Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede.” Come un atleta che non si arrende, Paolo è arrivato al traguardo e sa che riceverà la “corona di giustizia”, la ricompensa promessa a tutti i fedeli. Non si vanta di sé, perché questa corona non è un privilegio personale, ma un dono offerto a tutti coloro che hanno desiderato con amore la manifestazione di Cristo. Il “giudice giusto”, Dio, non guarda le apparenze ma il cuore — come insegnava il Siracide — e donerà la gloria non solo a Paolo, ma a tutti coloro che vivono nella speranza dell’avvento del Signore. La vita dell’apostolo è stata una corsa costante verso la manifestazione gloriosa di Cristo, orizzonte della sua fede e del suo servizio. Egli riconosce che la forza per perseverare non viene da lui, ma da Dio stesso: “Il Signore mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l’annuncio del vangelo e tutte le genti l’ascoltassero”. Questa forza divina ha sostenuto la sua missione, rendendolo capace di annunciare Cristo fino alla fine. Paolo spiega che la vita cristiana non è una competizione, ma una corsa condivisa, in cui ciascuno è chiamato a correre al proprio ritmo, con lo stesso desiderio ardente della venuta di Cristo. Nella lettera a Tito aveva definito i cristiani come coloro che “attendono la beata speranza e la manifestazione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo” — parole che la liturgia ripete ogni giorno nella Messa. Nel momento della prova, Paolo confessa anche la solitudine dell’apostolo: La prima volta che ho presentato la mia difesa, nessuno mi ha sostenuto; tutti mi hanno abbandonato. Che ciò non sia loro imputato(v.16). Come Gesù sulla croce e Stefano al momento della lapidazione, egli perdona e trasforma l’abbandono in un’esperienza di intima comunione con il Signore, che diventa la sua unica forza e consolazione. Paolo è il povero di cui parla Ben Sira, quello che Dio ascolta e consola, colui le cui lacrime scorrono sulle guance di Dio. Le sue parole finali rivelano la speranza che supera la morte: “Così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, salverà nel suo regno” (v 17-18). Non parla della liberazione fisica – sa che la morte è imminente – ma della liberazione spirituale, dal pericolo più grande: perdere la fede, smettere di combattere. Il Signore lo ha custodito nella fedeltà e gli ha donato la perseveranza fino alla fine. Per Paolo, la morte non è una sconfitta, ma una traversata verso la gloria. È la nascita alla vera vita, l’ingresso nel Regno dove canterà per sempre: “A lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.”
In sintesi: Il testo ci presenta Paolo come modello del credente fedele fino alla fine. Vive la morte come partenza verso Dio, non come fine. Guarda alla vita come a una corsa sostenuta dalla grazia. Riconosce che la forza e la perseveranza vengono dal Signore. Comprende che la ricompensa è promessa a tutti coloro che desiderano l’avvento di Cristo. Perdona chi lo abbandona e trova la presenza di Dio nella solitudine e nella debolezza. Vede la morte come passaggio nella gloria del Regno. La “buona battaglia” di Paolo diventa così la lotta di ogni cristiano: rimanere fedele, nella prova, fino a correre l’ultimo tratto con lo sguardo fisso su Cristo, fonte di forza, di pace e di speranza.
*Dal Vangelo secondo Luca (18, 9-14)
Una piccola osservazione preliminare prima di entrare nel testo: Luca ci dice chiaramente che si tratta di una parabola… dunque non dobbiamo immaginare che tutti i farisei o tutti i pubblicani del tempo di Gesù fossero come quelli qui descritti. Nessun fariseo, nessun pubblicano corrispondeva perfettamente a questo ritratto: Gesù in realtà ci presenta due atteggiamenti interiori, molto tipici e semplificati, per far risaltare la morale della storia. Egli vuole farci riflettere sulla nostra stessa attitudine, perché probabilmente ci riconosceremo ora nell’uno, ora nell’altro, secondo i giorni. Passiamo alla parabola: la scorsa domenica Luca ci aveva già proposto un insegnamento sulla preghiera; la parabola della vedova e del giudice ingiusto ci insegnava a pregare senza scoraggiarci mai. Oggi, invece, è un pubblicano a essere proposto come esempio. Quale rapporto – si dirà – può esserci tra una vedova povera e un pubblicano ricco? Non è certo il conto in banca il punto in questione, ma le disposizioni del cuore. La vedova è povera e costretta ad umiliarsi davanti a un giudice che la ignora; il pubblicano, forse benestante, porta però sulle spalle il peso della cattiva reputazione, che è un’altra forma di povertà. I pubblicani erano malvisti, e spesso non senza motivo: vivevano infatti in un periodo di occupazione romana, e lavoravano al servizio dell’occupante. Erano considerati dei “collaboratori”. Inoltre, si occupavano di un tema sensibile in ogni epoca: le tasse. Roma fissava la somma dovuta, e i pubblicani la anticipavano, ricevendo poi pieni poteri per recuperarla dai concittadini… spesso con largo margine di guadagno. Quando Zaccheo prometterà a Gesù di restituire quattro volte tanto a chi aveva frodato, il sospetto è confermato. Perciò, quando il pubblicano nella parabola non osa alzare gli occhi al cielo e si batte il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”, forse dice soltanto la pura verità. Essere veri davanti a Dio, riconoscere la propria fragilità: ecco la vera preghiera. È questa sincerità che lo rende “giusto” al ritorno a casa, dice Gesù. I farisei, al contrario, godevano di ottima reputazione: la loro fedeltà scrupolosa alla Legge, il digiuno due volte a settimana (più di quanto la Legge richiedesse!), le elemosine regolari, tutto esprimeva il loro desiderio di piacere a Dio. E tutto ciò che il fariseo dice nella sua preghiera è vero: non inventa nulla. Ma, in realtà, non prega. Si contempla. Si guarda con compiacenza: non ha bisogno di nulla, non chiede nulla. Fa il bilancio dei suoi meriti — e ne ha molti! — ma Dio non ragiona in termini di merito: il suo amore è gratuito, e tutto ciò che chiede è che ci fidiamo di Lui. Immaginiamo un giornalista all’uscita del Tempio che intervista i due uomini: Signor pubblicano, cosa si aspettava da Dio entrando nel Tempio? Sì, mi aspettavo qualcosa. E l’ha ricevuto? Sì, e anche di più. E lei, signor fariseo? No, non ho ricevuto nulla… Un attimo di silenzio, poi aggiunge: Ma non mi aspettavo nulla, del resto. La frase conclusiva della parabola riassume tutto: “Chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato.” Gesù non vuole presentare Dio come un contabile morale, che distribuisce premi e castighi. Egli constata una verità profonda: chi si esalta, cioè chi si crede più grande di ciò che è, come il fariseo, chiude il cuore e guarda gli altri dall’alto in basso. Ma chi si crede superiore perde la ricchezza degli altri e si isola da Dio, che non forza mai la porta del cuore. Si resta così com’eravamo, con la nostra “giustizia” umana, così diversa da quella divina. Al contrario, chi si umilia, chi si riconosce piccolo e povero, vede negli altri una superiorità, e può attingere alla loro ricchezza. Come dice san Paolo: “Considerate gli altri superiori a voi stessi.” E ciò è vero: ogni persona che incontriamo ha qualcosa che noi non abbiamo. Questo sguardo apre il cuore e permette a Dio di riempirci del suo dono. Non si tratta di complesso d’inferiorità, ma di verità del cuore. È proprio quando riconosciamo di non essere “brillanti” che può cominciare la grande avventura con Dio. In fondo, questa parabola è una magnifica illustrazione della prima beatitudine: “Beati i poveri di cuore, perché di essi è il Regno dei cieli.”
+ Giovanni D’Ercole
Io-Fariseo e io-pubblicano: l’Azione Creativa di Dio. Preghiera di Fede, o di maniera
29a Domenica T.O. (anno C)
XXIX Domenica Tempo Ordinario (anno C) [19 Ottobre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Ancora un forte richiamo a come vivere la fede in ogni situazione della vita.
Prima Lettura dal libro dell’Esodo (17,8-13)
La prova della fede. Nel cammino di Israele nel deserto, l’incontro con gli Amaleciti segna una tappa decisiva: è la prima battaglia del popolo liberato dall’Egitto, ma anche la prima grande prova della sua fede. Gli Amaleciti, discendenti di Esaù, rappresentano nella tradizione biblica il nemico ereditario, figura del male che tenta di impedire al popolo di Dio di raggiungere la terra promessa. La loro aggressione improvvisa contro gli ultimi della carovana — i più deboli e stanchi — manifesta la logica del male: colpire dove la fede vacilla, dove la stanchezza e la paura aprono la breccia del dubbio. Questo episodio avviene a Refidim, lo stesso luogo di Massa e Meriba, dove Israele aveva già mormorato contro Dio per la mancanza d’acqua. Là il popolo aveva sperimentato la prova della sete, ora vive la prova del combattimento: in entrambi i casi, la tentazione è la stessa — pensare che Dio non sia più con lui. Ma ancora una volta Dio interviene, mostrando che la fede si purifica attraverso la lotta e che la fiducia deve restare salda anche nel pericolo. Mosè, mentre Giosuè combatte nella pianura, sale sul monte con in mano il bastone di Dio — segno della sua presenza e del suo potere. Il racconto non insiste sui movimenti delle truppe, ma sul gesto di Mosè: le mani levate verso il cielo. Non è un gesto magico: è la preghiera che sostiene il combattimento, la fede che diventa forza per tutto il popolo. Quando le braccia di Mosè si abbassano, Israele perde; quando restano alzate, Israele vince. La vittoria dipende dunque non solo dalla forza delle armi, ma dalla comunione con Dio e dalla preghiera perseverante. Mosè si stanca, Aronne e Cur gli sostengono le mani: ecco l’immagine della fraternità spirituale, della comunità che porta insieme il peso della fede. Così la preghiera non è isolamento, ma solidarietà: chi prega sostiene gli altri, e chi combatte attinge forza dalla preghiera dei fratelli. Questo episodio diventa quindi un paradigma della vita spirituale: Israele, fragile e ancora in cammino, impara che la vittoria non viene dalla forza umana, ma dalla fiducia in Dio. La preghiera, rappresentata dalle mani levate di Mosè, non sostituisce l’azione ma la accompagna e la trasfigura. L’orante e il combattente sono due volti dello stesso credente: uno lotta nel mondo, l’altro intercede davanti a Dio ed entrambi partecipano all’unica opera della salvezza. Infine, la comunità orante diventa il segno vivente della presenza di Dio che opera nel suo popolo e quando un credente non ha più la forza di pregare, la fede dei fratelli lo sostiene. La storia di Amalek a Refidim non è solo una pagina di cronaca, bensì un’icona della vita cristiana: viviamo tutti le nostre battaglie sapendo che la vittoria appartiene a Dio e la preghiera è sorgente di ogni forza e garanzia della presenza divina.
Salmo responsoriale (120/121)
Il Salmo 120/121 appartiene al gruppo dei “Salmi delle ascensioni” (Sal 120-134), composti per accompagnare i pellegrinaggi del popolo d’Israele verso Gerusalemme, la città santa situata in alto, simbolo del luogo dove Dio abita in mezzo al suo popolo. Il verbo “salire” indica non solo l’ascesa geografica ma anche e soprattutto un movimento spirituale, una conversione del cuore che porta il credente ad avvicinarsi a Dio. Ogni pellegrinaggio rappresentava per Israele un segno dell’Alleanza e un atto di fede: il popolo, in cammino da ogni parte del paese, rinnovava la propria fiducia nel Signore. Quando il salmo parla in prima persona — “alzo gli occhi verso i monti” — in realtà dà voce al “noi” collettivo di tutto Israele, il popolo in marcia verso Dio. Questo cammino è immagine dell’intera storia d’Israele, una lunga marcia nella quale si intrecciano fatica, attesa, pericolo e fiducia. Le vie che conducono a Gerusalemme, oltre ad essere strade di pietra, sono vie spirituali segnate da prove e rischi. La stanchezza, la solitudine, le minacce esterne — briganti, animali, sole cocente, notti fredde — diventano simboli delle difficoltà della fede. In questa situazione, la parola del salmo è una professione di fiducia assoluta: “Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.” Con queste parole si afferma che il vero aiuto non viene da potenze umane né da idoli muti, ma dal Dio vivente, Creatore dell’universo, che non dorme e non abbandona il suo popolo. Egli è chiamato “Custode d’Israele”: colui che veglia continuamente, che accompagna, che si fa vicino come un’ombra che protegge dal sole e dalla luna. L’espressione ebraica “alla tua destra” indica una presenza intima e fedele, come quella di un compagno inseparabile. Il popolo che prega questo salmo ricorda così la colonna di nube e di fuoco che guidava Israele nel deserto, segno di Dio che protegge di giorno e di notte, mentre accompagna il cammino e custodisce la vita. Perciò il salmista può dire: “Il Signore ti custodirà da ogni male, egli custodirà la tua vita. Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri da ora e per sempre” . Il pellegrino che “sale” a Gerusalemme diventa l’immagine del credente che si affida a Dio solo, rinunciando agli idoli e alle false sicurezze. Questo movimento è la conversione: distogliersi da ciò che è vano per orientarsi al Dio che salva. Nel Nuovo Testamento, Gesù stesso ha potuto pregare questo salmo mentre “saliva a Gerusalemme” (Lc 9,51). Egli compie il cammino di Israele e di ogni uomo, affidando la propria vita al Padre. Le parole “Il Signore custodirà la tua vita” trovano il loro pieno compimento nella Pasqua, quando il ritorno del pellegrino diventa risurrezione perché è ritorno alla vita nuova e definitiva. Così, il Salmo 121 è molto più di una preghiera di viaggio: è la confessione di fede di un popolo in cammino, la proclamazione che Dio è fedele e che la sua presenza accompagna ogni passo dell’esistenza. In esso si uniscono la memoria storica, la fiducia teologica e la speranza escatologica. Israele, il credente e Cristo stesso condividono la stessa certezza: Dio custodisce la vita e ogni salita, anche la più faticosa, conduce alla comunione con Lui.
Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo a Timoteo (3, 14 - 4, 2)
In questo brano della seconda lettera a Timoteo (3,14-4,2), Paolo consegna al suo discepolo l’eredità più preziosa: la fedeltà alla Parola di Dio. È un testo scritto in un momento difficile, segnato da confusioni dottrinali e da tensioni nella comunità di Efeso. Timoteo è chiamato a essere “custode della Parola”, in mezzo a un mondo che rischia di smarrire la verità ricevuta. Le prime parole, “Tu rimani saldo in quello che hai imparato”, fanno capire che altri hanno abbandonato l’insegnamento apostolico: la fedeltà diventa allora un atto di resistenza spirituale, un rimanere ancorati alla sorgente. Paolo parla dell’“abitare” nella Parola: la fede non è un oggetto da possedere, ma un ambiente in cui vivere. Timoteo vi è entrato fin da bambino grazie alla madre Eunice e alla nonna Loide, donne credenti che gli hanno trasmesso l’amore per le Scritture. Abbiamo qui un richiamo al carattere comunitario e tradizionale della fede: nessuno scopre da sé la Parola, ma sempre nella Chiesa. L’accesso alla Scrittura avviene dentro la Tradizione viva, quella “catena” che parte da Cristo, passa attraverso gli apostoli e continua nei credenti. “Tradere” in latino significa “trasmettere”: ciò che si riceve, si dona. In questa fedeltà, la Scrittura è sorgente d’acqua viva che rigenera il credente e lo radica nella verità. Paolo afferma che le Sacre Scritture possono istruire per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù (v.15). L’Antico Testamento è cammino che conduce a Cristo: l’intera storia di Israele prepara il compimento del mistero pasquale. “Tutta la Scrittura è ispirata da Dio”: prima ancora che diventasse dogma, era la convinzione profonda del popolo d’Israele, da cui nasce il rispetto per i Libri santi custoditi nelle sinagoghe. L’ispirazione divina non annulla la parola umana, ma la trasfigura, facendone strumento dello Spirito. La Scrittura, dunque, non è un libro tra altri, ma una presenza viva di Dio che forma, educa, corregge e santifica: grazie a essa, l’uomo di Dio sarà perfetto, equipaggiato per ogni opera buona (vv16-17). Da questa sorgente nasce la missione e Paolo affida a Timoteo il comando decisivo: “Annuncia la Parola, insisti al momento opportuno e non opportuno”(v.4,2) perché l’annuncio del Vangelo è una necessità, non un compito facoltativo. Il riferimento solenne al giudizio di Cristo sui vivi e sui morti mostra la gravità della responsabilità apostolica. Proclamare la Parola significa rendere presente il Logos, cioè Cristo stesso, Parola vivente del Padre. È Lui che si comunica attraverso la voce del predicatore e la vita del testimone. Ma l’annuncio esige coraggio e pazienza: occorre parlare quando è comodo e quando non lo è, ammonire, correggere, incoraggiare, sempre con spirito di carità e desiderio di edificare la comunità. La verità, senza amore, ferisce; l’amore, senza verità, svuota la Parola. Per Paolo, la Scrittura non è solo memoria, ma dinamismo dello Spirito. Essa modella la mente e il cuore, forma il giudizio, ispira le scelte. Chi vi dimora diventa “uomo di Dio”, cioè persona plasmata dalla Parola e resa capace di servire. Timoteo è invitato non solo a custodire la dottrina, ma a farne sorgente di vita per sé e per gli altri. Così la Parola, accolta e vissuta, diventa luogo d’incontro con Cristo e sorgente di rinnovamento per la Chiesa. L’apostolo non fonda nulla di suo, ma trasmette ciò che ha ricevuto; allo stesso modo, ogni credente è chiamato a diventare anello di questa catena viva, perché la Parola continui a scorrere nel mondo come acqua che disseta, purifica e feconda. In sintesi: La Scrittura è la sorgente della fede, la Tradizione ne è il fiume che la trasmette, la proclamazione ne è il frutto che alimenta la vita della Chiesa. Restare nella Parola significa restare in Cristo; proclamarla significa lasciarLo agire e parlare attraverso di noi. Solo così l’uomo di Dio diventa pienamente formato e la comunità cresce nella verità e nella carità.
Dal Vangelo secondo Luca (18,1-8)
Il contesto di questa parabola è quello della “fine dei tempi”: Gesù cammina verso Gerusalemme, verso la Passione, morte e Risurrezione. I discepoli percepiscono l’epilogo tragico e misterioso, sentono la necessità di maggiore fede (“Aumenta in noi la fede”) e sono ansiosi di comprendere la venuta del Regno di Dio. Il termine “Figlio dell’uomo”, già presente in Daniele (7), indica colui che viene sulle nubi, riceve la regalità universale e eterna, e rappresenta in senso originale anche un essere collettivo, il popolo dei Santi dell’Altissimo. Gesù lo adopera per riferirsi a sé stesso, rassicurando i discepoli sulla vittoria definitiva di Dio, pur in un contesto di difficoltà imminenti. Il riferimento al giudizio e al Regno sottolinea la prospettiva escatologica: Dio farà giustizia ai suoi eletti, il Regno è già iniziato, ma sarà pienamente realizzato alla fine. La parabola della vedova ostinata è al cuore del messaggio: davanti a un giudice ingiusto, la vedova non si scoraggia perché la sua causa è giusta. Quest’esempio unisce due virtù essenziali per il cristiano: umiltà, riconoscendo la propria povertà (prima beatitudine: “Beati voi poveri, perché vostro è il Regno di Dio”), e perseveranza, l’insistenza fiduciosa nella preghiera e nella giustizia. L’ostinazione della vedova diventa paradigma per la fede in attesa del Regno: anche la nostra causa, fondata sulla volontà di Dio, richiede tenacia. Il testo richiama inoltre il legame con l’episodio dell’Antico Testamento: durante la battaglia contro gli Amaleciti, Mosè prega con ostinazione sulla collina mentre Giosuè combatte in pianura. La vittoria del popolo dipende dalla presenza e dall’intervento di Dio, sostenuto dalla preghiera perseverante di Mosè. La parabola della vedova ha la stessa funzione: ricordare ai credenti, di ogni tempo, che la fede è un combattimento continuo, una prova di resistenza davanti alle difficoltà, alle opposizioni e ai dubbi. La domanda conclusiva di Gesù, “Quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà la fede sulla terra?”, è un monito universale: la fede non va mai data per scontata, deve essere custodita, nutrita e protetta. Dal primo mattino della Risurrezione fino alla venuta definitiva del Figlio dell’uomo, la fede è una lotta di costanza e fiducia, anche quando il Regno sembra lontano. La vedova insegna come affrontare l’attesa: umili, ostinati, fiduciosi, consapevoli della propria debolezza ma certi della giustizia e della volontà salvifica di Dio che mi delude le attese di chi in lui confida totalmente. Luca sembra scrivere a una comunità minacciata dallo scoraggiamento, come suggerisce la frase finale: “Quando il Figlio dell’uomo verrà, troverà la fede sulla terra?”. Questa frase, pur apparendo pessimistica, è in realtà un monito alla vigilanza: la fede va custodita e alimentata, non data per scontata. Il testo forma un’inclusione: la prima frase insegna cosa sia la fede — “Bisogna pregare sempre senza scoraggiarsi” — e la frase finale invita alla perseveranza. Tra le due, l’esempio della vedova ostinata, trattata ingiustamente ma che non si arrende, mostra concretamente come praticare questa fede. L’insegnamento complessivo è chiaro: la fede è un impegno costante, una resistenza attiva, che richiede ostinazione, umiltà e fiducia nella giustizia di Dio, anche di fronte alle difficoltà e all’apparente assenza di risposta.
+ Giovanni D’Ercole
Preghiera: Fede-appropriazione. Lo scandalo dell’attesa
28a Domenica T.O. (anno C)
XXVIII Domenica Tempo Ordinario (anno C) [12 Ottobre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Riflettere sulla gratitudine che è più facile notare fra coloro che sono lontani è un invito a rivedere la nostra personale relazione con Dio.
Prima Lettura dal secondo libro dei Re (5, 14-17)
La lettura di questa domenica comincia nel momento in cui il generale Naaman, apparentemente docile come un agnello, si immerge nell’acqua del Giordano, su ordine del profeta Eliseo; ma ci manca l’inizio della storia: ve lo racconto. Naaman è un generale siriano molto stimato dal re di Aram (l’attuale Damasco). Ovviamente, per il popolo di Israele, egli è uno straniero e in certi periodi addirittura un nemico e soprattutto essendo un pagano non appartiene al popolo eletto. Ancora più grave: è lebbroso, il che significa che presto tutti lo eviteranno e per lui è una vera maledizione. Fortunatamente per lui, sua moglie ha una schiava israelita la quale dice alla padrona: “A Samaria c’è un grande profeta che potrebbe sicuramente guarire Naaman”. La padrona lo riferisce al marito Naaman, il quale lo dice al re di Aram: il profeta di Samaria può guarirmi. E poiché Naaman gode di grande favore, il re scrive una lettera di presentazione al re di Samaria raccomandando Naaman affetto da lebbra perché vada dal profeta Eliseo. Il re di Israele non sa che il profeta Eliseo può guarire anzi è nel panico perché pensa che il re di Siria sta cercando un pretesto per fargli guerra. Eliseo viene a sapere e chiede di venire Naaman che arriva con tutta la sua scorta e i bagagli pieni di doni per il guaritore. In realtà, solamente un servo socchiude la porta e si limita a dirgli che il suo padrone gli ordina di immergersi sette volte nel Giordano per essere purificato. Naaman ritiene questo offensivo e a che serve tuffarsi nel Giordano dato che in Siria ci sono fiumi ben più belli del Giordano. Infuriato riprende la strada verso Damasco, ma fortunatamente i suoi servi gli dicono: Ti aspettavi che il profeta ti chiedesse cose straordinarie per guarirti e le avresti fatte. Ora ti ordina una cosa ordinaria perché non puoi farla? Naaman si lascia convincere e comincia da questo punto la lettura di oggi. Naaman obbedisce a un ordine semplice immergendosi sette volte nel Giordano ed è guarito. A noi sembra semplice, ma per un grande generale di un esercito straniero è proprio questa obbedienza che non è affatto semplice! Il seguito del testo lo dimostra. Naaman è guarito e torna da Eliseo per dirgli due cose. La prima: “Ora so che non c’è Dio, su tutta la terra, se non in Israele” e aggiungerà dopo che tornato nel suo paese, gli offrirà sacrifici. L’autore di questo passo approfitta per dire agli Ebrei: voi avete da secoli la protezione dell’unico Dio e ora vedete che Dio è anche per gli stranieri, mentre voi continuate a lasciarvi tentare dall’idolatria. Questo straniero, invece ha capito in fretta da dove gli viene la guarigione. Inoltre Naaman dice a Eliseo che vuole dargli un dono per ringraziarlo, ma il profeta rifiuta energicamente: i doni di Dio non si comprano.. Infine perché Naaman vuol portare con sé un po’ di terra d’Israele? Egli motiva la richiesta perché non vuole offrire olocausti e sacrifici ad altri dèi, ma solo al Dio d’Israele. Questo fa capire che, al tempo del profeta Eliseo, tutti i popoli vicini a Israele credevano che le divinità regnassero su territori specifici e per offrire sacrifici al Dio d’Israele, Naaman crede dunque di dover portare con sé della terra sulla quale regna questo Dio.
Salmo Responsoriale (97/98, 1-4)
Nella prima lettura Naaman, generale siriano quindi un pagano, viene guarito dal profeta Eliseo e, grazie a questo, scopre il Dio d’Israele. Naaman è dunque del tutto adatto a cantare questo salmo, nel quale si parla dell’amore di Dio sia per i pagani, quelli che la Bibbia chiama le nazioni (o le genti), sia per Israele. “Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia” (v.2) e subito dopo (v 3): “Si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele”, che è l’espressione consacrata per ricordare l’elezione d’Israele, la relazione del tutto privilegiata che lega questo piccolo popolo al Dio dell’universo. Le semplici parole “la sua fedeltà”, “il suo amore” sono il richiamo all’Alleanza: è attraverso queste parole che, nel deserto, Dio si è fatto conoscere al popolo che ha scelto. La frase “Dio di amore e di fedeltà” indica che Israele è il popolo eletto ma la frase precedente ricorda che, se Israele è stato scelto, non è per godere egoisticamente del privilegio, non per considerarsi figlio unico, ma per comportarsi come fratello maggiore e il suo ruolo è annunciare l’amore di Dio per tutti gli uomini, così da integrare a poco a poco tutta l’umanità nell’Alleanza. In questo salmo, questa certezza segna perfino la composizione del testo; se lo si guarda più da vicino, si nota la costruzione in inclusione dei versetti 2 e 3. Ricordo che l’inclusione è un procedimento letterario che si trova spesso nella Bibbia. È un po’ come un riquadro in un giornale o in una rivista; ovviamente, lo scopo è mettere in evidenza il testo scritto all’interno del riquadro. Nella Bibbia, funziona allo stesso modo: il testo centrale viene messo in risalto, incorniciato da due frasi identiche, una prima e una dopo. Qui, la frase centrale parla di Israele, il popolo eletto, ed è incorniciata da due frasi che parlano delle nazioni: la prima frase “Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia” e la seconda riguarda Israele: “Si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa d’Israele” e la terza: “Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio”. Qui non compare il termine “le genti” ma è sostituito dall’espressione “tutti i confini della terra”. Il che significa che l’elezione d’Israele è centrale, ma non bisogna dimenticare che deve irradiare su tutta l’umanità. Una seconda sottolineatura di questo salmo è la proclamazione molto marcata della regalità di Dio. Per esempio, nel Tempio di Gerusalemme si canta: “Acclamate il Signore, terra intera, acclamate il vostro re”. Questo salmo è un grido di vittoria, il grido che si innalza sul campo di battaglia dopo il trionfo, la teru‘ah in onore del vincitore. La vittoria di Dio, di cui qui si parla, è duplice: è innanzitutto la vittoria della liberazione dall’Egitto e poi la vittoria attesa per la fine dei tempi, la vittoria definitiva di Dio contro tutte le forze del male. E già allora si acclamava Dio come un tempo si acclamava il nuovo re nel giorno della sua incoronazione, con grida di vittoria al suono delle trombe, dei corni e tra gli applausi della folla. Ma mentre con i re della terra si andava sempre verso la delusione, questa volta si sa che non si sarà delusi; ecco perché stavolta la teru‘ah deve essere particolarmente vibrante! I cristiani acclamano Dio con ancora più forza, perché hanno visto con i loro occhi il re del mondo: dall’Incarnazione del Figlio, essi sanno e affermano, contro ogni evento apparentemente contrario, che il Regno di Dio, cioè dell’amore, è già cominciato.
Seconda Lettura dalla seconda Lettera di san Paolo apostolo a Timoteo (2, 8 – 13)
Il canto «Ricordati di Gesù Cristo, risorto dai morti; egli è la nostra salvezza, la nostra gloria eterna» si trova nel suo contesto originale nella seconda lettera a Timoteo, dove Paolo scrive: «Ricordati di Gesù Cristo, discendente di Davide». In ambiente ebraico era essenziale affermare che Gesù fosse davvero della stirpe di Davide per essere riconosciuto come Messia. Paolo aggiunge: «Egli è risorto dai morti: questo è il mio Vangelo». La questione è radicale: o Gesù è risorto, o non lo è. Paolo, inizialmente convinto che fosse un’invenzione, aveva cercato di impedire la diffusione di tale annuncio. Ma, dopo l’esperienza sulla via di Damasco, ha visto il Risorto e ne è diventato testimone. Gesù è vincitore della morte e del male, e con lui nasce il mondo nuovo, a cui i credenti devono partecipare con tutta la loro vita. Per questo Paolo si consacra all’annuncio del Vangelo e invita Timoteo a fare lo stesso, preparandolo alle opposizioni e incoraggiandolo a combattere la buona battaglia con coraggio, dolcezza e fiducia nello Spirito ricevuto. La risurrezione è il cuore della fede cristiana. Se per molti Ebrei la risurrezione della carne era credibile, per i Greci era difficile da accogliere, come mostra il fallimento della predicazione di Paolo ad Atene. Proprio per l’annuncio della risurrezione Paolo ha conosciuto più volte il carcere: «Cristo è risorto dai morti, questo è il mio Vangelo. Per lui soffro, fino a essere incatenato come un malfattore». Anche Timoteo, ammonisce Paolo, dovrà soffrire per il Vangelo. Le catene di Paolo non fermano la verità: «Sono incatenato, ma la Parola di Dio non è incatenata». Gesù stesso aveva detto che se taceranno loro, grideranno le pietre perché nulla può fermare la verità. Paolo aggiunge che sopporta tutto per gli eletti, affinché ottengano anch’essi la salvezza che è in Cristo Gesù, con la gloria eterna. Qui riecheggia il canto iniziale e .segue probabilmente un antico inno battesimale introdotto con la formula: Ecco una parola degna di fede:Se siamo morti con lui, con lui vivremo; se perseveriamo, con lui regnerem». È il mistero del Battesimo, già spiegato in Romani 6: con esso siamo immersi nella morte e risurrezione di Cristo, uniti a lui in modo inseparabile. Passione, morte e risurrezione costituiscono un unico evento che ha inaugurato una nuova epoca per l’umanità. Le ultime frasi mettono in luce la tensione tra libertà umana e fedeltà di Dio perché se lo rinneghiamo, anch’egli ci rinnegherà: Dio rispetta il nostro rifiuto consapevole. Se manchiamo di fede, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso dato che Dio resta sempre fedele anche di fronte alle nostre fragilità.
Dal Vangelo secondo Luca (17, 11-19)
Gesù è in cammino verso Gerusalemme, dove lo attendono passione, morte e risurrezione. Luca sottolinea l’itinerario perché ciò che narra è legato al mistero della salvezza. Durante il viaggio, incontra dieci lebbrosi che, costretti a restare a distanza secondo la Legge, gridano verso di lui chiamandolo “Maestro”: è segno insieme della loro debolezza e della fiducia che ripongono in lui. Diversamente da un altro episodio (Lc 5,12), questa volta Gesù non li tocca, ma ordina soltanto di andare a presentarvi ai sacerdoti, passo necessario per il riconoscimento ufficiale della guarigione. L’ordine è già promessa di salvezza. Il racconto richiama l’episodio di Naaman e del profeta Eliseo (2Re 5) della prima lettura perché mentre i dieci si mettono in cammino, la loro lebbra scompare: la loro fiducia li salva. La malattia li aveva uniti, ma la guarigione rivela la differenza dei cuori: nove Giudei vanno verso i sacerdoti, uno solo,- un Samaritano, considerato eretico — torna indietro. Egli riconosce che la vita e la guarigione vengono da Dio, glorifica Dio a gran voce, si prostra ai piedi di Gesù rendendogli grazie: un atteggiamento riservato a Dio. Così riconosce il Messia e comprende che il vero luogo per rendere gloria a Dio non è più il Tempio di Gerusalemme, ma Gesù stesso. Il suo ritorno è conversione, e Gesù lo proclama: “Àlzati e va’: la tua fede ti ha salvato”. Degli altri nove, Gesù chiede conto: hanno incontrato il Messia ma non lo hanno riconosciuto, scegliendo di correre subito verso il Tempio per compiere la Legge senza fermarsi a ringraziare. Il Vangelo sottolinea così un tema ricorrente: la salvezza è per tutti, ma spesso non sono i più vicini a Dio ad accoglierla: “Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno riconosciuto”. Già l’Antico Testamento affermava l’universalità della salvezza (cf. Sal 97/98). La prima lettura ricorda la conversione di Naaman, straniero, e Gesù aveva rimproverato a Nazaret, citando l’esempio del Siro guarito mentre molti lebbrosi in Israele non lo furono (Lc 4,27), suscitando la collera della sinagoga. Negli Atti, Luca mostrerà ancora il contrasto tra il rifiuto di parte d’Israele e l’accoglienza dei pagani. Questa questione era viva nelle prime comunità cristiane: bisognava essere Giudei per ricevere il battesimo, o anche i pagani potevano essere accolti? Il racconto del Samaritano convertito ricorda tre verità: la salvezza portata da Cristo con passione, morte e risurrezione è per tutti; il rendimento di grazie è spesso compiuto meglio dagli stranieri o dagli eretici; i poveri sono i più disponibili a incontrare Dio. In conclusione, sul cammino verso Gerusalemme, cioè verso la salvezza, Gesù conduce tutti gli uomini disposti a convertirsi, qualunque sia la loro origine o religione.
+ Giovanni D’Ercole
Dalla Guarigione al Cammino verso il Tempio, alla Fede Personale straniera
ESPERIENZE TRAUMATICHE O DI PRECARIETÀ. «BUIO»: APATIA, DEPRESSIONE, PSICOSI, OSTILITÀ - (di Francesco Giovannozzi, psicologo e psicoterapeuta)
Uno sguardo nel «buio».
Come ho già detto in precedenza molti poeti e scrittori hanno descritto il fluire dell’animo umano.
Eugenio Montale lo esprime in una sua poesia del 1925, sul male di vivere, fornendoci l’immagine di un ruscello che non riesce a far scorrere le sue acque, di una foglia accartocciata dal troppo calore, di un cavallo sfinito a terra.
Immagini che nella nostra mente non passano senza lasciare una riflessione e qualche interrogativo.
Momenti di “buio” nella nostra vita ce ne sono stati e forse ci saranno ancora.
Sensazioni di scoraggiamento e di non sapere quale strada prendere - ognuno di noi lo ha sperimentato sulla propria pelle.
L’intensità e la durata del “buio” variano a seconda delle circostanze e dalle capacità di reagire personali.
Di fronte a sconfitte o delusioni reagiamo in modo differente; ciò che disturba un soggetto, può lasciare un altro individuo del tutto indifferente.
Un incontro col “ buio” può essere usuale di fronte a gravi difficoltà come un lutto, la perdita del lavoro, l’insorgere di una malattia, la fine di relazioni affettive, e altro.
Tale stato d’animo è provvisorio e finisce spontaneamente, senza portare cambiamenti nella vita di una persona.
In casi diversi è bene non sottovalutare lo stato d’animo, perché potrebbe essere un segno di una sofferenza psicosomatica o psichica.
In questi casi spesso si provano delle sensazioni inspiegabili di preoccupazione, di apatia; e ci sentiamo più affaticati.
Ricordiamoci che la reazione al “buio” segue sovente un’esperienza traumatica, la quale in circostanze ordinarie della vita non avrebbe causato nessuna sensazione temporanea di cattivo umore.
Una reazione maggiore e più protratta nel tempo, una reazione che l’individuo non riesce a superare da solo, è una condizione non usuale.
Nelle persone anziane le scosse emotive possono far insorgere momenti di “buio” più facilmente che nei giovani.
Talora gli anziani vengono messi da parte, hanno meno relazioni sociali, e spesso ne viene a soffrire il loro prestigio; principalmente quando viene meno la speranza.
Ma anche gli adolescenti [con la loro precarietà] non sono immuni a questi momenti di inquietudine.
Non è vero che l’adolescenza è un periodo felice della vita; anzi, forse è uno dei più travagliati.
In questi momenti di “buio” che la clinica chiama «depressione», notiamo: le persone che attraversano questa fase riducono di molto le loro attività, hanno meno fiducia in se stessi, si intesseranno a poche cose.
Sono capaci di conservare il lavoro anche se devono intensificare gli sforzi. Di solito la memoria e il rapporto con la realtà non sono alterati - a meno che non è insorto uno stato grave («psicosi»).
Arieti parla della depressione che qui abbiamo chiamato “buio” come una combinazione di tristezza e pessimismo.
Quest’ultimo costituisce l’elemento essenziale della combinazione; l’idea non sana sta nel credere che ciò che è accaduto a una persona gli succederà sempre, o che lo stato d’animo in cui si trova non muterà mai.
Il disfattismo, l’illusione di saper cosa ci succederà in futuro, consolida la tristezza in “buio”.
Spesso il “buio” dell’anima viene scaricato sul corpo.
Possiamo subire perdita di peso, sensazioni di oppressione a livello cardiaco; diminuzione delle secrezioni corporee; insonnia; e sovente mal di testa.
Nel comportamento con gli altri il “buio” ci fa tendere a sfruttare e condizionare il prossimo; ci fa essere poco inclini a essere persuasi. Difficilmente diamo soddisfazione al prossimo, e spesso l’ostilità ci invade.
Faber Andrew ha scritto una poesia intitolata ‘A chi sta attraversando il suo buio’…
Il poeta invita il lettore a «credere nella poesia. Negli occhi di chi quella strada l’ha già ritrovata».
Poi ancora: «C’è un cielo di qua che vi aspetta, con un panorama di sogni da togliere il fiato».
Per un poeta la poesia è la strada maestra, ma noi che non siamo poeti abbiamo qualcosa in cui Credere, e che costituisce il pilastro della nostra realtà.
Ricordiamoci sempre che quando la notte raggiunge il suo punto più oscuro, lì inizia l’alba di un nuovo giorno.
Francesco Giovannozzi psicologo psicoterapeuta.
AGITAZIONI, INQUIETUDINE, PREOCCUPAZIONI, PAURA - (di Francesco Giovannozzi, psicologo e psicoterapeuta)
Nella società odierna i fattori che procurano affanno e inquietudine sono molteplici e sovente le strategie per combatterle sono più difficili da trovare.
Questo tempo caratterizza il “barcollare” di valori fondamentali, di norme, di aspirazioni, che spingevano l’uomo verso la sua realizzazione, verso una sana relazione con gli altri.
Le attuali guerre nel mondo, il ricordo di esse per i meno giovani, le minacce atomiche, si aggiungono alla lista.
In un clima così ostile l’isolamento dell’uomo si accentua.
Ogni persona ha il proprio modo di reagire: quello più usuale è un senso di disagio, di ansietà, di sentirsi in pericolo senza sapere quale esso sia; di rovina, o altro.
Sovente ci sfugge la causa di tutto questo. La persona si sente disarmata, e se questa inquietudine è forte, può essere scaricata sul corpo.
Si noterà una rigidità muscolare, o possono essere presenti tremori, un sentirsi deboli, stanchi; anche la voce può tremare.
A livello cardio-circolatorio possono manifestarsi palpitazioni, svenimenti, aumento del battito cardiaco, aumento della pressione.
Anche a livello dell’intestino possono manifestarsi nausee, vomiti, mal di pancia - che non hanno origine organica.
Vi possono essere anche altre manifestazioni tipiche della storia di ogni persona, e non c’è organo su cui non può essere scaricata la tensione interna.
Ricordo che nella mia attività professionale ho incontrato soggetti con problematiche psicologiche “scaricate” in diverse parti del corpo; a volte, le più impensabili.
Mi sono ritrovato di fronte alopecie (perdita di capelli), arti bloccati, disturbi della vista, svenimenti, e negli ultimi tempi adolescenti che si tagliavano…
Se la persona si sente sopraffare da un’onda anomala di malessere interiore, può reagire in maniera inadeguata o addirittura pericolosa (alcol, droghe, corse in auto, gioco d’azzardo, ecc.).
La comprensione di queste agitazioni, preoccupazioni, ansie, è importante per stabilire quando esse sono nella norma o meno.
Gli stati di ansia non comuni si distinguono da una apprensione più o meno persistente, con crisi acute.
Questi stati sono da distinguersi dallo stato di preoccupazione diffusa che troviamo come usuale nella nostra vita quotidiana.
Ricordiamoci che per definire la nostra ansia, agitazione, dobbiamo convincerci che essa è qualcosa di normale quando l’individuo si sente minacciato.
L’agitazione va distinta dalla paura, dove il pericolo è reale: l’individuo può valutare la situazione e scegliere se affrontarla, o fuggire.
Quando parliamo di agitazione nella norma, vogliamo dire che è nella natura umana provarla di fronte ad un pericolo, a una malattia, etc.
Rappresenta il modo di vivere più profondo della nostra esistenza umana,
Ci fa trovare dinanzi ai nostri limiti, alle nostre debolezze, che non sono manifestazioni del malessere interiore o di malattia, ma espressioni della natura umana.
Più siamo coscienti dei nostri limiti, più riusciamo a vivere con le nostre ansie.
Per i nostri simili che si sentono onnipotenti l’agitazione, l’ansia, risultano insopportabili, poiché vengono alla coscienza i limiti che sono una ferita al proprio “sentirsi una creatura superiore”.
Sperimentiamo una normale inquietudine anche quando lasciamo una “strada vecchia per una nuova”.
Sotto questo punto di vista essa ci accompagna nei nostri cambiamenti, nella nostra evoluzione, e nel trovare un significato nella nostra vita.
Dott Francesco Giovannozzi psicologo-psicoterapeuta
And quite often we too, beaten by the trials of life, have cried out to the Lord: “Why do you remain silent and do nothing for me?”. Especially when it seems we are sinking, because love or the project in which we had laid great hopes disappears (Pope Francis)
E tante volte anche noi, assaliti dalle prove della vita, abbiamo gridato al Signore: “Perché resti in silenzio e non fai nulla per me?”. Soprattutto quando ci sembra di affondare, perché l’amore o il progetto nel quale avevamo riposto grandi speranze svanisce (Papa Francesco)
The Kingdom of God grows here on earth, in the history of humanity, by virtue of an initial sowing, that is, of a foundation, which comes from God, and of a mysterious work of God himself, which continues to cultivate the Church down the centuries. The scythe of sacrifice is also present in God's action with regard to the Kingdom: the development of the Kingdom cannot be achieved without suffering (John Paul II)
Il Regno di Dio cresce qui sulla terra, nella storia dell’umanità, in virtù di una semina iniziale, cioè di una fondazione, che viene da Dio, e di un misterioso operare di Dio stesso, che continua a coltivare la Chiesa lungo i secoli. Nell’azione di Dio in ordine al Regno è presente anche la falce del sacrificio: lo sviluppo del Regno non si realizza senza sofferenza (Giovanni Paolo II)
For those who first heard Jesus, as for us, the symbol of light evokes the desire for truth and the thirst for the fullness of knowledge which are imprinted deep within every human being. When the light fades or vanishes altogether, we no longer see things as they really are. In the heart of the night we can feel frightened and insecure, and we impatiently await the coming of the light of dawn. Dear young people, it is up to you to be the watchmen of the morning (cf. Is 21:11-12) who announce the coming of the sun who is the Risen Christ! (John Paul II)
Per quanti da principio ascoltarono Gesù, come anche per noi, il simbolo della luce evoca il desiderio di verità e la sete di giungere alla pienezza della conoscenza, impressi nell'intimo di ogni essere umano. Quando la luce va scemando o scompare del tutto, non si riesce più a distinguere la realtà circostante. Nel cuore della notte ci si può sentire intimoriti ed insicuri, e si attende allora con impazienza l'arrivo della luce dell'aurora. Cari giovani, tocca a voi essere le sentinelle del mattino (cfr Is 21, 11-12) che annunciano l'avvento del sole che è Cristo risorto! (Giovanni Paolo II)
Christ compares himself to the sower and explains that the seed is the word (cf. Mk 4: 14); those who hear it, accept it and bear fruit (cf. Mk 4: 20) take part in the Kingdom of God, that is, they live under his lordship. They remain in the world, but are no longer of the world. They bear within them a seed of eternity a principle of transformation [Pope Benedict]
Cristo si paragona al seminatore e spiega che il seme è la Parola (cfr Mc 4,14): coloro che l’ascoltano, l’accolgono e portano frutto (cfr Mc 4,20) fanno parte del Regno di Dio, cioè vivono sotto la sua signoria; rimangono nel mondo, ma non sono più del mondo; portano in sé un germe di eternità, un principio di trasformazione [Papa Benedetto]
In one of his most celebrated sermons, Saint Bernard of Clairvaux “recreates”, as it were, the scene where God and humanity wait for Mary to say “yes”. Turning to her he begs: “[…] Arise, run, open up! Arise with faith, run with your devotion, open up with your consent!” [Pope Benedict]
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.