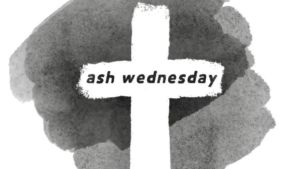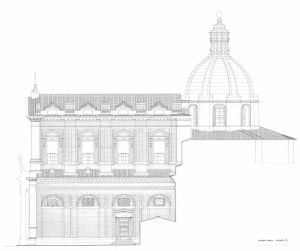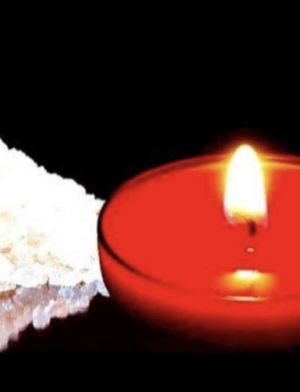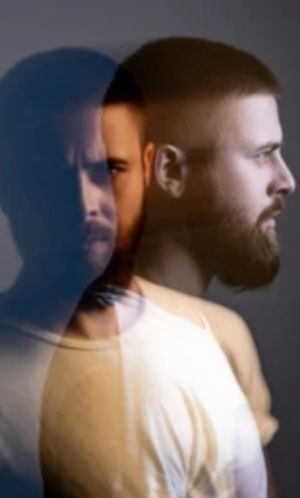don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Quaresima senza mortificazione: la Cenere che fa Fiorire
6a Domenica T.O.
VI Domenica Tempo Ordinario (anno A) [15 febbraio 2026]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Il tema delle due vie, tanto caro ai profeti, tocca il tema della libertà dell’uomo e della sua responsabilità. Le letture di questa domenica ci aiutano a meglio capire come non sbagliare strada nella vita
Prima Lettura dal libro del Siracide (15,15-20 NV 15, 16-21)
Dio ci ha creati liberi e Ben Sira il Saggio ci propone qui una riflessione sulla libertà dell’uomo che si articola in tre punti: PRIMO, il male è esterno all’uomo; SECONDO, l’uomo è libero di scegliere tra il male e il bene; TERZO, scegliere il bene significa anche scegliere la felicità. PRIMO: il male è esterno all’uomo perché non fa parte della nostra natura, ed è già una grande notizia; perché se il male facesse parte della nostra natura, non ci sarebbe alcuna speranza di salvezza: non ce ne potremmo mai liberare. Questa, per esempio, era la concezione dei Babilonesi, al contrario, la Bibbia è molto più ottimista: afferma che il male è esterno all’uomo; Dio non ha creato il male e non è lui che ci spinge a compierlo. Egli dunque non è responsabile del male che commettiamo. È il senso dell’ultimo versetto di questa Lettura: “A nessuno (Dio) ha comandato di essere empio, e a nessuno ha dato il permesso di peccare”. Mentre poco prima di questo brano, Ben Sira scrive: “Non dire: “È il Signore che mi ha fatto deviare...Non dire: “È lui che mi ha fatto smarrire” (Sir 15,11-12).
Se Dio avesse creato Adamo come un essere in parte buono e in parte cattivo, come immaginavano i Babilonesi, il male farebbe parte della nostra natura. Ma Dio è solo amore, e il male gli è totalmente estraneo. Il racconto della caduta di Adamo ed Eva, nel libro della Genesi, è stato scritto proprio per far comprendere che il male è esterno all’uomo, poiché viene introdotto dal serpente e si diffonde nel mondo nel momento in cui l’uomo comincia a diffidare di Dio. Ritroviamo la stessa affermazione nella lettera di san Giacomo: “Nessuno, quando è tentato, dica: “La tentazione viene da Dio”; perché Dio non può essere tentato dal male ed egli non tenta nessuno”. In altre parole, il male è totalmente estraneo a Dio: egli non può spingere a compierlo. E san Giacomo continua: “Ciascuno invece è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo seduce” (Gc 1,13-14). SECONDO: l’uomo è libero e può scegliere il male o il bene. Questa certezza è stata acquisita lentamente dal popolo d’Israele; eppure, anche qui, la Bibbia è inequivocabile: Dio ha creato l’uomo libero. Perché questa certezza maturasse in Israele, è stato necessario che il popolo sperimentasse l’azione liberatrice di Dio in ogni tappa della sua storia, a cominciare dall’esperienza della liberazione dall’Egitto. Tutta la fede d’Israele è nata dalla sua esperienza storica: Dio è il suo liberatore; e poco a poco si è compreso che ciò che è vero oggi lo era già al momento della creazione, e quindi si è dedotto che Dio ha creato l’uomo libero. Occorrerà dunque imparare a conciliare queste due certezze bibliche: che Dio è onnipotente e che, tuttavia, di fronte a lui l’uomo è libero. Ed è proprio perché l’uomo è libero di scegliere che si può parlare di peccato: la nozione stessa di peccato presuppone la libertà; se non fossimo liberi, i nostri errori non potrebbero essere chiamati peccati. Forse, per entrare un po’ in questo mistero, dobbiamo ricordare che l’onnipotenza di Dio è quella dell’amore: lo sappiamo bene, solo l’amore vero rende l’altro libero. Per guidare l’uomo nelle sue scelte, Dio gli ha dato la sua Legge e il libro del Deuteronomio lo sottolinea con forza:Cf Dt 30,11-14.). TERZO: scegliere il bene significa scegliere la felicità. Leggiamo nel testo: “Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che avrà scelto”. Detto in altri termini, è nella fedeltà a Dio che l’uomo trova la vera felicità. Allontanarsi da lui significa, prima o poi, procurarsi la propria infelicità. In modo figurato si dice che l’uomo si trova costantemente a un bivio: due strade si aprono davanti a lui (nella Bibbia si parla di due «vie»). Una via conduce alla luce, alla gioia, alla vita: beati coloro che la percorrono. L’altra è una via di notte e di tenebra e, in definitiva, non porta che tristezza e morte. Infelici coloro che vi si smarriscono. Anche qui non si può fare a meno di pensare al racconto della caduta di Adamo ed Eva: la loro cattiva scelta li ha condotti sulla via sbagliata. Il tema delle due vie è molto frequente nella Bibbia, in particolare nel libro del Deuteronomio (30,15-20). Secondo il tema delle due vie, non siamo mai definitivamente prigionieri, neppure dopo scelte sbagliate, poiché è sempre possibile tornare indietro. Con il Battesimo siamo innestati in Cristo, il quale in ogni istante ci dona la forza di scegliere di nuovo la via buona: è per questo che lo chiamiamo Redentore, cioè Liberatore. Ben Sira diceva che dipende dalla nostra scelta restare fedeli e , da battezzati, dobbiamo aggiungere: restiamo fedeli con la grazia di Gesù Cristo.
Salmo responsoriale (118/119)
Questo salmo fa perfettamente eco alla prima lettura tratta da Ben Sira: è la stessa meditazione che prosegue; l’idea sviluppata (in modo diverso, certo, ma in piena coerenza) in questi due testi è che l’umanità trova la propria felicità solo nella fiducia in Dio e nell’obbedienza ai suoi comandamenti: “Beato chi è integro nella lsua via, e cammina nella Legge del Signore”. La sventura e la morte cominciano per l’uomo nel momento in cui egli si allontana dalla via della fiducia serena. Infatti, lasciar entrare in noi il sospetto nei confronti di Dio e dei suoi comandamenti e, di conseguenza, fare di testa propria significa imboccare una cattiva strada senza uscita. È esattamente il problema di Adamo ed Eva nel racconto della caduta nel paradiso terrestre. Ritroviamo, come in filigrana, il tema delle due vie di cui parla la prima lettura: se diamo ascolto a Ben Sira, siamo viandanti perpetui, costretti a verificare continuamente il nostro cammino… Beati tra noi coloro che hanno trovato la strada giusta! Perché, delle due vie che si aprono costantemente davanti a noi, una conduce alla felicità, l’altra all’infelicità. Il credente sperimenta la dolcezza della fedeltà ai comandamenti di Dio: è questo che il salmo vuole dirci. È il salmo più lungo del Salterio (176 versetti con 22 strofe di 8 versetti) e i pochi versetti proposti oggi non ne costituiscono che una piccolissima parte, l’equivalente di una sola strofa. Perché ventidue strofe? Perché ventidue sono le lettere dell’alfabeto ebraico: ogni versetto di ciascuna strofa comincia con la stessa lettera e le strofe si susseguono secondo l’ordine alfabetico. In letteratura si parla di “acrostico” anche se qui non si tratta di virtuosismo letterario, ma di una vera professione di fede: questo salmo è un poema in onore della Legge, una meditazione sul dono di Dio che è la Legge, cioè i comandamenti. Anzi, più che di un salmo, sarebbe meglio parlare di una litania in onore della Legge: qualcosa che ci è piuttosto estraneo. Infatti, una delle caratteristiche della Bibbia, per noi un po’ sorprendente, è il vero amore per la Legge che abita il credente biblico. I comandamenti non sono subiti come una dominazione che Dio eserciterebbe su di noi, ma come consigli, gli unici validi per condurre una vita felice. “Beati gli uomini integri nella loro via, che camminano secondo la Legge del Signore”: quando l’uomo biblico pronuncia questa frase, la pensa con tutto il cuore. Non si tratta ovviamente di una magia: uomini fedeli alla Legge possono incontrare ogni sorta di sventure nel corso della loro vita; ma, in questi casi tragici, il credente sa che solo il cammino della fiducia in Dio può donargli la pace dell’anima. La Legge è accolta come un dono che Dio fa al suo popolo, mettendolo in guardia da tutte le false strade; è l’espressione della sollecitudine del Padre per i suoi figli, così come noi, talvolta, mettiamo in guardia un bambino o un amico da ciò che ci sembra pericoloso per lui. Si dice che Dio dona la sua Legge ed essa è davvero considerata come un regalo. Infatti, Dio non si è limitato a liberare il suo popolo dalla schiavitù dell’Egitto; lasciato a se stesso, Israele avrebbe rischiato di ricadere in altre schiavitù forse ancora peggiori. Donando la sua Legge, Dio offriva in qualche modo il manuale d’uso della libertà. La Legge è dunque espressione dell’amore di Dio per il suo popolo. Occorre dire che non si è dovuto attendere il Nuovo Testamento per scoprire che Dio è Amore e che, in definitiva, la Legge non ha altro scopo che condurci sulla via dell’amore. Tutta la Bibbia è la storia dell’apprendimento del popolo eletto alla scuola dell’amore e della vita fraterna. Il libro del Deuteronomio affermava: “Ascolta, Israele: il Signore nostro Dio è l’Unico; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza» (Dt 6,4). E il libro del Levitico proseguiva: “Amerai il tuo prossimo come te stesso” (Lv 19,18). Più tardi, Gesù, unendo questi due comandamenti, ha potuto dire che essi riassumono tutta la Legge giudaica. Torniamo alla Beatitudine del primo versetto di questo salmo: “Beato l’uomo che segue la Legge del Signore”. La parola “beato”, lo abbiamo già imparato, può essere tradotta con l’espressione “in cammino” per cui il senso di questo versetto sarebbe: “Cammina con fiducia, uomo che osservi la Legge del Signore”. L’uomo biblico è talmente convinto che in questo è in gioco la sua vita e la sua felicità, che questa litania di cui parlavo poco fa è in realtà una preghiera. Dopo i primi tre versetti, che sono affermazioni sulla felicità degli uomini fedeli alla Legge, i restanti centosettantatré versetti si rivolgono direttamente a Dio, in uno stile ora contemplativo, ora supplice, con invocazioni come: “Apri i miei occhi, perché io contempli le meraviglie della tua Legge”. E la litania continua, ripetendo senza sosta quasi le stesse formule: per esempio, in ebraico, in ogni strofa ricorrono sempre gli stessi otto termini per descrivere la Legge. Solo gli innamorati osano ripetersi così, senza rischiare di stancarsi. Otto parole sempre le stesse e anche otto versetti in ciascuna delle ventidue strofe: il numero otto, nella Bibbia, è il numero della nuova Creazione. La prima Creazione è stata compiuta da Dio in sette giorni; l’ottavo giorno sarà dunque quello della Creazione rinnovata, dei “cieli nuovi e della terra nuova”, secondo un’altra espressione biblica. Essa potrà finalmente manifestarsi quando tutta l’umanità vivrà secondo la Legge di Dio, cioè nell’amore, poiché è la stessa cosa. Altri elementi della simbologia del numero otto: nell’arca di Noè c’erano quattro coppie umane (otto persone); a risurrezione di Cristo è avvenuta di domenica, giorno che è insieme il primo e l’ottavo della settimana. er questo motivo i battisteri dei primi secoli erano spesso ottagonali; ancora oggi incontriamo numerosi campanili ottagonali.
APPROFONDIMENTO: gli otto termini del vocabolario della Legge, considerati sinonimi che esprimono le diverse sfaccettature dell’amore di Dio che si dona nella sua Legge: Comandamenti: ordinare, comandare; Legge: deriva da una radice che non significa «prescrivere», ma «insegnare»; essa indica la via per andare a Dio. È una pedagogia, un accompagnamento che Dio ci offre: un dono; Parola: la Parola di Dio è sempre creatrice, parola d’amore: «Dio disse… e così avvenne» (Gen 1). Sappiamo bene che anche «ti amo» è una parola creatrice; Promessa: la Parola di Dio è sempre promessa e fedeltà; Giudizi: trattare con giustizia; Decreti: dal verbo «incidere», «scrivere sulla pietra» (le tavole della Legge); Precetti: ciò che Dio ci ha affidato; Testimonianze: della fedeltà di Dio.
Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi (2,6-10)
Domenica scorsa, san Paolo opponeva già la sapienza umana alla sapienza di Dio: “La vostra fede – diceva – non si fonda sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio”. E insisteva nel dire che il mistero di Cristo non ha nulla a che vedere con i nostri ragionamenti: agli occhi degli uomini il Vangelo appare come una follia e insensati sono coloro che vi scommettono la propria vita. Questa insistenza sul termine “sapienza” forse ci sorprende, ma Paolo si rivolge ai Corinzi, cioè a dei Greci per i quali la sapienza è la virtù più preziosa.
Oggi Paolo continua sulla stessa linea: l’annuncio del mistero di Dio può sembrare follia agli occhi del mondo, ma si tratta di una sapienza infinitamente più alta, la sapienza di Dio. “Tra coloro che sono perfetti parliamo sì di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo…parliamo invece della sapienza di Dio”. Tocca a noi scegliere se vivere secondo la sapienza del mondo, lo spirito del mondo, oppure secondo la sapienza di Dio: due sapienze totalmente contraddittorie. Ritorna qui il tema delle altre letture di questa domenica: la prima lettura tratta dal libro del Siracide e il salmo 118/119 sviluppavano entrambi, ciascuno a modo suo il tema delle due vie: l’uomo è posto al crocevia di due strade ed è libero di scegliere il proprio cammino; una via conduce alla vita e alla felicità; l’altra sprofonda nella notte, nella morte, e in definitiva non offre che false gioie. “Sapienza di Dio che è rimasta nascosta” (v.7): una delle grandi affermazioni della Bibbia è che l’uomo non può comprendere tutto del mistero della vita e della creazione né il mistero di Dio stesso. Questo limite fa parte del nostro stesso essere. In proposito leggiamo nel Deuteronomio: “Le cose nascoste appartengono al Signore nostro Dio, ma le cose rivelate sono per noi e per i nostri figli per sempre, affinché mettiamo in pratica tutte le parole di questa Legge» (Dt 29,28). Ciò significa: Dio tutto conosce, e noi conosciamo solo ciò che egli ha voluto rivelarci, a cominciare dalla Legge, che è la chiave di tutto il resto. Torniamo ancora una volta al libro della Genesi che racconta il giardino di Eden dove c’erano alberi di ogni specie, “belli a vedersi e buoni da mangiare” (Gn 2,9); e c’erano anche due alberi particolari: uno, posto in mezzo al giardino, era l’albero della vita; l’altro, situato in un luogo non precisato, si chiamava albero della conoscenza di ciò che rende felici o infelici. Ad Adamo era permesso mangiare del frutto dell’albero della vita, anzi era raccomandato, poiché Dio aveva detto: “Potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino… tranne uno”. Solo il frutto dell’albero della conoscenza era proibito. È un modo figurato per dire che l’uomo non può conoscere tutto e deve accettare questo limite: Al Signore nostro Dio appartengono le cose nascoste, dice il Deuteronomio. Al contrario, la Torah, la Legge, che è l’albero della vita, è affidata all’uomo: praticare la Legge significa nutrirsi giorno dopo giorno di ciò che ci farà vivere.
Riprendo quest’espressione: Sapienza rimasta nascosta, stabilita da Dio prima dei secoli per la nostra gloria (cf v7). Paolo insiste più volte nelle sue lettere sul fatto che il progetto di Dio è stabilito da tutta l’eternità e non c’è mai stato un ripensamento e un cambio perché lo svolgersi del progetto di Dio non cambia secondo il comportamento dell’umanità: non possiamo immaginare che prima Dio creò il mondo perfetto fino al giorno in cui Adamo commise la colpa e allora, per riparare ha pensato di mandare suo Figlio. Contro questa concezione, Paolo sviluppa in molte sue lettere l’idea che il ruolo di Gesù Cristo è previsto da tutta l’eternità e che il disegno di Dio precede tutta la storia umana. Lo dice chiaramente nella lettera agli Efesini (cf Ef 1,9-10), oppure, nella lettera ai Romani (cf Rm 16,25-26). Il compimento di questo progetto, come dice Paolo, è “darci la gloria”: la gloria un attributo di Dio e di lui solo e la nostra vocazione sarà partecipare alla sua gloria. Questa espressione è, per Paolo, un altro modo di parlare del progetto di Dio di riunirci tutti in Gesù Cristo e farci partecipi della gloria della Trinità, come leggiamo nella lettera agli Efesini. Scrive ancora san Paolo:” Ma come sta scritto: Quelle cose che occhio non vide né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano” (v.9). Quando afferma “Come sta scritto” si riferisce al profeta Isaia che dice: “Mai si è udito, mai si è sentito dire, mai occhio ha visto un dio, fuori di te, che agisca così per chi confida in lui» (Is 64,3). Ecco lo stupore del credente gratificato dalla rivelazione dei misteri di Dio. E continua: “quelle cose… Dio le ha preparate per coloro che lo amano”. Ma ci possono essere persone per le quali questo non sarebbe stato preparato? Ci ssono dunque privilegiati ed esclusi? Certamente no: il progetto di Dio è per tutti; ma vi possono partecipare solo coloro che hanno lo vogliono a cuore aperto e del cuore ognuno è unico padrone. E’ il tema della fiducia in Dio perché il mistero del suo disegno provvidenziale si apre solo ai piccoli come dice Gesù: “Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli” (cf Mt11,25 e Lc 10,21). Siccome tutti siamo piccoli, basta saperlo riconoscere umilmente e con fiducia in Dio
Dal Vangelo secondo Matteo (5,17-37)
Il Regno avanza lentamente ma con sicurezza. Questo Vangelo di Matteo 5 ci permette di capire come il Regno di Dio avanza nella storia: non per rottura, ma per compimento. Il verbo chiave, che san Matteo mette sulle labbra di Gesù – “Non sono venuto ad abolire, ma a portare a compimento”. Tutta la Bibbia, fin da Abramo, è orientata verso un compimento progressivo del disegno benevolo di Dio. Il cristiano, infatti, non vive di nostalgia del passato, ma di attesa operosa: giudica la storia non in base ai successi immediati, ma all’avanzamento del Regno. È per questo che si può dire che la Messa domenicale è la “riunione del cantiere del Regno”: il luogo in cui si verifica se il Vangelo sta realmente trasformando la vita. Una crescita lenta, inscritta nella Legge. L’evangelista mostra che questa lentezza non è un difetto, ma il metodo stesso di Dio. La Legge data a Mosè ha rappresentato le prime tappe: indicare il minimo vitale perché la convivenza fosse possibile – non uccidere, non rubare, non mentire. Era già un passo decisivo rispetto alla legge del più forte. Gesù non cancella queste acquisizioni; al contrario, le porta a maturazione. Le antitesi («Avete inteso che fu detto… ma io vi dico…») manifestano questo avanzare del Regno: non solo evitare l’omicidio, ma estirpare l’ira; non solo evitare l’adulterio, ma purificare lo sguardo; non solo evitare il falso giuramento, ma vivere nella verità della parola. Ogni volta il Regno fa un passo avanti, perché il cuore dell’uomo viene lentamente convertito. E così il Regno cresce attraverso le relazioni. Il testo metteva in luce un punto decisivo: i comandamenti rinnovati da Gesù riguardano tutti le relazioni con gli altri: riconciliazione con il fratello, rispetto della donna, parola affidabile, amore del nemico. Se il disegno misericordioso di Dio è, come dice Paolo, riunire tutti in Cristo, allora ogni passo verso una fraternità più vera è già un avanzamento del Regno. Per questo Gesù non si limita a insegnare a pregare “Venga il tuo Regno”, ma indica come farlo venire: attraverso scelte concrete, quotidiane, spesso nascoste, ma reali. All’inizio del discorso, Matteo pone le Beatitudini che descrivono coloro che permettono al Regno di avanzare: non i potenti, ma i poveri in spirito, i miti, i misericordiosi, gli operatori di pace. Sono i piccoli ai quali il Padre rivela i suoi misteri. Anche qui il Regno non avanza per forza o spettacolarità, ma per umiltà e fedeltà.
Il Regno avanza come il sale che scompare e come la luce che rischiara senza rumore. È una crescita che si misura sul lungo periodo, non sull’immediato. Per questo Gesù può dire alla fine del capitolo: “Siate perfetti” (Mt 5,48), cioè portati a compimento. Non è un ideale irraggiungibile, ma la meta di un cammino che Dio stesso accompagna. Il Regno di Dio non irrompe, ma cresce; non elimina il passato, ma lo porta a pienezza; non avanza con la forza, ma con la conversione del cuore. Ogni passo in più nell’amore, ogni relazione riconciliata, ogni parola resa vera: è così, lentamente ma con sicurezza, che il Regno viene.
+Giovanni D’Ercole
TENDENZE ANTISOCIALI - (di Francesco Giovannozzi, psicologo e psicoterapeuta)
Qualche giorno fa apprendo dal quotidiano di un altro caso di accoltellamento di una ragazza di 22 anni. E’ stata pugnalata perché ascoltava la musica a un volume troppo alto, infastidendo l’aggressore.
Negli ultimi tempi diversi eventi del genere sono stati riportati dai mezzi di comunicazione; episodi con protagonisti giovani - tutti per futili motivi. Chi per uno sguardo di troppo alla ragazza del cuore, chi per un apprezzamento un po’ osé ecc.
Purtroppo molti giovani negli ultimi tempi aggrediscono i simili con coltelli che portano con sé.
Da premettere che come tutti gli oggetti, il coltello non ha solo una valenza negativa. Esso viene usato in cucina, per lavorare; nelle mani di un cuoco abile diventa qualcosa di prezioso.
Nelle società primitive veniva usato per difendersi dagli animali e dai nemici.
Oggi nel mondo giovanile e non solo se pensiamo ai numerosi femminicidi dove si uccide con una ferocia inaudita, e sembra stia diventando una specie di status.
Tale arnese viene percepito come un segno di durezza e di forza; maggiormente in giovani che si sentono ai margini.
Gli episodi di violenza che accadono tra due individui non hanno motivi fondati, ma la scintilla che li fa scattare è un motivo banale, talora frivolo.
Spesso l’uso del coltello - arma facile da procurarsi - è insita in tizi contigui a gang giovanili, per poterne fare parte e diventarne appunto affiliati. Qui è come se tale oggetto possa essere una “bacchetta magica” contro il senso di malessere interiore, le delusioni affettive e sociali. E tale arma ci farebbe sentire invincibili, o magari solo più forti.
Escluso gli addetti ai lavori, abituarsi a portare un’arma con sé può avere delle ripercussioni sul nostro modi di essere. Ci si abitua; e possiamo vieppiù tendere a episodi di aggressività verso gli altri.
Uscire di casa e portare con se’ un coltello - prima o poi, alla minima contrarietà, si è tentati di usarlo; alimentando cosi la paura e con la probabilità di diventare a sua volta una vittima. Così a lungo andare la nostra psiche “tira fuori” aspetti di noi che magari giacevano “dormienti” in angoli riposti della nostra inconsapevolezza.
L’uomo arriva a seguire un comportamento antisociale. E nei molti obiettivi che cerca di raggiungere, a volte tale comportamento può risultare anche nocivo per sé.
Sono dei soggetti che hanno un livello intellettivo nella norma; a volte anche superiore.
Nella mia esperienza di casi simili, inviati dal Tribunale dei Minori al Servizio di Neuropsichiatria Infantile, gli episodi di violenza con il coltello erano associati a un basso livello intellettivo.
Questi soggetti sovente vanno incontro a insuccessi in ogni iniziativa che prendono, aumentando così il loro senso di frustrazione.
Generalmente tendono a mentire e spesso sfruttano gli altri dando poca importanza ai valori morali.
Abitualmente non dicono quasi mai la verità, neanche quando fanno una promessa (che solitamente non mantengono), mostrando nessun turbamento e mantenendo con freddezza le loro posizioni.
Essi possono subire l’influsso di film, di culture ancestrali, che possono rafforzare in loro una inclinazione all’uso di tali armi; senza che siano coscienti delle possibili conseguenze e di eventuali crescendo di violenza
A noi ”giovani del passato” è stato insegnato e trasmesso di saper reagire in modo costruttivo alle difficoltà e alle mortificazioni che la vita inevitabilmente ci reca.
Oggi tuttavia sembra che tutto sia dovuto, che la privazione di qualcosa in questo eccesso di benessere sia insopportabile.
E allora soprattutto in individui emotivamente instabili scatta qualcosa che li rende capaci di far del male; si va verso un’aggressività insana, malata. Non verso quella “sana grinta” che aiuta a superare gli ostacoli della vita.
Molte volte ho sentito dire dalle persone che mi hanno preceduto e forse anche da qualche lettura che ora non ricordo, che la belva più crudele è l’uomo. Nel suo cuore si annidano due anime: una fatta di socievolezza e spinta al prossimo, l’altra di gelosia e rivalità, di crudeltà verso gli altri.
Abitualmente le persone con queste problematiche tendono a essere disonesti, a mentire e raggirare il prossimo; a cercare di sfruttarlo, dimenticando i principi morali appresi.
Questa gente si considera sempre ‘la migliore’. Se questo non viene avvertito, sale la rabbia - in maniera consapevole o meno.
Nel caso di ferite arrecate, costoro non provano rimorso alcuno; e nessun senso di colpa.
Il limite tra ciò che è legale e ciò che non lo è diventa labile. Tendiamo a agire in modo impulsivo, senza considerare l’effetto delle nostre azioni sugli altri.
Conseguentemente si scende sempre più in basso. Sono a che gli altri serviranno solo per ottenere ciò che vogliamo.
Spesso al comportamento violento o addirittura venato di sadismo, è associato un certo piacere.
E qui si tende anche a partecipare a scontri con il “potere” .
A livello collettivo, basta guardare agli ultimi fatti accaduti a Torino - dove la violenza si accanisce verso i rappresentanti della legge; contro coloro che rappresentano la regola e cercano di ripristinare la legalità’.
Senza aderenza a ideologie, personalmente sono convinto, lasciando da parte l’adesione a ideologie partitiche, che i limiti vadano ripristinati fin dall’infanzia. In modo tale che un bambino possa crescere con una chiara distinzione fra ciò che è Bene e quanto rappresenta il Male.
Dott. Francesco Giovannozzi, Psicologo-Psicoterapeuta.
5a Domenica T.O.
V Domenica Tempo Ordinario (anno A) [8 Febbraio 2026]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Ci avviciniamo alla Quaresima. Cominciamo a prepararci spiritualmente. Dopo la sesta domenica, il 15 febbraio, entreremo in Quaresima.
*Prima Lettura dal libro del profeta Isaia (58,7-10)
A prima vista, questo testo potrebbe sembrare una bella lezione morale, e non sarebbe già poco. In realtà, però, dice molto di più. Il contesto è quello della fine del VI secolo a.C.: il ritorno dall’Esilio è avvenuto, ma restano profonde ferite, “le devastazioni del passato” e le rovine da ricostruire. A Gerusalemme la pratica religiosa è stata ristabilita e, in buona fede, si cerca di piacere a Dio. Tuttavia, il profeta deve trasmettere un messaggio delicato: il culto che piace a Dio non è quello che il popolo immagina. I digiuni sono spettacolari, ma la vita quotidiana è segnata da liti, violenze e avidità. Per questo Isaia denuncia un culto che pretende di ottenere il favore di Dio senza conversione del cuore: “Digiunate tra contese e percuotendo con pugni violenti… È forse questo il digiuno che io preferisco?” (Is 58,4-5).
Siamo di fronte a uno dei testi più forti dell’Antico Testamento, che scuote le nostre idee su Dio e sulla religione e risponde con grande chiarezza a una domanda fondamentale: che cosa si aspetta Dio da noi? Questi pochi versetti biblici sono il frutto di una lunga maturazione nella fede di Israele. Da Abramo in poi, si è cercato ciò che piace a Dio: prima i sacrifici umani, poi quelli di animali, quindi digiuni, offerte e preghiere. Ma lungo tutta questa storia, i profeti non hanno smesso di ricordare che il vero culto non può separarsi dalla vita dell’Alleanza vissuta ogni giorno. Per questo Isaia proclama: il digiuno che Dio vuole è sciogliere le catene dell’ingiustizia, liberare gli oppressi, spezzare ogni giogo. Agli occhi di Dio, ogni gesto che libera il fratello vale più del digiuno più austero. Segue allora l’elenco dei gesti concreti: nutrire l’affamato, dissetare l’assetato, accogliere il povero senza casa, vestire chi è nudo, soccorrere ogni miseria umana. È qui che si misura la verità della fede. Tre osservazioni concludono il messaggio: Primo: questi gesti sono l’imitazione dell’opera stessa di Dio, che Israele ha sperimentato sempre come liberatore e misericordioso. L’uomo è davvero chiamato a essere immagine di Dio, e il modo in cui tratta gli altri rivela il suo rapporto con Lui. Secondo: quando Isaia promette “la gloria del Signore”(v.8) a chi si prende cura del povero, non parla di una ricompensa esterna, ma di una realtà: chi agisce come Dio riflette la sua presenza, diventa luce nelle tenebre, perché “dove c’è amore, lì c’è Dio”. Terzo: ogni gesto di giustizia, liberazione e condivisione è un passo verso il Regno di Dio, quel Regno di giustizia e di amore che l’Antico Testamento attende e che il Vangelo delle Beatitudini presenta come costruito giorno dopo giorno dai miti, dai pacifici e dagli affamati di giustizia.
*Salmo responsoriale (111/112)
Ogni anno, durante la festa delle Capanne, questa festa che ancora oggi dura una settimana in autunno, tutto il popolo compiva quella che potremmo chiamare la sua “professione di fede”: rinnovava l’Alleanza con Dio e si impegnava nuovamente a rispettare la Legge. Il Salmo 111/112 era certamente cantato in questa occasione. L’intero salmo è di per sé un piccolo trattato sulla vita nell’Alleanza: per comprenderlo meglio, bisogna leggerlo dall’inizio. Vi leggo il primo verso: “Alleluia! Beato l’uomo che teme il Signore, che ama con tutto sé stesso la sua volontà!”. Innanzitutto, quindi, il salmo comincia con la parola Alleluia, letteralmente “Lodate Dio”, che è la parola chiave dei credenti: quando l’uomo della Bibbia ci invita a lodare Dio, è proprio per il dono dell’Alleanza. Poi, questo salmo è un salmo alfabetico: cioè contiene ventidue versetti, tanti quanti sono le lettere dell’alfabeto ebraico; la prima parola di ogni versetto comincia con una lettera dell’alfabeto nell’ordine alfabetico. È un modo per affermare che l’Alleanza con Dio riguarda tutta la vita dell’uomo e che la Legge di Dio è il solo cammino di felicità per l’intera esistenza, dalla A alla Z. Infine, il primo versetto inizia con la parola “beato”, rivolta all’uomo che sa rimanere sul cammino dell’Alleanza. Questo ricorda subito il Vangelo delle Beatitudini, che risuona dello stesso termine “beato”: Gesù usa qui una parola molto comune nella Bibbia, ma che purtroppo la nostra traduzione italiana non rende completamente. Nel suo commento ai Salmi, André Chouraqui osservava che la radice ebraica di questa parola (beato l’uomo Ashrê hā’îsh) ha come significato fondamentale il cammino, il passo dell’uomo sulla strada senza ostacoli che conduce al Signore. Si tratta quindi “meno della felicità che del cammino che ad essa conduce”. Per questo lo stesso Chouraqui traduceva “Beato” con “In cammino”, sottointeso: siete sulla buona strada, continuate. Generalmente, nella Bibbia, la parola “beato” non va da sola: è contrapposta al suo opposto “infelice” ( benedetto si dice barùk e maledetto ‘arūr). L’idea generale è che nella vita ci sono percorsi falsi da evitare; alcune scelte o comportamenti conducono al bene, altri, contrari, portano solo infelicità. E se leggiamo tutto il salmo, ci accorgiamo che è costruito in questo modo. Anche il Salmo 1, più conosciuto, è strutturato allo stesso modo: prima descrive i buoni percorsi, il cammino verso la felicità, e solo brevemente i cattivi, perché non vale la pena soffermarsi Qui, la buona scelta è indicata già nel primo verso: “Beato l’uomo che teme il Signore!”. Ritroviamo questa espressione frequente nell’Antico Testamento: la “paura di Dio”. Purtroppo, nella lettura liturgica, manca la seconda parte del verso; ve la leggo intera: “Beato l’uomo che teme il Signore, che ama con tutto sé stesso la sua volontà.” Ecco dunque una definizione di “timore di Dio”: è l’amore della sua volontà, perché si agisce in fiducia. La paura del Signore non è paura in senso negativo: infatti, poco più avanti, un altro verso lo precisa bene: L’uomo retto… confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore” (vv7-8). Il “timore di Dio” nel senso biblico è insieme consapevolezza della santità di Dio, riconoscimento di tutto ciò che Egli fa per l’uomo e, poiché è il nostro Creatore, attenzione a obbedirgli: solo Lui sa cosa è bene per noi. È un atteggiamento filiale di rispetto e obbedienza fiduciosa. Israele scopre così due verità: Dio è il Tutto-Altro, ma si fa anche Tutto-Vicino. È infinitamente potente, ma questa potenza è quella dell’amore. Non abbiamo nulla da temere, perché Egli può e vuole la nostra felicità! Nel Salmo 102/103 leggiamo: “Come la tenerezza del padre verso i figli, così la tenerezza del Signore verso chi lo teme.” Temere il Signore significa avere verso di Lui un atteggiamento rispettoso e fiducioso. Significa anche “appoggiarsi a Lui”. Ecco la giusta attitudine verso Dio, quella che mette l’uomo sulla buona strada: “Beato l’uomo che teme il Signore!” Ed ecco anche la giusta attitudine verso gli altri: “L’uomo retto, misericordioso , pietoso e giusto…egli dona largamente ai poveri”(vv4,8). Il salmo precedente (110/111), molto simile a questo, usa le stesse parole “giustizia, tenerezza e misericordia” per Dio e per l’uomo. L’osservanza quotidiana della Legge, nella vita di tutti i giorni, dalla A alla Z, come simboleggia l’alfabeto del salmo, ci plasma alla somiglianza di Dio. Ho detto somiglianza, perché il salmista ricorda che il Signore resta il Tutto-Altro: le formule non sono identiche. Per Dio si dice che Egli È giustizia, tenerezza e misericordia, mentre per l’uomo il salmista dice “è uomo di giustizia, di tenerezza, di misericordia”, cioè sono virtù che pratica, non il suo essere intrinseco. Queste virtù vengono da Dio e l’uomo le riflette in qualche modo. E poiché la sua azione è a immagine di Dio, l’uomo retto diventa luce per gli altri:”spunta nelle tenebre, luce per gli uomini retti”(v.4). Qui si sente un eco della prima lettura tratta dal profeta Isaia: “Condividere il pane con l’affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, , vestire c chi è nudo… allora la tua luce sorgerà come l’aurora.”(58,7). Quando doniamo e condividiamo, siamo più a immagine di Dio, che è dono puro. A nostra misura, riflettiamo la sua luce.
*Seconda Lettura dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinti (2,1-5)
San Paolo, come spesso, procede per contrasti: la prima opposizione è che il mistero di Dio è completamente diverso dalla sapienza degli uomini; la seconda opposizione riguarda il linguaggio dell’apostolo che annuncia il mistero, molto diverso dal bel parlare umano, dall’eloquenza. Riprendiamo queste due opposizioni: mistero di Dio / sapienza umana; linguaggio del cristiano / eloquenza o arte oratoria. Prima opposizione: mistero di Dio o sapienza umana. Paolo dice di essere venuto “per annunciare il mistero di Dio”; per mistero va inteso il “disegno misericordioso” di Dio , che sarà sviluppato più tardi nella Lettera agli Efesini (Ef 1,3-14): questo disegno è di fare dell’umanità una comunione perfetta di amore attorno a Gesù Cristo, fondata sui valori dell’amore, del servizio reciproco, del dono e del perdono. Gesù lo mette già in pratica lungo tutta la sua vita terrena. Siamo quindi lontanissimi dall’idea di un Dio potente in senso militare, come talvolta alcuni immaginano. Questo mistero di Dio si realizza tramite un “Messia crocifisso”, del tutto contrario alla logica umana, quasi un paradosso. Paolo afferma che Gesù di Nazareth è il Messia, ma non come lo si aspettava: non lo si attendeva crocifisso; secondo la nostra logica, la crocifissione sembrava provare il contrario, perché tutti ricordavano una famosa frase del Deuteronomio: chi era condannato a morte per la legge era considerato maledetto da Dio (Dt 21,22-23). Eppure, questo disegno del Dio onnipotente è nulla meno che Gesù Cristo, come dice Paolo. Nel testimoniare la sua fede, Paolo non ha nulla da annunciare se non Gesù Cristo: Egli è il centro della storia umana, del progetto di Dio e della sua fede. Non vuole sapere nulla di altro: “Ritenni infatti di non sapere altro.. che Gesù Cristo”. Dietro questa frase si intravedono le difficoltà di resistere alle pressioni, agli insulti e alle persecuzioni già presenti. Questo Messia crocifisso ci mostra la vera sapienza, la sapienza di Dio: dono e perdono, rifiuto della violenza… tutto il messaggio del Vangelo delle Beatitudini. Di fronte a questa sapienza divina, la sapienza umana è ragionamento, persuasione, forza e potenza; questa sapienza non può comprendere il messaggio del Vangelo. Infatti, Paolo ha sperimentato un fallimento ad Atene, il centro della filosofia (At17,16-34). Seconda opposizione: linguaggio del predicatore o arte oratoria. Paolo non ha alcuna pretesa di eloquenza: questo già ci rassicura, se non siamo abili oratori. Ma va oltre: per lui l’eloquenza, l’arte oratoria, la capacità di persuadere sono addirittura un ostacolo, incompatibili con il messaggio del Vangelo. Annunciare il Vangelo non significa sfoggiare conoscenza né imporre argomenti. Interessante notare che nella parola “convincere” c’è “vincere”: forse non siamo al posto giusto se pensiamo di annunciare la religione dell’Amore. La fede, come l’amore, non si persuade… Provate a convincere qualcuno ad amarvi: l’amore non si dimostra, non si ragiona. Lo stesso vale per il mistero di Dio: lo si può solo penetrare gradualmente. Il mistero di un Messia povero, Messia-Servitore, Messia crocifisso, non può essere annunciato con mezzi di potenza: sarebbe il contrario del mistero stesso! È nella povertà che il Vangelo si annuncia: questo ci dovrebbe dare coraggio! Il Messia povero può essere annunciato solo con mezzi poveri; il Messia servo solo da servi. Non ti preoccupare se non sei un grande oratore: la nostra povertà di linguaggio è l’unica compatibile con il Vangelo. Paolo va oltre e dice addirittura che la nostra povertà è condizione necessaria della predicazione: essa lascia spazio all’azione di Dio. Non è Paolo a convincere i Corinzi, ma lo Spirito di Dio, che conferisce alla predicazione la forza della verità, facendo scoprire Cristo. Ne consegue che non è la forza del nostro ragionamento a convincere: la fede non si fonda sulla sapienza umana, ma sulla potenza dello Spirito di Dio. Noi possiamo solo prestargli la nostra voce. Ovviamente come per Paolo, ciò richiede un atto di fede enorme: È nella mia debolezza, tremante e timoroso, che sono venuto da voi. Il mio linguaggio, la mia predicazione non avevano nulla a che fare con la sapienza che convince; ma si manifestavano lo Spirito e la sua potenza, affinché la vostra fede non si fondasse sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Quando sembra che il cerchio dei credenti si restringa, quando sogneremmo strumenti mediatici, elettronici o finanziari potenti, ci fa bene sentire che l’annuncio del Vangelo si adatta meglio ai mezzi poveri. Ma per accettarlo bisogna ammettere che lo Spirito Santo è il miglior predicatore, e che la testimonianza della nostra povertà è la predicazione migliore.
*Dal Vangelo secondo Matteo (5, 13 -16)
Se una lampada è bella è meglio, ma non è la cosa più importante! Ciò che si chiede prima di tutto è che illumini perché se non illumina bene non si vede nulla. Quanto al sale, la sua vocazione è scomparire svolgendo il suo compito: se manca, il piatto sarà meno buono. A ben vedere sale e luce non esistono per sé stessi. Gesù dice ai discepoli: “Voi siete il sale della terra… Voi siete la luce del mondo”: ciò che conta è la terra, il mondo; il sale e la luce contano solo in rapporto alla terra e al mondo! Dicendo ai discepoli che sono sale e luce, Gesù li mette in situazione missionaria: Voi che ricevete le mie parole, diventate per questo stesso motivo sale e luce per il mondo: la vostra presenza è indispensabile. In altre parole, la Chiesa esiste solo per evangelizzare il mondo. Questo ci rimette al nostro posto! Già la Bibbia ricordava al popolo di Israele che era il popolo eletto, ma al servizio del mondo; questa lezione vale anche per noi. Tornando a sale e luce: ci si può chiedere qual è il punto in comune tra questi due elementi a cui Gesù paragona i discepoli. Possiamo rispondere che entrambi sono rivelatori: il sale esalta il sapore del cibo, la luce rivela la bellezza delle persone e del mondo. Il cibo esiste prima di ricevere il sale; il mondo e gli esseri esistono prima di essere illuminati. Ci dice molto sulla missione che Gesù affida ai suoi discepoli, a noi: nessuno ha bisogno di noi per esistere, ma abbiamo un ruolo specifico da svolgere. Sale della terra: siamo qui per rivelare agli uomini il sapore della loro vita. Gli uomini non ci aspettano per compiere gesti d’amore e di condivisione, talvolta meravigliosi. Evangelizzare significa dire che il Regno è in mezzo a voi, in ogni gesto, in ogni parola d’amore e “dove c’è amore, lì c’è Dio.” Luce del mondo: siamo qui per valorizzare la bellezza di questo mondo. È lo sguardo d’amore che rivela il vero volto delle persone e delle cose. Lo Spirito Santo ci è stato dato proprio per entrare in sintonia con ogni gesto o parola che viene da Lui. Ma questo può avvenire solo con discrezione e umiltà. Troppo sale rovina il gusto del cibo; una luce troppo forte schiaccia ciò che vuole illuminare. Per essere sale e luce, bisogna amare molto, amare davvero. I testi di oggi ce lo ripetono in modi diversi ma coerenti. L’evangelizzazione non è una conquista; la Nuova Evangelizzazione non è una riconquista. L’annuncio del Vangelo avviene solo nella presenza d’amore. Ricordiamo l’avvertimento di Paolo ai Corinzi nella seconda lettura: solo i poveri e gli umili possono predicare il Regno. Questa presenza d’amore può essere molto esigente, come mostra la prima lettura: il collegamento tra Isaia e il Vangelo è molto significativo. Essere luce del mondo significa mettersi al servizio dei fratelli; Isaia è concreto: condividere pane o vestiti, abbattere tutti gli ostacoli che impediscono la libertà degli uomini. Anche il Salmo di questa domenica dice lo stesso: “l’uomo retto”, cioè colui che condivide generosamente le sue ricchezze, è luce per gli altri. Attraverso le sue parole e i suoi gesti d’amore, gli altri scopriranno la fonte di ogni amore: come dice Gesù. Vedendo ciò che i discepoli fanno di bene, gli uomini renderanno gloria al Padre che è nei cieli, cioè scopriranno che il progetto di Dio per l’umanità è un progetto di pace e giustizia. Al contrario, come potranno gli uomini credere al progetto d’amore di Dio se noi, suoi ambasciatori, non moltiplichiamo i gesti di solidarietà e giustizia che la società richiede? Il sale è sempre in pericolo di perdere sapore: è facile dimenticare le parole forti del profeta Isaia, ascoltate nella prima lettura; e non è un caso se la liturgia ce le propone poco prima dell’inizio della Quaresima, tempo in cui rifletteremo su quale digiuno Dio preferisca. Ultima osservazione: il Vangelo di oggi (sale e luce) segue immediatamente la proclamazione delle Beatitudini in Matteo di domenica scorsa. Vi è quindi un legame tra i due passi, che possono illuminarsi a vicenda. Forse il modo migliore di essere sale e luce è vivere secondo lo spirito delle Beatitudini, cioè all’opposto dello spirito del mondo: accettare umiltà, dolcezza, purezza, giustizia; essere artigiani di pace in ogni circostanza; e, soprattutto, accettare la povertà e la mancanza, con un solo obiettivo: “perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre nostro che. è nei cieli”. Complementi: Secondo il documento del Concilio Vaticano II sulla Chiesa “Lumen Gentium”, la vera luce del mondo non siamo noi, è Gesù Cristo. Dicendo ai discepoli che sono luce, Gesù rivela che è Dio stesso a brillare attraverso di loro, perché nella Scrittura, come nel Concilio, è sempre chiarito che tutta la luce viene da Dio.
+Giovanni D’Ercole
L’origine del male non è in una causa esteriore
Purezza, impudicizie e santità travisate
(Mc 7,14-23)
Il Signore è per una umanizzazione a tutto campo. Ma nelle culture antiche la visione mitica del mondo portava la gente ad apprezzare qualsiasi realtà partendo dalla categoria della ‘santità’ come ‘distacco’.
Le leggi sulla purezza indicavano le condizioni necessarie per mettersi davanti a Dio e sentirsi bene alla sua presenza - ma di fatto sempre sgomenti, perché [ovvio] non totalmente ottemperanti.
All’epoca di Mc alcuni giudei convertiti ritenevano di poter abbandonare gli antichi costumi e avvicinarsi ai pagani; altri erano di opinione opposta: sarebbe stato come rigettare parti consistenti della Torah.
Infatti l’evangelista sottolinea che il problema è «in Casa» (v.17) ossia nella Chiesa. Fraternità dove ancora non si capiva il Maestro, venuto per liberare da ossessioni artificiose.
Cristo deve insistere nel suo insegnamento, ora non rivolto a degli estranei ma proprio ai discepoli [appunto] incapaci di «comprendere» (vv.14.18).
In tal guisa, il Vangelo rigetta la distinzione tra la sfera religiosa della vita e un assetto quotidiano “contaminato”; fonte di corruzione. Ma normale, spicciolo, sommario - per questo valutato distante dal ‘divino’.
Quintessenza che viceversa non intende soggiogare nessuno.
La presenza attiva di un Ordine nuovo abolisce le prescrizioni legali e sposta il centro della moralità dei nostri atti.
Qui si richiama l’insegnamento di Gesù: l’impurità non viene dall’esterno [ossia da fuori a dentro]. Non è quella la minaccia.
Le realtà del mondo non sono mai scellerate e inadatte - neanche al culto.
Diventano obbrobrio solo passando attraverso decisioni queste sì sacrileghe, perché bloccano la vita. E distacchi che imbarbariscono.
Non vi è sacro e profano in sé.
Mistero e Beatitudine vengono al mondo esclusivamente attraverso il canale del dialogo e dell’incontro nel rispetto dell’intelligenza, dell’anima personale, e delle culture difformi. Non percorrendo entità di meriti, né strettoie travisate.
Qui il legalismo formale uccide il dilatarsi della vita e degli ideali: “impuro” è ciò che avvelena l'esistenza e la realizzazione spontanea delle persone, le loro relazioni, e la creazione stessa.
Gesù libera la folla dei senza voce e smarriti dall’ossessione di tormenti e timori, dallo stare sempre sulla difensiva.
Siamo chiamati a voler bene ai limiti: sono il terreno di energie preparatorie della reale fioritura - impulsi e segni del nostro ‘compito nel mondo’ secondo la Novità di Dio.
Ogni Esodo valorizza le alternative.
E troviamo la realizzazione, il senso della vita, nonché via via maggiore completezza, incontrando appunto i nostri lati opposti.
Non siamo chiamati a fissarci in una direzione. Ce ne sono altre.
Chiunque intimorisce il fratello “inadeguato” minaccia la vita del cosmo e rende sfiduciate proprio le persone più sensibili e attente.
Sono le imperfezioni a renderci nuovi, eccezionali, unici!
Impariamo dunque a non provare sgomento per il fatto che ‘non siamo’ religiosamente “riusciti” - bensì Primizia!
[Mercoledì 5.a sett. T.O. 11 febbraio 2026]
L’origine del male non è in una causa esteriore
Purezza, impudicizie e santità travisate
(Mc 7,14-23)
La Chiesa ha conservato la fede nella bontà del creato; non vede di malocchio la natura, la società, e l’opera concreta del Padre, come purtroppo si propugna in certe mentalità schizzinose (in chiave devota).
Neppure ritiene che per sentirsi salvi esistano strumenti o zone di rifugio che basterebbe usare, fruire o raggiungere, e rifrequentare. Il Signore è per una umanizzazione a tutto campo.
Nelle culture antiche la visione religiosa e mitica del mondo portava la gente ad apprezzare qualsiasi realtà partendo dalla categoria della santità come distacco e separatezza - persino inaccessibilità.
Le leggi sulla purezza indicavano le condizioni necessarie per mettersi davanti a Dio e sentirsi bene alla sua presenza - ma di fatto sempre sgomenti, perché (ovvio) non totalmente ottemperanti.
Non ci si poteva presentare nel punto in cui la persona era, o in qualsiasi occasione e modo - bensì secondo norme legate al cibo, al contatto, al vestito, ai tempi raccomandati di preghiera; così via.
Nel contesto della dominazione achemenide, per valorizzare l’identità, ricostruire il Tempio di Gerusalemme e mantenere la propria classe, i sacerdoti accentuarono le norme di purità e gli obblighi sacrificali, manipolando più volte il senso, i contesti, e le postille della Scrittura.
Ovviamente, parte consistente delle offerte così gonfiate rimanevano al ceto che si occupava dei riti.
Tutto ciò, a spese d’una concezione appiattita sullo stile cultuale propiziatorio e (supposto) taumaturgico, il quale investiva ogni aspetto della vita ordinaria della gente.
Moltitudine resa schiava dalla visione imposta - in sé infantile - algida forse, ma paludosa e irritante.
All’epoca di Mc alcuni giudei convertiti ritenevano di poter abbandonare gli antichi costumi e avvicinarsi ai pagani; altri erano di opinione opposta: sarebbe stato come rigettare parti consistenti della Torah [es: Lv 11-16 e 17ss].
Infatti Mc sottolinea che il problema è «in Casa» (v.17 testo greco: dentro casa) ossia nella Chiesa e fra i suoi intimi [la traduzione CEI recita in “una” casa].
Un posto dove paradossalmente ancora non si capisce il Maestro [!] venuto per liberarci dalle ossessioni inventate e artificiose.
Cristo deve insistere nel suo insegnamento, ora non rivolto a degli estranei, ma proprio agli habitué, incapaci - al contrario delle folle - di «comprendere» (v.14) perfino i rudimenti delle cose spirituali.
Per educare i testardi ancora «privi d’intelletto» (v.18) che si ritengono maestri, non si dirige in una dimora qualsiasi, ma esattamente nel posto dove purtroppo si coltivano aspettative talora ben lontane dal popolo (vv.14.17).
L’evangelista rigetta la distinzione tra la sfera religiosa della vita e un assetto quotidiano “contaminato”; fonte di corruzione. Ma normale, spicciolo, sommario - per questo valutato distante dal “divino”.
Quintessenza che viceversa non intende soggiogare nessuno.
Le prescrizioni restano insufficienti a darci accesso a Dio: esse non sono che simboli, traiettorie, e immagini.
La presenza attiva di un Ordine nuovo abolisce le prescrizioni legali, e sposta il centro della moralità dei nostri atti.
Qui si richiama l’insegnamento di Gesù: l’impurità non viene dall’esterno [ossia da fuori a dentro].
Non è quella la minaccia per la vita della donna, dell’uomo, e della comunità, secondo il disegno senza trucchi di Dio.
Le realtà del mondo non sono mai scellerate e inadatte - neanche al culto.
Diventano obbrobrio solo passando attraverso decisioni queste sì sacrileghe, perché bloccano la vita. E distacchi che imbarbariscono.
La canonicità del bigotto e talare non c’entra nulla con la divinizzazione, la quale viceversa fa rima con ciò che è concretamente umanizzante.
Il dibattito sul puro e impuro non va collocato sul piano delle cose [ad es. dei cibi che vanno fino allo stomaco] bensì del comportamento, che parte e va fino al cuore. Luogo non sempre sereno e ben “ordinato”.
Non vi sono apriorismi sacri: non basta che un luogo, una casa, degli oggetti, una persona... siano stati legittimati da cerimonie o addirittura scambi, perché diventino intoccabili, onesti ed eminenti.
In tal guisa, non vi è sacro e profano in sé.
Mistero e Beatitudine vengono al mondo esclusivamente attraverso il canale del dialogo e dell’incontro nel rispetto dell’intelligenza, dell’anima personale, e delle culture difformi. Non percorrendo entità di meriti, né strettoie travisate.
La santificazione è legata alla condotta. E nei casi di coerenza, persino all’insuccesso, all’angoscia, alle frustrazioni, che derivano da scelte di campo impegnative.
Sono decisioni le quali mettono a repentaglio, e talora ci ridicolizzano nel paragone con il costume delle autenticazioni obbligate - ove talora sembra che sia necessario eludere la vita. O non sei “nessuno”.
Qui il legalismo formale purtroppo uccide qualsivoglia dilatarsi delle risorse e degli ideali.
Insomma, impuro è ciò che avvelena l'esistenza e la realizzazione spontanea delle persone, le loro relazioni, e la creazione stessa.
Eppure sono le imperfezioni a renderci nuovi, eccezionali, unici!
Gesù apre una nuova Via per far avvicinare tutti noi malfermi a Dio, agli altri persino lontani, e a se stessi - senza esclusioni puritane.
Quando ad es. non ci accettiamo così come siamo - dentro, o in campo, non accogliendo il diverso e l’opposto - perché nell’opinione comune “non va bene”, rischiamo di trasformare l’insoddisfazione in un clima d’intimo assillo.
Perfino il religioso senso d’impurezza ci porterà dall’agitazione al disastro.
Ma fuori dall’impegno per l’amicizia con noi stessi, con le cose create, e lo spirito di fraternità, di convivialità dei contrari, la paura di contaminarsi è infondata.
Anzi, siamo chiamati a voler bene ai limiti: sono il terreno anche scomposto e impudico di energie preparatorie della reale fioritura.
Sono impulsi e segni primordiali del nostro compito nel mondo secondo la Novità di Dio.
Ogni Esodo valorizza le alternative.
E troviamo la realizzazione, il senso della vita, nonché via via maggiore completezza, incontrando appunto i nostri lati opposti.
Chiunque intimorisce il fratello “inadeguato” minaccia la vita del cosmo e rende sfiduciate proprio le persone più sensibili e attente.
Gesù libera la folla dei senza voce, degli smarriti, dall’ossessione di apprensioni e timori, dallo stare sempre sulla difensiva.
Non siamo chiamati a fissarci in una direzione. Ce ne sono altre.
Impariamo dunque a non provare sgomento per il fatto che non siamo religiosamente “riusciti” - bensì Primizia!
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Cosa ritieni ti renda presentabile in società? In che senso sei impeccabile - perché imbellettato e conforme all’opinione?
Essere “figlio” e “primizia” ti fa stare sulla difensiva o restituisce voglia di vivere in pienezza?
L’ingiustizia non ha radici esclusivamente esterne
L’evangelista Marco riporta le seguenti parole di Gesù, che si inseriscono nel dibattito di allora circa ciò che è puro e ciò che è impuro: “Non c'è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a renderlo impuro... Ciò che esce dall’uomo è quello che rende impuro l’uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male” (Mc 7,14-15.20-21). Al di là della questione immediata relativa al cibo, possiamo scorgere nella reazione dei farisei una tentazione permanente dell’uomo: quella di individuare l’origine del male in una causa esteriore. Molte delle moderne ideologie hanno, a ben vedere, questo presupposto: poiché l’ingiustizia viene “da fuori”, affinché regni la giustizia è sufficiente rimuovere le cause esteriori che ne impediscono l’attuazione. Questo modo di pensare - ammonisce Gesù - è ingenuo e miope. L’ingiustizia, frutto del male, non ha radici esclusivamente esterne; ha origine nel cuore umano, dove si trovano i germi di una misteriosa connivenza col male. Lo riconosce amaramente il Salmista: “Ecco, nella colpa io sono nato, nel peccato mi ha concepito mia madre” (Sal 51,7). Sì, l’uomo è reso fragile da una spinta profonda, che lo mortifica nella capacità di entrare in comunione con l’altro. Aperto per natura al libero flusso della condivisione, avverte dentro di sé una strana forza di gravità che lo porta a ripiegarsi su se stesso, ad affermarsi sopra e contro gli altri: è l’egoismo, conseguenza della colpa originale. Adamo ed Eva, sedotti dalla menzogna di Satana, afferrando il misterioso frutto contro il comando divino, hanno sostituito alla logica del confidare nell’Amore quella del sospetto e della competizione; alla logica del ricevere, dell’attendere fiducioso dall’Altro, quella ansiosa dell’afferrare e del fare da sé (cfr Gen 3,1-6), sperimentando come risultato un senso di inquietudine e di incertezza. Come può l’uomo liberarsi da questa spinta egoistica e aprirsi all’amore?
[Papa Benedetto, Messaggio per la Quaresima 2010]
Nuovo significato di Purezza
Tradizione anticotestamentaria e nuovo significato di “purezza”
1. Un indispensabile completamento delle parole pronunziate da Cristo nel Discorso della montagna sulle quali abbiamo centrato il ciclo delle nostre presenti riflessioni, dovrà essere l’analisi della purezza. Quando Cristo, spiegando il giusto significato del comandamento "Non commettere adulterio", fece richiamo all’uomo interiore, specificò al tempo stesso la dimensione fondamentale della purezza, con cui vanno contrassegnati i reciproci rapporti tra l’uomo e la donna nel matrimonio e fuori del matrimonio. Le parole: "Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore" (Mt 5,27-28) esprimono ciò che contrasta con la purezza. Ad un tempo, queste parole esigono la purezza che nel Discorso della montagna è compresa nell’enunciato delle beatitudini: "Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio" (Mt 5,8). In tal modo Cristo rivolge al cuore umano un appello: lo invita, non lo accusa, come già abbiamo precedentemente chiarito.
2. Cristo vede nel cuore, nell’intimo dell’uomo la sorgente della purezza - ma anche dell’impurità morale - nel significato fondamentale e più generico della parola. Ciò è confermato, ad esempio, dalla risposta data ai farisei, scandalizzati per il fatto che i suoi discepoli "trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono cibo" (Mt 15,2). Gesù disse allora ai presenti: "Non quello che entra nella bocca rende impuro l’uomo, ma quello che esce dalla bocca rende impuro l’uomo" (Mt 15,11). Ai suoi discepoli, invece, rispondendo alla domanda di Pietro, così spiegò queste parole: "...ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l’uomo. Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l’uomo, ma il mangiare senza lavarsi le mani non rende immondo l’uomo" (cf. Mt 15,18-20; cf. Mc 7,20-23).
Quando diciamo "purezza", "puro", nel significato primo di questi termini, indichiamo ciò che contrasta con lo sporco. "Sporcare" significa "rendete immondo", "inquinare". Ciò si riferisce ai diversi ambiti del mondo fisico. Si parla, ad esempio, di una "strada sporca", di una "stanza sporca", si parla anche dell’"aria inquinata". È così pure, anche l’uomo può essere "immondo", quando il suo corpo non è pulito. Per togliere le lordure del corpo, bisogna lavarlo. Nella tradizione dell’Antico Testamento si attribuiva una grande importanza alle abluzioni rituali, ad esempio il lavarsi le mani prima di mangiare, di cui parla il testo citato. Numerose e particolareggiate prescrizioni riguardavano le abluzioni del corpo in rapporto all’impurità sessuale, intesa in senso esclusivamente fisiologico, a cui abbiamo accennato in precedenza (cf. Lv 15 ). Secondo lo stato della scienza medica del tempo, le varie abluzioni potevano corrispondere a prescrizioni igieniche. In quanto erano imposte in nome di Dio e contenute nei Libri Sacri della legislazione anticotestamentaria, l’osservanza di esse acquistava, indirettamente, un significato religioso; erano abluzioni rituali e, nella vita dell’uomo dell’Antica Alleanza, servivano alla "purezza" rituale.
3. In rapporto alla suddetta tradizione giuridico-religiosa dell’Antica Alleanza si è formato un modo erroneo di intendere la purezza morale(1). La si capiva spesso in modo esclusivamente esteriore e "materiale". In ogni caso, si diffuse una tendenza esplicita ad una tale interpretazione. Cristo vi si oppone in modo radicale: nulla rende l’uomo immondo "dall’esterno", nessuna sporcizia "materiale" rende l’uomo impuro in senso morale, ossia interiore. Nessuna abluzione, neppure rituale, è idonea di per sé a produrre la purezza morale. Questa ha la sua sorgente esclusiva nell’interno dell’uomo: essa proviene dal cuore. È probabile che le rispettive prescrizioni dell’Antico Testamento (quelle, ad esempio, che si trovano nel Levitico) ( Lv 15,16-24 ; 18,1ss ; 12,1-5 ) servissero, oltre che a fini igienici, anche ad attribuire una certa dimensione di interiorità a ciò che nella persona umana è corporeo e sessuale. In ogni caso Cristo si è ben guardato dal collegare la purezza in senso morale (etico) con la fisiologia e con i relativi processi organici. Alla luce delle parole di Matteo 15,18-20, sopra citate, nessuno degli aspetti dell’"immondezza" sessuale, nel senso strettamente somatico, biofisiologico, entra di per sé nella definizione della purezza o della impurità in senso morale (etico).
4. Il suddetto enunciato ( Mt 15,18-20 ) è soprattutto importante per ragioni semantiche. Parlando della purezza in senso morale, cioè della virtù della purezza, ci serviamo di un’analogia, secondo la quale il male morale viene paragonato appunto alla immondezza. Certamente tale analogia è entrata a far parte, fin dai tempi più remoti, dell’ambito dei concetti etici. Cristo la riprende e la conferma in tutta la sua estensione: "Ciò che esce dalla bocca proviene dal cuore. Questo rende immondo l’uomo". Qui Cristo parla di ogni male morale, di ogni peccato, cioè di trasgressioni dei vari comandamenti, ed enumera "i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie", senza limitarsi ad uno specifico genere di peccato. Ne deriva che il concetto di "purezza" e di "impurità" in senso morale è anzitutto un concetto generale, non specifico: per cui ogni bene morale è manifestazione di purezza, ed ogni male morale è manifestazione di impurità. L’enunciato di Matteo 15,18-20 non restringe la purezza ad un unico settore della morale, ossia a quello connesso al comandamento "Non commettere adulterio" e "Non desiderare la moglie del tuo prossimo", cioè a quello che riguarda i rapporti reciproci tra l’uomo e la donna, legati al corpo e alla relativa concupiscenza. Analogamente possiamo anche intendere la beatitudine del Discorso della montagna, rivolta agli uomini "puri di cuore", sia in senso generico, sia in quello più specifico. Soltanto gli eventuali contesti permetteranno di delimitare e di precisare tale significato.
5. Il significato più ampio e generale della purezza è presente anche nelle lettere di San Paolo, in cui gradualmente individueremo i contesti che, in modo esplicito, restringono il significato della purezza all’ambito "somatico" e "sessuale", cioè a quel significato che possiamo cogliere dalle parole pronunziate da Cristo nel Discorso della montagna sulla concupiscenza, che si esprime già nel "guardare la donna", e viene equiparata ad un "adulterio commesso nel cuore" (cf. Mt 5,27-28 ).
Non è San Paolo l’autore delle parole sulla triplice concupiscenza. Esse, come sappiamo, si trovano nella prima lettera di Giovanni. Si può, tuttavia, dire che analogamente a quella che per Giovanni ( 1Gv 2,16-17 ) è contrapposizione all’interno dell’uomo tra Dio e il mondo (tra ciò che viene "dal Padre" e ciò che viene "dal mondo") - contrapposizione che nasce nel cuore e penetra nelle azioni dell’uomo come"concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne e superbia della vita" - San Paolo rileva nel cristiano un’altra contraddizione: l’opposizione e insieme la tensione tra la "carne" e lo "Spirito" (scritto con la maiuscola, cioè lo Spirito Santo): "Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne; la carne infatti ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste" ( Gal 5,16-17 ). Ne consegue che la vita "secondo la carne" è in opposizione alla vita "secondo lo Spirito". "Quelli infatti che vivono secondo la carne, pensano alle cose della carne; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, alle cose dello Spirito" ( Rm 8,5 ).
Nelle successive analisi cercheremo di mostrare che la purezza - la purezza di cuore, di cui ha parlato Cristo nel Discorso della montagna - si realizza propriamente nella vita "secondo lo Spirito".
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 10 dicembre 1980]
Riportare la Fede al suo centro. Non trucchiamo l’anima
Il Vangelo della Liturgia di oggi mostra alcuni scribi e farisei stupiti dall’atteggiamento di Gesù. Sono scandalizzati perché i suoi discepoli prendono cibo senza compiere prima le tradizionali abluzioni rituali. Pensano tra sé: “Questo modo di fare è contrario alla pratica religiosa” (cfr Mc 7,2-5).
Anche noi potremmo chiederci: perché Gesù e i suoi discepoli trascurano queste tradizioni? In fondo non sono cose cattive, ma buone abitudini rituali, semplici lavaggi prima di prendere cibo. Perché Gesù non ci bada? Perché per Lui è importante riportare la fede al suo centro. Nel Vangelo lo vediamo continuamente: questo riportare la fede al centro. Ed evitare un rischio, che vale per quegli scribi come per noi: osservare formalità esterne mettendo in secondo piano il cuore della fede. Anche noi tante volte ci “trucchiamo” l’anima. La formalità esterna e non il cuore della fede: questo è un rischio. È il rischio di una religiosità dell’apparenza: apparire per bene fuori, trascurando di purificare il cuore. C’è sempre la tentazione di “sistemare Dio” con qualche devozione esteriore, ma Gesù non si accontenta di questo culto. Gesù non vuole esteriorità, vuole una fede che arrivi al cuore.
Infatti, subito dopo, richiama la folla per dire una grande verità: «Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro» (v. 15). Invece, è «dal di dentro, dal cuore» (v. 21) che nascono le cose cattive. Queste parole sono rivoluzionarie, perché nella mentalità di allora si pensava che certi cibi o contatti esterni rendessero impuri. Gesù ribalta la prospettiva: non fa male quello che viene da fuori, ma quello che nasce da dentro.
Cari fratelli e sorelle, questo riguarda anche noi. Spesso pensiamo che il male provenga soprattutto da fuori: dai comportamenti altrui, da chi pensa male di noi, dalla società. Quante volte incolpiamo gli altri, la società, il mondo, per tutto quello che ci accade! È sempre colpa degli “altri”: è colpa della gente, di chi governa, della sfortuna, e così via. Sembra che i problemi arrivino sempre da fuori. E passiamo il tempo a distribuire colpe; ma passare il tempo a incolpare gli altri è perdere tempo. Si diventa arrabbiati, acidi e si tiene Dio lontano dal cuore. Come quelle persone del Vangelo, che si lamentano, si scandalizzano, fanno polemica e non accolgono Gesù. Non si può essere veramente religiosi nella lamentela: la lamentela avvelena, ti porta alla rabbia, al risentimento e alla tristezza, quella del cuore, che chiude le porte a Dio.
Chiediamo oggi al Signore che ci liberi dal colpevolizzare gli altri – come i bambini: “No, io non sono stato! È l’altro, è l’altro…” –. Domandiamo nella preghiera la grazia di non sprecare tempo a inquinare il mondo di lamentele, perché questo non è cristiano. Gesù ci invita piuttosto a guardare la vita e il mondo a partire dal nostro cuore. Se ci guardiamo dentro, troveremo quasi tutto quello che detestiamo fuori. E se, con sincerità, chiederemo a Dio di purificarci il cuore, allora sì che cominceremo a rendere più pulito il mondo. Perché c’è un modo infallibile per vincere il male: iniziare a sconfiggerlo dentro di sé. I primi Padri della Chiesa, i monaci, quando si domandava loro: “Qual è la strada della santità? Come devo incominciare?”, il primo passo, dicevano, era accusare sé stessi: accusa te stesso. L’accusa di noi stessi. Quanti di noi, nella giornata, in un momento della giornata o in un momento della settimana, sono capaci di accusare sé stessi dentro? “Sì, questo mi ha fatto questo, quell’altro… quello una barbarità…”. Ma io? Io faccio lo stesso, o io lo faccio così... È una saggezza: imparare ad accusare sé stessi. Provate a farlo, vi farà bene. A me fa bene, quando riesco a farlo, ma fa bene, a tutti farà bene.
La Vergine Maria, che ha cambiato la storia attraverso la purezza del suo cuore, ci aiuti a purificare il nostro, superando anzitutto il vizio di colpevolizzare gli altri e di lamentarci di tutto.
[Papa Francesco, Angelus 29 agosto 2021]
Purezza dell’avvantaggiare, non del modello di perfezione
Tradizioni o idee ipocrite, e ordine ideale
(Mc 7,1-13)
La religiosità può ingannare l’ordine ideale; la vita di Fede lo promuove, facendo leva su una perfezione e purezza derivate dalla dimensione umana - del buon senso e dell’accorgersi.
È così che si migliora e si redime il mondo: unendosi con la Shekhinah del Padre; non arroccandosi in un fortino, come fossimo in una tana.
E l’avventura piena, oltre i confini, nello Spirito, ci fa sentire belli dentro, invece che malati da curare; anzi, capaci di dare spazio alla magia del Divino in noi stessi e nelle relazioni.
Senza mai sentirsi assediati, i ‘figli’ reagiscono spontaneamente agli accadimenti - con innumerevoli iniziative benefiche personalizzanti, estranee a qualsiasi abitudine, concatenazione, nomenclatura.
Sotto la dinastia degli Erode il senso del clan e della comunità si stavano sgretolando.
Causa problemi di sopravvivenza, le famiglie erano costrette a chiudersi in se stesse, allentare i legami, pensare a proprie necessità.
Tale chiusura era rafforzata dalla devozione dell’epoca sotto ogni aspetto. Ai vv.10-12 ne vediamo un esempio incredibile: chi dedicava la propria eredità al Tempio poteva lasciare i genitori privi d’aiuto!
Offesa e offerta: ingiustizia e comportamento normativo - strano legame, nell’apparente forma dall’accento esemplare.
L’osservanza delle norme di purità era fattore di ordinaria emarginazione per molte persone.
Proprio i miseri venivano considerati in specie ignoranti e maledetti, perché impossibilitati all’adempimento globale; di conseguenza manchevoli a ricevere la consolante benedizione promessa ad Abramo.
Uno stillicidio quotidiano che minava il significato profondo dell’esistere assieme.
In particolare, le abluzioni erano una sorta di rito durante il quale si celebrava un’appagante divaricazione tra sacro e profano - nel distacco da persone e situazioni considerate impure.
Stando fuori dalle supposte sozzure, mai nessuno dei malfermi poteva essere risollevato.
Quindi le norme non erano fonte di pace, bensì di schiavitù. Porgere una mano caritatevole sarebbe stato perfino sacrilego.
Insomma, si anteponevano inezie disumane alla stessa Legge, vanificandone lo spirito comprensivo [fraternità che avrebbe accentuato l’entusiasmo di esistere].
Calate in quel contesto, le persone abbracciavano solo percorsi che già conoscevano.
La donna e l’uomo smarrivano il senso del loro esistere poliedrico. E la vita senza i “contrari” affievoliva l’Esodo del popolo tutto.
«Bellamente annullate il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione» (Mc 7,9).
Gesù non sopporta che il mondo chiuso della religiosità conformista venga piegato e usato per annientare i rapporti.
Per questo al controllo dei farisei si oppone la libertà dei discepoli (v.2), che rifiutano di obbedire a ciò che non ha senso per la vita concreta - dove passa l’amore visibile che alimenta l’amore ideale.
Il Maestro e Signore insegna che il vero culto è Vicinanza. In tal guisa, nel solco della Parola c’è una tappa e un intero ordine nuovo, che conquista all’interiorità tutti i nessi esterni.
Autentica ‘estasi’ è la ‘purezza dell’avvantaggiare tutti’ - non l’autocompiacimento del modello di perfezione.
[Martedì 5.a sett. T.O. 10 febbraio 2026]
And this is the problem: when the People put down roots in the land and are the depository of the Law, they are tempted to place their security and joy in something that is no longer the Word of God: in possessions, in power, in other ‘gods’ that in reality are useless, they are idols. Of course, the Law of God remains but it is no longer the most important thing, the rule of life; rather, it becomes a camouflage, a cover-up, while life follows other paths, other rules, interests that are often forms of egoism, both individual and collective. Thus religion loses its authentic meaning, which is to live listening to God in order to do his will — that is the truth of our being — and thus we live well, in true freedom, and it is reduced to practising secondary customs which instead satisfy the human need to feel in God’s place. This is a serious threat to every religion which Jesus encountered in his time and which, unfortunately, is also to be found in Christianity. Jesus’ words against the scribes and Pharisees in today’s Gospel should therefore be food for thought for us as well (Pope Benedict)
Ed ecco il problema: quando il popolo si stabilisce nella terra, ed è depositario della Legge, è tentato di riporre la sua sicurezza e la sua gioia in qualcosa che non è più la Parola del Signore: nei beni, nel potere, in altre ‘divinità’ che in realtà sono vane, sono idoli. Certo, la Legge di Dio rimane, ma non è più la cosa più importante, la regola della vita; diventa piuttosto un rivestimento, una copertura, mentre la vita segue altre strade, altre regole, interessi spesso egoistici individuali e di gruppo. E così la religione smarrisce il suo senso autentico che è vivere in ascolto di Dio per fare la sua volontà - che è la verità del nostro essere - e così vivere bene, nella vera libertà, e si riduce a pratica di usanze secondarie, che soddisfano piuttosto il bisogno umano di sentirsi a posto con Dio. Ed è questo un grave rischio di ogni religione, che Gesù ha riscontrato nel suo tempo, ma che si può verificare, purtroppo, anche nella cristianità. Perciò le parole di Gesù nel Vangelo di oggi contro gli scribi e i farisei devono far pensare anche noi (Papa Benedetto)
Salt, in the cultures of the Middle East, calls to mind several values such as the Covenant, solidarity, life and wisdom. Light is the first work of God the Creator and is a source of life; the word of God is compared to light (Pope Benedict)
Il sale, nella cultura mediorientale, evoca diversi valori quali l’alleanza, la solidarietà, la vita e la sapienza. La luce è la prima opera di Dio Creatore ed è fonte della vita; la stessa Parola di Dio è paragonata alla luce (Papa Benedetto)
Even after his failure even in Nazareth (vv.1-6) - his heralds gladly confused the Servant [who was educating them] with the victorious, sighed, respected and glorious Messiah…
Ancora dopo il suo fallimento persino a Nazareth (vv.1-6) - i suoi banditori hanno ben volentieri confuso il Servo [che li stava educando] col Messia vincitore, sospirato, rispettato e glorioso…
During more than 40 years of his reign, Herod Antipas had created a class of functionaries and a system of privileged people who had in their hands the government, the tax authorities, the economy, the justice, every aspect of civil and police life, and his command covered the territory extensively…
Durante più di 40 anni di regno, Erode Antipa aveva creato una classe di funzionari e un sistema di privilegiati che avevano in pugno il governo, il fisco, l’economia, la giustizia, ogni aspetto della vita civile e di polizia, e il suo comando copriva capillarmente il territorio…
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.