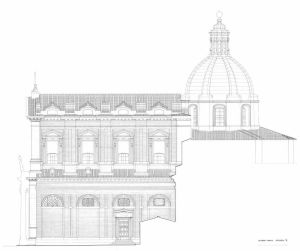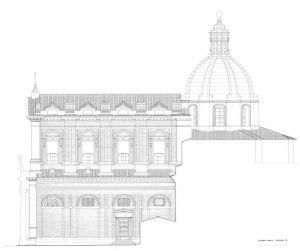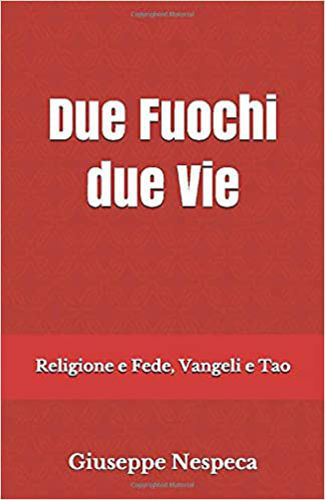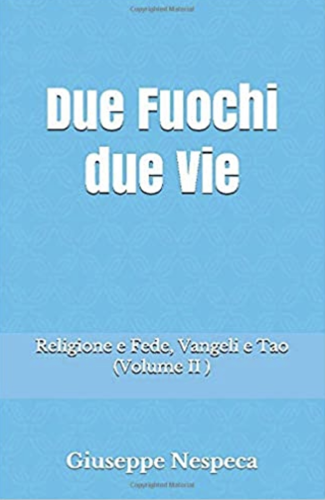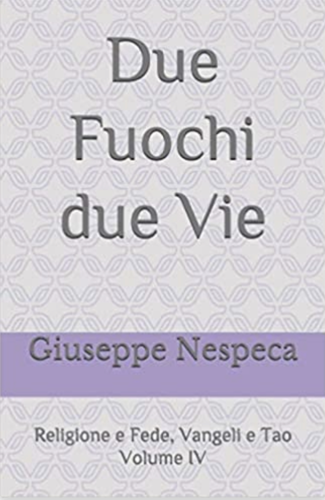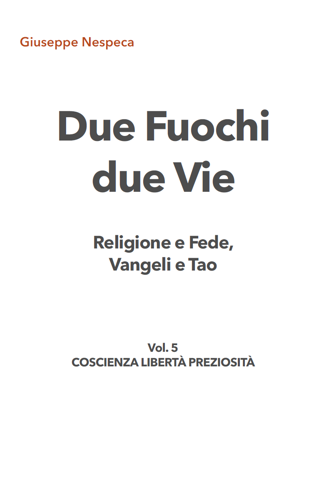don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Immacolata: Personalismo fatto salvo
OSSESSIONE E COMPULSIONE - (di Francesco Giovannozzi, psicologo e psicoterapeuta)
Ossessione e Compulsione
Un signore mi confida che da tempo ha bisogno di controllare se ha chiuso il portone della sua casa. Una signora invece deve essere certa che ha chiuso il gas in cucina.
Dopo aver controllato, sia il gas che il portone stavano bene e in ordine.
Un altro signore di mezza età sente il bisogno di dover vedere se la sua auto è a posto, poi deve andare a controllarla, deve fare un giro intorno alla stessa, toccarla in diversi punti, e solo dopo aver compiuto queste sequenze comportamentali, può rientrare tranquillamente. A volte sente il bisogno di farlo più volte in una giornata.
Nel vocabolario Treccani al termine «ossessione» si legge: «rappresentazione mentale che la volontà non riesce ad eliminare accompagnata da ansia».
Alla voce «compulsione»: «costrizione, l’essere spinto da necessità a fare qualcosa».
Molte persone hanno dei pensieri verso i quali non hanno alcun interesse; spesso sono delle idee senza alcun senso, ma che richiedono loro un notevole sforzo mentale.
Senza volerlo queste idee ci invadono, e fanno “lambiccare” il cervello come se fossero questioni fondamentali.
Possono trattarsi di pensieri, immagini che generano preoccupazione - e di solito vengono seguiti da costrizioni che la persona deve compiere per calmare l’inquietudine.
Tra l’idea ”fissa” e il bisogno di compiere qualche atto, gesto per far sì che non succeda nulla di male, insorge spesso un dubbio, che intacca le nostre convinzioni più certe .
Il tutto sfocia in una indecisione sempre più grande che limita la propria libertà di azione: per fare una scelta anche semplice si impiega tanto tempo.
A volte ci fa giungere a non saper prendere una decisione. Il dubbio può riguardare un pensiero, un ricordo, un’azione, ecc. e può sconfinare da un contenuto all’altro.
Una persona con questi problemi, uscendo di casa a volte si sente costretta a tornarci per essere certa di non aver lasciato la luce accesa, e per essere sicura a volte lo deve fare parecchie volte.
In letteratura vengono citati esempi di persone che nello spedire una lettera sentivano poi il bisogno di riaprirla per controllare ciò che avevano scritto.
In quadri psicologici come questo si parla anche di «ruminazione», che è sempre associato al dubbio.
In campo biologico essa si configura quale processo digestivo di alcuni animali, tipo i bovini. Il cibo ingerito viene riportato in bocca per essere masticato nuovamente, in maniera migliore; quindi inghiottito di nuovo per ultimare la digestione.
In campo psicologico la «ruminazione» descrive un pensiero ripetitivo e durevole focalizzato su eventi passati, diverso dal «rimuginio» che invece riguarda più gli eventi futuri.
Vengono descritti anche dei cerimoniali. In essi l’individuo deve fare una sequenza di atti come lavarsi sovente le mani, pulire tante volte oggetti della vita quotidiana.
Interviene qui un aspetto del quadro psicologico descritto: la «rupofobia» e contaminazione. La rupofobia è la paura morbosa dello sporco e di poter essere infettati. Può riguardare qualsiasi aspetto della nostra vita: sia oggetti che persone, o luoghi pubblici. È un aspetto che può nuocere anche all’intimità.
Il periodo del Covid ha aumentato la paura del contagio, ma questo era un evento reale. Anche tanti anni fa intorno agli anni 1986 ci fu il fenomeno di Chernobyl e lì veramente dovevamo essere attenti a ciò che si mangiava poiché il cibo e soprattutto le verdure potevano essere state contaminate.
Chiunque ha queste idee, passeggiando potrà contare le auto nel parcheggio, o toccare i pali dei lampioni, oppure cercare di evitare le fenditure dei pavimenti, ecc.
Nei casi gravi queste persone possono sentire di far del male a qualcuno; così questi pensieri lo fanno “indietreggiare”. Costoro devono darsi uno “scossone” onde cercare di scacciare tali idee che terrorizzano.
Le persone con queste caratteristiche generalmente sono delle persone rigorose, si preoccupano dei particolari, osservano minuziosamente regole e formalità.
Tuttavia dando importanza ai dettagli, spesso trascurano l’essenziale.
Quanta gente nel loro ambito lavorativo sente il bisogno di mettere in fila e in eccessivo ordine i loro oggetti.
Ordine e controllo sono strettamente interconnessi, perché l’ordine esterno può essere una modalità per raggiungere un ordine interno che può ridurre lo stress.
Parliamo però di ordine eccessivo. Un minimo di ordine è necessario per non creare confusione e poter ritrovare le nostre cose
Anche la balbuzie è un’alterazione del linguaggio collegata a questo quadro psicologico.
La persona che balbetta si impegna all’inizio, alla prima lettera o sillaba, e la ripete finché non finisce la parola.
Come si sa, il suo linguaggio è sciolto quando è solo o quando recita, quando canta.
Altrimenti mortificato dal suo difetto tenderà a isolarsi e a parlare il meno possibile. Oppure insisterà ostinatamente a parlare con intensi sforzi fisici.
La balbuzie «è un conflitto tra la tendenza erotico uretrale all’espulsione e la tendenza erotico-anale alla ritenzione, spostata alla bocca» (Manuale di Psichiatria, Arieti, vol. I pag.353).
Dott. Francesco Giovannozzi, Psicologo-Psicoterapeuta.
1a Domenica di Avvento (A)
Prima Domenica di Avvento (anno A) [30 Novembre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci progetta! Inizia con l’Avvento un nuovo anno liturgico (Anno A) accompagnati dall’evangelista Matteo che già c’invita a farci collaboratori del progetto di salvezza che Dio ha preordinato per la Chiesa. e il mondo. Una piccola novità: da ora offro ogni volta anche una sintesi degli elementi principali di ogni testo.
Prima Lettura dal libro del profeta Isaia (2, 1-5)
Si sa che gli autori biblici amano le immagini! Eccone due, bellissime, nella predicazione di Isaia: prima quella di una folla immensa in cammino, poi quella di tutte le armate del mondo che decidono di trasformare le armi in strumenti agricoli. Vediamo queste immagini una dopo l’altra. La folla in cammino sale su una montagna: alla fine del percorso c’è Gerusalemme e il Tempio. Isaia, invece, è già a Gerusalemme e vede arrivare questa folla, una vera e propria marea umana. È naturalmente un’immagine, un’anticipazione, probabilmente ispirata dai grandi pellegrinaggi degli Israeliti a Gerusalemme durante la festa delle Capanne (Succot). In questa occasione, per otto giorni si vive sotto capanne, anche in città, ricordando il soggiorno nel deserto durante l’Esodo. Tutte le comunità ebraiche vi affluiscono e il Deuteronomio invita a partecipare con gioia, anche con figli, servi, stranieri, orfani e vedove (Dt 16,14-15). il profeta Isaia, osservando questo straordinario raduno annuale, ne intuì uno futuro e, ispirato dallo Spirito Santo, annunciò che un giorno non solo Israele, ma tutte le nazioni parteciperanno a questo pellegrinaggio e il Tempio diventerà il luogo di raccolta di tutti i popoli, perché l’umanità intera conoscerà l’amore di Dio. Il testo intreccia Israele e le nazioni: “il monte del tempio del Signore s’innalzerà sopra i colli … e ad esso affluiranno tutte le genti”. Questa affluenza simboleggia l’ingresso delle altre nazioni nell’Alleanza. La legge uscirà da Sion e la parola del Signore da Gerusalemme: Israele è eletto da Dio, ma ha anche la responsabilità di collaborare all’inclusione delle nazioni nel progetto divino. Così l’Alleanza ha una dimensione doppia: particolare (Israele eletto) e universale (tutte le nazioni). L’ingresso delle nazioni nel Tempio non riguarda il sacrificio, ma l’ascolto della Parola di Dio e la vita secondo la sua Legge: “Venite, saliamo sul monte del Signore … perché c’insegni le sue vie e possiamo camminare peri suoi sentieri”. La seconda immagine mostra il frutto di questa obbedienza: le nazioni vivranno in pace, Dio sarà giudice e arbitro, e le armi saranno trasformate in strumenti di lavoro: Dalle loro spade forgeranno aratri, dalle loro lance falci. Non alzeranno più la spada contro un popolo. Infine Isaia invita Israele a camminare nella luce del Signore, a realizzare la propria vocazione e a guidare tutti verso la Luce: salire al Tempio significa celebrare l’Alleanza, camminare nella luce significa vivere secondo la Legge.
In sintesi ecco tutti gli elementi principali del testo:
+Due immagini simboliche di Isaia: la folla in pellegrinaggio e la trasformazione delle armi in strumenti di pace.
+Gerusalemme e il Tempio: meta del pellegrinaggio, simbolo della presenza di Dio e centro dell’Alleanza.
+Festa delle Capanne (Succot): riferimento storico al pellegrinaggio annuale degli Israeliti.
+Universalità della salvezza: Israele eletto guida tutte le nazioni, che saranno incluse nell’Alleanza.
+Dimensione dell’Alleanza: particolare (Israele) e universale (tutte le nazioni).
+Ascolto della Parola e vita secondo la Legge: la partecipazione non è solo rituale, ma impegno concreto di vita.
+Pace e trasformazione delle armi: simbolo della realizzazione del progetto divino di giustizia e concordia.
+Invito finale: Israele deve camminare nella luce del Signore e guidare l’umanità verso Dio.
+Profezia come promessa, non predizione: i profeti parlano della volontà di Dio, non del futuro in senso divinatorio.
Salmo responsoriale (121/122, 1-9)
Abbiamo qui la migliore traduzione possibile della parola ebraica “Shalom”: “Pace a chi ti ama! Che la pace regni nelle tue mura, la felicità nei tuoi palazzi…”. Quando si saluta qualcuno con questo termine, gli si augura tutto questo. Qui questo augurio è rivolto a Gerusalemme: “Chiedete pace per Gerusalemme… Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò: Sia su di te pace! Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene”. Nel nome stesso di Gerusalemme è contenuta la parola shalom; essa è, dovrebbe essere, e sarà la città della pace. Questo augurio di pace e felicità è però ancora lontano dall’essere realizzato. La storia di Gerusalemme è turbolenta: intorno al 1000 a.C. era un piccolo villaggio chiamato Jebus, abitato dai Gebusei. Davide scelse questo luogo per la capitale del suo regno: inizialmente la capitale era Ebron, e Davide era re solo della tribù di Giuda; poi, con l’adesione delle altre tribù, fu scelta Jebus, che diventò Gerusalemme, “città di Davide”. Qui Davide trasferì l’Arca dell’Alleanza e acquistò il campo di Arauna per il Tempio, seguendo la volontà di Dio. La definizione di Gerusalemme come “città santa” significa che appartiene a Dio: è il luogo dove si deve vivere secondo Dio. Con Davide e Salomone, la città raggiunge il suo splendore culturale e spirituale, e diventa centro della vita religiosa con il Tempio, meta dei pellegrinaggi tre volte l’anno, in particolare per la festa delle Capanne. Il profeta Natan ricorda a Davide che Dio è più interessato al popolo che al Tempio: “Tu vuoi costruire una casa a Dio, ma è Dio che ti costruirà una casa (discendenza)”. Così Dio promette di mantenere per sempre la discendenza di Davide, da cui verrà il Messia. Alla fine, fu Salomone a costruire il Tempio, rendendo Gerusalemme il centro cultuale. La città conoscerà poi distruzioni e ricostruzioni: la conquista di Nabucodonosor nel 587 a.C., l’Esilio a Babilonia, il ritorno autorizzato da Ciro nel 538 a.C. e la ricostruzione del Tempio di Salomone. Anche dopo le persecuzioni di Antioco Epifane e la distruzione del Tempio nel 70 d.C., Gerusalemme resta la città santa, simbolo della presenza di Dio, e la speranza della sua piena restaurazione rimane viva. I credenti, ovunque siano, continuano a rivolgersi a Gerusalemme nelle preghiere quotidiane, ricordando la fedeltà di Dio alle promesse fatte a Davide. Questo salmo 121/122, cantico dei pellegrinaggi, celebrava questa centralità di Gerusalemme, invitando i fedeli a salire verso la casa del Signore e a camminare nella luce di Dio.
Sintesi dei punti principali
+Shalom e Gerusalemme: Shalom significa pace e felicità; Gerusalemme è la città della pace.
+Storia della città: da Jebus a capitale di Davide, trasferimento dell’Arca, costruzione del Tempio.
+Città santa: appartiene a Dio; vivere a Gerusalemme significa vivere secondo Dio.
+Natan e la discendenza di Davide: Dio più interessato al popolo che al Tempio; promessa del Messia.
+Pellegrinaggi e vita religiosa: Gerusalemme centro cultuale con pellegrinaggi tre volte l’anno.
+Distruzioni e ricostruzioni: Nabucodonosor, Esilio, Ciro, persecuzioni di Antioco, distruzione del Tempio nel 70 d.C.
+Speranza e fede: Gerusalemme resta simbolo della fedeltà di Dio; i fedeli pregano orientandosi verso di essa.
+Psalmo 121/122: cantico dei pellegrinaggi, invita a salire verso la casa del Signore e camminare nella luce divina.
Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (13, 11 – 14)
In questo testo san Paolo sviluppa la classica contrapposizione fra “luce e tenebre”. “La nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti”. Questa frase resta sempre vera! Uno degli articoli della fede cattolica è che la storia non è un continuo ripetersi, ma al contrario il progetto di Dio avanza inesorabilmente. Ogni giorno possiamo dire che il disegno provvidenziale di Dio è più avanti di ieri: si sta compiendo, procede… lentamente ma con sicurezza. Dimenticare di annunciare questo significa dimenticare un punto essenziale della fede cristiana. I cristiani non hanno diritto a essere tristi, perché ogni giorno “la salvezza è più vicina”, come dice Paolo. Questo disegno provvidenziale e misericordioso di Dio ha bisogno di noi: non è tempo di dormire. Chi conosce il progetto di Dio non può rischiare di ritardarlo. Come dice la seconda lettera di Pietro: «Il Signore non tarda nel compiere la sua promessa… ma è paziente verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano alla conversione» (2 Pt 3,9). La nostra inattività, il nostro “sonno” ha conseguenze sul compiersi del progetto di Dio; lasciare dormienti le nostre capacità significa comprometterlo o almeno ritardarlo. Ecco perché i peccati di omissione sono gravi. Paolo dice: “La notte è avanzata, il giorno è vicino”; e altrove parla di un tempo breve, usando un termine marinaro: la nave ha spiegato le vele, si avvicina al porto (1 Cor 7,26.29). Può sembrare presuntuoso pensare che la nostra condotta influisca sul progetto di Dio, ma è proprio questo il valore e la gravità della nostra vita. Paolo ricorda: «Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie”. Esistono comportamenti di luce e di tenebra, quando il battezzato non vive secondo il vangelo. Paolo non dice solo ci scegliere le opere della luce, ma di rifiutare quelle delle tenebre combattendo sempre per la luce. Ciò significa due cose: Ogni giorno dobbiamo scegliere la luce, un vero combattimento, soprattutto di fronte alle sfide antropologiche, sociali, al perdono, al rifiuto dei compromessi e dei privilegi (cfr. Fil 2,12). Anche altrove san Paolo parla delle armature della giustizia, della corazza della fede e dell’amore, del casco della speranza della salvezza (cf.2 Cor 6,7; 1 Tess 5,8). Qui la veste di luce è Gesù Cristo stesso, la cui luce ci avvolge come un mantello. Nel battesimo l’immersione simboleggia la morte al peccato e il rivestirsi di Cristo (Ga 3,27). Il combattimento cristiano non è solo nostro, ma è Cristo che combatte in noi e ci promette che quando siamo perseguitati, dobbiamo non prepararci perché è lui a dirci parole e darci saggezza che nessuno potrà contrastare.
Sintesi dei punti principali
+La salvezza è sempre più vicina: la storia non è un ciclo, ma un progresso del progetto di Dio.
+I credenti non possono essere passivi: la nostra inattività ritarda il compiersi del disegno divino e i peccati di omissione sono gravi perché ogni giorno dobbiamo realizzare il progetto di Dio.
+Esistono attività di luce e di tenebra: comportamenti cristiani e non cristiani che non coincidono sempre con la fede o il battesimo.
+Il combattimento cristiano è quotidiano: scegliere la luce, il perdono, rifiutare compromessi e immoralità.
+L’immagine della veste di luce rappresenta Gesù Cristo che ci avvolge e guida la nostra vita. Il battesimo simboleggia il rivestirsi di Cristo e l’inizio del combattimento della luce.
+La forza del cristiano non è solo propria: Cristo combatte in noi, garantendo saggezza e parole contro le persecuzioni.
Dal Vangelo secondo Matteo (24, 37 – 44)
Una cosa è certa: questo testo non è stato scritto per spaventarci, ma per illuminarci. Testi come questo vengono definiti apocalittici, il che significa letteralmente che “sollevano un lembo del velo”: rivelano la realtà. E la realtà, l’unica che conta, è la venuta di Cristo. Notate il linguaggio: venire, venuta, avvento, sempre riferito a Gesù: Gesù parlava ai discepoli della sua venuta che sarà come ai tempi di Noè. Anche voi non conoscete il giorno in cui il Signore verrà perché sarà proprio all’ora in cui non pensate. Il cuore del messaggio è dunque l’annuncio che Gesù Cristo verrà. Curiosamente, Gesù parla al futuro: “Il Signore vostro verrà”. Sarebbe più logico parlare al passato perché Gesù era già venuto... Questo ci mostra che la “venuta” non è la nascita, ma qualcosa che riguarda il compimento del progetto di Dio. Molto spesso ci disturbano le immagini del giudizio, come la comparazione con il diluvio: “Due uomini saranno nel campo nei campi, uno verrà portato via e l’altro lasciato”. Questo non è un arbitrio divino, ma un invito alla fiducia: come Noè fu trovato giusto e salvato, così tutto ciò che è giusto sarà salvato. Il giudizio distingue il buono dal cattivo, il buon grano dalla zizzania, e questo avviene nel cuore di ciascuno. Gesù usa il titolo Figlio dell’Uomo per parlare di sé, ma non solo di sé come individuo: riprende la visione del profeta Daniele, in cui il “Figlio dell’Uomo” rappresenta anche il popolo dei santi, un essere collettivo. Così, la venuta di Cristo riguarda l’intera umanità. Come dice san Paolo, Cristo è la testa e noi siamo i membri; sant’Agostino parla del Cristo totale: testa nei cieli, membri sulla terra. Quando diciamo pregando che attendiamo il bene che Dio ci prometti, cioè l’avvento di Gesù Cristo, ci riferiamo a Cristo totale: l’uomo Gesù è già venuto, ma il Cristo totale è in crescita e compimento continuo. San Paolo e recentemente Teilhard de Chardin sottolineano che la creazione intera geme in attesa del compimento di Cristo, che si completa progressivamente nella storia e in ciascuno di noi. Quando Gesù invita a vegliare, è un invito a custodire il grande progetto di Dio, dedicando la nostra vita a farlo avanzare. Infine, questo discorso avviene poco prima della Passione: Gesù avverte della distruzione del Tempio, il simbolo della sua presenza e dell’Alleanza, ma non risponde a domande precise sulla fine del mondo; invita invece alla vigilanza, rassicurando i discepoli davanti alle prove.
Sintesi dei punti principali
+Scopo del testo: non spaventare, ma illuminare; rivelare la realtà della venuta di Cristo.
+Venuta di Cristo: Gesù parla al futuro perché la venuta completa riguarda Cristo totale, non solo la nascita storica di Gesù.
+Giudizio e giustizia: distinguere il buono dal cattivo avviene nel cuore di ciascuno; il giusto sarà salvato.
+Titolo Figlio dell’Uomo: indica non solo Gesù, ma il popolo dei santi, cioè l’umanità salvata. Cristo totale: Cristo come testa e i credenti come membri; il compimento è progressivo nella storia.
+Veglia e vigilanza: i discepoli sono chiamati a custodire il progetto di Dio e dedicare la loro vita al suo compimento.
+Tempio e passione: il discorso precede la Passione, annuncia la distruzione del Tempio e invita di discepoli alla fiducia nonostante le prove che dovranno subire.
+ Giovanni D’Ercole
Avvento, Venuta. Perché? e Dove
Cristo Re
Solennità di Cristo Re dell’Universo [23 Novembre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Chiudiamo con animo grato al l’Anno liturgico C preparandoci a riprendere il cammino con l’Avvento.
*Prima Lettura dal secondo libro di Samuele (5,1-3)
Questi sono i primi passi della monarchia in Israele. Tutto comincia a Ebron, antica città delle montagne di Giudea, dove riposano i patriarchi d’Israele: Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea, e persino Giuseppe, le cui ossa furono riportate dall’Egitto. È un luogo carico di memoria e di fede, e proprio qui Davide diventa re di tutte le dodici tribù d’Israele. Dopo la morte di Mosè, verso il 1200 a.C., il popolo d’Israele si stabilì in Palestina. Le tribù vivevano in modo autonomo, unite soltanto dal ricordo della liberazione dall’Egitto e dalla fede nel loro unico Dio. Nei momenti di pericolo, Dio suscitava dei capi temporanei, i Giudici, che guidavano il popolo e spesso agivano anche come profeti. Uno di questi fu Samuele, grande uomo di Dio. Col tempo, però, gli Israeliti vollero essere “come gli altri popoli” e chiesero a Samuele di avere un re. Il profeta ne fu turbato, perché Israele doveva riconoscere solo Dio come Re, ma alla fine, su comando divino, consacrò Saul, il primo re d’Israele. Dopo un inizio promettente, Saul cadde nella disobbedienza e nella follia e Dio scelse un altro uomo: Davide, il giovane pastore di Betlemme, al quale Samuele versò l’olio dell’unzione. Davide non prese subito il potere: servì Saul con fedeltà, divenne suo musicista e valoroso guerriero, amato dal popolo e legato da profonda amicizia a Gionata, il figlio di Saul. Ma la gelosia del re si trasformò in odio, e Davide fu costretto a fuggire, pur rifiutandosi sempre di alzare la mano contro “l’unto del Signore”. Dopo la morte di Saul, Israele si divise: Davide regnava a Ebron sulla tribù di Giuda, mentre al Nord un figlio di Saul regnava per breve tempo. Quando quest’ultimo fu ucciso, le tribù del Nord si radunarono a Ebron e riconobbero Davide come loro re. Quel giorno nacque il regno unito d’Israele: dodici tribù sotto un solo pastore, scelto da Dio e riconosciuto dai fratelli. L’unzione con l’olio sacro fece di Davide il “Messia”, cioè l’“unto del Signore”. Egli doveva essere un re secondo il cuore di Dio, un pastore che guida il suo popolo verso l’unità e la pace. Ma la storia mostrò quanto fosse difficile realizzare questo ideale. Tuttavia, la speranza non morì: Israele attese sempre il vero Messia, il discendente di Davide che avrebbe instaurato un regno eterno. E mille anni dopo, Gesù Cristo, chiamato “Figlio di Davide”, si presentò come il Buon Pastore, colui che offre la vita per il suo gregge. Ogni domenica, nell’Eucaristia, Egli rinnova la sua alleanza e ci dice: “Voi siete del mio stesso sangue.”
*Salmo responsoriale (121/122,1-2,3-4,5-6a.7a)
“Quale gioia quando mi dissero: Andremo alla casa del Signore” . Un pellegrino racconta la sua emozione: dopo un lungo viaggio, finalmente i suoi piedi si fermano alle porte di Gerusalemme. Siamo nel tempo del ritorno dall’esilio babilonese: la città è stata ricostruita, il Tempio restaurato (attorno al 515 a.C.), e il popolo ritrova nella casa del Signore il segno vivo dell’Alleanza. Davanti alla città risorta, il pellegrino esclama: Gerusalemme, eccoti dentro le tue mura, città ben compatta, dove tutto insieme forma un solo corpo! Gerusalemme non è solo un luogo geografico: è il cuore del popolo di Dio, simbolo della unità e della comunione. Ogni pietra, ogni muro ricorda che Israele è un popolo radunato da un’unica promessa e da un destino comune. Dio stesso ha voluto che Israele salisse ogni anno in pellegrinaggio a Gerusalemme, perché il cammino comune e la fatica condivisa mantenessero vivo il legame dell’Alleanza. Per questo il Salmo proclama:”E’ là che salgono le tribù, le tribù del Signore…per lodare il nome del Signore”. Il verbo “salire” indica sia la posizione elevata della città, sia la salita spirituale del popolo verso il suo Dio liberatore, lo stesso che li fece salire cioè uscire dall’Egitto. La formula “le tribù del Signore” richiama l’appartenenza reciproca dell’Alleanza: “Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.” Il pellegrinaggio, fatto a piedi, tra fatica, sete e canti, è un cammino di fede e di fraternità. Quando il pellegrino esclama: Ora il nostro cammino ha fine!, esprime la gioia di chi ha raggiunto non solo una meta geografica, ma anche spirituale: l’incontro con Dio nella città della sua presenza. Rendere grazie al Signore è la vocazione di Israele. Finché il mondo intero non riconoscerà Dio, Israele è chiamato a essere nel mondo il popolo dell’azione di grazie, testimone della fedeltà divina. Così ogni pellegrinaggio a Gerusalemme rinnova la missione di Israele: ringraziare, lodare e mostrare la via alle altre nazioni. Il profeta Isaia aveva preannunciato questo disegno universale:”Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti,e tutte le nazioni affluiranno ad esso…Da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.” (Is 2,2-3) Gerusalemme diventa allora segno profetico del mondo rinnovato, dove tutti i popoli saranno uniti nella stessa lode e nella stessa pace. Il Salmo ricorda ancora:”Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.” Con queste parole, Israele rievoca la promessa fatta da Dio a Davide per mezzo del profeta Natan: “Susciterò dalla tua discendenza un re, e renderò stabile il suo regno.” (2 Sam 7,12). Dopo l’esilio, non c’è più un re sul trono, ma la promessa resta viva: Dio non si smentisce. Nelle celebrazioni al Tempio, questo ricordo diventa preghiera e speranza: verrà il giorno in cui Dio susciterà un re secondo il suo cuore, giusto e fedele, che ristabilirà la pace e la giustizia. Il nome stesso di Gerusalemme significa “città della pace”. Quando si prega: «Domandate pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano!» (Sal 122,6) non si pronuncia un semplice augurio, ma una professione di fede: solo Dio può dare la pace vera, e Israele è chiamato a esserne testimone nel mondo. Con il passare dei secoli, la speranza di un re giusto trova compimento in Gesù Cristo, il Figlio di Davide. È Lui che inaugura il Regno di vita e di verità, di grazia e di santità, di giustizia, d’amore e di pace, come proclama la liturgia della festa di Cristo Re. In Lui la Gerusalemme terrena diventa Gerusalemme nuova, la città dell’incontro definitivo tra Dio e l’uomo. Ogni Eucaristia è una salita verso quella città, un pellegrinaggio dell’anima che termina nel cuore di Dio. Il pellegrinaggio di Israele verso Gerusalemme diventa allora simbolo del cammino di tutta l’umanità verso la comunione con Dio. E come i pellegrini del Salmo, anche noi, Chiesa del Nuovo Testamento, possiamo dire con gioia: “Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore”
*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (1,12-20)
Il volto invisibile di Dio. C’era una volta un mondo che cercava Dio, ma non sapeva come vederlo. Gli uomini alzavano gli occhi al cielo, costruivano templi, offrivano sacrifici, ma Dio restava invisibile, lontano. Poi, un giorno, il Verbo si fece carne: il Dio che nessuno aveva mai visto prese un volto umano, e quel volto fu quello di Gesù di Nazareth. Da allora, ogni volta che un uomo guarda Gesù, guarda Dio.San Paolo lo ha detto con parole che sembrano un canto: ”Egli è immagine del Dio invisibile, il primogenito di tutta la creazione”. In Lui, tutto ciò che esiste trova origine e senso. Non è solo il principio del mondo, ma anche il suo cuore: in Lui tutto è stato creato, e in Lui tutto è stato riconciliato. Questo piano di Dio non è nato ieri e Paolo parla di un disegno pensato da sempre: “Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel Regno del Figlio del suo amore.” Da sempre Dio ha sognato l’uomo libero, luminoso, capace di comunione. Ma ciò che Dio aveva preparato nell’eternità si è realizzato nel tempo, nel presente del Cristo. Per questo Paolo scrive: “In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.” Il mistero di Gesù non è un ricordo, è una realtà viva che ogni giorno continua a operare nel cuore dei credenti. Dio aveva fatto l’uomo “a sua immagine e somiglianza”. Ma quell’immagine, nel peccato, si era come appannata. Allora Dio stesso è venuto a mostrarci che cosa significa essere uomo. In Gesù, l’uomo è restituito alla sua bellezza originaria. Quando Pilato lo mostra alla folla e dice: “Ecco l’uomo!” non sa di pronunciare una profezia: in quel volto ferito, in quel silenzio umile, si manifesta l’uomo vero, come Dio lo aveva voluto. Ma in quel volto c’è anche il volto di Dio. Gesù è la visibilità dell’invisibile. È Dio che si lascia guardare, toccare, ascoltare. “Chi ha visto me, ha visto il Padre”, dirà a Filippo. E Paolo aggiungerà: “In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità.” In Gesù, Dio e l’uomo si incontrano per sempre. L’infinito ha preso corpo, il cielo si è fatto carne. E’ il mistero della Croce. Ma come può la Croce essere segno di pace e di riconciliazione? Paolo lo spiega così: “Dio ha voluto riconciliare a sé tutte le cose, facendo la pace per mezzo del sangue della sua croce.” Non è Dio a volere la sofferenza del Figlio. È l’odio degli uomini che lo uccide. Eppure, Dio trasforma quell’odio in amore redentore. È il grande rovesciamento della storia: la violenza si fa perdono, la morte diventa vita, la croce diventa albero di pace. Abbiamo visto nella storia uomini che hanno testimoniato la pace e sono stati uccisi per questo — Gandhi, Martin Luther King, Itzhak Rabin, Sadat… — ma solo Cristo, essendo uomo e Dio insieme, ha potuto trasformare il male in grazia per tutto il mondo. Nel suo perdono ai crocifissori — “Padre, perdonali” — si rivela il perdono stesso di Dio. Da quel giorno, sappiamo che nessun peccato è più grande dell’amore di Dio. Sulla croce, tutto è compiuto. Paolo scrive: “Dio ha voluto che in Lui abitasse tutta la pienezza, e che tutto, per mezzo di Lui, fosse riconciliato.” La creazione trova finalmente la sua unità, la sua pace. Il primo a entrare in questo Regno è il ladrone pentito: “Oggi sarai con me in paradiso”. E da allora, ogni uomo che si apre al perdono entra in quella stessa luce. L’Ecaristia è cuore del mistero Di fronte a un tale dono, la risposta possibile è una sola: rendere grazie. Per questo Paolo invita: “Rendete grazie a Dio Padre, che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.” L’Eucaristia — in greco eucharistia significa proprio “rendimento di grazie” — è il luogo dove la Chiesa rivive questo mistero. Ogni Messa è memoria viva di questa riconciliazione: Dio si dona, il mondo viene rinnovato, l’uomo ritrova se stesso. È lì che tutto si ricompone: il visibile e l’invisibile, la terra e il cielo, l’uomo e Dio. E così, nella storia del mondo, un volto ha rivelato l’invisibile. Un cuore trafitto ha portato la pace. Un pane spezzato continua a rendere presente la pienezza dell’amore. E ogni volta che la Chiesa si raduna per l’Eucaristia, il canto di Paolo si rinnova come una lode cosmica: Cristo è l’immagine del Dio invisibile, il primo e l’ultimo, colui che riconcilia il mondo con il Padre, colui nel quale tutto sussiste. In Lui, tutto trova senso. In Lui, tutto è grazia. In Lui, il Dio invisibile ha finalmente un volto: Gesù Cristo, Signore del cielo e della terra.
*Dal Vangelo secondo Luca (23, 35-43)
La logica degli uomini e la logica di Dio. Tre volte, ai piedi della croce, risuona la stessa provocazione a Gesù:”Se tu sei…” — “Se tu sei il Messia”, deridono i capi religiosi; “Se tu sei il re dei Giudei”, sogghignano i soldati romani;” Se tu sei il Messia”, lo insulta uno dei malfattori crocifissi con lui. Ognuno parla a partire dal proprio punto di vista: i capi d’Israele aspettano un Messia potente, ma davanti a loro c’è un uomo vinto e crocifisso; i soldati, uomini del potere terreno, ridono di un “re” senza difese; il malfattore, invece, attende un salvatore che lo liberi dalla morte. Queste tre voci ricordano le tre tentazioni nel deserto (Lc 4): anche allora il tentatore ripeteva: «Se tu sei Figlio di Dio…». Tentazioni di potere, di dominio e di miracolo. Gesù aveva risposto ogni volta con la Parola: “Sta scritto: l’uomo non vive di solo pane…” “Adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo renderai culto…” “Non tenterai il Signore tuo Dio”. La Scrittura era stata la sua forza per rimanere fedele alla missione del Messia povero e obbediente. Sulla croce, invece, Gesù tace. Non risponde più alle provocazioni. Eppure sa bene chi è: il Messia, il Salvatore. Ma non secondo la logica degli uomini, che vorrebbero un Dio capace di salvarsi da solo, di dominare, di vincere con la forza. Gesù muore proprio perché non corrisponde a questa logica umana. La sua logica è quella di Dio: salvare donandosi, senza imporsi. Il suo silenzio non è vuoto, ma pieno di fiducia. Il suo stesso nome, Gesù, significa: «Dio salva». Attende il suo riscatto da Dio solo, non da sé stesso. Le tentazioni sono vinte per sempre: egli rimane fedele, consegnato totalmente nelle mani degli uomini, ma confidando nel Padre. In mezzo alle offese, due parole racchiudono il mistero della Croce. La prima: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”. La seconda, rivolta al “buon ladrone”: “Oggi sarai con me in Paradiso”. Il perdono e la salvezza: due gesti divini e umani insieme. In Gesù, Dio stesso perdona e riconcilia l’umanità. Il ladrone pentito — che si rivolge a lui dicendo: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno” — è il primo a comprendere chi è veramente Cristo. Non chiede di scendere dalla croce, ma di essere accolto. In quella supplica di umiltà e fiducia, il “ricordati” diventa la preghiera che apre il Paradiso. Là dove Adamo, nel giardino dell’Eden, aveva ceduto alla tentazione di “essere come Dio”, Gesù, il nuovo Adamo, vince attendendo tutto da Dio. Adamo aveva voluto decidere da solo la propria grandezza ed era stato cacciato dal Paradiso; Gesù, invece, accettando di essere Figlio nel totale abbandono, riapre il Paradiso all’umanità. Nel racconto della Passione, si incrociano due logiche: quella degli uomini, che cercano un Dio potente, e quella di Dio, che salva attraverso l’amore e la debolezza. Gesù rifiuta la tentazione di dimostrare la propria forza; sceglie invece di fidarsi del Padre fino alla fine. Nel suo silenzio e nel suo perdono, la potenza divina si manifesta come misericordia. Accanto a lui, il ladrone pentito diventa il primo testimone del Regno: riconosce in Cristo il vero Re, non dei potenti, ma dei salvati. Dove Adamo aveva chiuso le porte del Paradiso, Gesù le riapre: “Oggi sarai con me in Paradiso” è la risposta definitiva di Dio alla logica del mondo.
+ Giovanni D’Ercole
33a Domenica T.O. (anno C)
XXXIII Domenica Tempo Ordinario C [16 Novembre 2025]
Prima Lettura dal libro del profeta Malachia (3,19-20 a)
Quando Malachia scrive queste parole, verso il 450 a.C., il popolo è scoraggiato: la fede sembra spegnersi, persino tra i sacerdoti di Gerusalemme, che ormai celebrano il culto in modo superficiale. Tutti si chiedono: “Che cosa fa Dio? Ci ha dimenticati? La vita è ingiusta! Ai malvagi tutto riesce, a che serve essere il popolo eletto e osservare i comandamenti? Dov’è la giustizia di Dio?”. Il profeta allora compie il suo compito: risvegliare la fede e le energie interiori. Rimprovera sacerdoti e laici, ma soprattutto proclama che Dio è giusto e che il suo progetto di giustizia sta avanzando irresistibilmente. “Ecco, sta per venire il giorno del Signore”: la storia non è un ciclo che si ripete, ma cammina verso un compimento. Per chi crede, questa è una verità di fede: il giorno del Signore viene. Secondo l’immagine che ciascuno ha di Dio, questa venuta può far paura o suscitare attesa ardente. Ma per chi riconosce che Dio è Padre, il giorno del Signore è una buona notizia, un giorno di amore e di luce. Malachia usa l’immagine del sole: “Ecco, viene il giorno del Signore, ardente come un forno”. Non è una minaccia! All’inizio del libro Dio dice: “Vi amo” (Ml 1,2) e “Io sono Padre” (Ml 1,6). La “il forno” non è punizione, ma simbolo dell’amore incandescente di Dio. Come i discepoli di Emmaus sentivano il cuore ardere nel petto, così chi incontra Dio è avvolto nel calore del suo amore. Il “sole di giustizia” è dunque fuoco d’amore: nel giorno dell’incontro con Dio saremo immersi in questo oceano ardente di misericordia. Dio non può che amare, soprattutto tutto ciò che è povero, nudo, senza difesa. È il senso stesso della misericordia: un cuore che si piega sulla miseria. Malachia parla anche di giudizio. Il sole, infatti, può bruciare o guarire: è ambivalente. Allo stesso modo, il “Sole di Dio” rivela tutto, illumina senza lasciare zone d’ombra: nessuna menzogna o ipocrisia può nascondersi davanti alla sua luce. Il giudizio di Dio non è distruzione, ma rivelazione e purificazione. Il sole “brucerà” gli arroganti e gli empi, ma “guarirà” coloro che temono il suo nome. L’arroganza, il cuore chiuso, si consumeranno come paglia; l’umiltà e la fede saranno trasfigurate. In ciascuno di noi convivono orgoglio e umiltà, egoismo e amore. Il giudizio di Dio avverrà dentro di noi: ciò che è “paglia” brucerà, ciò che è “buon seme” germoglierà al sole di Dio. Sarà un processo di purificazione interiore, fino a che in noi risplenderà l’immagine e somiglianza di Dio. Malachia usa anche altre due immagini: quella del fonditore, che purifica l’oro non per distruggerlo, ma perché brilli di tutta la sua bellezza; e quella del candeggiatore, che non rovina la veste, ma la rende splendente. Così, il giudizio di Dio è un’opera di luce: tutto ciò che è amore, servizio e misericordia sarà esaltato; tutto ciò che non è amore sparirà. Alla fine resterà solo ciò che riflette il volto di Dio. Il contesto storico: ci aiuta a capire questo testo: Israele vive una crisi di fede e di speranza dopo l’esilio; i sacerdoti sono tiepidi e il popolo è disilluso. Messaggio del profeta: Dio non è assente né ingiusto. Il suo “giorno” verrà: è il momento in cui la sua giustizia e il suo amore si manifesteranno pienamente. Immagine centrale è il Sole di giustizia, simbolo dell’amore purificatore di Dio. Come il sole, l’amore divino brucia e guarisce, consuma il male e fa fiorire il bene. In ognuno di noi Dio non condanna, ma trasforma tutto in salvezza compiendo un discernimento che glorifica l’amore e dissolve l’orgoglio. Il fuoco, il sole, il fonditore e il candeggiatore indicano la purificazione che porta alla bellezza originaria dell’uomo creato a immagine di Dio. Infine: non c’è nulla da temere: per chi crede, il giorno del Signore rivela è l’amore. “sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia” (Ml 3,20).
Salmo Responsoriale (97/98, 5-6, 7-8, 9)
Questo salmo ci trasporta idealmente alla fine dei tempi, quando tutta la creazione rinnovata acclama con gioia l’avvento del Regno di Dio. Il testo parla infatti del mare e delle sue ricchezze, del mondo e dei suoi abitanti, dei fiumi e dei monti: tutta la creazione è coinvolta. San Paolo, nella Lettera agli Efesini (1,9-10), ricorda che questo è il disegno eterno di Dio: «ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra». Dio vuole riunire tutto, creare una comunione piena fra il cosmo e le creature, instaurare l’armonia universale. Nel salmo questa armonia è già cantata come realizzata: il mare rimbomba, i fiumi battono le mani, le montagne esultano. È il sogno di Dio, annunciato già dal profeta Isaia (11,6-9): «Il lupo dimorerà con l’agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto… nessuno farà più del male né distruzione su tutto il mio monte santo». Ma la realtà è ben diversa: l’uomo conosce i pericoli del mare, i conflitti con la natura e con i suoi simili. La creazione è segnata da lotta e disarmonia. Tuttavia, la fede biblica sa che verrà il giorno in cui il sogno diventerà realtà, perché è il progetto di Dio stesso. l ruolo dei profeti, come Isaia, è quello di ravvivare la speranza di questo Regno messianico di giustizia e fedeltà. Anche i Salmi ripetono instancabilmente i motivi di questa speranza: nel Salmo 97(98) si canta il Regno di Dio come ristabilimento dell’ordine e della pace universale. Dopo tanti re ingiusti, si attende un Regno di giustizia e rettitudine. Il popolo canta come se tutto fosse già compiuto“Cantate inni al Signore che viene a giudicare la terra…e i popoli con rettitudine” All’inizio del salmo si ricordano le meraviglie del passato — l’esodo dall’Egitto, la fedeltà di Dio nella storia d’Israele — ma ora si proclama che Dio viene: il suo Regno è certo, anche se non ancora pienamente visibile. L’esperienza del passato diventa garanzia dell’avvenire: Dio ha già mostrato la sua fedeltà, e ciò permette al credente di anticipare con gioia l’avvento del Regno.Come dice il Salmo 89(90): “Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri”. E san Pietro (2 Pt 3,8-9) ricorda che Dio non ritarda la sua promessa, ma attende la conversione di tutti. Questo salmo dunque fa eco alle promesse del profeta Malachia: “Sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia” (Ml 3,20). I cantori di questo salmo sono i poveri del Signore, coloro che attendono la venuta del Cristo come luce e calore.Un tempo era Israele solo a cantare: “Acclama al Signore, terra intera, acclama il tuo re!” Ma nei tempi ultimi sarà tutta la creazione a unirsi in questo canto di vittoria, non più soltanto il popolo eletto. In ebraico, il verbo “acclamare” evoca il grido di trionfo del vincitore sul campo di battaglia (“teru‘ah”). Ma nel mondo nuovo, questo grido non sarà più di guerra, bensì di gioia e salvezza, perché — come dice Isaia (51,8): “La mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione”.Gesù ci insegna a pregare: “Venga il tuo Regno”, che è il compimento del sogno eterno di Dio: la riconciliazione e la comunione universale, in cui tutta la creazione canterà all’unisono la giustizia e la pace del suo Signore.
Seconda Lettura dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi (3, 7-12)
San Paolo scrive: “Chi non vuole lavorare, neppure mangi” (2 Ts 3,10). Questa frase, oggi, non potrebbe essere ripetuta alla lettera, perché non si riferisce ai disoccupati di buona volontà del nostro tempo, ma a una situazione del tutto diversa. Paolo non parla di chi non può lavorare, ma di chi non vuole lavorare, approfittando dell’attesa della venuta imminente del Signore per vivere nell’inerzia. Nel mondo di Paolo il lavoro non mancava. Egli stesso, arrivato a Corinto, trovò facilmente impiego presso Priscilla e Aquila, che esercitavano il suo stesso mestiere: fabbricanti di tende (At 18,1-3). Il suo lavoro manuale, tessere tele di capra, un’arte imparata a Tarso in Cilicia, era faticoso e poco redditizio, ma gli permetteva di non essere di peso a nessuno: «Nella fatica e nella pena, notte e giorno abbiamo lavorato per non essere di peso a nessuno» (2 Ts 3,8). Questo lavoro continuo, sostenuto anche dall’aiuto economico dei Filippesi, diventa per Paolo una testimonianza viva contro l’ozio di coloro che, convinti dell’imminente ritorno di Cristo, avevano abbandonato ogni impegno. La sua frase «chi non vuole lavorare, non mangi» non è un’invenzione personale, ma un detto rabbinico corrente, espressione di una saggezza antica che univa fede e responsabilità concreta. Il primo motivo che Paolo addduce è il rispetto degli altri: non approfittare della comunità, non vivere a spese altrui.La fede nell’avvento del Regno non deve diventare un pretesto per la passività. Al contrario, l’attesa del Regno si traduce in un impegno operoso e solidale: il cristiano collabora alla costruzione del mondo nuovo con le proprie mani, la propria intelligenza, la propria dedizione. Paolo ricorda implicitamente il mandato della Genesi:«Dominate la terra e sottomettetela» (Gn 1,28), che non significa sfruttare, ma prendere parte al progetto di Dio, trasformando la terra in un luogo di giustizia e di amore, anticipo del suo Regno. Il Regno non nasce fuori dal mondo, ma cresce dentro la storia, attraverso la collaborazione degli uomini. Come canta il padre Aimé Duval: “Il tuo cielo si farà sulla terra con le tue braccia”. E come scrive Khalil Gibran ne Il Profeta: “Quando lavorate, realizzate una parte del sogno della terra… Il lavoro è l’amore reso visibile”. In questa prospettiva, ogni gesto di amore, di cura, di servizio, anche se non retribuito, è una partecipazione alla costruzione del Regno di Dio. Lavorare, creare, servire, è collaborare con il Creatore. San Pietro ricorda: «Per il Signore, un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno… Egli non ritarda nel compiere la sua promessa, ma usa pazienza, volendo che tutti giungano alla conversione» (2 Pt 3,8-9). Questo significa che il tempo dell’attesa non è un vuoto, ma un tempo affidato alla nostra responsabilità. Ogni atto di giustizia, ogni opera buona, ogni gesto d’amore accelera la venuta del Regno. Perciò — conclude il testo — se desideriamo davvero che il Regno di Dio arrivi più presto, non abbiamo un minuto da perdere. Ecco una piccola sintesi spirituale: L’ozio non è semplice mancanza di lavoro, ma rinuncia alla collaborazione con Dio. l lavoro, in qualunque forma, è parte del sogno divino: rendere la terra luogo di comunione e di giustizia. Attendere il Regno non significa evadere dal mondo, ma impegnarsi a trasfigurarlo. Ogni gesto d’amore è una pietra posata per il Regno che viene. Chi lavora con cuore puro accelera l’alba del “Sole di giustizia” promesso dai profeti.
Dal Vangelo secondo Luca (21, 5-19)
“Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto” Qui c’è un linguaggio profetico, non letterale. Constatiamo ogni giorno che i capelli si perdono davvero! Ciò dimostra che le parole di Gesù non vanno prese alla lettera, ma come un linguaggio simbolico. Gesù, come i profeti prima di lui, non fa predizioni sul futuro: fa predicazioni. Non annuncia cronache di avvenimenti, ma chiavi di fede per interpretare la storia. Anche il suo discorso sulla fine del Tempio va compreso così: non è un oroscopo dell’apocalisse, ma un insegnamento per vivere con fede il presente, soprattutto quando tutto sembra crollare. Il messaggio è chiaro: “Qualunque cosa accada… non abbiate paura!» Gesù invita a non fondare la vita su ciò che passa. Il Tempio di Gerusalemme, restaurato da Erode e coperto d’oro, era splendido, ma destinato a crollare. Ogni realtà terrena, anche la più sacra o solida, è provvisoria. La vera stabilità non sta nelle pietre, ma in Dio. Gesù non offre dettagli sul “quando” o sul “come” del Regno; egli sposta la questione: “Fate attenzione a non lasciarvi ingannare…” Non ci serve conoscere il calendario del futuro, ma vivere il presente nella fedeltà. Gesù avverte i suoi discepoli: “Prima di tutto questo vi perseguiteranno, vi trascineranno davanti ai re e ai governatori a causa del mio Nome». Luca, che scrive dopo anni di persecuzioni, sa bene quanto questo si sia avverato: da Stefano a Giacomo, da Pietro a Paolo, fino a tanti altri. Ma anche nelle persecuzioni, Gesù promette: «Io vi darò una parola e una sapienza alla quale nessuno potrà resistere». Questo non significa che i cristiani saranno risparmiati dalla morte — «uccideranno alcuni di voi» —, ma che nessuna violenza potrà distruggere ciò che siete in Dio :«Neppure un capello del vostro capo andrà perduto». È un modo per dire: la vostra vita è custodita nelle mani del Padre. Anche attraverso la morte, rimanete vivi della vita di Dio Gesù pronuncia due volte l’espressione «a causa del mio Nome». Nel linguaggio ebraico, “Il Nome” indica Dio stesso: dire “a causa del Nome” è dire “a causa di Dio”. Così Gesù rivela la sua stessa divinità: soffrire per il suo Nome è partecipare al mistero del suo amore. San Luca, negli Atti degli Apostoli, mostra Pietro e Giovanni che, dopo essere stati flagellati, «se ne andarono pieni di gioia, perché si erano sentiti degni di soffrire per il Nome di Gesù» (At 5,41).È la stessa certezza che san Paolo esprimerà nella Lettera ai Romani: «Né la morte né la vita, né alcuna creatura potrà separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù» (Rm 8,38-39). Le catastrofi, le guerre, le epidemie — tutte queste “scosse” del mondo — non devono toglierci la pace. Il vero segno dei credenti è la serenità che viene dalla fiducia. Nell’agitazione del mondo, la calma dei figli di Dio è già una testimonianza. Gesù lo riassume in una parola: Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33). Ed ecco una sintesi spirituale: Gesù non promette una vita senza prove, ma una salvezza più forte della morte. Neppure un capello…» significa: nessun frammento di te è dimenticato da Dio. La persecuzione non distrugge, ma purifica la fede. Niente potrà separarci dall’amore di Dio: la nostra sicurezza è il Cristo risorto. Credere è rimanere saldi, anche quando tutto trema.
+ Giovanni D’Ercole
Cristo Re: «Oggi con Me nel Paradiso». Amore e aceto
ESPERIENZE TRAUMATICHE O DI PRECARIETÀ. «BUIO»: APATIA, DEPRESSIONE, PSICOSI, OSTILITÀ - (di Francesco Giovannozzi, psicologo e psicoterapeuta)
Uno sguardo nel «buio».
Come ho già detto in precedenza molti poeti e scrittori hanno descritto il fluire dell’animo umano.
Eugenio Montale lo esprime in una sua poesia del 1925, sul male di vivere, fornendoci l’immagine di un ruscello che non riesce a far scorrere le sue acque, di una foglia accartocciata dal troppo calore, di un cavallo sfinito a terra.
Immagini che nella nostra mente non passano senza lasciare una riflessione e qualche interrogativo.
Momenti di “buio” nella nostra vita ce ne sono stati e forse ci saranno ancora.
Sensazioni di scoraggiamento e di non sapere quale strada prendere - ognuno di noi lo ha sperimentato sulla propria pelle.
L’intensità e la durata del “buio” variano a seconda delle circostanze e dalle capacità di reagire personali.
Di fronte a sconfitte o delusioni reagiamo in modo differente; ciò che disturba un soggetto, può lasciare un altro individuo del tutto indifferente.
Un incontro col “ buio” può essere usuale di fronte a gravi difficoltà come un lutto, la perdita del lavoro, l’insorgere di una malattia, la fine di relazioni affettive, e altro.
Tale stato d’animo è provvisorio e finisce spontaneamente, senza portare cambiamenti nella vita di una persona.
In casi diversi è bene non sottovalutare lo stato d’animo, perché potrebbe essere un segno di una sofferenza psicosomatica o psichica.
In questi casi spesso si provano delle sensazioni inspiegabili di preoccupazione, di apatia; e ci sentiamo più affaticati.
Ricordiamoci che la reazione al “buio” segue sovente un’esperienza traumatica, la quale in circostanze ordinarie della vita non avrebbe causato nessuna sensazione temporanea di cattivo umore.
Una reazione maggiore e più protratta nel tempo, una reazione che l’individuo non riesce a superare da solo, è una condizione non usuale.
Nelle persone anziane le scosse emotive possono far insorgere momenti di “buio” più facilmente che nei giovani.
Talora gli anziani vengono messi da parte, hanno meno relazioni sociali, e spesso ne viene a soffrire il loro prestigio; principalmente quando viene meno la speranza.
Ma anche gli adolescenti [con la loro precarietà] non sono immuni a questi momenti di inquietudine.
Non è vero che l’adolescenza è un periodo felice della vita; anzi, forse è uno dei più travagliati.
In questi momenti di “buio” che la clinica chiama «depressione», notiamo: le persone che attraversano questa fase riducono di molto le loro attività, hanno meno fiducia in se stessi, si intesseranno a poche cose.
Sono capaci di conservare il lavoro anche se devono intensificare gli sforzi. Di solito la memoria e il rapporto con la realtà non sono alterati - a meno che non è insorto uno stato grave («psicosi»).
Arieti parla della depressione che qui abbiamo chiamato “buio” come una combinazione di tristezza e pessimismo.
Quest’ultimo costituisce l’elemento essenziale della combinazione; l’idea non sana sta nel credere che ciò che è accaduto a una persona gli succederà sempre, o che lo stato d’animo in cui si trova non muterà mai.
Il disfattismo, l’illusione di saper cosa ci succederà in futuro, consolida la tristezza in “buio”.
Spesso il “buio” dell’anima viene scaricato sul corpo.
Possiamo subire perdita di peso, sensazioni di oppressione a livello cardiaco; diminuzione delle secrezioni corporee; insonnia; e sovente mal di testa.
Nel comportamento con gli altri il “buio” ci fa tendere a sfruttare e condizionare il prossimo; ci fa essere poco inclini a essere persuasi. Difficilmente diamo soddisfazione al prossimo, e spesso l’ostilità ci invade.
Faber Andrew ha scritto una poesia intitolata ‘A chi sta attraversando il suo buio’…
Il poeta invita il lettore a «credere nella poesia. Negli occhi di chi quella strada l’ha già ritrovata».
Poi ancora: «C’è un cielo di qua che vi aspetta, con un panorama di sogni da togliere il fiato».
Per un poeta la poesia è la strada maestra, ma noi che non siamo poeti abbiamo qualcosa in cui Credere, e che costituisce il pilastro della nostra realtà.
Ricordiamoci sempre che quando la notte raggiunge il suo punto più oscuro, lì inizia l’alba di un nuovo giorno.
Francesco Giovannozzi psicologo psicoterapeuta.
AGITAZIONI, INQUIETUDINE, PREOCCUPAZIONI, PAURA - (di Francesco Giovannozzi, psicologo e psicoterapeuta)
Nella società odierna i fattori che procurano affanno e inquietudine sono molteplici e sovente le strategie per combatterle sono più difficili da trovare.
Questo tempo caratterizza il “barcollare” di valori fondamentali, di norme, di aspirazioni, che spingevano l’uomo verso la sua realizzazione, verso una sana relazione con gli altri.
Le attuali guerre nel mondo, il ricordo di esse per i meno giovani, le minacce atomiche, si aggiungono alla lista.
In un clima così ostile l’isolamento dell’uomo si accentua.
Ogni persona ha il proprio modo di reagire: quello più usuale è un senso di disagio, di ansietà, di sentirsi in pericolo senza sapere quale esso sia; di rovina, o altro.
Sovente ci sfugge la causa di tutto questo. La persona si sente disarmata, e se questa inquietudine è forte, può essere scaricata sul corpo.
Si noterà una rigidità muscolare, o possono essere presenti tremori, un sentirsi deboli, stanchi; anche la voce può tremare.
A livello cardio-circolatorio possono manifestarsi palpitazioni, svenimenti, aumento del battito cardiaco, aumento della pressione.
Anche a livello dell’intestino possono manifestarsi nausee, vomiti, mal di pancia - che non hanno origine organica.
Vi possono essere anche altre manifestazioni tipiche della storia di ogni persona, e non c’è organo su cui non può essere scaricata la tensione interna.
Ricordo che nella mia attività professionale ho incontrato soggetti con problematiche psicologiche “scaricate” in diverse parti del corpo; a volte, le più impensabili.
Mi sono ritrovato di fronte alopecie (perdita di capelli), arti bloccati, disturbi della vista, svenimenti, e negli ultimi tempi adolescenti che si tagliavano…
Se la persona si sente sopraffare da un’onda anomala di malessere interiore, può reagire in maniera inadeguata o addirittura pericolosa (alcol, droghe, corse in auto, gioco d’azzardo, ecc.).
La comprensione di queste agitazioni, preoccupazioni, ansie, è importante per stabilire quando esse sono nella norma o meno.
Gli stati di ansia non comuni si distinguono da una apprensione più o meno persistente, con crisi acute.
Questi stati sono da distinguersi dallo stato di preoccupazione diffusa che troviamo come usuale nella nostra vita quotidiana.
Ricordiamoci che per definire la nostra ansia, agitazione, dobbiamo convincerci che essa è qualcosa di normale quando l’individuo si sente minacciato.
L’agitazione va distinta dalla paura, dove il pericolo è reale: l’individuo può valutare la situazione e scegliere se affrontarla, o fuggire.
Quando parliamo di agitazione nella norma, vogliamo dire che è nella natura umana provarla di fronte ad un pericolo, a una malattia, etc.
Rappresenta il modo di vivere più profondo della nostra esistenza umana,
Ci fa trovare dinanzi ai nostri limiti, alle nostre debolezze, che non sono manifestazioni del malessere interiore o di malattia, ma espressioni della natura umana.
Più siamo coscienti dei nostri limiti, più riusciamo a vivere con le nostre ansie.
Per i nostri simili che si sentono onnipotenti l’agitazione, l’ansia, risultano insopportabili, poiché vengono alla coscienza i limiti che sono una ferita al proprio “sentirsi una creatura superiore”.
Sperimentiamo una normale inquietudine anche quando lasciamo una “strada vecchia per una nuova”.
Sotto questo punto di vista essa ci accompagna nei nostri cambiamenti, nella nostra evoluzione, e nel trovare un significato nella nostra vita.
Dott Francesco Giovannozzi psicologo-psicoterapeuta
Conversione e Tempi: la Fede del quarto anno
The true prophet does not obey others as he does God, and puts himself at the service of the truth, ready to pay in person. It is true that Jesus was a prophet of love, but love has a truth of its own. Indeed, love and truth are two names of the same reality, two names of God (Pope Benedict)
Il vero profeta non obbedisce ad altri che a Dio e si mette al servizio della verità, pronto a pagare di persona. E’ vero che Gesù è il profeta dell’amore, ma l’amore ha la sua verità. Anzi, amore e verità sono due nomi della stessa realtà, due nomi di Dio (Papa Benedetto)
“Give me a drink” (v. 7). Breaking every barrier, he begins a dialogue in which he reveals to the woman the mystery of living water, that is, of the Holy Spirit, God’s gift [Pope Francis]
«Dammi da bere» (v. 7). Così, rompendo ogni barriera, comincia un dialogo in cui svela a quella donna il mistero dell’acqua viva, cioè dello Spirito Santo, dono di Dio [Papa Francesco]
The mystery of ‘home-coming’ wonderfully expresses the encounter between the Father and humanity, between mercy and misery, in a circle of love that touches not only the son who was lost, but is extended to all (Pope John Paul II)
Il mistero del ‘ritorno-a-casa’ esprime mirabilmente l’incontro tra il Padre e l’umanità, tra la misericordia e la miseria, in un circolo d’amore che non riguarda solo il figlio perduto, ma si estende a tutti (Papa Giovanni Paolo II)
The image of the vineyard is clear: it represents the people whom the Lord has chosen and formed with such care; the servants sent by the landowner are the prophets, sent by God, while the son represents Jesus. And just as the prophets were rejected, so too Christ was rejected and killed (Pope Francis)
L’immagine della vigna è chiara: rappresenta il popolo che il Signore si è scelto e ha formato con tanta cura; i servi mandati dal padrone sono i profeti, inviati da Dio, mentre il figlio è figura di Gesù. E come furono rifiutati i profeti, così anche il Cristo è stato respinto e ucciso (Papa Francesco)
‘Lazarus’ means ‘God helps’. Lazarus, who is lying at the gate, is a living reminder to the rich man to remember God, but the rich man does not receive that reminder. Hence, he will be condemned not because of his wealth, but for being incapable of feeling compassion for Lazarus and for not coming to his aid. In the second part of the parable, we again meet Lazarus and the rich man after their death (vv. 22-31). In the hereafter the situation is reversed [Pope Francis]
“Lazzaro” significa “Dio aiuta”. Lazzaro, che giace davanti alla porta, è un richiamo vivente al ricco per ricordarsi di Dio, ma il ricco non accoglie tale richiamo. Sarà condannato pertanto non per le sue ricchezze, ma per essere stato incapace di sentire compassione per Lazzaro e di soccorrerlo. Nella seconda parte della parabola, ritroviamo Lazzaro e il ricco dopo la loro morte (vv. 22-31). Nell’al di là la situazione si è rovesciata [Papa Francesco]
Brothers and sisters, a frequent flaw of those in authority, whether civil or ecclesiastic authority, is that of demanding of others things — even righteous things — that they do not, however, put into practise in the first person. They live a double life. Jesus says: “They bind heavy burdens, hard to bear, and lay them on men’s shoulders; but they themselves will not move them with their finger (v.4). This attitude sets a bad example of authority, which should instead derive its primary strength precisely from setting a good example. Authority arises from a good example, so as to help others to practise what is right and proper, sustaining them in the trials that they meet on the right path (Pope Francis)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.