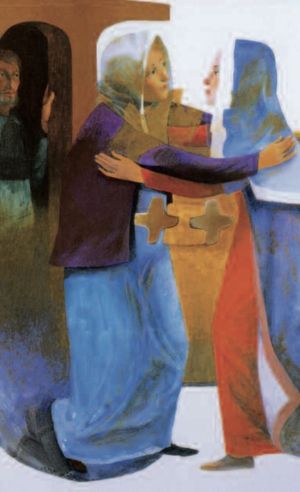don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Magnificat: parentela religiosa, e lo scatto della Fede
(Lc 1,46-55)
Il canto-insieme di Maria ed Elisabetta riassume e celebra la storia della salvezza. Esso riflette una lauda liturgica giudeo cristiana propria delle prime comunità di ‘anawim.
I piccoli e fedeli sperimentano il tracciato ideale della storia, della quale paradossalmente diventano motore.
Le due Donne porgono voce alle ‘chiese’ povere e minoritarie, spesso sfidate dalle forze del potere imperiale in duelli drammatici.
Raffigurano le primitive assemblee, fraternità minuscole; focolari di convivenza e vita intima.
In esse le anime credenti facevano esperienza di un Dio che non rimane impassibile nei confronti del grido dei minimi perseguitati.
In un quadro di visita famigliare e (appunto) di lode, si riflette tutta la destinazione del nuovo Popolo.
La diversità tra le due figure sottolinea lo scatto di Fede in Maria, rispetto alle attese della ‘parentela’ religiosa.
In Elisabetta il Primo Patto ha già percorso tutto il suo cammino, e non andrebbe molto oltre.
La storia degli uomini è arida, ma Dio la feconda di novità e letizia, che finalmente muta i confini.
Le vie previste sono giunte al termine; ancora cieche e sottomesse alle potenze della terra... Esse non rendono forte il debole.
La Fede trasmuta interamente i fondamenti della storia antidivina, perché consente allo Spirito d’impadronirsi della vita personale e permearla, rendendola capace di azione benedicente.
Nel modo di credere di Maria noi conosciamo ciò che non sappiamo - perché abbiamo una Visione che guida, un’immagine sacra che agisce dentro, come un istinto innato.
E possediamo già ciò che speriamo - perché la Fede è un colpo di mano, un’azione che si appropria, un atto-calamita (cf. Eb 11,1).
[Il suo vertice è scoprire stupori di recupero impossibile, a partire dai lati in ombra e perfino che detestiamo di noi - vicenda propria degli scartati].
L’Inno esprime dunque la traiettoria della vita del credente e la direzione della nostra esistenza, che ricompone l’essere malfermo nell’armonia nuova del progetto divino.
Tesi classica già del Primo Testamento: Dio solleva dalla polvere il misero e innalza il povero dalle immondizie.
Egli non s’indirizza a coloro che sono pieni di sé, ma a chi sa rivolgersi alle profondità, e come Maria le estende agli altri.
Entro tale vicenda del perdersi per ritrovarsi - incarnata sia dai discepoli che dalle chiese - si rintraccia l’esperienza del mattino di Pasqua.
Lc evangelista dei poveri celebra questo ribaltamento di situazioni in molti episodi di persone ed eventi ai margini.
Anche il Magnificat ribadisce: le scelte del Signore sono davvero estrose. Liberamente Egli passa per gli sconfitti e i derisi, che trovano guadagno nella perdita e vita dalla morte.
Maria in specie diventa figura espressiva della bassezza [ταπείνωσις (tapeínōsis, “abbassamento”), da ταπεινός (tapeinós, “basso”); v.48 testo greco] come ‘radice’ della trasformazione dell’essere - nell’Imprevedibile di Dio.
Egli è fedele.
[Feria propria del 22 dicembre]
L’Anima diversa di Maria
(Lc 1,39-45)
‘Incarnazione’: se lo sguardo non si fissa su alcune idee ma lievemente inizia a posarsi sulla condizione umana, ecco esordire un regno di pace.
La folla esitante nel paltò antico può esultare, perché giunge quella Presenza lieve ma decisiva che libera e ci dona respiro.
Opportunità inconsueta d’un riscatto a misura di donna e uomo, persino di bimbi.
Il popolo ha un Sogno: cogliere la sua identità e missione, malgrado la religione della mediocrità, dei soprusi - sguardi arcigni e paure.
Maria aiuta ciascuno a capire come sostituire la carezza d’un cuore di carne a tante estranee prescrizioni su fredde lastre di pietra.
La sua pace-Shalom non viene augurata al professionista del sacro. Egli omette l’unicità della Chiamata, della Sorpresa, della Persona.
Zaccaria non vive Beatitudini: è già identificato, quindi radicalmente incredulo.
Le grandi reminiscenze e il suo ruolo tipico lo rendono refrattario alla Novità dello Spirito.
Inutile persino rivolgergli la parola, benché padrone della Casa in cui si ‘ricordano’ le Promesse. Un’abitudine a fare memoria che oramai non attende più nulla.
L’Incontro decisivo? Forse ci sarà... ma chissà quando.
L’attesa mitica distrae, non coinvolge. Il riattualizzare idolatrico non rallegra; fissa, non fa danzare.
La festa è segno che il Signore è giunto in famiglia; non sul set, sul serio. [Non è semplice comprenderlo nel tempo dell’esteriorità].
Maria non ambisce a essere e mostrarsi “vip”; si colloca spontaneamente fra gente normale, che soffre una condizione penosa.
Non rincorre progetti, le sue idee precedenti, qualche ticchio vincolato che gli rimbalza nel pensiero. Questa la purezza di Maria.
Chi le assomiglia non ha bisogno di mendicare o esibire un riconoscimento, traguardi, credenziali, titoli, benemerenze. Questa la sua incontaminatezza.
Non ha frainteso Dio scambiandolo con delle apparenze. Non si è lasciata ingabbiare da luoghi comuni, perché non ha ostacolato la sua identità irripetibile, pensando di essere sbagliata.
Con mente silenziosa e distacco da giudizi ha consentito al suo istinto vocazionale di rigenerarla, concepire, donare vita.
Non ha inseguito un’immagine ideale, priva di pesi (e di senso), come fosse calata in un personaggio - e conformista.
Se si è corretta non lo ha fatto ripiegando su se stessa, ma sorpassando e tirando dritto; così ha scoperto come regolarsi, ma per volare.
Non gli è andato tutto bene, come se già avesse il film della sua vita in testa. Ha avuto nascondigli e dubbi, travagli da superare.
Non pensava, non parlava, non agiva come fosse “infinita”; ma con decisione, sì.
Non aveva sempre successo, eppure non si ritraeva solo vereconda.
Affrontava i conflitti, tuttavia senza quei pesi mentali che c’imbrigliano di fissazioni [anche sacrali] che a Dio non interessano, e bloccano il cammino.
Negli eventi e dentro sé coglieva i momenti dell’insicurezza per ricordarsi della Perla da vagliare.
Ricerca appassionata che l’ha tenuta in Vita, sapendo che le cose dell’anima sono differenti.
Non era una santa buonista, conduceva battaglie - e con attività di denuncia spirituale.
Infatti non chiede autorizzazioni a intraprendere un viaggio azzardato.
Neppure ‘vede’ l’uomo dell’istituzione ufficiale: il sacerdote dalla ritualità scandita nei minimi dettagli.
Si riconosce invece in Elisabetta. Anche lei una dimenticata, ma che coltiva la promessa («Eli-shébet»: il Signore Mio-Personale ha ‘giurato’; come dire “Dio Mi è fedele”).
Zaccaria invece («zachar-Ja» il Signore sì ma non “mio” bensì d'Israele, ‘ricorda’) non riesce a passare dalla religiosità regolare alla Fede che coinvolge il suo Eros fondante.
Maria non voleva essere finta, non desiderava diventare artificiale - quindi inutile, e nel tempo frantumata.
Ambiva a piantarsi ancora e sempre meglio sulle proprie Radici.
Se non riusciva a capire qualcosa, utilizzava queste sospensioni per proiettarsi avanti, alla ricerca di tutto lo scrigno prezioso della sua destinazione.
Non dava spazio alle tossine della mente create dalla consuetudine senza sogno, dai paradigmi del suo luogo e tempo. Non ha immaginato di rimanere sempre la stessa.
Sceglie di non deporre il lato evolutivo: capisce che poteva essere stimolata proprio dalle amarezze, dagli abbandoni, dagli impatti, dalle ferite.
Arca dell’Alleanza dall’intimità visionaria e attuabile, senza (dentro) gelide tavole di legalismi; perché Dio non si esprime emanando norme, ma nell’Amore - che non demolisce.
Aveva col Cielo un rapporto d’Incarnazione; non esteriore e senz’Unicità [di pietra come per obbedienza intimidita]. Nel suo midollo: Assomigliante - da Pari a Pari.
Dalla religione dei molti subalterni alla Fede?
Non una Chiesa delle cunette: Maria è la nuova coscienza e il diverso orientamento dell’umanità.
Magnificat: parentela religiosa, e lo scatto della Fede
(Lc 1,46-55)
Sebbene il contesto in lingua greca dei primi codici alluda a un cantico proprio di Elisabetta (vv.42-46), la tradizione successiva ha voluto porre l’inno sulla bocca di Maria.
Il loro canto-insieme riassume e celebra la storia della salvezza. Esso riflette una lauda liturgica giudeo cristiana propria delle prime comunità di ‘anawim.
[Oggi come allora i piccoli e fedeli sperimentano il tracciato ideale della storia, della quale paradossalmente diventano motore].
Maria ed Elisabetta danno voce alle ‘chiese’ povere e minoritarie, spesso sfidate dalle forze del potere imperiale in duelli drammatici.
Fraternità che facevano esperienza di un Dio che non rimane impassibile nei confronti del grido dei minimi perseguitati.
In un quadro di visita famigliare e (appunto) di lode, si riflette tutta la destinazione del nuovo Popolo.
La diversità fra le due donne sottolinea lo scatto della Fede in Maria, rispetto alle attese della ‘parentela’ religiosa.
In Elisabetta il Primo Patto ha già percorso tutto il suo cammino, e non andrebbe molto oltre.
La storia degli uomini è arida, ma l’Eterno la feconda di novità e letizia, che finalmente muta i confini.
Le vie previste sono giunte al termine; ancora cieche e sottomesse alle potenze della terra - autodivinizzanti...
Ma qui si rivela che la sicurezza dei grandi è vana, inesistente; ricercatrice di soli profitti.
E malgrado i millenni, sono ancora troppi coloro che rivestono le loro posizioni di proclami apparentemente devoti - inconsistenti d’amore che aiuta e arricchisce i piccoli, che rendano forte il debole.
La Fede trasmuta interamente i fondamenti della storia antidivina, perché consente allo Spirito d’impadronirsi della vita personale e fecondarla, rendendola capace di azione benedicente.
Nel modo di credere di Maria noi conosciamo ciò che non sappiamo - perché abbiamo una Visione che guida, un’Immagine che agisce dentro come un istinto innato.
E possediamo già ciò che speriamo - perché la Fede è un colpo di mano, un’azione che si appropria, un atto-calamita (cf. Eb 11,1).
Il suo vertice sarà scoprire stupori di recupero impossibile, a partire dai lati in ombra e che detestiamo di noi [proprio degli scartati].
L’inno esprime dunque la traiettoria della vita del credente in Cristo e la direzione della nostra esistenza che poco a poco o d’improvviso ricompone l’essere malfermo, nell’armonia nuova del progetto divino.
Tesi classica già del Primo Testamento: Dio solleva dalla polvere il misero e innalza il povero - l’emarginato (con indifferenza) - dalle immondizie.
Egli non s’indirizza a coloro che sono pieni di sé e con ruoli identificati, bensì a chi sa rivolgersi alle profondità, e come Maria le estende agli altri.
Entro tale vicenda del perdersi per ritrovarsi - una logica incarnata sia dai discepoli che dalle chiese - si rintraccia l’esperienza del mattino di Pasqua, i cui Vangeli “descrivono” la Risurrezione come capacità di vedere aperte le tombe e scorgere vita persino fra segni di assenza, e nel luogo della morte.
Lc evangelista dei poveri celebra questo ribaltamento di situazioni in molti episodi: fariseo e pubblicano, figlio prodigo e primogenito, samaritano e sacerdote levita, Lazzaro e ricco epulone, primo e ultimo posto, Beatitudini e ‘guai’...
Anche il Magnificat ribadisce: le scelte del Signore sono davvero estrose per la mentalità religiosa da nomenclatura.
Liberamente Egli passa per gli sconfitti, i derisi, ritenuti stupidi, ignobili; i deboli, emarginati da cricche, rifiutati dal club degli acclamati.
Il cantico è un ‘tipo’ perfetto di questa predilezione, che trova guadagno nella perdita e vita dalla morte, in persone ed eventi ai margini.
Maria in specie diventa figura espressiva della bassezza [ταπείνωσις (tapeínōsis, “abbassamento”), da ταπεινός (tapeinós, “basso”); v.48 testo greco] come ‘radice’ della trasformazione dell’essere - nell’Imprevedibile di Dio.
In Maria ed Elisabetta gli ‘anawim contemplavano la festa del trionfo dei figli, delle creature che ripetono in sé la Pasqua del Cristo.
Accadimento e proposta che anche nel tempo dell’emergenza fa rifiorire la vita dal fallimento delle mitologie del potere e della forza.
Nel Risorto che mostra sempre le piaghe, ovunque i credenti si sono resi conto: la povertà del cuore e di vita vissuta dal Cristo e dalla (Chiesa) Madre è la vera forza dirompente della storia.
Dio è fedele.
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha rivolto il suo sguardo alla bassezza della sua serva» (Lc 1,46b-48a).
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Ritieni la munificenza divina una proprietà?
Come proclami le tue consapevolezze personali ed ecclesiali - di compimento in Cristo - delle Promesse dell’Alleanza?
Voce solista e movimento poetico spirituale
Cantico della Beata Vergine
1. Siamo giunti ormai all'approdo finale del lungo itinerario cominciato proprio cinque anni fa, nella primavera del 2001, dal mio amato Predecessore, l'indimenticabile Papa Giovanni Paolo II. Il grande Papa aveva voluto percorrere nelle sue catechesi l'intera sequenza dei Salmi e dei Cantici che costituiscono il tessuto orante fondamentale della Liturgia delle Lodi e dei Vespri. Pervenuti ormai alla fine di questo pellegrinaggio testuale, simile a un viaggio nel giardino fiorito della lode, dell'invocazione, della preghiera e della contemplazione, lasciamo ora spazio a quel Cantico che idealmente suggella ogni celebrazione dei Vespri, il Magnificat (Lc 1, 46-55).
È un canto che rivela in filigrana la spiritualità degli anawim biblici, ossia di quei fedeli che si riconoscevano "poveri" non solo nel distacco da ogni idolatria della ricchezza e del potere, ma anche nell'umiltà profonda del cuore, spoglio dalla tentazione dell'orgoglio, aperto all'irruzione della grazia divina salvatrice. Tutto il Magnificat, che abbiamo sentito adesso dalla Cappella Sistina, è, infatti, marcato da questa "umiltà", in greco tapeinosis, che indica una situazione di concreta umiltà e povertà.
2. Il primo movimento del cantico mariano (cfr Lc 1, 46-50) è una sorta di voce solista che si leva verso il cielo per raggiungere il Signore. Sentiamo proprio la voce della Madonna che parla così del suo Salvatore, che ha fatto grandi cose nella sua anima e nel suo corpo. Si noti, infatti, il risuonare costante della prima persona: "L'anima mia... il mio spirito... mio salvatore... mi chiameranno beata... grandi cose ha fatto in me...". L'anima della preghiera è, quindi, la celebrazione della grazia divina che ha fatto irruzione nel cuore e nell'esistenza di Maria, rendendola la Madre del Signore.
L'intima struttura del suo canto orante è, allora, la lode, il ringraziamento, la gioia riconoscente. Ma questa testimonianza personale non è solitaria e intimistica, puramente individualistica, perché la Vergine Madre è consapevole di avere una missione da compiere per l'umanità e la sua vicenda si inserisce all'interno della storia della salvezza. E così può dire: "Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono" (v. 50). La Madonna con questa lode del Signore dà voce a tutte le creature redente che nel suo "Fiat", e così nella figura di Gesù nato dalla Vergine, trovano la misericordia di Dio.
3. È a questo punto che si svolge il secondo movimento poetico e spirituale del Magnificat (cfr vv. 51-55). Esso ha una tonalità più corale, quasi che alla voce di Maria si associ quella dell'intera comunità dei fedeli che celebrano le scelte sorprendenti di Dio. Nell'originale greco del Vangelo di Luca abbiamo sette verbi all'aoristo, che indicano altrettante azioni che il Signore compie in modo permanente nella storia: "Ha spiegato la potenza... ha disperso i superbi... ha rovesciato i potenti... ha innalzato gli umili... ha ricolmato di beni gli affamati... ha rimandato i ricchi... ha soccorso Israele".
In questo settenario di opere divine è evidente lo "stile" a cui il Signore della storia ispira il suo comportamento: egli si schiera dalla parte degli ultimi. Il suo è un progetto che è spesso nascosto sotto il terreno opaco delle vicende umane, che vedono trionfare "i superbi, i potenti e i ricchi". Eppure la sua forza segreta è destinata alla fine a svelarsi, per mostrare chi sono i veri prediletti di Dio: "Coloro che lo temono", fedeli alla sua parola; "gli umili, gli affamati, Israele suo servo", ossia la comunità del popolo di Dio che, come Maria, è costituita da coloro che sono "poveri", puri e semplici di cuore. È quel "piccolo gregge" che è invitato a non temere perché al Padre è piaciuto dare ad esso il suo regno (cfr Lc 12, 32). E così questo canto ci invita ad associarci a questo piccolo gregge, ad essere realmente membri del Popolo di Dio nella purezza e nella semplicità del cuore, nell'amore di Dio.
4. Raccogliamo, allora, l'invito che nel suo commento al testo del Magnificat ci rivolge sant'Ambrogio, dice il grande Dottore della Chiesa: "Sia in ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in Dio; se, secondo la carne, una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo; ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio... L'anima di Maria magnifica il Signore, e il suo spirito esulta in Dio, perché, consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale esistono tutte le cose" (Esposizione del Vangelo secondo Luca, 2, 26-27: SAEMO, XI, Milano-Roma 1978, p. 169).
In questo meraviglioso commento del Magnificat di sant'Ambrogio mi tocca sempre particolarmente la parola sorprendente: "Se, secondo la carne, una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano Cristo; ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio". Così il santo Dottore, interpretando le parole della Madonna stessa, ci invita a far sì che nella nostra anima e nella nostra vita il Signore trovi una dimora. Non dobbiamo solo portarlo nel cuore, ma dobbiamo portarlo al mondo, cosicché anche noi possiamo generare Cristo per i nostri tempi. Preghiamo il Signore perché ci aiuti a magnificarlo con lo spirito e l'anima di Maria e a portare di nuovo Cristo al nostro mondo.
[Papa Benedetto, Udienza Generale 15 febbraio 2006]
Magnificat: risposta all’Annunciazione, benché senza influsso nella storia
1. Ispirandosi alla tradizione veterotestamentaria, col cantico del Magnificat Maria celebra le meraviglie compiute in lei da Dio. Il cantico è la risposta della Vergine al mistero dell’Annunciazione: l’angelo l’aveva invitata alla gioia, ora Maria esprime l’esultanza del suo spirito in Dio salvatore. La sua gioia nasce dall’aver fatto l’esperienza personale dello sguardo benevolo rivolto da Dio a lei, creatura povera e senza influsso nella storia.
Con l’espressione Magnificat, versione latina di un vocabolo greco dello stesso significato, viene celebrata la grandezza di Dio, che con l’annuncio dell’angelo rivela la sua onnipotenza, superando attese e speranze del popolo dell’Alleanza e anche i più nobili desideri dell’anima umana.
Di fronte al Signore, potente e misericordioso, Maria esprime il sentimento della propria piccolezza: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva” (Lc 1, 47-48). Il termine greco “tapéinosis” è probabilmente mutuato dal cantico di Anna, madre di Samuele. In esso sono indicate l’“umiliazione” e la “miseria” di una donna sterile (cf. 1 Sam 1, 11), che affida la sua pena al Signore. Con simile espressione Maria rende nota la sua situazione di povertà e la consapevolezza di essere piccola davanti a Dio che, con decisione gratuita, ha posato lo sguardo su di Lei, umile ragazza di Nazaret, chiamandola a divenire la Madre del Messia.
2. Le parole “d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata” (Lc 1, 48) prendono avvio dal fatto che Elisabetta per prima abbia proclamato Maria “beata” (Lc 1, 45). Non senza audacia, il cantico predice che la stessa proclamazione si andrà estendendo ed ampliando con un dinamismo inarrestabile. Allo stesso tempo, esso testimonia la speciale venerazione per la Madre di Gesù, presente nella Comunità cristiana sin dal primo secolo. Il Magnificat costituisce la primizia delle varie espressioni di culto, trasmesse da una generazione all’altra, con cui la Chiesa manifesta il suo amore alla Vergine di Nazaret.
3. “Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono” (Lc 1, 49-50).
Che cosa sono le “grandi cose” operate in Maria dall’Onnipotente? L’espressione ricorre nell’Antico Testamento per indicare la liberazione del popolo d’Israele dall’Egitto o da Babilonia. Nel Magnificat essa si riferisce all’evento misterioso del concepimento verginale di Gesù, avvenuto a Nazaret dopo l’annuncio dell’angelo.
Nel Magnificat, cantico veramente teologico perché rivela l’esperienza del volto di Dio compiuta da Maria, Dio non è soltanto l’Onnipotente al quale nulla è impossibile, come aveva dichiarato Gabriele (cf. Lc 1, 37), ma anche il Misericordioso, capace di tenerezza e fedeltà verso ogni essere umano.
4. “Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote” (Lc 1, 51-53).
Con la sua lettura sapienziale della storia, Maria ci introduce a scoprire i criteri del misterioso agire di Dio. Egli, capovolgendo i giudizi del mondo, viene in soccorso dei poveri e dei piccoli, a scapito dei ricchi e dei potenti e, in modo sorprendente, colma di beni gli umili, che gli affidano la loro esistenza (cf. Giovanni Paolo II, Redemptoris Mater, 37).
Queste parole del cantico, mentre ci mostrano in Maria un concreto e sublime modello, ci fanno capire che è soprattutto l’umiltà del cuore ad attrarre la benevolenza di Dio.
5. Infine, il cantico esalta il compimento delle promesse e la fedeltà di Dio verso il popolo eletto: “Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre” (Lc 1, 54-55).
Colmata di doni divini, Maria non ferma il suo sguardo al suo caso personale, ma capisce come questi doni siano una manifestazione della misericordia di Dio per tutto il suo popolo. In lei Dio compie le sue promesse con una fedeltà e generosità sovrabbondante.
Ispirato all’Antico Testamento ed alla spiritualità della figlia di Sion, il Magnificat supera i testi profetici che sono alla sua origine, rivelando nella “piena di grazia” l’inizio di un intervento divino che va ben oltre le speranze messianiche d’Israele: il mistero santo dell’Incarnazione del Verbo.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 6 novembre 1996]
Gioia, non dall’assenza di problemi. Siamo la sua debolezza di amore
Che cosa ci consiglia la nostra Madre? Oggi nel Vangelo la prima cosa che dice è: «L’anima mia magnifica il Signore» (Lc 1,46). Noi, abituati a sentire queste parole, forse non facciamo più caso al loro significato. Magnificare letteralmente significa “fare grande”, ingrandire. Maria “ingrandisce il Signore”: non i problemi, che pure non le mancavano in quel momento, ma il Signore. Quante volte, invece, noi ci lasciamo sovrastare dalle difficoltà e assorbire dalle paure! La Madonna no, perché mette Dio come prima grandezza della vita. Da qui scaturisce il Magnificat, da qui nasce la gioia: non dall’assenza dei problemi, che prima o poi arrivano, ma la gioia nasce dalla presenza di Dio che ci aiuta, che è vicino a noi. Perché Dio è grande. E soprattutto, Dio guarda ai piccoli. Noi siamo la sua debolezza di amore: Dio guarda e ama i piccoli.
Maria, infatti, si riconosce piccola ed esalta le «grandi cose» (v. 49) che il Signore ha fatto per lei. Quali? Anzitutto il dono inatteso della vita: Maria è vergine e rimane incinta; e pure Elisabetta, che era anziana, aspetta un figlio. Il Signore fa meraviglie con i piccoli, con chi non si crede grande ma dà grande spazio a Dio nella vita. Egli stende la sua misericordia su chi confida in Lui e innalza gli umili. Maria loda Dio per questo.
E noi – possiamo chiederci – ci ricordiamo di lodare Dio? Lo ringraziamo per le grandi cose che fa per noi? Per ogni giornata che ci dona, perché ci ama e ci perdona sempre, per la sua tenerezza? E ancora, per averci dato la sua Madre, per i fratelli e le sorelle che ci mette sul cammino, perché ci ha aperto il Cielo? Noi ringraziamo Dio, lodiamo Dio per queste cose? Se dimentichiamo il bene, il cuore si rimpicciolisce. Ma se, come Maria, ricordiamo le grandi cose che il Signore compie, se almeno una volta al giorno lo magnifichiamo, allora facciamo un grande passo in avanti. Una volta al giorno possiamo dire: “Io lodo il Signore”; “Benedetto il Signore”: è una piccola preghiera di lode. Questo è lodare Dio. Il cuore, con questa piccola preghiera, si dilaterà, la gioia aumenterà. Chiediamo alla Madonna, porta del Cielo, la grazia di iniziare ogni giorno alzando lo sguardo verso il cielo, verso Dio, per dirgli: “Grazie!”, come dicono i piccoli ai grandi.
[Papa Francesco, Angelus 15 agosto 2020]
Natale: Pasqua. Respiro per me
Annunciazione a Giuseppe: senso e valore del Dubbio
(Mt 1,18-24)
«Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande» [Patris Corde n.2].
Incarnazione: il Padre si colloca a fianco dei suoi figli e figlie. Non solo non teme di rendersi impuro nel contatto con le cose che riguardano le dinamiche umane: addirittura si riconosce nella loro Condizione.
Per questo motivo, dall’imbarazzo di Giuseppe scaturisce addirittura il culmine dell’intera Storia di Salvezza.
Le fonti attestano che non era affatto un personaggio col giglio in mano, ma forse questo può interessarci sino a un certo punto.
La narrazione di Mt colpisce, perché il discrimine e le possibilità d’irruzione (della vetta stessa) del Disegno di Dio sull’umanità sembrano scaturiti non da una certezza, ma da un Dubbio.
Il punto interrogativo coinvolge. Il disagio semina dentro un nuovo Germe. Strappa e abbatte le pianticelle tutte uguali dell’erba infestante la vita piena - che era Legge cesellata sulle apparenze.
Il “problema” guida a sognare ben altri orizzonti da aprire, e in prima persona. L’esitazione conduce fuori dalle gabbie mentali che mortificano i rapporti, prima ridotti a casistiche.
La perplessità fa valicare l’opinione comune, che attenua e spegne la Novità di Dio.
L’esitazione cerca fenditure esistenziali, perché vuole introdurci in territori di vita - dove anche gli altri possono attingere esperienze differenti, percezioni variegate, e momenti in cui avere in dono intuizioni decisive.
La sua Energia sapiente trova brecce e piccoli varchi; agisce per farci evolvere come figli dell’Eternità - anche suscitando disagi, che inondano l’esistenza di sospensioni creative e nuova passione.
La sua lucida Azione s’introduce attraverso Sogni che scrollano di dosso i progetti consueti, o stati d’animo che mettono in bilico; e le strettoie di un pensiero emarginato che fa ritrovare il motivo per cui siamo nati, scoprire la nostra parte nel mondo.
Ogni oscillazione, ogni dolore, ogni pericolo, ogni trasloco, possono diventare un ‘parto’ verso l’Originalità - senza prima le identificazioni.
L’Unicità non fa smarrire la Fonte che ‘veglia’ in noi. Guai a sottrarsi: perderemmo la nostra destinazione.
Lo Spirito che s’infila nei pertugi delle mentalità standard trova un punto intimo che consente di fiorire diversamente adesso, in grado di far venir fuori l’essenza di chi siamo autenticamente, smettendo di copiare cliché.
Allora non continueremo a chiederci Ma di chi è la colpa? Come tamponare la situazione? A chi conviene appoggiarsi?. Bensì: Qual è la nuova ‘vita’ che devo esplorare? Cosa c’è ancora da scoprire?.
Infatti il morso dei dubbi non fa diventare credenti-spazzatura, come ipotizzato nelle religioni disciplinate, legaliste - nelle filosofie puritane dalla sapienza artificiosa - bensì amici, figli adottivi [ossia scelti] ed eredi.
Grazie alla Relazione di Fede, non siamo più persi nel deserto - perché le tante cose e gli azzardi diventano dialogo di peso specifico: siamo a Casa, nel rispetto del nostro misterioso carattere e Chiamata.
Iniziamo come Giuseppe a essere presenti a noi stessi. E cambiando sguardo, si godrà la Bellezza del Nuovo.
«San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine» [Patris Corde intr.].
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
In quale occasione il ‘dubbio’ ti ha aperto orizzonti da sbalordire? Nei momenti belli e colorati della vita sei forse partito da una tua certezza?
[4.a Domenica Avvento (anno A), 21 dicembre 2025]
Annunciazione a Giuseppe
Mt 1,18-24 (1-24)
Contatto con la terra: devianze e Risalita
Incarnazione disinvolta, in tenuità e densità
(Mt 1,1-17)
Nell’oriente antico le genealogie indicavano solo uomini, e sorprende che Mt riporti il nome di ben cinque donne - considerate creature solo servili, inaffidabili, impure per natura.
Ma nella vicenda delle quattro compagne di Maria c’è non poco di a-normale [anche per il modello di vita scelto] che però vale la pena.
Eccoci allora interpellati dal Vangelo sul peso da dare alla rigidità delle norme, le quali nella storia della spiritualità hanno spesso divorato l’essere spontaneo dei chiamati dal Padre (semplicemente a esprimersi).
Anche le culture animate da Sapienza di Natura ne attestano il peso.
Scrive il Tao Tê Ching (LVII): «Quando con la correzione si governa il mondo, con la falsità s’adopran l’armi [...] Per questo il santo dice: io non agisco e il popolo da sé si trasforma [...] io non bramo e il popolo da sé si fa semplice».
Per giungere alla pienezza umana del Figlio, Dio non ha preteso superare le vicende concrete, viceversa le ha assunte e valorizzate.
Il cammino che porta a Cristo non è questione di scalate, né di risultati o performance da calibrare sempre meglio in un crescendo lineare quindi moralizzatore e dirigista (che non impone svolte che contano, né risolve i veri problemi).
Commentando il Tao (i) il maestro Ho-shang Kung scrive: «Mistero è il Cielo. Dice che tanto l’uomo che ha desideri quanto quello che non ne ha ricevono parimenti il ch’ì dal Cielo. All’interno del cielo c’è un altro cielo; nel ch’ì c’è densità e tenuità».
Nella storia, l’Eterno riesce a dare ali spiegate non tanto alla forza e al genio, ma a tutte le povere origini, alla pochezza della nostra natura, la quale d’improvviso si tramuta in ricchezza totalmente imprevedibile.
E se di continuo strappiamo il filo, il Signore lo riannoda - non per aggiustare, metterci una pezza e riprendere come prima, ma per rifare un’intera trama nuova. Proprio a partire dalle cadute.
Sono quei momenti del discrimine terra-terra che costringono l'umanità a cambiare direzione simbolo e non ripetersi, stagnando nel circuito dei soliti perimetri cerebrali e puristi - abitudinari, e dove tutto è normale.
In seguito a schianti interiori e ripensamenti, quante persone hanno realizzato il proprio destino, deviando il percorso tracciato, quieto, protetto e confortevole (Cottolengo, madre Teresa, così via)!
Dal fango della palude spuntano fiori splendidi e puliti, che neppure somigliano a quelli cui nelle varie fasi della vita avevamo mai immaginato di poter contemplare.
I ruzzoloni dei protagonisti della storia della salvezza non sono arrivati per debolezza. Erano segnali d’un cattivo o parziale utilizzo delle risorse; stimoli a modificare l’occhio, rivalutare il punto di vista e tante speranze.
Quei crolli hanno configurato nuove sfide: sono state interpretati come provocazioni forti: a spostare energie e cambiare binario.
Le Risalite conseguenti ai ribassi si sono tramutate in nuove opportunità, affatto impreviste, appieno discordanti con le soluzioni già pronte che spengono i caratteri.
Anche la nostra crisi diventa seria solo quando i fallimenti non sfociano in nuove cognizioni e differenti percorsi che non avevamo pensato (forse in nessuno dei nostri buoni propositi).
Strano questo legame tra i nostri abissi e gli apici dello Spirito: è l’Incarnazione, nessuna teoria - tutta realtà.
Non esiste Dono che ci rassomiglia al top divino e che giunga a noi senza passare e coinvolgere la dimensione della finitudine.
I buchi nell’acqua trasmettono la cifra tutta umana di quel che siamo - dietro le illusioni o le stesse apparenze che non vogliamo deporre, per autoconvincerci di essere invece “personaggi” identificati.
Ma le ambivalenze e le falle continuano a voler schiodare il nostro sguardo e destino altrove, rispetto alle attese comuni [oggi anche il parossismo del punto nei sondaggi].
Dietro la maschera e oltre le convinzioni acquisite dall’ambiente, dai modi o dalle procedure... c’è il grande Segreto del Padre su di noi.
Proprio le discese spiritualizzano, attraverso un lavorio dell’anima che viene speronata dalle vicende, affinché volga ad acquistare nuove consapevolezze, interiorizzi differenti valutazioni, veda e abbracci altri variegati orizzonti anche missionari.
Il crack che butta giù può essere più consistente di ogni progresso; non perché avvia un’ascesi: diventa contatto con la “terra” - dove troviamo la linfa che ci corrisponde davvero, per rigenerare.
Il calo o addirittura la rovina di uno status rassicurante ha in ogni accadimento una funzione propulsiva, rigenerativa, trasmutativa; normale, in fondo, e in cui la storia di Dio si riconosce totalmente.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Quali sono stati i tuoi momenti di svolta?
Quale deviazione ti ha realizzato?
Non solo mediante uomini, bensì Con loro
Con l’odierna Liturgia entriamo nell’ultimo tratto del cammino dell’Avvento, che esorta ad intensificare la nostra preparazione, per celebrare con fede e con gioia il Natale del Signore, accogliendo con intimo stupore Dio che si fa vicino all’uomo, a ciascuno di noi.
La prima lettura ci presenta l’anziano Giacobbe che raduna i suoi figli per la benedizione: è un evento di grande intensità e commozione. Questa benedizione è come un sigillo della fedeltà all’alleanza con Dio, ma è anche una visione profetica, che guarda in avanti e indica una missione. Giacobbe è il padre che, attraverso le vie non sempre lineari della propria storia, giunge alla gioia di radunare i suoi figli attorno a sé e tracciare il futuro di ciascuno e della loro discendenza. In particolare, oggi abbiamo ascoltato il riferimento alla tribù di Giuda, di cui si esalta la forza regale, rappresentata dal leone, come pure alla monarchia di Davide, rappresentata dallo scettro, dal bastone del comando, che allude alla venuta del Messia. Così, in questa duplice immagine, traspare il futuro mistero del leone che si fa agnello, del re il cui bastone di comando è la Croce, segno della vera regalità. Giacobbe ha preso progressivamente coscienza del primato di Dio, ha compreso che il suo cammino è guidato e sostenuto dalla fedeltà del Signore, e non può che rispondere con adesione piena all’alleanza e al disegno di salvezza di Dio, diventando a sua volta, insieme con la propria discendenza, anello del progetto divino.
Il brano del Vangelo di Matteo ci presenta la "genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo" (Mt 1,1), sottolineando ed esplicitando ulteriormente la fedeltà di Dio alla promessa, che Egli attua non soltanto mediante gli uomini, ma con loro e, come per Giacobbe, talora attraverso vie tortuose e impreviste. Il Messia atteso, oggetto della promessa, è vero Dio, ma anche vero uomo; Figlio di Dio, ma anche Figlio partorito dalla Vergine, Maria di Nazaret, carne santa di Abramo, nel cui seme saranno benedetti tutti i popoli della terra (cfr Gen 22,18). In questa genealogia, oltre a Maria, vengono ricordate quattro donne. Non sono Sara, Rebecca, Lia, Rachele, cioè le grandi figure della storia d’Israele. Paradossalmente, invece, sono quattro donne pagane: Racab, Rut, Betsabea, Tamar, che apparentemente "disturbano" la purezza di una genealogia. Ma in queste donne pagane, che appaiono in punti determinanti della storia della salvezza, traspare il mistero della chiesa dei pagani, l’universalità della salvezza. Sono donne pagane nelle quali appare il futuro, l’universalità della salvezza. Sono anche donne peccatrici e così appare in loro anche il mistero della grazia: non sono le nostre opere che redimono il mondo, ma è il Signore che ci dà la vera vita. Sono donne peccatrici, sì, in cui appare la grandezza della grazia della quale noi tutti abbiamo bisogno. Queste donne rivelano tuttavia una risposta esemplare alla fedeltà di Dio, mostrando la fede nel Dio di Israele. E così vediamo trasparire la chiesa dei pagani, mistero della grazia, la fede come dono e come cammino verso la comunione con Dio. La genealogia di Matteo, pertanto, non è semplicemente l’elenco delle generazioni: è la storia realizzata primariamente da Dio, ma con la risposta dell’umanità. È una genealogia della grazia e della fede: proprio sulla fedeltà assoluta di Dio e sulla fede solida di queste donne poggia la prosecuzione della promessa fatta a Israele
[Papa Benedetto, omelia al Centro Aletti, 17 dicembre 2009]
L’uomo, cognome di Dio
L’uomo è il cognome di Dio: il Signore infatti prende il nome da ognuno di noi — sia che siamo santi, sia che siamo peccatori — per farlo diventare il proprio cognome. Perché incarnandosi il Signore ha fatto storia con l’umanità: la sua gioia è stata condividere la sua vita con noi, «e questo fa piangere: tanto amore, tanta tenerezza».
È con il pensiero rivolto al Natale ormai imminente che Papa Francesco ha commentato martedì 17 dicembre le due letture proposte dalla liturgia della parola, tratte rispettivamente dalla Genesi (49, 2.8-10) e dal Vangelo di Matteo (1, 1-17). Nel giorno del suo settantasettesimo compleanno, il Santo Padre ha presieduto come di consueto la messa mattutina nella cappella di Santa Marta. Ha concelebrato tra gli altri il cardinale decano Angelo Sodano, che gli ha espresso gli auguri di tutto il collegio cardinalizio.
All’omelia, incentrata sulla presenza di Dio nella storia dell’umanità, il vescovo di Roma ha individuato in due termini — eredità e genealogia — le chiavi per interpretare rispettivamente la prima lettura (riguardante la profezia di Giacobbe che raduna i propri figli e predice una discendenza gloriosa per Giuda) e il brano evangelico contenente la genealogia di Gesù. Soffermandosi in particolare su quest’ultima, ha sottolineato che non si tratta di «un elenco telefonico», ma di «un argomento importante: è pura storia», perché «Dio ha inviato il suo figlio» in mezzo agli uomini. E, ha aggiunto, «Gesù è consostanziale al padre, Dio; ma anche consostanziale alla madre, una donna. E questa è quella consostanzialità della madre: Dio si è fatto storia, Dio ha voluto farsi storia. È con noi. Ha fatto cammino con noi».
Un cammino — ha proseguito il vescovo di Roma — iniziato da lontano, nel Paradiso, subito dopo il peccato originale. Da quel momento, infatti, il Signore «ha avuto questa idea: fare cammino con noi». Perciò «ha chiamato Abramo, il primo nominato in questa lista, in questo elenco, e lo ha invitato a camminare. E Abramo ha cominciato quel cammino: ha generato Isacco, e Isacco Giacobbe, e Giacobbe Giuda». E così via, avanti nella storia dell’umanità. «Dio cammina con il suo popolo», dunque, perché «non ha voluto venire a salvarci senza storia; lui ha voluto fare storia con noi».
Una storia, ha affermato il Pontefice, fatta di santità e di peccato, perché nell’elenco della genealogia di Gesù ci sono santi e peccatori. Tra i primi il Papa ha ricordato «il nostro padre Abramo» e «Davide, che dopo il peccato si è convertito». Tra i secondi ha individuato «peccatori di alto livello, che hanno fatto peccati grossi», ma con i quali Dio ugualmente «ha fatto storia». Peccatori che non hanno saputo rispondere al progetto che Dio aveva immaginato per loro: come «Salomone, tanto grande e intelligente, finito come un poveraccio che non sapeva nemmeno come si chiamasse». Eppure, ha constatato Papa Francesco, Dio era anche con lui. «E questo è il bello: Dio fa storia con noi. Di più, quando Dio vuol dire chi è, dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe».
Ecco perché alla domanda «qual è il cognome di Dio?» per Papa Francesco è possibile rispondere: «Siamo noi, ognuno di noi. Lui prende da noi il nome per farne il suo cognome». E nell’esempio offerto dal Pontefice non ci sono solo i padri della nostra fede, ma anche gente comune. «Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Pedro, di Marietta, di Armony, di Marisa, di Simone, di tutti. Da noi prende il cognome. Il cognome di Dio è ognuno di noi», ha spiegato.
Da qui la constatazione che prendendo «il cognome dal nostro nome, Dio ha fatto storia con noi»; anzi, di più: «si è lasciato scrivere la storia da noi». E noi ancora oggi continuiamo a scrivere «questa storia», che è fatta «di grazia e di peccato», mentre il Signore non si stanca di venirci dietro: «questa è l’umiltà di Dio, la pazienza di Dio, l’amore di Dio». Del resto, anche «il libro della Sapienza dice che la gioia del Signore è tra i figli dell’uomo, con noi».
Ecco allora che «avvicinandosi il Natale», a Papa Francesco — com’egli stesso ha confidato concludendo la sua riflessione — è venuto naturale pensare: «Se lui ha fatto la sua storia con noi, se lui ha preso il suo cognome da noi, se lui ha lasciato che noi scrivessimo la sua storia», noi da parte nostra dovremmo lasciare che Dio scriva la nostra. Perché, ha chiarito, «la santità» è proprio «lasciare che il Signore scriva la nostra storia». E questo è l’augurio di Natale che il Pontefice ha voluto fare «per tutti noi». Un augurio che è un invito ad aprire il cuore: «Fa’ che il Signore ti scriva la storia e che tu lasci che te la scriva».
[Papa Francesco, omelia s. Marta, in L’Osservatore Romano 18/12/2013]
Annunciazione a Giuseppe: senso e valore del Dubbio
(Mt 1,16.18-21.24)
«Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande» [Patris Corde n.2].
Nei Vangeli dell’infanzia di Mt Dio assume due Nomi: Redentore [Yeshua: Dio è Salvatore] e Con-noi. Il senso di tali prerogative divine non è meccanico, bensì teologico.
Il Nome proprio del Figlio Gesù descrive la sua Opera di recupero di tutto l’essere. E l’attributo caratteristico Immanu’el (tratto da Isaia) ne puntualizza i molti recapiti - i suoi tanti indirizzi, che siamo ciascuno di noi, in crescita nel tempo.
Incarnazione: il Padre si colloca a fianco dei suoi figli e figlie. Non solo non teme di rendersi impuro nel contatto con le cose che riguardano le dinamiche umane: addirittura si riconosce nella loro Condizione.
Per questo motivo, dall’imbarazzo di Giuseppe scaturisce addirittura il culmine dell’intera Storia di Salvezza.
Le fonti attestano che non era affatto un personaggio col giglio in mano, ma forse questo può interessarci sino a un certo punto.
La narrazione di Mt colpisce, perché il discrimine e le possibilità d’irruzione (della vetta stessa) del Disegno di Dio sull’umanità sembrano scaturiti non da una certezza, ma da un Dubbio.
Il punto interrogativo coinvolge. Il disagio semina dentro un nuovo Germe. Strappa e abbatte le pianticelle tutte uguali dell’erba infestante la vita piena - che era Legge cesellata sulle apparenze.
Il “problema” guida a sognare ben altri orizzonti da aprire, e in prima persona; perché la soluzione non è a portata di mano.
La perplessità conduce fuori dalle gabbie mentali che mortificano i rapporti prima ridotti a casistiche - sorvolando gl’ingranaggi che spersonalizzano.
La perplessità fa valicare l’opinione comune, che attenua e spegne la Novità di Dio.
L’esitazione cerca fenditure esistenziali, perché vuole introdurci in territori di vita - dove anche gli altri possono attingere esperienze differenti, percezioni variegate, e momenti in cui avere in dono intuizioni decisive.
La sua Energia sapiente trova brecce e piccoli varchi; agisce per farci evolvere come figli dell’Eternità - anche suscitando disagi che inondano l’esistenza di sospensioni creative e nuova passione.
La sua lucida Azione s’introduce attraverso Sogni che scrollano di dosso i progetti consueti, o stati d’animo che mettono in bilico; e le strettoie di un pensiero emarginato che fa ritrovare il motivo per cui siamo nati, scoprire la nostra parte nel mondo.
Ogni oscillazione, ogni dolore, ogni pericolo, ogni trasloco, possono diventare un parto verso l’Originalità - senza prima le identificazioni.
L’Unicità non fa smarrire la Fonte che “veglia” in noi. Guai a sottrarsi: perderemmo la nostra destinazione.
Ciò mentre le cerchie dei risoluti restano lì e inaridiscono, proprio perché sempre pronte alla spiegazione di tutto.
Così ad es. come per la Famiglia di Nazaret, la vita in solitudine - costretta o non - diventa rigenerante, più che terribile.
Lo Spirito che s’infila nei pertugi delle mentalità standard trova un “punto” intimo che consente di fiorire diversamente adesso, in grado di far venir fuori l’essenza di chi siamo autenticamente, smettendo di copiare cliché.
Così invece di chiedersi come mai sia capitato qualcosa, dopo la prima esperienza discriminante che non teme la paura di restare isolati, forse rientriamo più di frequente nel nostro Nucleo, il quale senza posa zampilla per un Dialogo superiore.
Allora non continueremo a chiederci ‘Ma di chi è la colpa? Come tamponare la situazione? A chi conviene appoggiarsi?’. Bensì: ‘Qual è la nuova vita che devo esplorare? Cosa c’è ancora da scoprire?’.
Si uscirà con ben altra virtù di vocazione, perché lo Spirito Santo che fa breccia nelle crepe delle norme che rendono conformisti, poi smantella e rovescia quei muri. Infine dilaga, per costruire la sua storia - che non è prevedibile, “a modo” come quella di tutti i legati alla comparazione.
Sentire il fastidio di partecipare a rituali di composta identificazione causa molti problemi, ma può essere la grande occasione della vita per dilatare gli orizzonti... anche di coloro che non gradiscono percorrere la via mediocre dell’assicurarsi - rendendosi per timore dipendenti dall’opinione, dai luoghi comuni, dal sentirsi subito festeggiati.
Felicità apparente. Infatti il morso dei dubbi non fa diventare credenti-spazzatura, come ipotizzato nelle religioni disciplinate, legaliste - nelle filosofie puritane dalla sapienza artificiosa - bensì amici, figli adottivi [ossia scelti] ed eredi.
Grazie alla Relazione di Fede, non siamo più persi nel deserto - perché le tante cose e gli azzardi diventano dialogo di peso specifico: siamo a Casa, nel rispetto del nostro misterioso carattere e Chiamata.
Già qui e ora ci spostiamo dalle tante cose che vincolano di costrizioni e pretese il nostro Centro - e sia il pensiero che l’azione.
Solo in tal guisa non siamo più folla mitologica o assuefatta, stracolma di colpe, doveri e appartenenze - bensì Famiglia e informalità colloquiale delle dissonanze.
Non più massa, ma (a tutto tondo) Persone: proprio nel nostro essere nel limite facciamo rima con grande-Missione.
Iniziamo come Giuseppe a essere presenti a noi stessi. E cambiando sguardo, si godrà la Bellezza del Nuovo.
«San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine» [Patris Corde intr.].
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Quali sono stati i tuoi momenti di svolta? Quale deviazione ti ha realizzato?
In quale occasione il dubbio ti ha aperto orizzonti da sbalordire?
Quando e se hai cambiato lo sguardo conformista, hai conosciuto o meno l’accendersi nel tuo mondo interiore di prospettive, relazioni ed energie rigeneranti?
Come hai percepito accanto e “visto” o “sognato” ciò che prima restava Invisibile e Altrove?
Sei forse partito da una tua certezza?
Silenzio permeato, robusta interiorità
In questi ultimi giorni dell’Avvento la liturgia ci invita a contemplare in modo speciale la Vergine Maria e san Giuseppe, che hanno vissuto con intensità unica il tempo dell'attesa e della preparazione della nascita di Gesù. Desidero quest'oggi rivolgere lo sguardo alla figura di san Giuseppe. Nell'odierna pagina evangelica san Luca presenta la Vergine Maria come "sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe" (Lc 1, 27). È però l'evangelista Matteo a dare maggior risalto al padre putativo di Gesù, sottolineando che, per suo tramite, il Bambino risultava legalmente inserito nella discendenza davidica e realizzava così le Scritture, nelle quali il Messia era profetizzato come "figlio di Davide". Ma il ruolo di Giuseppe non può certo ridursi a questo aspetto legale. Egli è modello dell'uomo "giusto" (Mt 1, 19), che in perfetta sintonia con la sua sposa accoglie il Figlio di Dio fatto uomo e veglia sulla sua crescita umana. Per questo, nei giorni che precedono il Natale, è quanto mai opportuno stabilire una sorta di colloquio spirituale con san Giuseppe, perché egli ci aiuti a vivere in pienezza questo grande mistero della fede.
L'amato Papa Giovanni Paolo II, che era molto devoto di san Giuseppe, ci ha lasciato una mirabile meditazione a lui dedicata nell'Esortazione apostolica Redemptoris Custos, "Custode del Redentore". Tra i molti aspetti che pone in luce, un accento particolare dedica al silenzio di san Giuseppe. Il suo è un silenzio permeato di contemplazione del mistero di Dio, in atteggiamento di totale disponibilità ai voleri divini. In altre parole, il silenzio di san Giuseppe non manifesta un vuoto interiore, ma, al contrario, la pienezza di fede che egli porta nel cuore, e che guida ogni suo pensiero ed ogni sua azione. Un silenzio grazie al quale Giuseppe, all'unisono con Maria, custodisce la Parola di Dio, conosciuta attraverso le Sacre Scritture, confrontandola continuamente con gli avvenimenti della vita di Gesù; un silenzio intessuto di preghiera costante, preghiera di benedizione del Signore, di adorazione della sua santa volontà e di affidamento senza riserve alla sua provvidenza. Non si esagera se si pensa che proprio dal "padre" Giuseppe Gesù abbia appreso - sul piano umano - quella robusta interiorità che è presupposto dell'autentica giustizia, la "giustizia superiore", che Egli un giorno insegnerà ai suoi discepoli (cfr Mt 5, 20).
Lasciamoci "contagiare" dal silenzio di san Giuseppe! Ne abbiamo tanto bisogno, in un mondo spesso troppo rumoroso, che non favorisce il raccoglimento e l'ascolto della voce di Dio. In questo tempo di preparazione al Natale coltiviamo il raccoglimento interiore, per accogliere e custodire Gesù nella nostra vita.
[Papa Benedetto, Angelus 18 dicembre 2005]
Gli è affidato il Mistero
2. "Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati" ( Mt 1,20-21 ).
Troviamo queste parole nel capitolo primo del Vangelo secondo Matteo. Esse - soprattutto nella seconda parte - suonano simili a quelle che ascoltò Miriam, cioè Maria, nel momento dell’Annunciazione. Tra qualche giorno - il 25 marzo - ricorderemo nella liturgia della Chiesa il momento in cui quelle parole furono pronunciate a Nazaret "a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria" ( Lc 1,27 ).
La descrizione dell’annunciazione si trova nel Vangelo secondo Luca.
In seguito Matteo nota di nuovo che, dopo le nozze di Maria con Giuseppe "prima che andassero a vivere insieme, ella si trovò incinta per opera dello Spirito Santo" ( Mt 1,18 ).
Così dunque si compì in Maria il mistero che aveva avuto il suo inizio nel momento dell’annunciazione, nel momento, in cui la Vergine rispose alle parole di Gabriele: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto" ( Lc 1,38 ).
A mano a mano che il mistero della maternità di Maria si rivelava alla coscienza di Giuseppe, egli, "che era giusto, non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto" ( Mt 1,19 ), così dice il seguito della descrizione di Matteo.
E proprio allora Giuseppe, sposo di Maria e dinanzi alla legge già suo marito, riceve la sua personale "Annunciazione".
Egli sente durante la notte le parole che abbiamo riportato sopra, le parole, che sono spiegazione e nello stesso tempo invito da parte di Dio: "Non temere di prendere con te Maria" ( Mt 1,20 ).
3. Nello stesso tempo Dio affida a Giuseppe il mistero, il cui compimento avevano aspettato da tante generazioni la stirpe di Davide e tutta la "casa d’Israele", ed al tempo stesso affida a Lui tutto ciò da cui dipende il compimento di tale mistero nella storia del Popolo di Dio.
Dal momento in cui tali parole sono giunte alla sua coscienza, Giuseppe diventa l’uomo della divina elezione: l’uomo di un particolare affidamento. Viene definito il suo posto nella storia della salvezza. Giuseppe entra in questo posto con la semplicità e l’umiltà, in cui si manifesta la profondità spirituale dell’uomo; ed egli lo riempie completamente con la sua vita.
"Destatosi dal sonno - leggiamo da Matteo - Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore" ( Mt 1,24 ). In queste poche parole c’è tutto. Tutta la descrizione della vita di Giuseppe e la piena caratteristica della sua santità: "Fece". Giuseppe, quello che conosciamo dal Vangelo, è uomo di azione.
È uomo di lavoro. Il Vangelo non ha conservato alcuna sua parola. Ha descritto invece le sue azioni: azioni semplici, quotidiane, che hanno nello stesso tempo il significato limpido per il compimento della promessa divina nella storia dell’uomo; opere piene della profondità spirituale e della semplicità matura.
[Papa Giovanni Paolo II, omelia 19 marzo 1980]
Intimidated by the nightmare of demons and concrete dangers, the crowds could not see the possibility of emancipation from an existence of obsessions - slavish, frightened, lost, overwhelmed...
Intimidite dall’incubo di demoni e pericoli concreti, le folle non riuscivano a vedere possibilità di emancipazione da un’esistenza di ossessioni - pedissequa, spaventata, smarrita, sopraffatta…
Justification incorporates us into the long history of salvation that demonstrates God’s justice: faced with our continual falls and inadequacies, he did not give up, but wanted to make us righteous (Pope Francis)
La giustificazione ci inserisce nella lunga storia della salvezza, che mostra la giustizia di Dio: di fronte alle nostre continue cadute e alle nostre insufficienze, Egli non si è rassegnato, ma ha voluto renderci giusti (Papa Francesco)
Against this cultural pressure, which not only threatened the Israelite identity but also the faith in the one God and in his promises, it was necessary to create a wall of distinction, a shield of defence to protect the precious heritage of the faith; this wall consisted precisely in the Judaic observances and prescriptions (Pope Benedict)
Contro questa pressione culturale, che minacciava non solo l’identità israelitica, ma anche la fede nell’unico Dio e nelle sue promesse, era necessario creare un muro di distinzione, uno scudo di difesa a protezione della preziosa eredità della fede; tale muro consisteva proprio nelle osservanze e prescrizioni giudaiche (Papa Benedetto)
It is not an anecdote. It is a decisive historical fact! This scene is decisive for our faith; and it is also decisive for the Church’s mission (Pope Francis)
Non è un aneddoto. E’ un fatto storico decisivo! Questa scena è decisiva per la nostra fede; ed è decisiva anche per la missione della Chiesa (Papa Francesco)
Being considered strong, capable of commanding, excellent, pristine, magnificent, performing, extraordinary, glorious… harms people. It puts a mask on us, makes us one-sided; takes away understanding. It floats the character we are sitting in, above reality
Essere considerati forti, capaci di comandare, eccellenti, incontaminati, magnifici, performanti, straordinari, gloriosi… danneggia le persone. Ci mette una maschera, rende unilaterali; toglie la comprensione. Fa galleggiare il personaggio in cui siamo seduti, al di sopra della realtà
The paralytic is not a paralytic
Il paralitico non è un paralitico
The Kingdom of God is precisely the presence of truth and love and thus is healing in the depths of our being. One therefore understands why his preaching and the cures he works always go together: in fact, they form one message of hope and salvation (Pope Benedict)
Il Regno di Dio è proprio la presenza della verità e dell’amore e così è guarigione nella profondità del nostro essere. Si comprende, pertanto, perché la sua predicazione e le guarigioni che opera siano sempre unite: formano infatti un unico messaggio di speranza e di salvezza (Papa Benedetto)
To repent and believe in the Gospel are not two different things or in some way only juxtaposed, but express the same reality (Pope Benedict)
Convertirsi e credere al Vangelo non sono due cose diverse o in qualche modo soltanto accostate tra loro, ma esprimono la medesima realtà (Papa Benedetto)
The fire of God's creative and redeeming love burns sin and destroys it and takes possession of the soul, which becomes the home of the Most High! (Pope John Paul II)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.