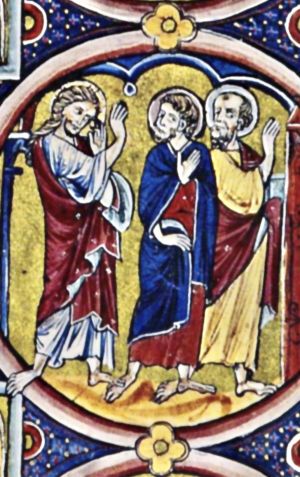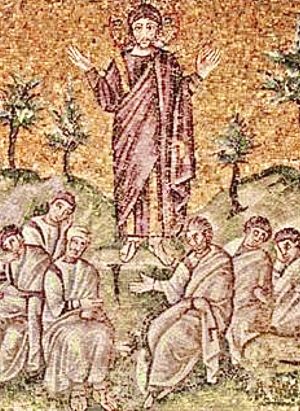don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
La lotta per la Liberazione dai corrotti, e la vita di corte
(Mc 6,14-29)
La domanda «Chi è Gesù?» cresce lungo tutto il Vangelo di Mc, sino alla risposta del centurione sotto la Croce (Mc 15,39).
Il bilancio sulle opinioni della gente (vv.14-16) lascia intendere che anche attorno alle prime assemblee di credenti qualcuno tentava di comprendere Cristo a partire da quanto si sapeva già.
Non pochi desideravano capire la sua Persona sulla base di criteri tratti dalle Scritture o dalla Tradizione anche orale del popolo eletto; dalle credenze e suggestioni antiche - persino superstiziose [come nel caso di Erode].
Ma l’Araldo di Dio non è stato un purificatore del Tempio, né semplice rabberciatore della religiosità datata, d’idee culturali addomesticate. Neppure uno dei tanti “riformatori”… tutto sommato conformisti.
Egli capovolge le speranze del popolo, così inquieta qualsiasi scuola di pensiero; in particolare, coloro che detengono l’esclusiva.
Quando avverte un pericolo, chi è avvolto di lustro e potere diventa sfrontato e disposto a ogni violenza, anche per un falso punto d’onore.
I tiranni si fanno sempre beffe dell’isolato, scomodo e indifeso.
Ma capi e potenti sono anche vigliacchi: non intendono perdere la faccia davanti agli alleati del loro ambiente smodato e senza controllo, ammantato di esenzioni.
Durante più di 40 anni di regno, Erode Antipa aveva creato una classe di funzionari e un sistema di privilegiati che avevano in pugno il governo, il fisco, l’economia, la giustizia, ogni aspetto della vita civile e di polizia.
Il suo comando copriva capillarmente il territorio.
In ogni villaggio il sovrano poteva contare sull’appoggio di tutte le cricche e dei vari leaders locali, interessati al controllo delle coscienze - insieme a scribi e farisei compromessi, legati alla sua politica.
Oltre che fantoccio di Roma - cui garantiva il controllo del territorio e il flusso delle imposte - Erode era un depravato e (appunto) superstizioso. Pensava che perfino il giuramento leggero a una ballerina andasse mantenuto.
Giuseppe Flavio riferisce invece che Giovanni era in prigione per timore del sovrano di una sommossa popolare - e stava valutando che fosse bene per lui agire in anticipo.
La trama dell’assassinio è stata probabilmente occasionale.
Il coraggioso che denuncia soprusi viene stroncato, ma la Voce del suo martirio non tace più.
Per questo motivo l’episodio non induce Gesù a maggiore prudenza. Ucciso un inviato, subentra un altro maggiore e più incisivo: all’ultimo dei Profeti, il Figlio di Dio.
I delinquenti non devono illudersi che la Provvidenza non sappia equipaggiare anche le alte sfere più smidollate, del contraltare di persone coerenti e valide.
La religiosità generica e confusionaria può adattarsi a ogni stagione ed esser fatta propria anche da chi pensa che la vita altrui non valga nulla - ma un Profeta non si arresta di fronte al capriccio del sistema corrotto.
Sia Giovanni che il Signore non hanno mai frequentato la nuova capitale erodiana, Tiberiade, la città dei palazzi di corte. Costruita - dopo Sefforis, dove anche Gesù ha lavorato - in diplomatico omaggio all’imperatore romano.
Nei villaggi palestinesi la vita della gente era vessata di tasse e abusi di latifondisti, che neppure risiedevano in loco; controllata dal perfetto connubio d’interessi fra potere civile e religioso.
Complicità che in modo scaltro i dirigenti tentavano d’imporre, secondo il loro stile di vita. Anche trasmettendo alle folle molte narrazioni calibrate, e inculcando un sapere (inutile) ormai consolidato.
I leaders della fede popolare, ortodossa e confacente - come spesso capita - erano a guinzaglio delle autorità sul territorio, le quali si consideravano definitive e trovavano forza nella coalizione.
Sembrava assurdo che in quella società qualcuno osasse infrangere il muro omertoso il quale garantiva ai facinorosi, alle autorità “spirituali” e ai prepotenti persino d’infimo livello di considerarsi intoccabili.
Di fronte al ricatto (senza troppi complimenti) dei privilegiati che avevano il controllo d’ogni ceto sociale e culturale, pareva impossibile iniziare un nuovo cammino, o dire e fare qualsiasi cosa non allineata.
Giovanni e Gesù sfidano lo status quo e attraggono su di sé le vendette di coloro che tentano di perpetuare le prerogative del cosmo gerarchico antico, e le rabbie di quanti vengono smascherati nelle loro ipocrisie.
È la difficoltà reale che incontra l’Annuncio del nuovo Regno nel mondo. Il suo rifiuto sprezzante e ogni tentativo di omicidio saranno una cartina al tornasole d’una nostra nobile franchezza critica, la cui rivelazione correrà parallela ai Due.
Il Battezzatore è stato intrepido denunciatore del vizio, della superficialità, del malcostume, delle perversioni dei potenti.
Di costoro, Papa Francesco avrebbe parlato di buone maniere [nella ricerca di alleanze di cordata] e di pessime abitudini [nella vita privata irresponsabile e insulsa, e nella violenza con cui si perpetua il dominio sui piccoli].
Anche Gesù ha puntato i piedi, invece di fare carriera interna. Malgrado il presagio di Giovanni, ha rifiutato la strada delle malizie soppesate, della finzione, della diplomazia, delle piroette di circostanza.
Il Maestro si è eretto in difesa della coscienza e della stessa legge divina, contro le autorità religiose e politiche opportuniste, che ha sfidato a viso aperto.
Anche oggi il Signore chiede coraggio di non piegarsi di fronte alla corruzione, al male, alla mentalità corrente; di essere diversi nel modo di pensare, di parlare [mellifluo].
Chiede di scegliere e agire.
Non ascoltati, derisi, osteggiati da molti signori, luminari e cortigiani, i figli di Dio rendono testimonianza alla Verità, pagando di persona: perfetta Letizia.
Autentica Pienezza.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Conosci vittime di autoritarismo, corruzione, dominio di potenti, eccesso e strafottenza di potere? Anche nella Chiesa?
Come mai ancora capita questo - e tutto prima o poi vien messo a tacere?
Chi è Gesù secondo te e gli altri? E che direbbe?
Denunciò, anche quando protagonisti ne erano i potenti
Da autentico profeta, Giovanni rese testimonianza alla verità senza compromessi. Denunciò le trasgressioni dei comandamenti di Dio, anche quando protagonisti ne erano i potenti. Così, quando accusò di adulterio Erode ed Erodiade, pagò con la vita, sigillando col martirio il suo servizio a Cristo, che è la Verità in persona. Invochiamo la sua intercessione, insieme con quella di Maria Santissima, perché anche ai nostri giorni la Chiesa sappia mantenersi sempre fedele a Cristo e testimoniare con coraggio la sua verità e il suo amore per tutti.
[Papa Benedetto, Angelus 24 giugno 2007]
Impegno eroico per non cedere alle difficoltà che spingono al compromesso
1. […] la tradizione cristiana fa memoria del martirio di San Giovanni Battista, "il più grande fra i nati di donna", secondo l’elogio del Messia stesso (cfr Lc 7, 28). Egli rese a Dio la suprema testimonianza del sangue immolando la sua esistenza per la verità e la giustizia; fu infatti decapitato per ordine di Erode, al quale aveva osato dire che non gli era lecito tenere la moglie di suo fratello (cfr Mt 6, 17 – 29).
2. Nell’Enciclica Veritatis splendor, ricordando il sacrificio di Giovanni Battista (cfr n.91), notavo che il martirio è "un segno preclaro della santità della Chiesa" (n.93). Esso infatti "rappresenta il vertice della testimonianza alla verità morale" (ibid.). Se relativamente pochi sono chiamati al sacrificio supremo, vi è però "una coerente testimonianza che tutti i cristiani devono esser pronti a dare ogni giorno anche a costo di sofferenze e di gravi sacrifici" (ibid.). Ci vuole davvero un impegno talvolta eroico per non cedere, anche nella vita quotidiana, alle difficoltà che spingono al compromesso e per vivere il Vangelo "sine glossa".
3. L’eroico esempio di Giovanni Battista fa pensare ai martiri della fede che lungo i secoli hanno seguito coraggiosamente le sue orme. In modo speciale, mi tornano alla mente i numerosi cristiani, che nel secolo scorso sono stati vittime dell’odio religioso in diverse nazioni d’Europa. Anche oggi, in alcune parti del mondo, i credenti continuano ad essere sottoposti a dure prove per la loro adesione a Cristo e alla sua Chiesa.
Sentano questi nostri fratelli e sorelle la piena solidarietà dell’intera comunità ecclesiale! Li affidiamo alla Vergine Santa, Regina dei martiri, che ora insieme invochiamo.
[Papa Giovanni Paolo II, Angelus 29 agosto 2004]
Strade parallele
Un uomo, Giovanni, e una strada, che è quella di Gesù, indicata dal Battista, ma è anche la nostra, nella quale tutti siamo chiamati al momento della prova.
Parte dalla figura di Giovanni, «il grande Giovanni: al dire di Gesù “l’uomo più grande nato da donna”» la riflessione di Papa Francesco nella messa celebrata a Santa Marta venerdì 6 febbraio. Il vangelo di Marco (6, 14-29) racconta della prigionia e del martirio di quest’«uomo fedele alla sua missione; l’uomo che ha sofferto tante tentazioni» e che «mai, mai ha tradito la sua vocazione». Un uomo «fedele» e «di grande autorità, rispettato da tutti: il grande di quel tempo».
Papa Francesco si è soffermato ad analizzare la sua figura: «Quello che gli usciva dalla bocca era giusto. Il suo cuore era giusto». Era tanto grande che «Gesù dirà anche di lui che “è Elia che è tornato, per pulire la casa, per preparare il cammino”». E Giovanni «era cosciente che il suo dovere era soltanto annunziare: annunziare la prossimità del Messia. Lui era cosciente, come ci fa riflettere sant’Agostino, che lui era la voce soltanto, la Parola era un altro». Anche quando «è stato tentato di “rapinare” questa verità, lui è rimasto giusto: “Io non sono, dietro di me viene, ma io non sono: io sono il servo; io sono il servitore; io sono quello che apre le porte, perché lui venga».
A questo punto il Pontefice ha introdotto il concetto di strada, perché, ha ricordato: «Giovanni è il precursore: precursore non solo della entrata del Signore nella vita pubblica, ma di tutta la vita del Signore». Il Battista «va avanti nel cammino del Signore; dà testimonianza del Signore non soltanto mostrandolo — “È questo!”— ma anche portando la vita fino alla fine come l’ha portata il Signore». E finendo la vita «col martirio» è stato «precursore della vita e della morte di Gesù Cristo».
Il Papa ha continuato a riflettere su queste strade parallele lungo le quali «il grande» soffre «tante prove e diventa piccolo, piccolo, piccolo, piccolo fino al disprezzo». Giovanni, come Gesù, «si annienta, conosce la strada dell’annientamento. Giovanni con tutta quella autorità, pensando alla sua vita, comparandola con quella di Gesù, dice alla gente chi è lui, come sarà la sua vita: “Conviene che lui cresca, io invece debbo diminuire”». È questa, ha sottolineato il Papa, «la vita di Giovanni: diminuire davanti a Cristo, perché Cristo cresca». È «la vita del servo che fa posto, fa strada perché venga il Signore».
La vita di Giovanni «non è stata facile»: infatti, «quando Gesù ha incominciato la sua vita pubblica», egli era «vicino agli Esseni, cioè agli osservanti della legge, ma anche delle preghiere, delle penitenze». Così, a un certo punto, nel periodo in cui era in carcere, «ha sofferto la prova del buio, della notte nella sua anima». E quella scena, ha commentato Francesco, «commuove: il grande, il più grande manda da Gesù due discepoli per domandargli: “Ma Giovanni ti domanda: sei tu o ho sbagliato e dobbiamo aspettare un altro?”». Lungo la strada di Giovanni si è affacciato quindi «il buio dello sbaglio, il buio di una vita bruciata nell’errore. E questa per lui è stata una croce».
Alla domanda di Giovanni «Gesù risponde con le parole di Isaia»: il Battista «capisce, ma il suo cuore rimane nel buio». Ciò nonostante si presta alle richieste del re, «al quale piaceva sentirlo, al quale piaceva portare avanti una vita adultera», e «quasi diventava un predicatore di corte, di questo re perplesso». Ma «lui si umiliava» perché «pensava di convertire quest’uomo».
Infine, ha detto il Papa, «dopo questa purificazione, dopo questo calare continuo nell’annientamento, facendo strada all’annientamento di Gesù, finisce la sua vita». Quel re da perplesso «diventa capace di una decisione, ma non perché il suo cuore sia stato convertito»; piuttosto «perché il vino gli dà coraggio».
E così Giovanni finisce la sua vita «sotto l’autorità di un re mediocre, ubriaco e corrotto, per il capriccio di una ballerina e per l’odio vendicativo di un’adultera». Così «finisce il grande, l’uomo più grande nato da donna», ha commentato Francesco che ha confessato: «Quando io leggo questo brano, mi commuovo». E ha aggiunto una considerazione utile alla vita spirituale di ogni cristiano: «Penso a due cose: primo, penso ai nostri martiri, ai martiri dei nostri giorni, quegli uomini, donne, bambini che sono perseguitati, odiati, cacciati via dalle case, torturati, massacrati». E questa, ha sottolineato, «non è una cosa del passato: oggi succede questo. I nostri martiri, che finiscono la loro vita sotto l’autorità corrotta di gente che odia Gesù Cristo». Perciò «ci farà bene pensare ai nostri martiri. Oggi pensiamo a Paolo Miki, ma quello è successo nel 1600. Pensiamo a quelli di oggi, del 2015».
Il Pontefice ha proseguito aggiungendo che questo brano lo spinge anche a riflettere su se stesso: «Anche io finirò. Tutti noi finiremo. Nessuno ha la vita “comprata”. Anche noi, volendo o non volendo, andiamo sulla strada dell’annientamento esistenziale della vita». E ciò, ha detto, lo spinge «a pregare che questo annientamento assomigli il più possibile a Gesù Cristo, al suo annientamento».
Si chiude così il cerchio della meditazione di Francesco: «Giovanni, il grande, che diminuisce continuamente fino al nulla; i martiri, che diminuiscono oggi, nella nostra Chiesa di oggi, fino al nulla; e noi, che siamo su questa strada e andiamo verso la terra, dove tutti finiremo». In questo senso la preghiera finale del Papa: «Che il Signore ci illumini, ci faccia capire questa strada di Giovanni, il precursore della strada di Gesù; e la strada di Gesù, che ci insegna come deve essere la nostra».
[Papa Francesco, s. Marta, in L’Osservatore Romano 07.02.2015]
Invio dei discepoli: fiducia, umanizzazione, sobrietà
Sobri, ma con i sandali
(Mc 6,7-13)
Il passaggio di Nazaret - doloroso per lo stesso Gesù - e la descrizione dell’invio dei discepoli, voleva essere di sostegno e luce per i credenti.
Il Figlio di Dio viene rifiutato dalla propria gente, e quello che prima era il suo paese ora non lo è più.
Non bisogna per questo scoraggiare: i conflitti costringono a stare faccia a faccia con nuovi modi di essere (e opportunità di Comunione).
Nel rapporto col Padre e le circostanze, nessuno se la cava da solo, magari centrando l’esistenza sui traguardi e solo su di sé - o cambiando residenza (v.10) e cercando poi eccessivi mezzi per stabilirsi [col pretesto della ‘efficacia’].
La testimonianza del Cristo è profonda, e relazionale sino alla convivenza; non individualista: da affrontare mostrando reciprocità, capacità di scambio non alienante - almeno fra due (v.7).
La mèta poi non è perseguibile se la vita è disintegrata dalle opinioni attorno, e priva di qualsiasi principio di trasformazione dei rapporti - espressione dell’Alleanza che suscita collaborazione, spirito di fraternità.
Nonché “modello”, “principio” di analisi e prognosi per la soluzione dei problemi, e per un futuro di convivenza; attraverso un completamento di ‘lati opposti’ riconosciuti in se stessi [attraverso le microrelazioni].
In tutte le religioni l’ideale di perfezione è il raggiungimento della propria purificazione, avanzamento, equilibrio.
Ma non basta questo perché possiamo proclamare che il Regno è venuto! Esso è frutto artigianale, di un cammino svolto come a tappe e tentativi; dell’Amore, nell’Esodo.
In tal guisa, il Risorto ci ha investiti di una forza tranquilla ma irresistibile e palese: la sua Parola efficace.
Logos che in noi si fa lucidità, carica, impulso, capacità di ascolto [che rimette in piedi; insieme, ci pone in grado di gestire le cose]: una potenza compassionevole mai vista prima.
La proposta dei Vangeli presuppone spirito di sobrietà, rischio, fraternità regale: così si evangelizzano gli ambienti, trasmettendo passione per la vita e annientando le forze di morte che allontanano dal prossimo.
Avendo fiducia nell’ospitalità e nella condivisione, i nuovi missionari trascurano finalmente le norme di purità legalista (v.8) e mostrano un diverso accesso alla stessa purezza, alle relazioni, all’intimità col Padre.
Dunque, ingredienti essenziali per edificare la comunità altrove sono: accontentarsi e rinunciare all’ambizione, la compartecipazione anche nella cultura [dando spazio a tutte le intuizioni]; famigliarità nei normali lavori e compensi; l’accoglienza degli esclusi.
Come nella mentalità comunitaria semitica, i nuovi ‘inviati’ devono farsi fratelli prossimi, difensori e riscattatori (Go’el) degli emarginati. In tal senso anche noi personifichiamo nella storia e nei contesti la figura del Cristo.
Proteggendo i miseri e bisognosi (v.13), si dispiega l’insegnamento e l’opera di Gesù, che tanto si era profuso per arginare la disintegrazione della vita comunitaria - allora intaccata dal servilismo politico, economico e religioso.
Quindi, evitando l’ambiguità delle ricchezze, i figli di Dio non avrebbero nutrito l’istinto di dominio sugli altri.
Purtroppo chi è amico del trionfalismo e possiede in eccesso, facilmente mancherà della cosa principale, caratteristica della credibilità: la fiducia nella Provvidenza - unico spirito che non inficia la situazione.
Gesù mette in guardia, affinché non lo smentiamo col nostro comportamento arraffone, amante del lusso, pronto sia alle deferenze che ad assecondare i giochi di potere; performante a ogni costo, sempre affannato per il ruolo e i livelli economici.
Certo, il Figlio di Dio sogna una Chiesa povera [non solo ‘dei poveri’] - ma un elemento di opulenza per noi lo concede, anzi lo vuole: che calziamo i sandali (v.9); a quel tempo in Roma segno di libertà e dignità non accattona.
Sì, perché dobbiamo riscoprire l’umano - e camminare molto.
[Giovedì 4.a sett. T.O. 5 febbraio 2026]
Invio dei discepoli: fiducia, umanizzazione, sobrietà
Sobri, ma con i sandali
(Mc 6,7-13)
E io e Te
La Verità non è affatto ciò che ho. Non è affatto ciò che hai. Essa è ciò che ci unisce nella sofferenza, nella gioia. Essa è figlia della nostra Unione, nel dolore e nel piacere partoriti. Né io né Te. E io e Te. La nostra opera comune, stupore permanente. Il suo nome è Saggezza.
(Irénée Guilane Dioh)
Mc scrive il suo Vangelo per le comunità romane, in un momento in cui sembrava non avessero futuro. Eppure, esse vivevano tale situazione di prova senza strillare.
Nerone iniziò a perseguitare le piccole fraternità nel 64. L’anno successivo scoppiò la rivolta giudaica. Nel breve periodo dei quattro Cesari, a Roma la guerra civile raggiunse il suo apice. Nel 70 Gerusalemme venne rasa al suolo.
Il passaggio di Nazaret - doloroso per lo stesso Gesù - e la descrizione dell’invio dei discepoli, voleva essere di sostegno e luce per i credenti.
Il Figlio di Dio [e in Lui chiunque autenticamente lo testimoni] viene rifiutato dalla propria gente, e quello che prima era il suo paese ora non lo è più.
Non bisogna per questo scoraggiare: i conflitti costringono a stare faccia a faccia con nuovi modi di essere.
Malgrado le difficoltà che in se stesse creerebbero solo trappole emotive, qualsiasi situazione non è priva d’un orientamento e preziosi orizzonti di nuova leggerezza, di possibilità di abbandono che riporta alla vita; soprattutto, di vera Comunione.
Nel rapporto col Padre e le circostanze, nessuno se la cava da solo, magari centrando l’esistenza su traguardi e solo su di sé - o cambiando residenza (v.10) e cercando poi eccessivi mezzi per stabilirsi [col pretesto dell’efficacia].
La testimonianza del Cristo è profonda, e relazionale sino alla convivenza (anche più che sommaria); non individualista: da affrontare mostrando reciprocità, capacità di scambio non alienante - almeno fra due (v.7).
È nel volto di un compagno di viaggio che si riconoscono gli opposti [gli stessi poli che abitano ciascuna anima, nel segreto…].
La mèta poi non è perseguibile se la testa permanesse disintegrata dalle opinioni attorno, e il desiderio privo di qualsiasi principio di trasformazione dei rapporti - espressione dell’Alleanza che ancora suscita collaborazione, spirito di fraternità, cammino.
Quindi “modello”, “principio” di analisi e prognosi per la soluzione dei problemi, e per un futuro di convivenza; attraverso un completamento di ‘lati opposti’ riconosciuti in se stessi [attraverso le microrelazioni].
In tutte le religioni l’ideale di perfezione è il raggiungimento della propria purificazione, avanzamento, equilibrio.
Ma non basta questo perché possiamo proclamare che il Regno è venuto! Esso è frutto artigianale, di un percorso svolto come a tappe e tentativi; dell’Amore, nell’Esodo.
In tal guisa, il Risorto ci ha investiti di una forza tranquilla ma irresistibile e palese: la sua Parola efficace.
Verbo che in noi si fa lucidità, carica, impulso, capacità di ascolto [che rimette in piedi; insieme, ci pone in grado di gestire le cose]: una potenza compassionevole mai vista prima.
La proposta dei Vangeli presuppone spirito di sobrietà, rischio, empatia regale: così si evangelizzano gli ambienti, trasmettendo passione per la vita e annientando le forze di morte che allontanano dal prossimo.
Avendo fiducia nell’ospitalità e nella condivisione, i nuovi missionari trascurano finalmente le norme di purità religiose (v.8) e mostrano un diverso accesso alla stessa purezza, alle relazioni, all’intimità col Padre.
Dunque, ingredienti essenziali per edificare la comunità altrove [e ovunque] sono: accontentarsi e rinunciare all’ambizione, la compartecipazione anche nella cultura [dando spazio a tutte le intuizioni], famigliarità nei normali lavori e compensi; l’accoglienza degli esclusi.
Come nella mentalità comunitaria semitica, i nuovi ‘inviati’ devono farsi fratelli prossimi, difensori e riscattatori (Go’el) degli emarginati. In tal senso anche noi personifichiamo nella storia e nei contesti la figura del Cristo.
Proteggendo i miseri e bisognosi (v.13), si dispiega l’insegnamento e l’opera di Gesù, che tanto si era profuso per arginare la disintegrazione della vita comunitaria - allora intaccata dal servilismo politico, economico e religioso.
I testimoni hanno occhi non oscurati da consuetudini di pensiero: vedono il divino nell’anima dell’umano apparentemente sommario.
Quindi - evitando l’ambiguità delle ricchezze - i figli di Dio non avrebbero nutrito l’istinto di dominio sugli altri.
Non tutti sentono la vocazione a una rinuncia volontaria, ma ciascuno deve chiedersi se proprio i beni materiali generano quella falsa sicurezza e [di fatto] schiavitù che poi blocca l’inclinazione al servizio.
Purtroppo chi è amico del trionfalismo e possiede in eccesso, facilmente mancherà della cosa principale, caratteristica della credibilità: la fiducia nella Provvidenza - unico spirito che non inficia la situazione.
Tutti i Fondatori hanno avuto la medesima preoccupazione del Signore: non contraddire ciò che si annunziava, e avere un cuore libero.
Il Regno di Dio si fa presente nella sobrietà più che nella dovizia, e nello spirito di amicizia più che nella distinzione: è il nuovo insegnamento della Fede, comparata alle credenze diffuse.
In una situazione successiva di quasi tre secoli, che stava iniziando rapidamente a degradare, Ilario di Poitiers denunciava così le seduzioni del potere nei confronti dei responsabili di Chiesa - già costituita - cui volentieri l'ordine antico iniziava a concedere lauti privilegi (per strumentalizzarli):
«Noi non abbiamo un imperatore anticristiano [Costanzo II, figlio di Costantino I]; prima eravamo perseguitati, ma adesso dobbiamo lottare contro un persecutore ancora più insidioso, contro un nemico che non ci picchia ma ci lusinga, non ci flagella la schiena ma ci accarezza il ventre; non ci confisca i beni, perché così ci darebbe la vita, ma ci arricchisce, per darci la morte, per farci diventare controtestimonianza evangelica. Non ci spinge verso la libertà mettendoci in carcere, ma ci schiavizza, invitandoci a palazzo e colmandoci di onori. Non ci colpisce il corpo, ma prende possesso del cuore; non ci taglia la testa con la spada, ma ci uccide l'anima con il denaro».
Altro che spirito di espropriazione, predicato all’esterno o ai soli sottoposti!
A commento del Tao Tê Ching (xx), il maestro Wang Pi riconosce:
«Il Tao, madre che nutre, è il fondamento della vita. Ma tutti gli uomini mettono da un canto il fondamento che fa vivere le genti, ed hanno in pregio le fioriture dell’accessorio e dell’orpello».
Gesù mette in guardia, affinché non lo smentiamo col nostro comportamento arraffone, amante del lusso, pronto sia alle deferenze che ad assecondare i giochi di potere; performante a ogni costo, sempre affannato per il ruolo e i livelli economici.
«Sogno una Chiesa libera e credibile, una Chiesa povera e per i poveri!» - ha sottolineato Papa Francesco subito dopo l’elezione a pontefice.
Certo, il Figlio di Dio sogna una Chiesa povera [non solo ‘dei poveri’] - ma un elemento di opulenza per noi lo concede, anzi lo vuole: che calziamo i sandali (v.9); a quel tempo in Roma segno di libertà e dignità non accattona).
Sì, perché dobbiamo riscoprire l’umano - e camminare molto.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
In che modo partecipi della Missione di Gesù e dei discepoli? Come puoi evitare le chiusure culturali, dottrinali o di carisma (già tutto progettato-regolato), e vivere l’universalità della nuova umanizzazione?
Pulire gli occhi dell’anima. Il successo lo lasciano a Dio
Nel Vangelo […] Gesù prende l’iniziativa di inviare i dodici Apostoli in missione (cfr Mc 6,7-13). In effetti il termine «apostoli» significa proprio «inviati, mandati». La loro vocazione si realizzerà pienamente dopo la risurrezione di Cristo, con il dono dello Spirito Santo a Pentecoste. Tuttavia, è molto importante che fin dall’inizio Gesù vuole coinvolgere i Dodici nella sua azione: è una specie di «tirocinio» in vista della grande responsabilità che li attende. Il fatto che Gesù chiami alcuni discepoli a collaborare direttamente alla sua missione, manifesta un aspetto del suo amore: cioè Egli non disdegna l’aiuto che altri uomini possono recare alla sua opera; conosce i loro limiti, le loro debolezze, ma non li disprezza, anzi, conferisce loro la dignità di essere suoi inviati. Gesù li manda a due a due e dà loro istruzioni, che l’Evangelista riassume in poche frasi. La prima riguarda lo spirito di distacco: gli apostoli non devono essere attaccati al denaro e alla comodità. Gesù poi avverte i discepoli che non riceveranno sempre un’accoglienza favorevole: talvolta saranno respinti; anzi, potranno essere anche perseguitati. Ma questo non li deve impressionare: essi devono parlare a nome di Gesù e predicare il Regno di Dio, senza essere preoccupati di avere successo. Successo. Il successo lo lasciano a Dio […]
Gesù avverte i Dodici che potrà accadere che in qualche località vengano rifiutati. In tal caso dovranno andarsene altrove, dopo aver compiuto davanti alla gente il gesto di scuotere la polvere sotto i piedi, segno che esprime il distacco in due sensi: distacco morale – come dire: l’annuncio vi è stato dato, siete voi a rifiutarlo – e distacco materiale – non abbiamo voluto e non vogliamo nulla per noi (cfr Mc 6,11). L’altra indicazione molto importante del brano evangelico è che i Dodici non possono accontentarsi di predicare la conversione: alla predicazione si deve accompagnare, secondo le istruzioni e l’esempio Gesù, la cura dei malati. Cura dei malati corporale e spirituale. Parla delle guarigioni concrete delle malattie, parla anche dello scacciare i demoni cioè purificare la mente umana, pulire, pulire gli occhi dell’anima che sono oscurati dalle ideologie e perciò non possono vedere Dio, non possono vedere la verità e la giustizia. Questa duplice guarigione corporale e spirituale è sempre il mandato dei discepoli di Cristo. Quindi la missione apostolica deve sempre comprendere i due aspetti di predicazione della parola di Dio e di manifestazione della sua bontà con gesti di carità, di servizio e di dedizione.
[Papa Benedetto, omelia Frascati 15 luglio 2012]
Vocazione integrale, Annuncio, e rispetto. Proposta alla libertà
7. L'urgenza dell'attività missionaria emerge dalla radicale novità di vita, portata da Cristo e vissuta dai suoi discepoli. Questa nuova vita è dono di Dio, e all'uomo è richiesto di accoglierlo e di svilupparlo, se vuole realizzarsi secondo la sua vocazione integrale in conformità a Cristo. Tutto il Nuovo Testamento è un inno alla vita nuova per colui che crede in Cristo e vive nella sua chiesa. La salvezza in Cristo, testimoniata e annunziata dalla chiesa, è autocomunicazione di Dio: «È l'amore che non soltanto crea il bene, ma fa partecipare alla vita stessa di Dio: Padre, Figlio e Spirito santo. Infatti, colui che ama, desidera donare se stesso».
Dio offre all'uomo questa novità di vita. «Si può rifiutare Cristo e tutto ciò che egli ha portato nella storia dell'uomo? Certamente si può. L'uomo è libero. L'uomo può dire a Dio: no. L'uomo può dire a Cristo: no. Ma rimane la domanda fondamentale: È lecito farlo? e in nome di che cosa è lecito?».
8. Nel mondo moderno c'è la tendenza a ridurre l'uomo alla sola dimensione orizzontale. Ma che cosa diventa l'uomo senza apertura verso l'Assoluto? La risposta sta nell'esperienza di ogni uomo, ma è anche inscritta nella storia dell'umanità col sangue versato in nome di ideologie e da regimi politici, che hanno voluto costruire un'«umanità nuova» senza Dio.
Del resto, a quanti sono preoccupati di salvare la libertà di coscienza, risponde il Concilio Vaticano II: «La persona umana ha il diritto alla libertà religiosa...Tutti gli uomini devono essere immuni dalla coercizione da parte di singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potestà umana, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la coscienza, né sia impedito, entro certi limiti, di agire in conformità a essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata».
L'annunzio e la testimonianza di Cristo, quando sono fatti in modo rispettoso delle coscienze, non violano la libertà. La fede esige la libera adesione dell'uomo, ma deve essere proposta, poiché «le moltitudini hanno il diritto di conoscere la ricchezza del mistero di Cristo, nel quale crediamo che tutta l'umanità può trovare, in una pienezza insospettabile, tutto ciò che essa cerca a tentoni su Dio, sull'uomo e sul suo destino, sulla vita e sulla morte, sulla verità... Per questo la chiesa mantiene il suo slancio missionario e vuole, altresì, intensificarlo nel nostro momento storico». Bisogna dire anche, però, sempre col Concilio, che «a motivo della loro dignità tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotati cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. Essi sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e a ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze».
[Papa Giovanni Paolo II, Redemptoris Missio]
Unzione della vicinanza
Sono contento di poter mantenere l’appuntamento domenicale dell’Angelus, anche qui dal Policlinico “Gemelli”. Vi ringrazio tutti: ho sentito la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere. Grazie di cuore! Il Vangelo che si legge oggi nella Liturgia narra che i discepoli di Gesù, inviati da Lui, «ungevano con olio molti infermi e li guarivano» (Mc 6,13). Questo “olio” ci fa pensare anche al sacramento dell’Unzione dei malati, che dà conforto allo spirito e al corpo. Ma questo “olio” è anche l’ascolto, la vicinanza, la premura, la tenerezza di chi si prende cura della persona malata: è come una carezza che fa stare meglio, lenisce il dolore e risolleva. Tutti noi, tutti, abbiamo bisogno prima o poi di questa “unzione” della vicinanza e della tenerezza, e tutti possiamo donarla a qualcun altro, con una visita, una telefonata, una mano tesa a chi ha bisogno di aiuto. Ricordiamo che, nel protocollo del giudizio finale – Matteo 25 – una delle cose che ci domanderanno sarà la vicinanza agli ammalati.
[Papa Francesco, Angelus 11 luglio 2021]
Tirocinio: irradiarsi di un Volto, da un Centro
Il Vangelo di oggi (cfr Mc 6,7-13) narra il momento in cui Gesù invia i Dodici in missione. Dopo averli chiamati per nome ad uno ad uno, «perché stessero con lui» (Mc 3,14) ascoltando le sue parole e osservando i suoi gesti di guarigione, ora li convoca di nuovo per «mandarli a due a due» (6,7) nei villaggi dove Lui stava per recarsi. E’ una sorta di “tirocinio” di quello che saranno chiamati a fare dopo la Risurrezione del Signore con la potenza dello Spirito Santo.
Il brano evangelico si sofferma sullo stile del missionario, che possiamo riassumere in due punti: la missione ha un centro; la missione ha un volto.
Il discepolo missionario ha prima di tutto un suo centro di riferimento, che è la persona di Gesù. Il racconto lo indica usando una serie di verbi che hanno Lui per soggetto – «chiamò a sé», «prese a mandarli», «dava loro potere», «ordinò», «diceva loro» (vv. 7.8.10) –, cosicché l’andare e l’operare dei Dodici appare come l’irradiarsi da un centro, il riproporsi della presenza e dell’opera di Gesù nella loro azione missionaria. Questo manifesta come gli Apostoli non abbiano niente di proprio da annunciare, né proprie capacità da dimostrare, ma parlano e agiscono in quanto “inviati”, in quanto messaggeri di Gesù.
Questo episodio evangelico riguarda anche noi, e non solo i sacerdoti, ma tutti i battezzati, chiamati a testimoniare, nei vari ambienti di vita, il Vangelo di Cristo. E anche per noi questa missione è autentica solo a partire dal suo centro immutabile che è Gesù. Non è un’iniziativa dei singoli fedeli né dei gruppi e nemmeno delle grandi aggregazioni, ma è la missione della Chiesa inseparabilmente unita al suo Signore. Nessun cristiano annuncia il Vangelo “in proprio”, ma solo inviato dalla Chiesa che ha ricevuto il mandato da Cristo stesso. È proprio il Battesimo che ci rende missionari. Un battezzato che non sente il bisogno di annunciare il Vangelo, di annunciare Gesù, non è un buon cristiano.
La seconda caratteristica dello stile del missionario è, per così dire, un volto, che consiste nella povertà dei mezzi. Il suo equipaggiamento risponde a un criterio di sobrietà. I Dodici, infatti, hanno l’ordine di «non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro nella cintura» (v. 8). Il Maestro li vuole liberi e leggeri, senza appoggi e senza favori, sicuri solo dell’amore di Lui che li invia, forti solo della sua parola che vanno ad annunciare. Il bastone e i sandali sono la dotazione dei pellegrini, perché tali sono i messaggeri del regno di Dio, non manager onnipotenti, non funzionari inamovibili, non divi in tournée. Pensiamo, ad esempio, a questa Diocesi della quale io sono il Vescovo. Pensiamo ad alcuni santi di questa Diocesi di Roma: San Filippo Neri, San Benedetto Giuseppe Labre, Sant’Alessio, Santa Ludovica Albertini, Santa Francesca Romana, San Gaspare Del Bufalo e tanti altri. Non erano funzionari o imprenditori, ma umili lavoratori del Regno. Avevano questo volto. E a questo “volto” appartiene anche il modo in cui viene accolto il messaggio: può infatti accadere di non essere accolti o ascoltati (cfr v. 11). Anche questo è povertà: l’esperienza del fallimento. La vicenda di Gesù, che fu rifiutato e crocifisso, prefigura il destino del suo messaggero. E solo se siamo uniti a Lui, morto e risorto, riusciamo a trovare il coraggio dell’evangelizzazione.
La Vergine Maria, prima discepola e missionaria della Parola di Dio, ci aiuti a portare nel mondo il messaggio del Vangelo in una esultanza umile e radiosa, oltre ogni rifiuto, incomprensione o tribolazione.
[Papa Francesco, Angelus 15 luglio 2018]
4a Domenica T.O.
IV Domenica del tempo ordinario (anno A) [1 Febbraio 2026]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Rileggere e meditare le Beatitudini nel vangelo di Matteo è sempre un invito a riscoprire il cuore della fede evangelica e ad avere il coraggio di viverla fedelmente.
*Prima Lettura dal libro del profeta Sofonia (2,3; 3,12-13)
Il libro di Sofonia è sorprendente per i suoi forti contrasti: da una parte ci sono terribili minacce contro Gerusalemme, con il profeta che appare molto collerico; dall’altra, vi sono incoraggiamenti e promesse di un futuro felice, sempre rivolti alla città. La domanda è: a chi sono rivolte le minacce e a chi gli incoraggiamenti? Storicamente, siamo nel VII secolo a.C., nel regno di Giuda, il regno del Sud. Il giovane re Giosia sale al trono a otto anni, dopo l’assassinio del padre, in tempi molto turbolenti. L’impero assiro, con capitale Ninive, è in espansione e i re locali preferiscono spesso arrendersi per evitare la distruzione: Gerusalemme diventa vassalla di Ninive. I profeti, però, sostengono fermamente la libertà del popolo eletto: chiedere alleanza a un re terreno significa non confidare nel Re del cielo. Accettare la tutela assira non è solo un atto politico, ma comporta l’influenza culturale e religiosa del dominatore, con rischi di idolatria e perdita della missione di Israele. Sofonia denuncia tutto questo e profetizza la punizione: “Alzerò la mano contro Giuda e contro tutti gli abitanti di Gerusalemme… il Giorno dell’ira del Signore” (So 1,4-6), testo che ricorda il famoso Dies Irae. Cercate il Signore, voi tutti, gli umili del paese. Accanto alle minacce, Sofonia rivolge un messaggio di conforto agli “umili del paese” (in ebraico anawim, i curvi), che sono osservanti della legge e giusti, protetti quindi dal Giorno dell’ira del Signore: Dio stesso è con loro. È il giorno in cui la creazione sarà rinnovata e il male distrutto. Il messaggio non è per altri, ma per ciascuno di noi: siamo tutti chiamati alla conversione, a diventare “umili del paese”, il “Resto di Israele” che i profeti precedenti avevano annunciato. Dio, fedele, salverà sempre almeno un piccolo gruppo rimasto fedele. Sarà questo piccolo resto, povero e umile, a portare avanti la missione del popolo eletto: rivelare al mondo il progetto di Dio. Essere umili significa riconoscere la propria limitatezza (humus) e confidare totalmente in Dio. Così, il giudizio di Dio non è contro le persone, ma contro il male che corrompe. Il piccolo resto fedele sarà il fermento nel mondo, preservando la vera identità del popolo e la missione divina. l’ira di Dio colpisce solo il male, mai l’innocente. Sofonia critica anche l’adozione delle usanze assire, come l’abbigliamento straniero (So 1,8): non era solo moda, ma segno di imitazione dei pagani, rischio di perdere identità e fede.
*Salmo responsoriale (145/146)
Abbiamo qui tre versetti del Salmo come un inventario dei beneficiari della misericordia di Dio: gli oppressi, gli affamati, gli incatenati, i ciechi, gli afflitti, gli stranieri, le vedove e gli orfani—tutti coloro che gli uomini ignorano o disprezzano. Gli Israeliti conoscono queste situazioni perché le hanno vissute: oppressione in Egitto, poi a Babilonia. Il Salmo è stato scritto dopo il ritorno dall’esilio babilonese, forse per la dedica del Tempio ricostruito. La liberazione dal male e dall’oppressione è percepita come prova della fedeltà di Dio all’alleanza: “Il Signore fa giustizia agli oppressi, il Signore scioglie gli incatenati”. Dio provvede anche ai bisogni materiali: durante l’Esodo, ha nutrito il popolo con manna e quaglie. Gradualmente, Dio rivela se stesso ai ciechi, rialza gli afflitti e guida il popolo verso la giustizia: “Dio ama i giusti”. Il Salmo è quindi un canto di riconoscenza: “Il Signore fa giustizia agli oppressi / agli affamati dà il pane / scioglie gli incatenati / apre gli occhi ai ciechi / rialza gli afflitti / ama i giusti / protegge lo straniero / sostiene vedove e orfani. Il Signore è il tuo Dio per sempre.” L’insistenza sul nome Signore (7 volte) richiama il Tetragramma sacro YHVH, rivelato a Mosè al roveto ardente, simbolo della presenza costante e liberatrice di Dio. “Il Signore é il tuo Dio per sempre, la frase finale richiama l’Alleanza: “Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio”. Il Salmo guarda al futuro, rafforzando la speranza del popolo. Il nome di Dio Ehiè asher ehiè (Io sono colui che sono / Sarò colui che sarò) sottolinea la sua presenza eterna. Ripetere questo Salmo serve a riconoscere l’opera di Dio e a orientare la condotta: se Dio ha agito così verso Israele, il popolo deve comportarsi allo stesso modo verso gli altri, specialmente gli esclusi. La Legge di Israele prevedeva regole per proteggere vedove, orfani e stranieri, affinché il popolo fosse libero e rispettoso della libertà altrui. I profeti giudicavano la fedeltà all’Alleanza principalmente in base all’atteggiamento verso i poveri e gli oppressi: lotta contro l’idolatria, promozione della giustizia e della misericordia, come in Os 6,6 (Desidero misericordia, non sacrifici) e Mi 6,8 (Agisci con giustizia, ama la fedeltà, cammina umilmente con Dio). Anche il Siracide ricorda: “Le lacrime della vedova scorrono sul volto di Dio” (Si 35,18), sottolineando che chi è vicino a Dio deve sentire compassione per chi soffre.
*Seconda Lettura dalla prima lettera di san paolo apostolo ai Corinti (1,26-31).
Sembrerebbe la parabola del fariseo e del pubblicano: il mondo è “capovolto”. Chi appare saggio agli occhi degli uomini, come sottolinea Paolo, non riceve considerazione davanti a Dio. Questo non significa che Paolo disprezzi la saggezza: sin dal re Salomone essa è una virtù richiesta nella preghiera, e Isaia la presenta come dono dello Spirito di Dio: “Su di lui riposerà lo Spirito del Signore, spirito di sapienza e di discernimento…” La Bibbia distingue due tipi di saggezza: la saggezza degli uomini e la saggezza di Dio. Ciò che agli occhi degli uomini sembra ragionevole può essere lontano dal progetto di Dio, e ciò che è saggio agli occhi di Dio può apparire folle agli uomini. La nostra logica è umana, quella di Dio è logica dell’amore: la follia dell’amore divino, come dice Paolo, supera ogni ragionamento umano. Per questo la vita e la morte di Cristo possono sembrare scandalose. Isaia lo dice chiaramente: “I miei pensieri non sono i vostri pensieri, e i vostri modi non sono i miei modi” (Is 55,8). Questa distanza tra pensiero umano e divino è tale che Gesù arriva a rimproverare Pietro: “Va’ dietro a me, Satana! Tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini” (Mt 16,23). Dio è il “Tutto-Altro”: la gerarchia dei valori umani è capovolta davanti a lui. Spesso nella storia dell’Alleanza, Dio sceglie i più piccoli: pensiamo a Davide, il più giovane tra i figli di Iesse, o al popolo d’Israele, “il più piccolo di tutti” (Dt 7,7; Dt 9,6). Le scelte di Dio sono gratuite, indipendenti dal merito umano. La vera saggezza, la saggezza divina è dono di Non possiamo comprendere Dio con le nostre forze: tutto ciò che sappiamo di Lui ci è rivelato da Lui. Paolo ricorda ai Corinzi che ogni conoscenza di Dio è un dono: “In lui avete ricevuto tutte le ricchezze… nessun dono di grazia vi manca” (1 Cor 1,4-7). Il dono della conoscenza di Dio non è motivo di orgoglio, ma di gratitudine. Come dice Geremia: “Il saggio non si vanti della sua saggezza… ma di avere intelligenza per conoscere me, il Signore” (Jr 9,22-23). Paolo applica questi principi ai Corinzi: essi, agli occhi del mondo, non erano né sapienti, né potenti, né nobili. Eppure Dio li chiama, creando la sua Chiesa dalla loro povertà e debolezza. La loro “nobiltà” è il Battesimo. Corinto diventa esempio dell’iniziativa sorprendente di Dio, che ricrea il mondo secondo la sua logica, invitando gli uomini non a vantarsi davanti a Dio, ma a renderGli gloria per il suo amore.
*Dal Vangelo secondo Matteo (5,1-12a)
Mi fermo a riflettere sulla beatitudine che può sembrare più difficile: “Beati quelli che piangono, perché saranno consolati” (Mt 5,4). Non si tratta di gioire per il pianto in sé, né di considerare la sofferenza come una fortuna. Gesù stesso ha dedicato gran parte della sua vita a consolare, guarire e incoraggiare le persone: Matteo ci ricorda che “Gesù proclamava la Buona Novella del Regno e guariva ogni malattia e infermità tra il popolo” (Mt 4,23). Le lacrime di cui parla Gesù sono, piuttosto, lacrime di pentimento e lacrime di compassione. Pensiamo a san Pietro, che dopo il suo rinnegamento pianse amaramente, trovando consolazione nella misericordia di Dio. Oppure ricordiamo la visione del profeta Ezechiele: al giorno ultimo, Dio “segnerà con una croce sulla fronte quelli che gemono e si lamentano per le abominazioni che si commettono” (Ez 9,4). Queste parole di Gesù erano rivolte ai suoi contemporanei ebrei, abituati alla predicazione dei profeti. Per noi, comprenderle significa rileggere l’Antico Testamento. Come ci invita il profeta Sofonia: “Cercate il Signore, voi tutti gli umili della terra” (So 2,3). E il salmo canta: “Ho chiesto una cosa al Signore: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita» (Sal 145/146,5). Questi sono i veri “poveri di cuore”, quelli che si affidano completamente a Dio, come il pubblicano della parabola: consapevoli dei propri peccati, si aprono alla salvezza del Signore. Gesù ci assicura: chi cerca Dio con tutto il cuore sarà esaudito: “Cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto” (Mt 7,7). E i profeti chiamano “puri” coloro il cui cuore è rivolto unicamente a Dio. Le Beatitudini, dunque, sono Buona Notizia: non è il potere, il sapere o la ricchezza a guidarci al Regno, ma la dolcezza, la misericordia e la giustizia. Come dice Gesù ai suoi discepoli: “Vi mando come agnelli in mezzo ai lupi” (Lc 10,3). Ogni beatitudine indica un cammino verso il Regno: ogni “Beati” è un invito, un incoraggiamento: è come se dicesse, “coraggio sei sulla strada giusta”. Le nostre debolezze diventano terreno fertile per la presenza di Dio: la povertà del cuore, le lacrime, la fame di giustizia, la persecuzione. Paolo ci ricorda: “Chi vuol vantarsi, si vanti nel Signore” (1 Cor 1,31). Infine, ricordiamo che Gesù è il modello perfetto: povero di cuore, dolce, misericordioso, compassionevole, giusto e perseguitato, sempre grato al Padre. La sua vita ci insegna a guardare noi stessi e gli altri con gli occhi di Dio, e a scoprire il Regno dove meno ce lo aspettiamo.
Scrive sant’Agostino commentando questa beatitudine: «Beati, dice il Signore, quelli che piangono, perché saranno consolati. Non indica la tristezza del corpo, ma il dolore del cuore per i peccati, e la volontà di convertirsi a Dio» (Enarrationes in Psalmos, 30,5).
+Giovanni D’Ercole
Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)
Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)
You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]
Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]
In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)
In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)
Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)
Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)
In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)
Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))
Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.