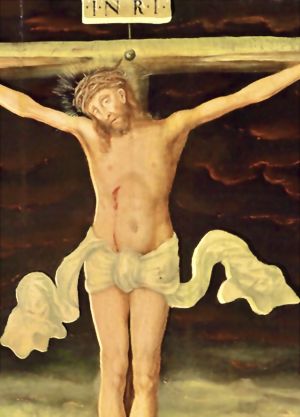don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Istanze del mondo, idea di ‘perfezione’, senso del Cristo
(Lc 21,5-11)
Nel suo Discorso Apocalittico Lc vuol farci meditare sul senso della storia e su ‘ciò che permane’... ma quante condizioni avverse e opposizioni!
Quindi mira a sostenere la speranza [non fittizia e tuttavia frustrata] della gente povera e sotto persecuzione delle sue comunità.
Certo, la Fede volge al Dio che guida la storia. Egli ne è Signore; però l’oggi rimane oscuro e incerto; in tal guisa restiamo come braccati da istanze che non ci corrispondono - ma sopravanzano.
Anche alcuni credenti iniziavano a dubitare: Dio ha davvero il controllo dei fatti e del cosmo? È la stessa domanda che ci poniamo oggi: in mezzo a tante sciagure, dove andremo a finire?
Come mordere la vita e realizzarsi pur nell’emergenza? In che modo vivere i conflitti e lo sconcerto, senza lasciarsi travolgere dagli eventi? Come mai affiorano tante oscurità, che non ci piacciono?
In tempi di mutamento, insicurezza globale e inquietudine politica, continuano a spuntare carie parassite, che accentuano il disorientamento, sentimenti d’inadeguatezza; forse i sensi di colpa.
Ecco gli astuti del quartierino che (pure nel sottobosco ecclesiale) vogliono trarre vantaggio dal turbamento e dalla confusione, ingannando le anime deboli e spaesate - perfino i giovani.
Per non farsi abbindolare, confondere e plagiare, deve subentrare una migliore consapevolezza, un affinamento della percezione, onde discernere il senso dei “regni” che si avvicendano e passano.
La sovranità di Dio propugna una maturazione della ‘messe’ con la luce e il calore dello Spirito, un più approfondito discernimento sul genio e i fatti del secolo.
Non escluse le brutture: anch’esse hanno il potere di attivarci, per cercare nuove armonie.
La Chiesa autentica ha una nuova Visione, che appunto caldeggia questi terremoti e calamità, ossia gli sconquassi del mondo antico - esso che, oggi come sempre, traballa e volge alla fine.
D’altro canto i sommovimenti non disintegrano la creazione: ne preparano una radicalmente nuova.
Bisogna resistere dentro e applicarsi - forse avendo più cura del carattere del tempo, degli amici inconsueti dell’anima, e trascurando l’idea ereditata [o imposta] di “perfezione”.
Tanti mondi costruiti dalla mente e dalle mani dell’uomo s’immaginavano perpetui, addirittura il Fine di tutto.
Invece continuano a crollare, trascinando via antiche espressioni, convinzioni, costumi, egemonie, visioni delle cose…
Ogni era porta con sé lo sgretolamento delle umane edificazioni e dei suoi imperi - fragili e inconsistenti, nonostante le apparenze contrarie (e il senso di permanenza con cui li interpretavamo).
Quindi anche il Tempio di mattoni e stucchi - centro della vita e dell’identità del popolo - è destinato all’agonia, alla frantumazione, alla più miserevole rovina, a essere raso al suolo... malgrado la sua imponente magnificenza.
Ci disorienta, certo. Ma se unilaterale, non più rende presente, bensì dissolve il Mistero - concentrazione di novità e amore.
Quando ad esempio si chiudono le frontiere culturali [e la ricerca di profondità] per timore dei “problemi”, e ci si fa intransigenti, il presente devoto diviene una pura realtà del mondo, che presto o tardi sarà smantellata.
Le funzioni della terra non hanno altra legge che quella di perire: sono minate alla base, destinate a evaporare. In un attimo passano dal controllo allo sfaldamento e dal predominio all’insignificanza.
Bellezza radiosa e “spessore” della città eterna e santa - coi suoi gelosi privilegi, nonché dottrine minute o generaliste (e terrificanti) - si tramutano in un sorpasso e rovesciamento: in un profilo di morte.
Basta un capovolgimento.
Futile immaginarla duratura e tenerla in piedi a tutti i costi.
Viceversa, il Regno nuovo si presenta intimo e sottovoce: per questo non rimane scheggiato da eventi esterni.
Ad alcuni sconvolgimenti non bisogna tanto resistere, quanto stare con essi.
L’obbiettivo è ‘ri-nascere’ - come figli, ancora rigenerati, che percorrono un altro Eros fondante [cui abbandonarsi, altrimenti non potrà svolgere la sua alta funzione].
Esso si stabilisce nei cuori e li trasforma; li cementa, senza clamore: con una potenza grandissima, sovversiva, che fa scattare nuove forme - ma con virtù segreta.
Ha un altro passo, accogliente, e un diverso tempo.
Così non perdiamo alcuna parte di noi, anzi facciamo crescere tutti i lati della personalità e delle relazioni.
È la Fede plurale che accoglie gli opposti, a solidificare le pietre.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Come vivi gli sconvolgimenti?
Appalti la tua libertà e insegui ciarlatani che fissano e peggiorano l’esistenza di tutti - o in Cristo li osteggi, accendendo Speranza e le tue potenze segrete più sfolgoranti (anche opposte)?
Il Roveto
Fede eccezionale, Conversione ardente
(Es 3,2-4)
Conversione in senso biblico non è tornare indietro, ma entrare dentro sé per non estraniarsi, e ritrovare la propria radice onde saper intervenire, liberando la vampa della propria Relazione essenziale.
La conversione non ha a che fare col tatticismo disinteressato di chi si chiude al mondo, evitando di farsi coinvolgere sino al momento in cui gli eventi non abbiano ripercussioni negative sui propri interessi.
Ma come prendere le misure della realtà, come comprenderla? Come capire se stessi? E da dove attingere orientamento, sapienza e forza per proporre soluzioni sagge e azioni efficaci?
Mosè è un fuoriuscito perché precipitoso. Il suo fare impulsivo lo ha costretto a fuggire nel deserto. Qui combina altri pasticci, ancora a causa del suo temperamento focoso. Così decide di darsi una calmata e una sistemazione.
Ma la soluzione non è quella di non immischiarsi in favore degli altri, scegliendo forzosamente una vita quieta. Quel suo Fuoco che gli brucia il petto e la mente non si estingue; anche sopito, lo porta sempre con sé.
Solo Dio capisce che proprio il suo lato oscuro e la sua carica irascibile - come nessun’altra energia - può renderlo protagonista d’’un disegno assurdo, in favore del popolo, e gli farà calcare situazioni e territori impervi.
Un compito rischioso, che obbligherà a tirar fuori la grinta, le pulsioni, la convinzione; ogni risorsa anche poco virtuosa. Una Missione unicamente sua, impossibile per altri animi più equilibrati e tranquilli.
Come spiegare la passione per la libertà degli umiliati?
Ce la troviamo dentro, come una fiamma che arde e non dà tregua. Essa risorge spontaneamente, malgrado i prudenti tentativi di soffocarla.
Per i suoi pazzeschi disegni di redenzione, Dio ha bisogno di qualcuno esattamente come noi, così come siamo. Con le nostre immense Risorse inespresse, celate persino dietro individuali puntigli sanguigni.
Qualità che sorgono spontanee e hanno un loro cammino di conversione, ma che prima o poi devono scendere in campo così come sono.
Esprimono noi stessi profondamente, e il Richiamo del Padre.
Diversi condizionamenti possono creare errori di percezione della nostra unicità personale; altrettanto, del suo sviluppo e destinazione.
Il grande rischio è quello di spendere la vita dissipando l’identità caratteriale alla ricerca d’illusioni indotte e riflessi condizionati: di ciò che non siamo e neanche vogliamo.
Non solo le distrazioni, ma anche il troppo ragionare può farci smarrire la via di quella dimora ch’è davvero nostra.
Continuare a insistere su ciò che danneggia lo sviluppo dell’anima e la sua piena fioritura, la rende indecisa o astuta e cocciuta - soprattutto se suggestionabile, timorosa, o anche ricettiva e indifesa.
Il nostro Eros fondante scende in campo quando si accorge che la realtà o il suo paradigma culturale (definito) possono farci perdere la strada.
La Vocazione allora si manifesta alla personale ‘visione’ in una sorta d’Immagine energetica, riservata e unica, che fa pensare coi sogni, ci fa da guida, trascina non si sa già perché e dove.
I credenti che sperimentano questo Fuoco interiore che non si estingue non sono introdotte in un mondo che vuole solo perdurare, tutto già cesellato e che ben conosce la mèta.
La Fiamma del Padre non si esprime attraverso artificiosità da recitare: vuole recuperare e condurre a casa tutte le risorse, la nostra essenza e i suoi monili - da esaltare invece che nascondere.
Gioielli tutti da estrarre dal mondo delle certezze disattente e rinchiuse. Fiori all’occhiello - non di rado celati dietro versanti e propensioni che (per l’occhio logorato da luoghi comuni) appaiono oscuri.
Spesso è proprio il nostro lato sconosciuto agli schemi la ‘scintilla’ che incalza e fa da terapia all’anima malata; la prende per mano, e con dovuta energia diventa guida alla scoperta rilevante di sé - e grande servizio altrui.
Il Roveto ardente nella carne - Rivelazione divina - si accende affinché realizziamo il Sogno dei nostri stessi sogni. Non perché l’anima diventi sempre più uguale e legata, o fondamentalista.
E solo il nostro Nucleo Fiaccola-che-non-si-consuma continuamente in atto, può evitare che chi nasce rivoluzionario dello spirito, poi [ma anche in fretta] sopravviva da poltronista.
Capita nella banalità delle ideologie come nel conformismo delle religioni, però non può succedere nella sfera della vita di Fede.
In tal guisa, la danza non è condotta da estraneità di controllo: fini, intenzioni, idee, progetti, o codici... bensì da potenze passionali e pulsive, che ogni giorno c’interrogano sulla marea che viene a trovarci.
La Provvidenza fa da regista, corteggia e dirige misteriosamente strategie irripetibili, che solcano la storia attraendo e trascinando, sbloccando meccanismi e potenziando energie - persino facendoci cambiare, rimodulare, o accentuare caratteri.
A tali linee personalissime ci si deve abbandonare. Non per bisogno, dovere, calcolo, né solo per capire qualcosa in più, bensì per goderne la Luce spirituale; i raggi d’Amore, vicini e lontani, creativi dell’interiore e di forze geniali [al contorno].
La Fiamma torna a speronarci per riaccendere il balsamo personale dell’istintività, le possibilità di realizzazione della nostra natura.
Il desiderio assurdo ch’esplode dentro vuole espandere le possibilità di Linfa - sia dell’albero che delle stesse radici - per farci diventare persone a tutto tondo.
Così non cercheremo più di assomigliare ai nostri “modelli”:
Il principio di tale trasmutazione che irrompe sullo scenario placido e convenzionale ha riproposto il motivo per cui siamo al mondo.
È il nostro compito che salva la vita... o l’aridità stessa dei “tipi” cui adeguarsi.
Eccoci allora ad azzerare e sorprendere il nostro lato nostalgico e morto, o il male oscuro di vivere - e lo sfiancarsi per una saggezza che non ha il di più della Sapienza.
Spento il fulgore e il bello della Fiaccola, la sua virtù energetica sulla nostra carne affievolisce, smorzando l’entusiasmo dell’anima - estinguendo l’agire (come in una posizione d’inedia).
Lo stato passionale è la forza del pensiero e dell’intelletto pratico.
Il coinvolgimento intimo fa volare la nostra identità-carattere, e ha ripercussioni significative sul prossimo.
È custodia dell’indipendenza. E ci integra, surclassando il senso d’imperfezione - o vuoto esistenziale.
L’Energia primordiale intelligente riconosce la nostra essenza; e riporta l’anima dalle vicende esterne al Nucleo: dalle vicissitudini, dalle cose, dalle ferite, al nostro essere intimo e più ricco.
Sa che dallo stimolo di tale centro sorgivo - legame intimo d’origine, primordiale - sprizzeranno eventi sbalorditivi, propensioni sconosciute, magie di accadimenti imprevisti.
Una nuova Creazione.
Da questa Casa della nuova vita e dei differenti inni, si sprigiona tutto un mondo di relazioni... nuovi impegni, intuizioni geniali; attitudini pratiche, che tessono la magia dell’anima sposa corrisposta.
È tale Fonte che subentra ancora, quando si accorge che non siamo compiuti, o che ci sentiamo da essa stessa traditi - ovvero per sorvolare le paure, il senso di desolazione, gli abbandoni amari. Come una potenza che richiama a noi stessi, ai nostri talenti inespressi, all’energia dello sguardo che coglie il senso di una storia, del genio del nostro territorio o tempo. E li varca, facendoci sporgere.
Diventa la bussola quotidiana della vita e delle trasformazioni. Ma sopporta male l’interferenza dei giudizi esterni, che non abitano nel profondo ma contribuiscono a creare l’atmosfera che circuisce attorno.
Sembra una forza che accade, un’energia che non può essere diretta né spiegata da un universo di significati pronti all’uso, da emozioni e simboli pianificanti, o manipolata per ottenere sottomissioni.
Pronta a risorgere come, quando e perché non ci aspettiamo; solo per rigenerare e rendere esponenziale l’inconsueta, autonoma semenza dell’anima. Così com’è: lo sforzo ascetico darebbe risultati scadenti.
La Sorgente nascosta si esprime in eventi impregnati di futuro, inzuppati da un’atmosfera di Presenza.
Accadimenti intrisi d’un intero versante della nostra personalità, e non solo di qualche propaggine del suo senso sociale [a nomenclatura].
Le Radici si manifestano in azioni che contengono saperi ancora inespressi ma fortemente potenziali, affettivamente vitali. Esse risolvono i problemi agendo a modo loro.
Proprio ciò che non conosciamo ancora di noi stessi (attitudini, desideri) può essere il segreto, la molla della nostra fioritura. Una scoperta che sgorga innata, non un strada insegnata e riconosciuta maestra.
La vera misura è più profonda.
Ci si smarrisce nelle banalità, se non si scopre il seme personale - e si presuppone di sapere già la direzione: cosa amare, come dire e fare secondo istruzioni.
Il mondo dei saperi acquisiti è viceversa spesso nemico del processo nascosto, il quale continua a voler svolgere il suo tema, e ripudiare ciò che non vuole assorbire, perché lo controbatterebbe.
Ed è questa tutta la partita: non affievolire, bensì intuire le attitudini e lasciare che siano, persino contraddittorie.
E danzino senza collocarle, identificarle, metterle in riga secondo costume o ideale - così inebetirle.
La caratteristica peculiare ha il sapore dell’Eterno.
Fa nascere incessantemente uno sguardo rinnovato, che si forma spontaneamente, strada facendo.
Preparando al Nuovo, che non sopporta le aspettative.
Quindi la scintilla imprevista del cuore [che mai combacia] non può essere umiliata, minacciata, frantumata, rimossa, o alienata.
È la nostra Inclinazione consistente, che libera un nitido fulgore d’Unicità.
Nell'odierna pagina evangelica, san Luca ripropone alla nostra riflessione la visione biblica della storia e riferisce le parole di Gesù, che invitano i discepoli a non avere paura, ma ad affrontare difficoltà, incomprensioni e persino persecuzioni con fiducia, perseverando nella fede in Lui. "Quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni - dice il Signore -, non vi terrorizzate. Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine" (Lc 21, 9). Memore di questo ammonimento, sin dall'inizio la Chiesa vive nell'attesa orante del ritorno del suo Signore, scrutando i segni dei tempi e mettendo in guardia i fedeli da ricorrenti messianismi, che di volta in volta annunciano come imminente la fine del mondo. In realtà, la storia deve fare il suo corso, che comporta anche drammi umani e calamità naturali. In essa si sviluppa un disegno di salvezza a cui Cristo ha già dato compimento nella sua incarnazione, morte e risurrezione. Questo mistero la Chiesa continua ad annunciare ed attuare con la predicazione, con la celebrazione dei sacramenti e la testimonianza della carità.
Cari fratelli e sorelle, raccogliamo l'invito di Cristo ad affrontare gli eventi quotidiani confidando nel suo amore provvidente. Non temiamo per l'avvenire, anche quando esso ci può apparire a tinte fosche, perché il Dio di Gesù Cristo, che ha assunto la storia per aprirla al suo compimento trascendente, ne è l'alfa e l'omega, il principio e la fine (cfr Ap 1, 8). Egli ci garantisce che in ogni piccolo ma genuino atto di amore c'è tutto il senso dell'universo, e che chi non esita a perdere la propria vita per Lui, la ritrova in pienezza (cfr Mt 16, 25).
[Papa Benedetto, Angelus 18 novembre 2007]
1. Dopo aver meditato sul traguardo escatologico della nostra esistenza, cioè sulla vita eterna, vogliamo ora riflettere sul cammino che ad esso conduce. Sviluppiamo per questo la prospettiva presentata nella Lettera Apostolica Tertio Millennio Adveniente: “Tutta la vita cristiana è come un grande pellegrinaggio verso la casa del Padre, di cui si riscopre ogni giorno l’amore incondizionato per ogni creatura umana, ed in particolare per il ‘figlio perduto’ (cfr Lc 15, 11-32). Tale pellegrinaggio coinvolge l’intimo della persona allargandosi poi alla comunità credente per raggiungere l’intera umanità” (n. 49).
In realtà, ciò che il cristiano vivrà un giorno in pienezza è già in qualche modo anticipato oggi. La Pasqua del Signore è infatti inaugurazione della vita del mondo che verrà.
2. L'Antico Testamento prepara l'annuncio di questa verità attraverso la complessa tematica dell'Esodo. Il cammino del popolo eletto verso la terra promessa (cfr Es 6, 6) è come una magnifica icona del cammino del cristiano verso la casa del Padre. Ovviamente la differenza è fondamentale: mentre nell’antico Esodo la liberazione era orientata al possesso della terra, dono provvisorio come tutte le realtà umane, il nuovo “Esodo” consiste nell'itinerario verso la casa del Padre, in prospettiva di definitività ed eternità, che trascende la storia umana e cosmica. La terra promessa dell’Antico Testamento fu perduta di fatto con la caduta dei due regni e con l’esilio babilonese, in seguito al quale si sviluppò l'idea di un ritorno come nuovo Esodo. Tuttavia questo cammino non si risolse unicamente in un altro insediamento di tipo geografico o politico, ma si aprì ad una visione “escatologica” che ormai preludeva alla piena rivelazione in Cristo. In questa direzione si muovono appunto le immagini universalistiche, che nel Libro di Isaia descrivono il cammino dei popoli e della storia verso una nuova Gerusalemme, centro del mondo (cfr Is 56-66).
3. Il Nuovo Testamento annuncia il compimento di questa grande attesa, additando in Cristo il Salvatore del mondo: “Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 4, 4-5). Alla luce di questo annuncio la vita presente è già sotto il segno della salvezza. Questa si realizza nell’evento di Gesù di Nazaret che culmina nella Pasqua, ma avrà la sua piena realizzazione nella “parusia”, nell’ultima venuta di Cristo.
Secondo l’apostolo Paolo questo itinerario di salvezza che collega il passato al presente proiettandolo nell'avvenire è frutto di un disegno di Dio, tutto incentrato nel mistero di Cristo. Si tratta del “mistero della sua volontà, secondo quanto, nella sua benevolenza, aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle sulla terra” (Ef 1, 9-10; cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 1042s).
In questo disegno divino, il presente è il tempo del “già e non ancora”, tempo della salvezza già realizzata e del cammino verso la sua perfetta attuazione: “Finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo” (Ef 4, 13).
4. La crescita verso una tale perfezione in Cristo, e perciò verso l’esperienza del mistero trinitario, implica che la Pasqua si realizzerà e celebrerà pienamente solo nel regno escatologico di Dio (cfr Lc 22, 16). Ma l’evento dell’incarnazione, della croce e della risurrezione costituisce già la rivelazione definitiva di Dio. L’offerta di redenzione che tale evento implica si inscrive nella storia della nostra libertà umana chiamata a rispondere all'appello di salvezza.
La vita cristiana è partecipazione al mistero pasquale, come cammino di croce e risurrezione. Cammino di croce, perché la nostra esistenza è continuamente sotto il vaglio purificatore che porta al superamento del vecchio mondo segnato dal peccato. Cammino di risurrezione, perché risuscitando Cristo, il Padre ha sconfitto il peccato, per cui nel credente il “giudizio della croce” diventa “giustizia di Dio”, vale a dire trionfo della sua Verità e del suo Amore sulla perversità del mondo.
5. La vita cristiana è in definitiva una crescita verso il mistero della Pasqua eterna. Essa esige pertanto di tenere fisso lo sguardo alla meta, alle realtà ultime, ma al tempo stesso di impegnarsi nelle realtà ‘penultime’: tra queste e il traguardo escatologico non vi è opposizione, ma al contrario un rapporto di mutua fecondazione. Se va affermato sempre il primato dell’Eterno, ciò non impedisce che viviamo rettamente alla luce di Dio, le realtà storiche (cfr CCC, 1048s).
Si tratta di purificare ogni espressione dell’umano e ogni attività terrena, perché in esse traspaia sempre più il Mistero della Pasqua del Signore. Come infatti ci ha ricordato il Concilio, l’attività umana, che porta sempre con sé il segno del peccato, è purificata ed elevata a perfezione dal mistero pasquale, cosicché “i beni quali la dignità dell'uomo, la fraternità e la libertà, e cioè tutti i buoni frutti della natura e della nostra operosità, dopo che li avremo diffusi sulla terra nello Spirito del Signore e secondo il suo precetto, li ritroveremo poi di nuovo, ma purificati da ogni macchia, illuminati e trasfigurati, allorquando il Cristo rimetterà al Padre il regno eterno e universale” (Gaudium et spes, 39).
Questa luce d’eternità illumina la vita e l’intera storia dell’uomo sulla terra.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 11 agosto 1999]
L’odierno brano evangelico (Lc 21,5-19) contiene la prima parte del discorso di Gesù sugli ultimi tempi, nella redazione di san Luca. Gesù lo pronuncia mentre si trova di fronte al tempio di Gerusalemme, e prende spunto dalle espressioni di ammirazione della gente per la bellezza del santuario e delle sue decorazioni (cfr v. 5). Allora Gesù dice: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta» (v. 6). Possiamo immaginare l’effetto di queste parole sui discepoli di Gesù! Lui però non vuole offendere il tempio, ma far capire, a loro e anche a noi oggi, che le costruzioni umane, anche le più sacre, sono passeggere e non bisogna riporre in esse la nostra sicurezza. Quante presunte certezze nella nostra vita pensavamo fossero definitive e poi si sono rivelate effimere! D’altra parte, quanti problemi ci sembravano senza uscita e poi sono stati superati!
Gesù sa che c’è sempre chi specula sul bisogno umano di sicurezze. Perciò dice: «Badate di non lasciarvi ingannare» (v. 8), e mette in guardia dai tanti falsi messia che si sarebbero presentati (v. 9). Anche oggi ce ne sono! E aggiunge di non farsi terrorizzare e disorientare da guerre, rivoluzioni e calamità, perché anch’esse fanno parte della realtà di questo mondo (cfr vv. 10-11). La storia della Chiesa è ricca di esempi di persone che hanno sostenuto tribolazioni e sofferenze terribili con serenità, perché avevano la consapevolezza di essere saldamente nelle mani di Dio. Egli è un Padre fedele, è un Padre premuroso, che non abbandona i suoi figli. Dio non ci abbandona mai! Questa certezza dobbiamo averla nel cuore: Dio non ci abbandona mai!
Rimanere saldi nel Signore, in questa certezza che Egli non ci abbandona, camminare nella speranza, lavorare per costruire un mondo migliore, nonostante le difficoltà e gli avvenimenti tristi che segnano l’esistenza personale e collettiva, è ciò che veramente conta; è quanto la comunità cristiana è chiamata a fare per andare incontro al “giorno del Signore”. Proprio in questa prospettiva vogliamo collocare l’impegno che scaturisce da questi mesi in cui abbiamo vissuto con fede il Giubileo Straordinario della Misericordia, che oggi si conclude nelle Diocesi di tutto il mondo con la chiusura delle Porte Sante nelle chiese cattedrali. L’Anno Santo ci ha sollecitati, da una parte, a tenere fisso lo sguardo verso il compimento del Regno di Dio e, dall’altra, a costruire il futuro su questa terra, lavorando per evangelizzare il presente, così da farne un tempo di salvezza per tutti.
Gesù nel Vangelo ci esorta a tenere ben salda nella mente e nel cuore la certezza che Dio conduce la nostra storia e conosce il fine ultimo delle cose e degli eventi. Sotto lo sguardo misericordioso del Signore si dipana la storia nel suo fluire incerto e nel suo intreccio di bene e di male. Ma tutto quello che succede è conservato in Lui; la nostra vita non si può perdere perché è nelle sue mani. Preghiamo la Vergine Maria, perché ci aiuti, attraverso le vicende liete e tristi di questo mondo, a mantenere salda la speranza dell’eternità e del Regno di Dio. Preghiamo la Vergine Maria, perché ci aiuti a capire in profondità questa verità: Dio mai abbandona i suoi figli!
[Papa Francesco, Angelus 13 novembre 2016]
Solennità di Cristo Re dell’Universo [23 Novembre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Chiudiamo con animo grato al l’Anno liturgico C preparandoci a riprendere il cammino con l’Avvento.
*Prima Lettura dal secondo libro di Samuele (5,1-3)
Questi sono i primi passi della monarchia in Israele. Tutto comincia a Ebron, antica città delle montagne di Giudea, dove riposano i patriarchi d’Israele: Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea, e persino Giuseppe, le cui ossa furono riportate dall’Egitto. È un luogo carico di memoria e di fede, e proprio qui Davide diventa re di tutte le dodici tribù d’Israele. Dopo la morte di Mosè, verso il 1200 a.C., il popolo d’Israele si stabilì in Palestina. Le tribù vivevano in modo autonomo, unite soltanto dal ricordo della liberazione dall’Egitto e dalla fede nel loro unico Dio. Nei momenti di pericolo, Dio suscitava dei capi temporanei, i Giudici, che guidavano il popolo e spesso agivano anche come profeti. Uno di questi fu Samuele, grande uomo di Dio. Col tempo, però, gli Israeliti vollero essere “come gli altri popoli” e chiesero a Samuele di avere un re. Il profeta ne fu turbato, perché Israele doveva riconoscere solo Dio come Re, ma alla fine, su comando divino, consacrò Saul, il primo re d’Israele. Dopo un inizio promettente, Saul cadde nella disobbedienza e nella follia e Dio scelse un altro uomo: Davide, il giovane pastore di Betlemme, al quale Samuele versò l’olio dell’unzione. Davide non prese subito il potere: servì Saul con fedeltà, divenne suo musicista e valoroso guerriero, amato dal popolo e legato da profonda amicizia a Gionata, il figlio di Saul. Ma la gelosia del re si trasformò in odio, e Davide fu costretto a fuggire, pur rifiutandosi sempre di alzare la mano contro “l’unto del Signore”. Dopo la morte di Saul, Israele si divise: Davide regnava a Ebron sulla tribù di Giuda, mentre al Nord un figlio di Saul regnava per breve tempo. Quando quest’ultimo fu ucciso, le tribù del Nord si radunarono a Ebron e riconobbero Davide come loro re. Quel giorno nacque il regno unito d’Israele: dodici tribù sotto un solo pastore, scelto da Dio e riconosciuto dai fratelli. L’unzione con l’olio sacro fece di Davide il “Messia”, cioè l’“unto del Signore”. Egli doveva essere un re secondo il cuore di Dio, un pastore che guida il suo popolo verso l’unità e la pace. Ma la storia mostrò quanto fosse difficile realizzare questo ideale. Tuttavia, la speranza non morì: Israele attese sempre il vero Messia, il discendente di Davide che avrebbe instaurato un regno eterno. E mille anni dopo, Gesù Cristo, chiamato “Figlio di Davide”, si presentò come il Buon Pastore, colui che offre la vita per il suo gregge. Ogni domenica, nell’Eucaristia, Egli rinnova la sua alleanza e ci dice: “Voi siete del mio stesso sangue.”
*Salmo responsoriale (121/122,1-2,3-4,5-6a.7a)
“Quale gioia quando mi dissero: Andremo alla casa del Signore” . Un pellegrino racconta la sua emozione: dopo un lungo viaggio, finalmente i suoi piedi si fermano alle porte di Gerusalemme. Siamo nel tempo del ritorno dall’esilio babilonese: la città è stata ricostruita, il Tempio restaurato (attorno al 515 a.C.), e il popolo ritrova nella casa del Signore il segno vivo dell’Alleanza. Davanti alla città risorta, il pellegrino esclama: Gerusalemme, eccoti dentro le tue mura, città ben compatta, dove tutto insieme forma un solo corpo! Gerusalemme non è solo un luogo geografico: è il cuore del popolo di Dio, simbolo della unità e della comunione. Ogni pietra, ogni muro ricorda che Israele è un popolo radunato da un’unica promessa e da un destino comune. Dio stesso ha voluto che Israele salisse ogni anno in pellegrinaggio a Gerusalemme, perché il cammino comune e la fatica condivisa mantenessero vivo il legame dell’Alleanza. Per questo il Salmo proclama:”E’ là che salgono le tribù, le tribù del Signore…per lodare il nome del Signore”. Il verbo “salire” indica sia la posizione elevata della città, sia la salita spirituale del popolo verso il suo Dio liberatore, lo stesso che li fece salire cioè uscire dall’Egitto. La formula “le tribù del Signore” richiama l’appartenenza reciproca dell’Alleanza: “Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.” Il pellegrinaggio, fatto a piedi, tra fatica, sete e canti, è un cammino di fede e di fraternità. Quando il pellegrino esclama: Ora il nostro cammino ha fine!, esprime la gioia di chi ha raggiunto non solo una meta geografica, ma anche spirituale: l’incontro con Dio nella città della sua presenza. Rendere grazie al Signore è la vocazione di Israele. Finché il mondo intero non riconoscerà Dio, Israele è chiamato a essere nel mondo il popolo dell’azione di grazie, testimone della fedeltà divina. Così ogni pellegrinaggio a Gerusalemme rinnova la missione di Israele: ringraziare, lodare e mostrare la via alle altre nazioni. Il profeta Isaia aveva preannunciato questo disegno universale:”Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti,e tutte le nazioni affluiranno ad esso…Da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.” (Is 2,2-3) Gerusalemme diventa allora segno profetico del mondo rinnovato, dove tutti i popoli saranno uniti nella stessa lode e nella stessa pace. Il Salmo ricorda ancora:”Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.” Con queste parole, Israele rievoca la promessa fatta da Dio a Davide per mezzo del profeta Natan: “Susciterò dalla tua discendenza un re, e renderò stabile il suo regno.” (2 Sam 7,12). Dopo l’esilio, non c’è più un re sul trono, ma la promessa resta viva: Dio non si smentisce. Nelle celebrazioni al Tempio, questo ricordo diventa preghiera e speranza: verrà il giorno in cui Dio susciterà un re secondo il suo cuore, giusto e fedele, che ristabilirà la pace e la giustizia. Il nome stesso di Gerusalemme significa “città della pace”. Quando si prega: «Domandate pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano!» (Sal 122,6) non si pronuncia un semplice augurio, ma una professione di fede: solo Dio può dare la pace vera, e Israele è chiamato a esserne testimone nel mondo. Con il passare dei secoli, la speranza di un re giusto trova compimento in Gesù Cristo, il Figlio di Davide. È Lui che inaugura il Regno di vita e di verità, di grazia e di santità, di giustizia, d’amore e di pace, come proclama la liturgia della festa di Cristo Re. In Lui la Gerusalemme terrena diventa Gerusalemme nuova, la città dell’incontro definitivo tra Dio e l’uomo. Ogni Eucaristia è una salita verso quella città, un pellegrinaggio dell’anima che termina nel cuore di Dio. Il pellegrinaggio di Israele verso Gerusalemme diventa allora simbolo del cammino di tutta l’umanità verso la comunione con Dio. E come i pellegrini del Salmo, anche noi, Chiesa del Nuovo Testamento, possiamo dire con gioia: “Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore”
*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (1,12-20)
Il volto invisibile di Dio. C’era una volta un mondo che cercava Dio, ma non sapeva come vederlo. Gli uomini alzavano gli occhi al cielo, costruivano templi, offrivano sacrifici, ma Dio restava invisibile, lontano. Poi, un giorno, il Verbo si fece carne: il Dio che nessuno aveva mai visto prese un volto umano, e quel volto fu quello di Gesù di Nazareth. Da allora, ogni volta che un uomo guarda Gesù, guarda Dio.San Paolo lo ha detto con parole che sembrano un canto: ”Egli è immagine del Dio invisibile, il primogenito di tutta la creazione”. In Lui, tutto ciò che esiste trova origine e senso. Non è solo il principio del mondo, ma anche il suo cuore: in Lui tutto è stato creato, e in Lui tutto è stato riconciliato. Questo piano di Dio non è nato ieri e Paolo parla di un disegno pensato da sempre: “Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel Regno del Figlio del suo amore.” Da sempre Dio ha sognato l’uomo libero, luminoso, capace di comunione. Ma ciò che Dio aveva preparato nell’eternità si è realizzato nel tempo, nel presente del Cristo. Per questo Paolo scrive: “In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.” Il mistero di Gesù non è un ricordo, è una realtà viva che ogni giorno continua a operare nel cuore dei credenti. Dio aveva fatto l’uomo “a sua immagine e somiglianza”. Ma quell’immagine, nel peccato, si era come appannata. Allora Dio stesso è venuto a mostrarci che cosa significa essere uomo. In Gesù, l’uomo è restituito alla sua bellezza originaria. Quando Pilato lo mostra alla folla e dice: “Ecco l’uomo!” non sa di pronunciare una profezia: in quel volto ferito, in quel silenzio umile, si manifesta l’uomo vero, come Dio lo aveva voluto. Ma in quel volto c’è anche il volto di Dio. Gesù è la visibilità dell’invisibile. È Dio che si lascia guardare, toccare, ascoltare. “Chi ha visto me, ha visto il Padre”, dirà a Filippo. E Paolo aggiungerà: “In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità.” In Gesù, Dio e l’uomo si incontrano per sempre. L’infinito ha preso corpo, il cielo si è fatto carne. E’ il mistero della Croce. Ma come può la Croce essere segno di pace e di riconciliazione? Paolo lo spiega così: “Dio ha voluto riconciliare a sé tutte le cose, facendo la pace per mezzo del sangue della sua croce.” Non è Dio a volere la sofferenza del Figlio. È l’odio degli uomini che lo uccide. Eppure, Dio trasforma quell’odio in amore redentore. È il grande rovesciamento della storia: la violenza si fa perdono, la morte diventa vita, la croce diventa albero di pace. Abbiamo visto nella storia uomini che hanno testimoniato la pace e sono stati uccisi per questo — Gandhi, Martin Luther King, Itzhak Rabin, Sadat… — ma solo Cristo, essendo uomo e Dio insieme, ha potuto trasformare il male in grazia per tutto il mondo. Nel suo perdono ai crocifissori — “Padre, perdonali” — si rivela il perdono stesso di Dio. Da quel giorno, sappiamo che nessun peccato è più grande dell’amore di Dio. Sulla croce, tutto è compiuto. Paolo scrive: “Dio ha voluto che in Lui abitasse tutta la pienezza, e che tutto, per mezzo di Lui, fosse riconciliato.” La creazione trova finalmente la sua unità, la sua pace. Il primo a entrare in questo Regno è il ladrone pentito: “Oggi sarai con me in paradiso”. E da allora, ogni uomo che si apre al perdono entra in quella stessa luce. L’Ecaristia è cuore del mistero Di fronte a un tale dono, la risposta possibile è una sola: rendere grazie. Per questo Paolo invita: “Rendete grazie a Dio Padre, che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.” L’Eucaristia — in greco eucharistia significa proprio “rendimento di grazie” — è il luogo dove la Chiesa rivive questo mistero. Ogni Messa è memoria viva di questa riconciliazione: Dio si dona, il mondo viene rinnovato, l’uomo ritrova se stesso. È lì che tutto si ricompone: il visibile e l’invisibile, la terra e il cielo, l’uomo e Dio. E così, nella storia del mondo, un volto ha rivelato l’invisibile. Un cuore trafitto ha portato la pace. Un pane spezzato continua a rendere presente la pienezza dell’amore. E ogni volta che la Chiesa si raduna per l’Eucaristia, il canto di Paolo si rinnova come una lode cosmica: Cristo è l’immagine del Dio invisibile, il primo e l’ultimo, colui che riconcilia il mondo con il Padre, colui nel quale tutto sussiste. In Lui, tutto trova senso. In Lui, tutto è grazia. In Lui, il Dio invisibile ha finalmente un volto: Gesù Cristo, Signore del cielo e della terra.
*Dal Vangelo secondo Luca (23, 35-43)
La logica degli uomini e la logica di Dio. Tre volte, ai piedi della croce, risuona la stessa provocazione a Gesù:”Se tu sei…” — “Se tu sei il Messia”, deridono i capi religiosi; “Se tu sei il re dei Giudei”, sogghignano i soldati romani;” Se tu sei il Messia”, lo insulta uno dei malfattori crocifissi con lui. Ognuno parla a partire dal proprio punto di vista: i capi d’Israele aspettano un Messia potente, ma davanti a loro c’è un uomo vinto e crocifisso; i soldati, uomini del potere terreno, ridono di un “re” senza difese; il malfattore, invece, attende un salvatore che lo liberi dalla morte. Queste tre voci ricordano le tre tentazioni nel deserto (Lc 4): anche allora il tentatore ripeteva: «Se tu sei Figlio di Dio…». Tentazioni di potere, di dominio e di miracolo. Gesù aveva risposto ogni volta con la Parola: “Sta scritto: l’uomo non vive di solo pane…” “Adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo renderai culto…” “Non tenterai il Signore tuo Dio”. La Scrittura era stata la sua forza per rimanere fedele alla missione del Messia povero e obbediente. Sulla croce, invece, Gesù tace. Non risponde più alle provocazioni. Eppure sa bene chi è: il Messia, il Salvatore. Ma non secondo la logica degli uomini, che vorrebbero un Dio capace di salvarsi da solo, di dominare, di vincere con la forza. Gesù muore proprio perché non corrisponde a questa logica umana. La sua logica è quella di Dio: salvare donandosi, senza imporsi. Il suo silenzio non è vuoto, ma pieno di fiducia. Il suo stesso nome, Gesù, significa: «Dio salva». Attende il suo riscatto da Dio solo, non da sé stesso. Le tentazioni sono vinte per sempre: egli rimane fedele, consegnato totalmente nelle mani degli uomini, ma confidando nel Padre. In mezzo alle offese, due parole racchiudono il mistero della Croce. La prima: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”. La seconda, rivolta al “buon ladrone”: “Oggi sarai con me in Paradiso”. Il perdono e la salvezza: due gesti divini e umani insieme. In Gesù, Dio stesso perdona e riconcilia l’umanità. Il ladrone pentito — che si rivolge a lui dicendo: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno” — è il primo a comprendere chi è veramente Cristo. Non chiede di scendere dalla croce, ma di essere accolto. In quella supplica di umiltà e fiducia, il “ricordati” diventa la preghiera che apre il Paradiso. Là dove Adamo, nel giardino dell’Eden, aveva ceduto alla tentazione di “essere come Dio”, Gesù, il nuovo Adamo, vince attendendo tutto da Dio. Adamo aveva voluto decidere da solo la propria grandezza ed era stato cacciato dal Paradiso; Gesù, invece, accettando di essere Figlio nel totale abbandono, riapre il Paradiso all’umanità. Nel racconto della Passione, si incrociano due logiche: quella degli uomini, che cercano un Dio potente, e quella di Dio, che salva attraverso l’amore e la debolezza. Gesù rifiuta la tentazione di dimostrare la propria forza; sceglie invece di fidarsi del Padre fino alla fine. Nel suo silenzio e nel suo perdono, la potenza divina si manifesta come misericordia. Accanto a lui, il ladrone pentito diventa il primo testimone del Regno: riconosce in Cristo il vero Re, non dei potenti, ma dei salvati. Dove Adamo aveva chiuso le porte del Paradiso, Gesù le riapre: “Oggi sarai con me in Paradiso” è la risposta definitiva di Dio alla logica del mondo.
+ Giovanni D’Ercole
Senza annullare la persona, già nuda di due centesimi
Spiccioli e festival del Dio vorace, in apparenze solenni
(Lc 21,1-4)
Gesù fronteggia il tesoro del Tempio, vero “dio” di tutto il santuario. Il confronto è spietato: uno contrapposto all’altro [v.1; cf. Mc 12,41].
Enigma che non poteva risolversi con una semplice “purificazione” del luogo sacro, o un rabberciamento della devozione.
Sorprenderà, ma il brano di Vangelo non tesse lodi dell’umiltà individuale che per fede si priva di tutto: è piuttosto un richiamo radicale ai responsabili di chiesa e al senso dell’istituzione.
Il Signore si rattrista di ogni espropriazione condizionata dalla paura. Il timore infatti toglie vita a coloro che non godono pienezza.
Cristo piange la condizione subalterna dei miseri e trascurati: non la fa salire in cattedra. Non accredita la situazione. Non vuole che la donna già nuda di due centesimi si spogli tutta.
Sembra affranto per quell’unica figura silenziosa; a sottolineare la differenza tra esigenze voraci del Dio delle religioni antiche e quelle di tutt’altro segno - in nostro favore - del Padre nella Fede.
Mentre Gesù notava e piangeva il gesto minuto della piccola donna, gli Apostoli neppure si accorsero dell’irrilevante poverella, continuando a rimanere a bocca aperta di fronte alla magnificenza del Tempio.
Chissà cosa inseguivano sognando... sedotti dall’onore.
Per distoglierli dalla febbre di reputazione e considerazioni di cui desideravano fregiarsi, c’era bisogno di una presa di coscienza; ma per smuoverli dal loro posto e metro di giudizio non sarebbero stati sufficienti i miracoli.
Così Gesù cerca di trasmettere in coscienza la Lieta Notizia che il Padre è l’esatto contrario di come era stato loro dipinto dalle guide spirituali del tempo.
L’Eterno sconcerta: non prende, non si appropria, non ci scippa, né assorbe o debilita - ma è Lui che dona.
Non mette in castigo se non lo plachi con entrambe le monetine che hai, senza trattenerne neppure una - anche solo facendo a metà (v.2).
L’onore a Dio non è esclusivo, bensì inclusivo.
Parafrasando l'enciclica Fratelli Tutti, potremmo dire che nelle comunità autentiche [come nelle famiglie] «tutti contribuiscono al progetto comune, tutti lavorano per il bene comune, ma senza annullare l’individuo; al contrario, lo sostengono, lo promuovono» (n.230).
Il Figlio constata con amarezza che proprio i bei protagonisti «divorano le case delle vedove» (Lc 20,47) come vampiri. Tanto convincenti da rendere le anime semplici addirittura loro sostenitrici e vittime.
Cristo si rattrista di tale inconsapevole complicità, indotta dalla mancata conoscenza del Volto del Padre - predicato come un Dio sanguisuga.
Infatti nel cammino di Fede personale i veri credenti non sono ripetitori di ruoli esterni (Lc 20,45-47).
Collaboriamo all’opera creatrice e divinizzante dell’Eterno nel proporci al pari di alimento vitale in favore dell’umanità cui è stato tolto lo Sposo - qui nella figura della povera «vedova» che si dissangua.
Insomma, non ci si deve più macerare e sfiancare, a motivo della gloria dell’Onnipotente, bensì arricchire di Lui e pronunciare appieno!
Un Dio tutta sostanza, di scarsa apparenza epidermica.
Eppure l’antitesi ricchi-poveri si stava ripresentando nelle prime comunità… a discapito degli isolati.
Qui proprio il rovesciamento delle sorti doveva diventare caratteristica della Chiesa adorante, che s’immerge nello stesso ritmo della suprema Sorgente vitale.
Sarà dunque l’istituzione amabile a restare spoglia e pellegrina, anche nello spazio del piccolo e malfermo.
E l’azione delle assemblee di credenti, a poter attivare un mondo nuovo, conviviale, in grado di umanizzare le disarmonie.
Realtà che batte il ‘tempo’. Per un ‘Regno’ davvero non neutrale. Ma dove conta l’anima, non il curriculum.
[Lunedì 34. sett. T.O. 24 novembre 2025]
Spiccioli e festival del Dio vorace, in apparenze solenni
(Lc 21,1-4)
Gesù trasmette la Lieta Notizia che il Padre è l’esatto contrario di come è stato immaginato.
Non prende, non si appropria, non ci scippa né assorbe o debilita, ma è Lui che dona; non mette in castigo se non lo plachi con entrambe le monetine che hai, senza trattenerne neppure una (v.2).
L’onore a Dio non è esclusivo, bensì inclusivo.
Parafrasando l'enciclica Fratelli Tutti, potremmo dire che nelle comunità autentiche [come nelle famiglie] «tutti contribuiscono al progetto comune, tutti lavorano per il bene comune, ma senza annullare l’individuo; al contrario, lo sostengono, lo promuovono» (n.230).
In particolare, all’antitesi ricchi-poveri è annunciato il capovolgimento dello stile di vita, delle situazioni e delle sorti: caratteristica della Chiesa ideale, che resta pellegrina - anche nello spazio della Persona.
La sua buona ragione, le pratiche virtuose e le implicazioni pubbliche s’immergono nello stesso ritmo della suprema Sorgente vitale - che ama l’unicità, per la ricchezza comune.
Fatte salve le relazioni buone, l’istituzione può apparire poco seducente. Essa non s’impone a forza di condizioni sociali “favorevoli”, bensì è Presenza sul piano della Fede.
Amicizia che contempla un mondo nuovo, in grado di umanizzare le disarmonie.
Realtà che batte il tempo - perché ne è dentro e fuori, come l’Amore.
Conta l’anima, non il curriculum; neppure gli influssi condizionanti, che mettono solo in difficoltà.
Infatti la sensazione di essere scarsi o in ritardo inizia dal fare paragoni - e voler aggiungere, anticipare, pretendere un di più esterno.
Ma quel che vale nel rapporto con se stessi, con gli altri e con Dio è solo riuscire a esprimere la propria natura. Fare scelte in sintonia con l’essenza che caratterizza.
I calcoli sono devianti, non consoni; così le comparazioni. Il piccolo dettaglio fuggevole ma personale è decisivo.
È importante solo coincidere con ciò che siamo, in quel presente; in sincronia col proprio carattere.
Siamo ciò che siamo. Lo sviluppo andrà bene così.
Gesù fronteggia il tesoro del Tempio, vero “dio” di tutto il santuario. Il confronto è spietato: uno contrapposto all’altro [v.1; cf. Mc 12,41].
Enigma che non poteva risolversi con una semplice “purificazione” del luogo sacro, o un rabberciamento della devozione.
Il Figlio annuncia un Padre: non è colui che succhia le risorse e le energie delle creature, fino a spennarle.
I grandi luoghi di culto antichi erano delle vere e proprie banche, i cui proventi avrebbero dovuto in parte provvedere alle necessità dei poveri.
La paura dei castighi divini inculcati dalle false guide spirituali aveva pervertito la situazione: anche i bisognosi ritenevano di dover provvedere allo sfarzo, al culto, agli addobbi degli edifici sacri e al sostentamento dei professionisti del rito.
Gesù qui non loda l’austerità e l’umiltà di un’emarginata, ma guarda con tristezza la povera donna che si lascia imbrogliare i pensieri, diventando una paradossale complice del sistema diseducativo.
Poteva trattenere una monetina; le getta invano entrambe, e con esse «tutta la sua vita» (v.4 testo greco).
L’episodio originale e gesuano viene ripreso da Lc per una catechesi alle sue comunità, sulla base di eventi [cf. gli antichi scritti di Giacomo e Paolo] sotto gli occhi dei cristiani di seconda e terza generazione.
Le prime fraternità erano composte da gente semplice, ma con l’ingresso dei primi benestanti e le loro magnifiche offerte iniziarono a riproporsi i medesimi attriti sociali presenti nella vita dell’impero.
Le tensioni diventavano sempre più palesi in occasione sia di riunioni che dello spezzare il Pane.
L’insegnamento del gesto della vedova voleva essere un monito alla Comunione reale.
Insomma, il Regno di Dio è penetrazione nelle profondità della vita; con la dedizione che non si riduce a quantità materiali, né a porgere ciò che avanza - bensì ciò che si è.
Nel contesto della società plurale [dell’impero romano e odierno] dalla Fede responsabile e motivata sorge l’Appello elementare dei Vangeli.
Richiamo antico e attuale - per un’esperienza singolare e comune. Davvero non neutrale.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Quali ritieni essere i personaggi di spicco della tua comunità?
E i tuoi due centesimi? Ne trattieni almeno uno?
Cosa invece metti più di tutti?
I problemi della gente possono essere risolti solo con molto denaro?
Le monete dei ragguardevoli sono davvero più utili dei tuoi pochi spiccioli?
Chiesa, e la Luce
Nella vedova che getta le sue due monetine nel tesoro nel tempio possiamo vedere l’«immagine della Chiesa» che deve essere povera, umile e fedele. Parte dal vangelo del giorno, tratto dal capitolo 21 di Luca (1-4), la riflessione di Papa Francesco durante la messa a Santa Marta lunedì 24 novembre. Nell’omelia viene richiamato il passo in cui Gesù, «dopo lunghe discussioni» con i sadducei e con i discepoli riguardo ai farisei e agli scribi che «si compiacciono di avere i primi posti, i primi seggi nelle sinagoghe, nei banchetti, di essere salutati», alzato lo sguardo «vede la vedova». Il «contrasto» è immediato e «forte» rispetto ai «ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del tempio». Ed è proprio la vedova «la persona più forte qui, in questo brano».
Della vedova, ha spiegato il Pontefice, «si dice due volte che è povera: due volte. E che è nella miseria». È come se il Signore avesse voluto sottolineare ai dottori della legge: «Avete tante ricchezze di vanità, di apparenza o anche di superbia. Questa è povera. Voi, che mangiate le case delle vedove...». Ma «nella Bibbia l’orfano e la vedova sono le figure dei più emarginati» così come anche i lebbrosi, e «per questo ci sono tanti comandamenti per aiutare, per prendersi cura delle vedove, degli orfani». E Gesù «guarda questa donna sola, semplicemente vestita» e «che getta tutto quello che ha per vivere: due monetine». Il pensiero corre anche a un’altra vedova, quella di Sarepta, «che aveva ricevuto il profeta Elia e ha dato tutto quello che aveva prima di morire: un po’ di farina con l’olio...».
Il Pontefice ha ricomposto la scena narrata dal Vangelo: «Una povera donna in mezzo ai potenti, in mezzo ai dottori, ai sacerdoti, agli scribi... anche in mezzo a quei ricchi che gettavano le loro offerte, e anche alcuni per farsi vedere». A loro Gesù dice: «Questo è il cammino, questo è l’esempio. Questa è la strada per la quale voi dovete andare». Emerge forte il «gesto di questa donna che era tutta per Dio, come la vedova Anna che ha ricevuto Gesù nel Tempio: tutta per Dio. La sua speranza era solo nel Signore».
«Il Signore sottolinea la persona della vedova», ha detto Francesco, e ha continuato: «Mi piace vedere qui, in questa donna una immagine della Chiesa». Innanzitutto la «Chiesa povera, perché la Chiesa non deve avere altre ricchezze che il suo Sposo»; poi la «Chiesa umile, come lo erano le vedove di quel tempo, perché in quel tempo non c’era la pensione, non c’erano gli aiuti sociali, niente». In un certo senso la Chiesa «è un po’ vedova, perché aspetta il suo Sposo che tornerà». Certo, «ha il suo Sposo nell’Eucaristia, nella parola di Dio, nei poveri: ma aspetta che torni».
E cosa spinge il Papa a «vedere in questa donna la figura della Chiesa»? Il fatto che «non era importante: il nome di questa vedova non appariva nei giornali, nessuno la conosceva, non aveva lauree... niente. Niente. Non brillava di luce propria». E la «grande virtù della Chiesa» dev’essere appunto quella «di non brillare di luce propria», ma di riflettere «la luce che viene dal suo Sposo». Tanto più che «nei secoli, quando la Chiesa ha voluto avere luce propria, ha sbagliato». Lo dicevano anche «i primi Padri», la Chiesa è «un mistero come quello della luna. La chiamavano mysterium lunae: la luna non ha luce propria; sempre la riceve dal sole».
Certo, ha specificato il Papa, «è vero che alcune volte il Signore può chiedere alla sua Chiesa di avere, di prendersi un po’ di luce propria», come quando chiese «alla vedova Giuditta di deporre le vesti di vedova e indossare le vesti di festa per fare una missione». Ma, ha ribadito, «sempre rimane l’atteggiamento della Chiesa verso il suo Sposo, verso il Signore». La Chiesa «riceve la luce da là, dal Signore» e «tutti i servizi che noi facciamo» in essa servono a «ricevere quella luce». Quando un servizio manca di questa luce «non va bene», perché «fa che la Chiesa diventi o ricca, o potente, o che cerchi il potere, o che sbagli strada, come è accaduto tante volte, nella storia, e come accade nelle nostre vite quando noi vogliamo avere un’altra luce, che non è proprio quella del Signore: una luce propria».
Il Vangelo, ha notato il Papa, presenta l’immagine della vedova proprio nel momento in cui «Gesù incomincia a sentire le resistenze della classe dirigente del suo popolo: i sadducei, i farisei, gli scribi, i dottori della legge». Ed è come se egli dicesse: «Succede tutto questo, ma guardate lì!», verso quella vedova. Il confronto è fondamentale per riconoscere la vera realtà della Chiesa che «quando è fedele alla speranza e al suo Sposo, è gioiosa di ricevere la luce da lui, di essere — in questo senso — vedova: aspettando quel sole che verrà».
Del resto, «non a caso il primo confronto forte, dopo quello che ha avuto con Satana, che Gesù ha avuto a Nazareth, è stato per aver nominato una vedova e per aver nominato un lebbroso: due emarginati». C’erano «tante vedove, in Israele, a quel tempo, ma soltanto Elia è stato inviato da quella vedova di Sarepta. E loro si arrabbiarono e volevano ucciderlo».
Quando la Chiesa, ha concluso Francesco, è «umile» e «povera», e anche quando «confessa le sue miserie — poi tutti ne abbiamo — la Chiesa è fedele». È come se essa dicesse: «Io sono oscura, ma la luce mi viene da lì!». E questo, ha aggiunto il Pontefice, «ci fa tanto bene». Allora «preghiamo questa vedova che è in cielo, sicuro», affinché «ci insegni a essere Chiesa così», rinunciando a «tutto quello che abbiamo» e non tenendo «niente per noi» ma «tutto per il Signore e per il prossimo». Sempre «umili» e «senza vantarci di avere luce propria», ma «cercando sempre la luce che viene dal Signore».
[Papa Francesco, s. Marta, in L’Osservatore Romano 25/11/2014]
Al centro della Liturgia della Parola […] troviamo il personaggio della vedova povera, o, più precisamente, troviamo il gesto che ella compie gettando nel tesoro del Tempio gli ultimi spiccioli che le rimangono. Un gesto che, grazie allo sguardo attento di Gesù, è diventato proverbiale: “l’obolo della vedova”, infatti, è sinonimo della generosità di chi dà senza riserve il poco che possiede. Prima ancora, però, vorrei sottolineare l’importanza dell’ambiente in cui si svolge tale episodio evangelico, cioè il Tempio di Gerusalemme, centro religioso del popolo d’Israele e il cuore di tutta la sua vita. Il Tempio è il luogo del culto pubblico e solenne, ma anche del pellegrinaggio, dei riti tradizionali, e delle dispute rabbiniche, come quelle riportate nel Vangelo tra Gesù e i rabbini di quel tempo, nelle quali, però, Gesù insegna con una singolare autorevolezza, quella del Figlio di Dio. Egli pronuncia giudizi severi - come abbiamo sentito - nei confronti degli scribi, a motivo della loro ipocrisia: essi, infatti, mentre ostentano grande religiosità, sfruttano la povera gente imponendo obblighi che loro stessi non osservano. Gesù, insomma, si dimostra affezionato al Tempio come casa di preghiera, ma proprio per questo lo vuole purificare da usanze improprie, anzi, vuole rivelarne il significato più profondo, legato al compimento del suo stesso Mistero, il Mistero della Sua morte e risurrezione, nella quale Egli stesso diventa il nuovo e definitivo Tempio, il luogo dove si incontrano Dio e l’uomo, il Creatore e la Sua creatura.
L’episodio dell’obolo della vedova si inscrive in tale contesto e ci conduce, attraverso lo sguardo stesso di Gesù, a fissare l’attenzione su un particolare fuggevole ma decisivo: il gesto di una vedova, molto povera, che getta nel tesoro del Tempio due monetine. Anche a noi, come quel giorno ai discepoli, Gesù dice: Fate attenzione! Guardate bene che cosa fa quella vedova, perché il suo atto contiene un grande insegnamento; esso, infatti, esprime la caratteristica fondamentale di coloro che sono le “pietre vive” di questo nuovo Tempio, cioè il dono completo di sé al Signore e al prossimo; la vedova del Vangelo, come anche quella dell’Antico Testamento, dà tutto, dà se stessa, e si mette nelle mani di Dio, per gli altri. È questo il significato perenne dell’offerta della vedova povera, che Gesù esalta perché ha dato più dei ricchi, i quali offrono parte del loro superfluo, mentre lei ha dato tutto ciò che aveva per vivere (cfr Mc 12,44), e così ha dato se stessa.
A Dio è bastato il sacrificio di Gesù, offerto “una volta sola”, per salvare il mondo intero (cfr Eb 9,26.28), perché in quell’unica oblazione è condensato tutto l’Amore del Figlio di Dio fattosi uomo, come nel gesto della vedova è concentrato tutto l’amore di quella donna per Dio e per i fratelli: non manca niente e niente vi si potrebbe aggiungere. La Chiesa, che incessantemente nasce dall’Eucaristia, dall’autodonazione di Gesù, è la continuazione di questo dono, di questa sovrabbondanza che si esprime nella povertà, del tutto che si offre nel frammento. È il Corpo di Cristo che si dona interamente, Corpo spezzato e condiviso, in costante adesione alla volontà del suo Capo.
[Papa Benedetto, omelia Brescia 8 novembre 2009]
2. Lodiamo Dio insieme col salmista: egli “è fedele per sempre”: il Dio dell’alleanza.
Egli è colui che “rende giustizia agli oppressi”, che “dà il pane agli affamati” - come gli chiediamo ogni giorno.
Dio è colui che “ridona la vista ai ciechi”: ridona in particolare la vista dello spirito.
Egli “rialza chi è caduto”.
Egli “sostiene l’orfano e la vedova” . . . (Sal 146 [145], 6-9).
3. Proprio la vedova si trova al centro della odierna liturgia della Parola. Questa è una ben nota figura del Vangelo: la povera vedova che gettò nel tesoro “due spiccioli, cioè un quattrino” (Mc 12, 42) - (quale è il valore approssimativo di questa moneta?).
Gesù osservava “come la folla gettava monete nel tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte” (Mc 12, 41).
Vedendo la vedova e la sua offerta disse ai discepoli: “Questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri . . . Tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere” (Mc 12, 43-44).
4. La vedova del Vangelo ha il suo parallelo nell’antica alleanza. La prima lettura della liturgia dal libro dei Re, ricorda un’altra vedova, quella di Zarepta, che su richiesta del profeta Elia divise con lui tutto ciò che aveva per sé e per suo figlio: il pane e l’olio, anche se ciò che aveva bastava solo per loro due.
Ed ecco - secondo la predizione di Elia - avvenne il miracolo: la farina della giara non si esaurì e l’orcio dell’olio non si svuotò . . . e così fu per diversi giorni (cf. 1 Re 17, 14-17).
5. Una comune caratteristica unisce ambedue le vedove - quella dell’antica e quella della nuova alleanza -. Tutte e due sono povere e al tempo stesso generose: danno tutto quello che è nella loro possibilità. Tutto ciò che possiedono. Tale generosità del cuore è una manifestazione del totale affidamento a Dio. E perciò la liturgia odierna giustamente ricollega queste due figure con la prima beatitudine del discorso della montagna di Cristo:
“Beati i poveri in spirito, perché di essi è il Regno dei cieli” (Mt 5, 3).
I “poveri in spirito” - così come quella vedova di Zarepta ai tempi di Elia, e quell’altra del tempio di Gerusalemme, ai tempi di Cristo - dimostrano nella loro povertà una grande ricchezza dello spirito.
Infatti: il povero in spirito è ricco nello spirito. E proprio solo colui che è ricco in spirito può arricchire gli altri.
Cristo insegna che “di essi è il Regno dei cieli”.
6. Per noi che partecipiamo al sacrificio eucaristico questa indicazione è particolarmente importante. Solo quando la nostra presenza qui rivela quella “povertà in spirito” di cui parla la beatitudine di Cristo, solo allora possiamo offrire la nostra offerta al grande “tesoro spirituale” della Chiesa: possiamo portare questa offerta all’altare in quello spirito che Dio, nostro creatore, e Cristo, nostro redentore, s’aspettano da noi.
La lettera agli Ebrei parla di Cristo, eterno sacerdote, che intercede in nostro favore presentando al cospetto di Dio Padre il sacrificio della croce sul Golgota.
E questo unico, santissimo e indefinito valore del sacrificio di Cristo abbraccia anche le offerte che noi portiamo all’altare.
Occorre che queste offerte siano simili allo spicciolo di quella vedova del tempio gerosolimitano, ed anche all’offerta della vedova di Zarepta dei tempi di Elia.
Occorre che queste nostre offerte presentate all’altare - la nostra partecipazione all’Eucaristia - portino in sé un segno della beatitudine di Cristo circa i “poveri in spirito”.
7. La Chiesa intera oggi medita la verità racchiusa in queste parole della liturgia. Mi è dato oggi, come Vescovo di Roma, meditarle insieme con voi fedeli della parrocchia di san Luigi Gonzaga, ai Parioli. Il vostro patrono, san Luigi, ha vissuto in pienezza ia beatitudine evangelica della povertà in spirito, cioè dello spogliamento degli onori e dei beni terreni per conquistare la vera ricchezza, che è il Regno di Dio. Diceva infatti al padre, marchese di Castiglione delle Stiviere: “Un marchesato non mi basta, io miro un regno”; intendeva riferirsi evidentemente al Regno dei cieli. Per attuare questo suo desiderio Luigi rinunciò al titolo e all’eredità paterna per entrare nel noviziato romano della Compagnia di Gesù. Si fece povero per diventare ricco. Annoterà più tardi in un suo scritto: “Anche i principi sono cenere, come i poveri”. Così come la “povera vedova”, diede tutto al Signore con generosità e slancio, che ha dell’eroismo. Scelse infatti per sé le incombenze più umili, dedicandosi al servizio degli ammalati, soprattutto nell’epidemia di peste che colpì Roma nel 1590, e dando la sua vita per essi.
[Papa Giovanni Paolo II, omelia alla parrocchia s. Luigi Gonzaga, 6 novembre 1988]
Il brano del Vangelo […] si compone di due parti: una in cui si descrive come non devono essere i seguaci di Cristo; l’altra in cui viene proposto un ideale esemplare di cristiano.
Cominciamo dalla prima: cosa non dobbiamo fare. Nella prima parte Gesù addebita agli scribi, maestri della legge, tre difetti che si manifestano nel loro stile di vita: superbia, avidità e ipocrisia. A loro – dice Gesù - piace «ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti» (Mc 12,38-39). Ma sotto apparenze così solenni si nascondono falsità e ingiustizia. Mentre si pavoneggiano in pubblico, usano la loro autorità per “divorare le case delle vedove” (cfr v. 40), che erano considerate, insieme agli orfani e agli stranieri, le persone più indifese e meno protette. Infine, gli scribi «pregano a lungo per farsi vedere» (v. 40). Anche oggi esiste il rischio di assumere questi atteggiamenti. Ad esempio, quando si separa la preghiera dalla giustizia, perché non si può rendere culto a Dio e causare danno ai poveri. O quando si dice di amare Dio, e invece si antepone a Lui la propria vanagloria, il proprio tornaconto.
E in questa linea si colloca la seconda parte del Vangelo di oggi. La scena è ambientata nel tempio di Gerusalemme, precisamente nel luogo dove la gente gettava le monete come offerta. Ci sono molti ricchi che versano tante monete, e c’è una povera donna, vedova, che mette appena due spiccioli, due monetine. Gesù osserva attentamente quella donna e richiama l’attenzione dei discepoli sul contrasto netto della scena. I ricchi hanno dato, con grande ostentazione, ciò che per loro era superfluo, mentre la vedova, con discrezione e umiltà, ha dato «tutto quanto aveva per vivere» (v. 44); per questo – dice Gesù – lei ha dato più di tutti. A motivo della sua estrema povertà, avrebbe potuto offrire una sola moneta per il tempio e tenere l’altra per sé. Ma lei non vuole fare a metà con Dio: si priva di tutto. Nella sua povertà ha compreso che, avendo Dio, ha tutto; si sente amata totalmente da Lui e a sua volta Lo ama totalmente. Che bell’esempio quella vecchietta!
Gesù, oggi, dice anche a noi che il metro di giudizio non è la quantità, ma la pienezza. C’è una differenza fra quantità e pienezza. Tu puoi avere tanti soldi, ma essere vuoto: non c’è pienezza nel tuo cuore. Pensate, in questa settimana, alla differenza che c’è fra quantità e pienezza. Non è questione di portafoglio, ma di cuore. C’è differenza fra portafoglio e cuore… Ci sono malattie cardiache, che fanno abbassare il cuore al portafoglio… E questo non va bene! Amare Dio “con tutto il cuore” significa fidarsi di Lui, della sua provvidenza, e servirlo nei fratelli più poveri senza attenderci nulla in cambio.
Mi permetto di raccontarvi un aneddoto, che è successo nella mia diocesi precedente. Erano a tavola una mamma con i tre figli; il papà era al lavoro; stavano mangiando cotolette alla milanese… In quel momento bussano alla porta e uno dei figli – piccoli, 5, 6 anni, 7 anni il più grande - viene e dice: “Mamma, c’è un mendicante che chiede da mangiare”. E la mamma, una buona cristiana, domando loro: “Cosa facciamo?” – “Diamogli, mamma…” – “Va bene”. Prende la forchetta e il coltello e toglie metà ad ognuna delle cotolette. “Ah no, mamma, no! Così no! Prendi dal frigo” – “No! facciamo tre panini così!”. E i figli hanno imparato che la vera carità si dà, si fa non da quello che ci avanza, ma da quello ci è necessario. Sono sicuro che quel pomeriggio hanno avuto un po’ di fame… Ma così si fa!
Di fronte ai bisogni del prossimo, siamo chiamati a privarci – come questi bambini, della metà delle cotolette – di qualcosa di indispensabile, non solo del superfluo; siamo chiamati a dare il tempo necessario, non solo quello che ci avanza; siamo chiamati a dare subito e senza riserve qualche nostro talento, non dopo averlo utilizzato per i nostri scopi personali o di gruppo.
Chiediamo al Signore di ammetterci alla scuola di questa povera vedova, che Gesù, tra lo sconcerto dei discepoli, fa salire in cattedra e presenta come maestra di Vangelo vivo. Per l’intercessione di Maria, la donna povera che ha dato tutta la sua vita a Dio per noi, chiediamo il dono di un cuore povero, ma ricco di una generosità lieta e gratuita.
[Papa Francesco, Angelus 8 novembre 2015]
We will not find a wall, no. We will find a way out […] Let us not fear the Lord (Pope Francis)
Non troveremo un muro, no, troveremo un’uscita […] Non abbiamo paura del Signore (Papa Francesco)
Raw life is full of powers: «Be grateful for everything that comes, because everything was sent as a guide to the afterlife» [Gialal al-Din Rumi]
La vita grezza è colma di potenze: «Sii grato per tutto quel che arriva, perché ogni cosa è stata mandata come guida dell’aldilà» [Gialal al-Din Rumi]
It is not enough to be a pious and devoted person to become aware of the presence of Christ - to see God himself, brothers and things with the eyes of the Spirit. An uncomfortable vision, which produces conflict with those who do not want to know
Non basta essere persone pie e devote per rendersi conto della presenza di Cristo - per vedere Dio stesso, i fratelli e le cose con gli occhi dello Spirito. Visione scomoda, che produce conflitto con chi non ne vuol sapere
An eloquent and peremptory manifestation of the power of the God of Israel and the submission of those who did not fulfill the Law was expected. Everyone imagined witnessing the triumphal entry of a great ruler, surrounded by military leaders or angelic ranks...
Ci si attendeva una manifestazione eloquente e perentoria della potenza del Dio d’Israele e la sottomissione di coloro che non adempivano la Legge. Tutti immaginavano di assistere all’ingresso trionfale d’un condottiero, circondato da capi militari o schiere angeliche…
May the Holy Family be a model for our families, so that parents and children may support each other mutually in adherence to the Gospel, the basis of the holiness of the family (Pope Francis)
La Santa Famiglia possa essere modello delle nostre famiglie, affinché genitori e figli si sostengano a vicenda nell’adesione al Vangelo, fondamento della santità della famiglia (Papa Francesco)
John is the origin of our loftiest spirituality. Like him, ‘the silent ones' experience that mysterious exchange of hearts, pray for John's presence, and their hearts are set on fire (Athinagoras)
Giovanni è all'origine della nostra più alta spiritualità. Come lui, i ‘silenziosi’ conoscono quel misterioso scambio dei cuori, invocano la presenza di Giovanni e il loro cuore si infiamma (Atenagora)
Stephen's story tells us many things: for example, that charitable social commitment must never be separated from the courageous proclamation of the faith. He was one of the seven made responsible above all for charity. But it was impossible to separate charity and faith. Thus, with charity, he proclaimed the crucified Christ, to the point of accepting even martyrdom. This is the first lesson we can learn from the figure of St Stephen: charity and the proclamation of faith always go hand in hand (Pope Benedict)
La storia di Stefano dice a noi molte cose. Per esempio, ci insegna che non bisogna mai disgiungere l'impegno sociale della carità dall'annuncio coraggioso della fede. Era uno dei sette incaricato soprattutto della carità. Ma non era possibile disgiungere carità e annuncio. Così, con la carità, annuncia Cristo crocifisso, fino al punto di accettare anche il martirio. Questa è la prima lezione che possiamo imparare dalla figura di santo Stefano: carità e annuncio vanno sempre insieme (Papa Benedetto)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.