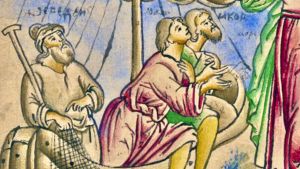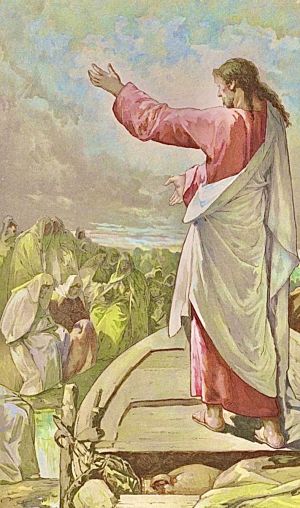don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Pescatori, Conversione, Regno vicino. Felicità non scadente
Volto opposto e Barchetta: l’espulsione (semplice) dei demoni
(Mc 3,7-12)
Il Regno del Padre annunciato da Gesù non era affatto legato a un credo qualsiasi: Dio non aveva solo un Volto diverso dal ‘sistema Impero’ e dal gran Sovrano delle religioni, ma addirittura opposto.
Questo il senso della lieta notizia che il suo Corpo vivente pressato da ogni dove e sballottato dalle onde [le sue fraternità, allora assediate] è sempre chiamato a proclamare con le opere di recupero delle persone in difficoltà, escluse dal giro dei forti.
In questo senso assai concreto, il Vangelo di Mc insiste sulla espulsione dei demoni - a partire da un genere di neutralizzazione che si radichi in una qualità di sguardo interiore e di rapporti eminenti, privi dell’istinto alla concorrenza. Persino laddove può sembrare impossibile.
In Cristo, medico dell'umanità sofferente, le cose dell’anima appaiono diverse, e così i rapporti. Tutto ciò porta il suo gruppo a una differente visione di sé, della storia, del mondo, delle moltitudini (vv.7-9) e dei problemi.
E con Lui in mezzo, i suoi intimi si configurano come nucleo di una società dai modi semplici, ma dal discernimento solido, e relazioni divine.
Al tempo di Mc, in un momento di consapevolezza dello sgretolamento dell’età dell’oro promessa dal regime, ecco accentuarsi la paura popolare e la credenza nel predominio degli spiriti immondi sul bene.
D’altro canto, invece di liberare la gente, tutte le autorità delle varie espressioni religiose ne risucchiavano le energie - proprio diffondendo fantasie e timori che finivano per alimentare angosce diffuse.
Sulla base dell’insegnamento alternativo e l’opera del Signore, la Chiesa intendeva liberare il popolo dei soggiogati da torture al cardiopalmo e incubo di scrupoli - attraverso una proposta di vita che non facesse più leva sui sensi d’indegnità e le fobie del castigo degli dèi.
L’esempio concreto del Cristo vivente [nella «Barchetta» qui al v.9: la minuscola Assemblea dei figli] doveva non lasciarsi schiacciare dalle inquietudini epocali e da sensi di colpa.
Le false guide spirituali del tempo inculcavano nel popolo bisognoso di tutto un’accentuazione del sentimento d’inadeguatezza.
Grazie alla loro diseducazione, le persone semplici non erano restituite a se stesse, bensì rese radicalmente insufficienti.
Per gli intimi del Signore, ciascuno deve invece avere ‘accesso’ - e vita nuova.
E la turba affranta può diventare convivenza di nuove armonie, di altre alleanze; ma a partire dalla sua debolezza integrata, conciliata - non più per via d’ignoranza e sottrazione, o psicosi.
Aderendo a Cristo, anche noi facciamo un’esperienza preziosa: qualità di sostegno, vocazione, naturalezza, carattere personale, e concretezza, si abbinano.
Così il Signore non vuole una istituzione “spiritata” e vuota - che possa creare scalpori, o piramidi, e mettere soggezione. Neppure magniloquente, bensì ridotta a «piccola barca» [v.9 testo greco].
Per questo motivo, mai Gesù ha sopportato la ricerca di fama o l’esibizionismo (v.12) inconcludenti.
La sua Amicizia non paternalista ci accompagna, comprende, sovviene, recupera, e sta pure un passo indietro.
Ecco la Comunione in grado di amalgamare; dalla configurazione intima, che accosta e congiunge tutti. Unica condizione convincente e amabile.
[Giovedì 2.a sett. T.O. 22 gennaio 2026]
Volto opposto e Barchetta: l’espulsione (semplice) dei demoni
(Mc 3,7-12)
Il Regno del Padre annunciato da Gesù non era affatto legato a un credo qualsiasi: Dio non aveva solo un Volto diverso dal sistema impero e dal gran Sovrano delle religioni, ma addirittura opposto.
Questo il senso della lieta notizia che il suo Corpo vivente pressato da ogni dove e sballottato dalle onde [le sue fraternità, allora assediate] è sempre chiamato a proclamare con le opere di recupero delle persone in difficoltà, escluse dal giro dei forti.
In questo senso assai concreto, il Vangelo di Mc insiste sulla espulsione dei demoni - a partire da un genere di neutralizzazione che si radichi in una qualità di sguardo interiore e di rapporti eminenti, privi dell’istinto alla concorrenza. Persino laddove può sembrare impossibile.
In Cristo, medico dell'umanità sofferente, le cose dell’anima appaiono diverse, e così i rapporti. Tutto ciò porta il suo gruppo a una differente visione di sé, della storia, del mondo, delle moltitudini (vv.7-9) e dei problemi.
Cosa incredibile, il Vangelo suggerisce di ripartire dalle masse abbandonate dalle loro guide, dai loro “pastori”!
In tal modo - secondo l’ideale dei Profeti - il Signore stesso raduna e forma l'autentico resto d’Israele. Non accetta il tessuto politico e confessionale a portata di mano.
E con Lui in mezzo, i suoi intimi si configurano come nucleo di una società dai modi semplici, ma finalmente dal discernimento solido, e relazioni divine.
Al tempo di Mc, con il moltiplicarsi delle congiure di palazzo e la guerra civile, a Roma tutti avevano ampia coscienza che la Pax Romana era ormai solo un antico ricordo, una cruda illusione.
In un momento di consapevolezza dello sgretolamento dell’età dell’oro promessa dal regime, ecco accentuarsi la paura popolare e la credenza nel predominio degli spiriti immondi sul bene.
D’altro canto, invece di liberare la gente, tutte le autorità delle varie espressioni religiose dell’epoca ne risucchiavano le energie - diffondendo fantasie e timori che finivano per alimentare angosce diffuse, in specie le ansie (pie ma tormentose) delle persone inconsapevoli.
Sulla base dell’insegnamento alternativo e dell’opera del suo Maestro, la Chiesa si sente investita dal compito di liberare il popolo dei soggiogati.
Le torture al cardiopalmo e gli incubi devotissimi andavano in ogni caso posti sullo sfondo, affinché affievolissero spontaneamente.
Se di matrice autentica, in ogni tempo la nuova proposta di vita non farà più leva sui sensi d’indegnità e le fobie del castigo degli dèi.
L’esempio concreto del Cristo vivente è la Barchetta, qui al v.9 [testo greco]: la minuscola Assemblea dei figli, in cui Egli permane.
Essa doveva non lasciarsi schiacciare dalle inquietudini epocali e da ossessioni di colpa, d’inadeguatezza, che le false guide spirituali del tempo inculcavano nel popolo bisognoso di tutto - e grazie alla loro diseducazione, reso ancor più radicalmente insufficiente.
Oltre gli schiavi, in quel momento altri miserabili erano i sottomessi del mondo spietato dell’Impero, nonché asserviti a dottrine puntigliose, strampalate, pedanti, delle varie “autorità” religiose.
Perché intimidite, le folle non riuscivano a vedere possibilità di emancipazione da un’esistenza pedissequa, spaventata, smarrita, sopraffatta - fatta di paure superstiziose portate all’eccesso.
Slegati dalle antiche prigionie e capaci di assumere ansie e speranze di ogni folla, i credenti facevano leva sulla fiducia.
La loro potenza di guarigione non si adagiava sulle capacità manipolatorie o di persuasione occulta degli imbonitori.
Nella folla dei semplici, costoro incutevano scrupoli a non finire.
Viceversa, i minimi acquisivano una visione limpida della storia e della vita. Ciò grazie alle relazioni conviviali e alla nuova Fede che disintegrava le ottusità del pensiero comune.
Così potevano rinvenire energie personali e comunitarie latenti, aiutarsi l’un l’altro, e sostenere altre persone a sollevarsi da ogni vicenda.
In tal guisa, rubando al potere del male tutta l'umanità prigioniera degl’idoli paralizzanti, o falsamente consolatori.
Ancora oggi, i fedeli autentici mai pretendono di rimpolpare l’adesione alla propria convivialità di sorelle e fratelli, allineandosi al clima di timori sul quale - ancora, a tutto spiano - fanno leva alcune credenze in campo e altri leaders.
«Il» Figlio di Dio atteso - con l'articolo determinativo [v.11 testo greco: «quello»] doveva essere una sorta di Re dei prìncipi della terra (proprio secondo la formula d’imposizione delle tiare - finalmente musealizzate).
«Il» Messia atteso veniva immaginato alla stregua d’un personaggio eccezionale, che doveva imporsi in modo perentorio.
L’Unto del Signore avrebbe definitivamente spazzato via i problemi, garantendo al popolo eletto uno straordinario benessere a scapito altrui.
Invece, la logica d’Incarnazione non s’identifica con astuzie, calcoli opportunisti, né tradizioni popolaresche, o convenzioni d’élite.
Il Signore si faceva semplicemente Presente in modo profondo - nell’io superiore di ciascuno e nel suo Popolo.
Ciascuno deve avere accesso e vita nuova.
Così la turba affranta può diventare chiesa di nuove armonie, di altre alleanze - ma a partire dalla sua debolezza integrata, conciliata - non più per via d’ignoranza e sottrazione, o psicosi.
Aderendo a Cristo, convivenza, comunione, qualità di sostegno, vocazione, naturalezza, carattere personale e concretezza si abbinano.
Il Signore non avrebbe voluto una istituzione servile e adulatrice, né spiritata e vuota - che possa creare scalpori o piramidi, e mettere soggezione.
Neppure magniloquente, forte, capace di dettare condizioni, ideologia e norme - bensì ridotta a «piccola barca» [v.9 testo greco].
Per questo motivo, mai Gesù ha sopportato la ricerca di fama o l’esibizionismo (v.12) inconcludenti.
La sua Amicizia non paternalista ci accompagna, comprende, sovviene, recupera, e sta pure un passo indietro.
Ecco la Fraternità particolare e Chiesa stessa in grado di amalgamare; dalla configurazione intima, che accosta e congiunge tutti. Unica condizione convincente e amabile.
Dice il Tao Tê Ching (xxxviii):
«L’uomo autentico resta in ciò che è solido e non si sofferma in ciò che è labile, resta nel frutto e non si sofferma nel fiore».
E il maestro Ho-shang Kung commenta: «Il saggio che pratica la Via resta in ciò che nel Tao [Via] è solido: significa che fa restare la propria persona nella semplicità».
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Cosa ti libera dalle ossessioni? C’è bisogno di una configurazione d’appoggio rassicurante, o fluida?
Secondo te, come si può far confluire le folle attorno a Gesù affinché si formino personalità libere, e cresca un apostolato e una ecclesiologia di comunione, nel rispetto delle differenze?
Stare con Lui, anche sociale
1 La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla vita di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. E’ possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta comporta immettersi in un cammino che dura tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm 6, 4), mediante il quale possiamo chiamare Dio con il nome di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del Signore Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in Lui (cfr Gv 17,22). Professare la fede nella Trinità – Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale a credere in un solo Dio che è Amore (cfr 1Gv 4,8): il Padre, che nella pienezza del tempo ha inviato suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù Cristo, che nel mistero della sua morte e risurrezione ha redento il mondo; lo Spirito Santo, che conduce la Chiesa attraverso i secoli nell’attesa del ritorno glorioso del Signore.
10 […] “Con il cuore … si crede … e con la bocca si fa la professione di fede” (Rm 10,10). Il cuore indica che il primo atto con cui si viene alla fede è dono di Dio e azione della grazia che agisce e trasforma la persona fin nel suo intimo.
L’esempio di Lidia è quanto mai eloquente in proposito. Racconta san Luca che Paolo, mentre si trovava a Filippi, andò di sabato per annunciare il Vangelo ad alcune donne; tra esse vi era Lidia e il “Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo” (At 16,14). Il senso racchiuso nell’espressione è importante. San Luca insegna che la conoscenza dei contenuti da credere non è sufficiente se poi il cuore, autentico sacrario della persona, non è aperto dalla grazia che consente di avere occhi per guardare in profondità e comprendere che quanto è stato annunciato è la Parola di Dio.
Professare con la bocca, a sua volta, indica che la fede implica una testimonianza ed un impegno pubblici. Il cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto privato. La fede è decidere di stare con il Signore per vivere con Lui. E questo “stare con Lui” introduce alla comprensione delle ragioni per cui si crede. La fede, proprio perché è atto della libertà, esige anche la responsabilità sociale di ciò che si crede. La Chiesa nel giorno di Pentecoste mostra con tutta evidenza questa dimensione pubblica del credere e dell’annunciare senza timore la propria fede ad ogni persona. È il dono dello Spirito Santo che abilita alla missione e fortifica la nostra testimonianza, rendendola franca e coraggiosa.
La stessa professione della fede è un atto personale ed insieme comunitario. E’ la Chiesa, infatti, il primo soggetto della fede.
[Papa Benedetto, motu proprio Porta Fidei]
Influsso degli angeli caduti
1. Continuando l’argomento delle precedenti catechesi dedicate all’articolo della fede riguardante gli angeli, creature di Dio, ci addentriamo oggi ad esplorare il mistero della libertà che alcuni di essi hanno indirizzato contro Dio e il suo piano di salvezza nei confronti degli uomini.
Come testimonia l’evangelista Luca, nel momento in cui i discepoli tornavano dal Maestro pieni di gioia per i frutti raccolti nel loro tirocinio missionario, Gesù pronuncia una frase che fa pensare: “Io vedevo satana cadere dal cielo come la folgore” (Lc 10, 18). Con queste parole il Signore afferma che l’annuncio del regno di Dio è sempre una vittoria sul diavolo, ma nello stesso tempo rivela anche che l’edificazione del Regno è continuamente esposta alle insidie dello spirito del male. Interessarsene, come intendiamo fare con la catechesi di oggi, vuol dire prepararsi alla condizione di lotta che è propria della vita della Chiesa in questo tempo ultimo della storia della salvezza (così come afferma l’Apocalisse). (cf. Ap 12, 7) D’altra parte, ciò permette di chiarire la retta fede della Chiesa di fronte a chi la stravolge esagerando l’importanza del diavolo, o di chi ne nega o ne minimizza la potenza malefica.
Le precedenti catechesi sugli angeli ci hanno preparati a comprendere la verità che la Sacra Scrittura ha rivelato e che la Tradizione della Chiesa ha trasmesso su satana, cioè sull’angelo caduto, lo spirito maligno, detto anche diavolo o demonio.
2. Questa “caduta”, che presenta il carattere del rifiuto di Dio con il conseguente stato di “dannazione”, consiste nella libera scelta di quegli spiriti creati, che hanno radicalmente e irrevocabilmente rifiutato Dio e il suo regno, usurpando i suoi diritti sovrani e tentando di sovvertire l’economia della salvezza e lo stesso ordinamento dell’intero creato. Un riflesso di questo atteggiamento lo si ritrova nelle parole del tentatore ai progenitori: “diventerete come Dio” o “come dèi” (cf. Gen 3, 5). Così lo spirito maligno tenta di trapiantare nell’uomo l’atteggiamento di rivalità, di insubordinazione e di opposizione a Dio, che è diventato quasi la motivazione di tutta la sua esistenza.
3. Nell’Antico Testamento la narrazione della caduta dell’uomo, riportata nel libro della Genesi, contiene un riferimento all’atteggiamento di antagonismo che satana vuole comunicare all’uomo per portarlo alla trasgressione. (cf. Gen 3, 5) Anche nel libro di Giobbe (cf. Gb 1, 11; 2, 5. 7) leggiamo che satana cerca di far nascere la ribellione nell’uomo che soffre. Nel libro della Sapienza (cf. Sap 2, 24) satana è presentato come l’artefice della morte, che è entrata nella storia dell’uomo assieme al peccato.
4. La Chiesa, nel Concilio Lateranense IV (1215), insegna che il diavolo (o satana) e gli altri demoni “sono stati creati buoni da Dio ma sono diventati cattivi per loro propria volontà”. Infatti leggiamo nella Lettera di san Giuda: “. . . gli angeli che non conservarono la loro dignità ma lasciarono la loro dimora, il Signore li tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del gran giorno” (Gd 6). Similmente nella seconda Lettera di san Pietro si parla di “angeli che avevano peccato” e che Dio “non risparmiò, ma . . . precipitò negli abissi tenebrosi dell’inferno, serbandoli per il giudizio” (2 Pt 2, 4). È chiaro che se Dio “non perdona” il peccato degli angeli lo fa perché essi rimangono nel loro peccato, perché sono eternamente “nelle catene” di quella scelta che hanno operato all’inizio, respingendo Dio, contro la verità del Bene supremo e definitivo che è Dio stesso. In questo senso scrive san Giovanni che “il diavolo è peccatore fin dal principio . . .” (1 Gv 3, 8). E “sin dal principio” egli è stato omicida e “non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui” (Gv 8, 4)
5. Questi testi ci aiutano a capire la natura e la dimensione del peccato di satana, consistente nel rifiuto della verità su Dio, conosciuto alla luce dell’intelligenza e della rivelazione come Bene infinito, Amore e Santità sussistente. Il peccato è stato tanto maggiore quanto maggiore era la perfezione spirituale e la perspicacia conoscitiva dell’intelletto angelico, quanto maggiore la sua libertà e la sua vicinanza a Dio. Respingendo la verità conosciuta su Dio con un atto della propria libera volontà, satana diventa “menzognero” cosmico e “padre della menzogna” (Gv 8, 4). Per questo egli vive nella radicale e irreversibile negazione di Dio e cerca di imporre alla creazione, agli altri esseri creati a immagine di Dio, e in particolare agli uomini, la sua tragica “menzogna sul Bene” che è Dio. Nel Libro della Genesi troviamo una descrizione precisa di tale menzogna e falsificazione della verità su Dio, che satana (sotto forma di serpente) tenta di trasmettere ai primi rappresentanti del genere umano: Dio sarebbe geloso delle sue prerogative e imporrebbe perciò delle limitazioni all’uomo (cf. Gen 3, 5). Satana invita l’uomo a liberarsi dell’imposizione di questo giogo, rendendosi “come Dio”.
6. In questa condizione di menzogna esistenziale satana diventa - secondo san Giovanni - anche “omicida”, cioè distruttore della vita soprannaturale che Dio sin dall’inizio aveva innestato in lui e nelle creature, fatte a “immagine di Dio”: gli altri puri spiriti e gli uomini; satana vuol distruggere la vita secondo la verità, la vita nella pienezza del bene, la soprannaturale vita di grazia e di amore. L’autore del Libro della Sapienza scrive: “. . . la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo e ne fanno esperienza coloro che gli appartengono” (Sap 2, 24). E nel Vangelo Gesù Cristo ammonisce: “Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l’anima e il corpo nella Geenna” (Mt 10, 28).
7. Come effetto del peccato dei progenitori questo angelo caduto ha conquistato in certa misura il dominio sull’uomo. Questa è la dottrina costantemente confessata e annunziata dalla Chiesa, e che il Concilio di Trento ha confermato nel trattato sul peccato originale (cf. DS 1511): essa trova drammatica espressione nella liturgia del Battesimo, quando al catecumeno viene richiesto di rinunziare al demonio e alle sue seduzioni.
Di questo influsso sull’uomo e sulle disposizioni del suo spirito (e del corpo), troviamo varie indicazioni nella Sacra Scrittura, nella quale satana è chiamato “il principe di questo mondo” (cf. Gv 12, 31; 14, 30; 16, 11), e persino il Dio “di questo mondo” (2 Cor 4, 4). Troviamo molti altri nomi che descrivono i suoi nefasti rapporti con l’uomo: “Beelzebul” o “Belial”, “spirito immondo”, “tentatore”, “maligno” e infine “anticristo” (1 Gv 4, 3). Viene paragonato a un “leone” (1 Pt 5, 8), a un “drago” (nell’Apocalisse) e a un “serpente” (Gen 3). Molto frequentemente per designarlo viene usato il nome “diavolo” dal greco “diaballein” (da cui “diabolos”), che vuol dire: causare la distruzione, dividere, calunniare, ingannare. E a dire il vero tutto questo avviene fin dall’inizio per opera dello spirito maligno che è presentato dalla Sacra Scrittura come una persona pur asserendo che non è solo: “siamo in molti”, gridano i diavoli a Gesù nella regione dei Geraseni (Mc 5, 9); “il diavolo e i suoi angeli”, dice Gesù nella descrizione del futuro giudizio (cf. Mt 25, 41).
8. Secondo la Sacra Scrittura, e specialmente il Nuovo Testamento, il dominio e l’influsso di satana e degli altri spiriti maligni abbraccia tutto il mondo. Pensiamo alla parabola di Cristo sul campo (che è il mondo), sul buon seme e su quello non buono che il diavolo semina in mezzo al grano cercando di strappare dai cuori quel bene che in essi è stato “seminato” (cf. Mt 13, 38-39). Pensiamo alle numerose esortazioni alla vigilanza (cf. Mt 26, 41; 1 Pt 5, 8), alla preghiera e al digiuno (cf. Mt 17, 21). Pensiamo a quella forte affermazione del Signore: “Questa specie di demoni in nessun altro modo si può scacciare se non con la preghiera” (Mc 9, 29). L’azione di satana consiste prima di tutto nel tentare gli uomini al male, influendo sulla loro immaginazione e sulle loro facoltà superiori per volgerle in direzione contraria alla legge di Dio. Satana mette alla prova persino Gesù (cf. Lc 4, 3-13), nel tentativo estremo di contrastare le esigenze dell’economia della salvezza così come Dio l’ha preordinata.
Non è escluso che in certi casi lo spirito maligno si spinga anche ad esercitare il suo influsso non solo sulle cose materiali, ma anche sul corpo dell’uomo, per cui si parla di “possessioni diaboliche” (cf. Mc 5, 2-9). Non è sempre facile discernere ciò che di preternaturale avviene in questi casi, né la Chiesa accondiscende o asseconda facilmente la tendenza ad attribuire molti fatti a interventi diretti del demonio; ma in linea di principio non si può negare che nella sua volontà di nuocere e di condurre al male, satana possa giungere a questa estrema manifestazione della sua superiorità.
9. Dobbiamo infine aggiungere che le impressionanti parole dell’apostolo Giovanni: “Tutto il mondo giace sotto il potere del maligno” (1 Gv 5, 19), alludono anche alla presenza di satana nella storia dell’umanità, una presenza che si acuisce man mano che l’uomo e la società si allontanano da Dio. L’influsso dello spirito maligno può “celarsi” in modo più profondo ed efficace: farsi ignorare corrisponde ai suoi “interessi”. L’abilità di satana nel mondo è quella di indurre gli uomini a negare la sua esistenza in nome del razionalismo e di ogni altro sistema di pensiero che cerca tutte le scappatoie pur di non ammetterne l’opera. Ciò non significa però l’eliminazione della libera volontà e della responsabilità dell’uomo e nemmeno la frustrazione dell’azione salvifica di Cristo. Si tratta piuttosto di un conflitto tra le forze oscure del male e quelle della redenzione. Sono eloquenti, a questo proposito, le parole che Gesù rivolse a Pietro all’inizio della passione: “. . . Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te perché non venga meno la tua fede” (Lc 22, 31).
Per questo comprendiamo come Gesù nella preghiera che ci ha insegnato, il “Padre nostro”, che è la preghiera del regno di Dio, termina quasi bruscamente, a differenza di tante altre preghiere del suo tempo, richiamandoci alla nostra condizione di esposti alle insidie del Male-Maligno. Il cristiano, appellandosi al Padre con lo spirito di Gesù e invocando il suo regno, grida con la forza della fede: fa’ che non soccombiamo alla tentazione, liberaci dal Male, dal Maligno. Fa’, o Signore, che non cadiamo nell’infedeltà a cui ci seduce colui che è stato infedele fin dall’inizio.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 13 agosto 1986]
Cuore, teatro di una lotta. E Gesù non è Maestro statico
Il cuore di ogni cristiano è teatro di una «lotta». Ogni volta che il Padre «ci attira» verso Gesù, c’è «qualcun altro che ci fa la guerra». Lo ha sottolineato Papa Francesco nell’omelia della messa celebrata a Santa Marta giovedì 19 gennaio, durante la quale, commentando il vangelo del giorno (Marco, 3, 7-12) si è soffermato sulle ragioni che spingono l’uomo a seguire Gesù. E ad analizzare come questa sequela non sia mai priva di difficoltà, anzi se non si combattesse ogni giorno con una serie di «tentazioni», si rischierebbe una religiosità formale e ideologica.
Nel passo evangelico, ha notato il Pontefice, per ben tre volte «si dice la parola “folla”: lo seguì molta folla da tutte le parti; una grande folla; e la folla si gettava su di lui, per toccarlo». Una folla «calda di entusiasmo, che seguiva Gesù con calore e veniva da tutte le parti: da Tiro e Sidone, dall’Idumea e dalla Transgiordania». In tanti «facevano questo cammino a piedi per trovare il Signore». E di fronte a tale insistenza viene da chiedersi: «Perché veniva questa folla? Perché questo entusiasmo? Di cosa aveva bisogno?». Le motivazioni suggerite da Francesco possono essere molteplici. «Lo stesso Vangelo ci dice che c’erano ammalati che cercavano di guarire» ma c’erano anche molti che erano giunti «per ascoltarlo». Del resto «a questa gente piaceva sentire Gesù, perché parlava non come i loro dottori, ma parlava con autorità. Questo toccava il cuore». Di sicuro, ha sottolineato il Papa, «era una folla di gente che veniva spontaneamente: non la portavano nei bus, come abbiamo visto tante volte quando si organizzano manifestazioni e tanti devono andare lì per “verificare” la presenza, per non perdere poi il posto di lavoro».
Quindi questa gente «andava perché sentiva qualcosa». Ed erano talmente numerosi «che Gesù ha dovuto chiedere una barca e andare un po’ lontano dalla riva, perché questa gente non lo schiacciasse». Ma il vero motivo, quello profondo, quale era? Secondo il Pontefice «Gesù stesso nel Vangelo spiega» questa sorta di «fenomeno sociale» e dice: «Nessuno può venire da me se non lo attira il Padre». Infatti, ha chiarito Francesco, se è vero che questa folla andava da Gesù perché «aveva bisogno» o perché «alcuni erano curiosi» il vero motivo si ritrova nel fatto che «questa folla la attirava il Padre: era il Padre che attirava la gente a Gesù». E Cristo «non rimaneva indifferente, come un maestro statico che diceva le sue parole e poi si lavava le mani. No! Questa folla toccava il cuore di Gesù». Proprio nel vangelo si legge che «Gesù era commosso, perché vedeva questa gente come pecore senza pastore».
Quindi, ha spiegato il Pontefice, «il Padre, tramite lo Spirito Santo, attira la gente a Gesù». È inutile andare a cercare «tutte le argomentazioni». Ogni motivo può essere «necessario» ma «non è sufficiente per far muovere un dito. Tu non puoi muovere» fare «un passo solo con gli argomenti apologetici». Ciò che è davvero necessario e decisivo invece è «che sia il Padre a tirarti a Gesù».
Lo spunto decisivo per la riflessione del Pontefice è giunto quando ha preso in esame le ultime righe del breve stralcio evangelico proposto dalla liturgia: «È curioso» — ha notato — che in questo passo mentre si parla «di Gesù, si parla della folla, dell’entusiasmo, anche con quanto amore con cui Gesù li riceveva e li guariva» si trovi un finale un po’ insolito. È scritto infatti: «Gli spiriti impuri quando lo vedevano cadevano ai suoi piedi e gridavano “Tu sei il Figlio di Dio!”».
Ma proprio questa — ha detto il Papa — «è la verità; questa è la realtà che ognuno di noi sente quando si avvicina Gesù» e cioè che «gli spiriti impuri cercano di impedirlo, ci fanno la guerra».
Qualcuno potrebbe obbiettare: «Ma, padre, io sono molto cattolico; io vado sempre a messa... Ma mai, mai ho queste tentazioni. Grazie a Dio!». E invece no. La risposta è: «No! Prega, perché sei su una strada sbagliata!» poiché «una vita cristiana senza tentazioni non è cristiana: è ideologica, è gnostica, ma non è cristiana». Succede infatti che «quando il Padre attira la gente a Gesù, c’è un altro che attira in modo contrario e ti fa la guerra dentro!». Non a caso san Paolo «parla della vita cristiana come di una lotta: una lotta di tutti i giorni. Per vincere, per distruggere l’impero di satana, l’impero del male». Ed proprio per questo, ha aggiunto il Papa, che «è venuto Gesù, per distruggere satana! Per distruggere il suo influsso sui nostri cuori».
Con questa notazione finale nel brano evangelico si sottolinea l’essenziale: «sembra che, in questa scena», spariscano «sia Gesù, sia la folla e soltanto restino il Padre e gli spiriti impuri, cioè lo spirito del male. Il Padre che attira la gente a Gesù e lo spirito del male che cerca di distruggere, sempre!».
Capiamo così — ha concluso il Pontefice — che «la vita cristiana è una lotta» nella quale «o tu ti lasci attirare da Gesù, per mezzo del Padre, o puoi dire “Io rimango tranquillo, in pace”... Ma nelle mani di questa gente, di questi spiriti impuri». Però «se tu vuoi andare avanti devi lottare! Sentire il cuore che lotta, perché Gesù vinca».
Perciò, è la conclusione, ogni cristiano deve fare questo esame di coscienza e chiedersi: «Io sento questa lotta nel mio cuore?». Questo conflitto «fra la comodità o il servizio agli altri, fra divertirmi un po’ o fare preghiera e adorare il Padre, fra una cosa e l’altra?». Sento «la voglia di fare il bene» o c’è «qualcosa che mi ferma, mi torna ascetico?». E ancora: «Io credo che la mia vita commuova il cuore di Gesù? Se io non credo questo — ha ammonito il Papa — devo pregare tanto per crederlo, perché mi sia data questa grazia».
[Papa Francesco, s. Marta, in L’Osservatore Romano 20/01/2017]
Il discernimento si fa acuto: simbologia della Mano
Sollecitudini diverse, e l’azione umanizzante
(Mc 3,1-6)
Procurare il bene e sollevare la persona reale - così com’è, nella propria unicità - è l’unico valore non negoziabile; criterio di tutto il Vangelo.
Anche la Torah nel suo nucleo e senso voleva essere un mezzo importante della pedagogia umana, personale, religiosa - non il fine.
Le norme ci accompagnano volentieri, quando facilitano la strada per dialogare con il Signore… in noi e nei fratelli. Ma la “lettera” è fredda e immotivata.
Avvenuto l’Incontro, la precedenza va data al Progetto di Dio, sollecito a realizzarci e lasciar fiorire; non alle procedure.
Infatti, le prescrizioni mettono tutti e sempre in allerta nei confronti del ‘bisogno diverso’.
Per questo, solidarietà e fraternità sono poste al di sopra di qualsiasi ossequio devoto e identitario, o necessità dottrinale, nonché osservanze esteriori del culto [se vissuto da automi].
Le stesse norme vanno comprese affinché conducano alla vita ‘con’ e ‘in’ Cristo - per la realizzazione e pienezza di essere.
Altrimenti la virtù scrupolosa di religione si converte in azione maligna e vizio di fede - che perde la totalità della persona (v.4).
In tal guisa, nel giorno della sinagoga non si deve celebrare una restaurazione che timbri il cartellino.
Piuttosto, ci si raduna in assemblea per meglio restituire la donna e l’uomo alla loro dignità di esseri sublimi, da promuovere in modo illimitato.
Il sabato del Messia non è giorno delle parzialità di costume: è tempo di benessere recuperato - di Liberazione e Creazione, di promozione delle energie vitali, secondo il Disegno originario e pieno del Padre.
Infatti, nel luogo del rito abitudinario, dove vige la mentalità compassata, Gesù non va a pregare, bensì a insegnare e curare.
Neppure il paralizzato aveva chiesto guarigione - tanto gli sembrava normale stare lì in quel modo e non ricevere attenzioni, né alcuno stimolo; neanche il bene.
Nondimeno l’Amore è nucleo ed essenza della Legge: anche in giorno di precetto l’aiuto era pur consentito dalle stesse prescrizioni in caso di necessità estrema o ripercussione sugli altri.
Gesù sta dicendo che sbloccare la persona che non riesce a fare nulla di buono - «mano arida» (vv.1.3) - è questione di vita o di morte, anche per tutta la comunità [guarire o «annientare»: v.4].
Osservare il giorno del Signore significa, anche per noi: potenziare le possibilità espressive dell’uomo e reintegrarlo in un ‘ordine nuovo’.
Per adempiere il “precetto” redentivo, gli atteggiamenti devianti vanno per primi anch’essi assunti, e salvati - al pari di energie preparatorie di nuovi assetti.
Non possiamo permetterci ulteriori trascuratezze.
La crisi che investe tutti fa trapelare la differenza tra… contenuti inconsci e verità, fossilizzazioni ed energie nascoste; religiosità e Fede - discrimine della vita in Cristo e nello Spirito.
Nei suoi lati di limitazione e Completezza, legalismo o Liberazione, stasi e Rinascita, ritorno a “come sempre” o Rigenerazione, formalismo e Letizia [così via], oggi il discernimento si fa più acuto.
Avendo già valutato inutile approfittare dell’istituzione religiosa ufficiale per immettere in essa la novità del Regno, nel cap.3 del Vangelo di Mc si propugna un nuovo progetto di comunità.
In tale opera il Signore parte sempre dalle masse abbandonate dai loro pastori; indicandoci la strada.
[Mercoledì 2.a sett. T.O. 21 gennaio 2026]
Il discernimento si fa acuto: simbologia della mano
Sollecitudini diverse: l’azione umanizzante, e quella secca dei gufi
(Mc 3,1-6)
Commentando il Tao Tê Ching (XLVII), il maestro Ho-shang Kung scrive: «Il santo conosce il grande basandosi sul piccolo, l’esteriore esaminando l’interiore».
E ribadisce: «Senza salire in cielo e senza scendere negli abissi, il santo conosce il Cielo e la Terra: li conosce con il cuore».
Procurare il bene e sollevare la persona reale - così com’è, nella propria unicità - è l’unico valore non negoziabile; criterio di tutto il Vangelo.
Anche la Torah nel suo nucleo e senso voleva essere un mezzo importante della pedagogia umana, personale, religiosa - non il fine.
Le norme ci accompagnano volentieri, quando esse facilitano la strada per dialogare con il Signore, incontrandolo in noi e nei fratelli.
Ma la “lettera” è fredda e immotivata.
Avvenuto l’Incontro, la precedenza va data al Progetto di Dio, sollecito a realizzarci e lasciar fiorire; non alle procedure.
Infatti, le prescrizioni mettono tutti e sempre in allerta nei confronti del ‘bisogno diverso’.
Per questo, solidarietà e fraternità sono poste al di sopra di qualsiasi ossequio devoto e identitario, o necessità dottrinale, nonché osservanza esteriore del culto [se vissuto da automi].
Le stesse norme vanno comprese affinché conducano alla vita ‘con’ e ‘in’ Cristo - per la realizzazione e pienezza di essere.
Altrimenti la virtù scrupolosa di religione si converte in azione maligna e vizio di fede - che perde la totalità della persona (v.4).
In tal guisa, nel giorno della sinagoga non si deve celebrare una restaurazione che timbri il cartellino.
Piuttosto, ci si raduna in assemblea per meglio restituire l’uomo alla sua dignità di essere sublime, da promuovere in modo illimitato.
Il sabato del Messia non è il giorno delle parzialità di costume: gesti e parole esprimono il Volto del Padre, la sua sollecitudine.
È tempo insieme di Liberazione e Creazione, di promozione delle energie vitali, secondo il Disegno originario e pieno.
Ma nel luogo del rito abitudinario, dove vige la mentalità tradizionale [ovvero à la page] compassata, Gesù non va a pregare, bensì a insegnare e curare.
Neppure il paralizzato aveva chiesto guarigione - tanto gli sembrava normale stare lì in quel modo e non ricevere attenzioni, né alcuno stimolo; neanche il bene.
Nondimeno l’Amore è nucleo ed essenza della Legge: anche in giorno di precetto l’aiuto era pur consentito dalle stesse prescrizioni, in caso di necessità estrema o ripercussione sugli altri.
Il Signore sta dicendo ai [suoi intimi] responsabili di chiesa:
Sbloccare la persona che non riesce a fare nulla di buono - «mano arida» (vv.1.3) - è questione di vita o di morte, anche per tutta la comunità [guarire o «annientare»: v.4].
Quando i parrucconi della religione indifferente e secca, e i primi della classe della devozione sofisticata, distorta, vengono provocati, la maschera pia scompare.
Diventano violenti anche di fronte al bene che Dio opera su chi è malmesso - e votato al peggio senza neanche accorgersi.
La mano [l’azione] da guarire resta anzitutto quella delle mummie unilaterali cui si rivolge l’insegnamento forte dell’episodio.
Osservare il giorno del Signore significa, anche per noi: potenziare le possibilità espressive dell’uomo e reintegrarlo in un ‘ordine nuovo’.
Ciò sgombrando l’ambiente incline al settarismo [o all’ideologismo] da gufi vecchi e nuovi che intendono salvare le apparenze per mantenere potere, finto prestigio dottrinale, sudditanza delle coscienze.
Ma per adempiere il “precetto” redentivo, gli atteggiamenti devianti vanno per primi anch’essi assunti, e salvati - al pari di energie preparatorie di nuovi assetti.
Ancora il maestro Ho-shang: «Quando chi sta in alto ama la Via, chi sta in basso ama la virtù; quando chi sta in alto ama la guerra, chi sta in basso ama la forza».
Le agenzie di plagio di alcune “chiesuole” particolari che vogliono le anime bloccate su rapporti di dominio, volentieri progetterebbero di far permanere i malati nel loro stato di dipendenza.
Per alcuni perversi meccanismi di pastorale e catechesi di massa, i timorosi e insicuri devono restare anonimi; anche nel tempo del cammino sinodale.
I senza voce sono sempre utili, affinché i ben introdotti possano continuare a galleggiare sul mondo - con le loro immutate manfrine o teorie.
Per interesse devoto, moralista, o di parte [questa sì privata e glamour, ovvero colma d’insidie legaliste] ben volentieri li lascerebbero incerti e inconsapevoli, o peggio - anche se si presentasse Gesù in persona a liberarli.
Non ce lo possiamo più permettere.
Non possiamo più acconsentire trascuratezze: l’attuale scossone della crisi globale sta accelerando la caduta delle maschere, degli atteggiamenti paludosi o istrionici; e delle pratiche simboliche fini a se stesse.
L’emergenza che investe tutti fa comprendere meglio la differenza tra contenuti inconsci e verità, fossilizzazioni sedentarie ed energie nascoste; religiosità e Fede - discrimine della vita in Cristo e nello Spirito.
Nei suoi lati di limitazione e Completezza, legalismo e Liberazione, stasi e Rinascita, ritorno a come sempre o Rigenerazione, formalismo e Letizia, oggi il discernimento si fa più acuto.
Avendo già valutato inutile approfittare dell’istituzione religiosa ufficiale per immettere in essa la novità del Regno, nel cap.3 del Vangelo di Mc si propugna un nuovo progetto di comunità.
Il Maestro vuole guidare le persone di ogni ceto a sentire e vivere profondamente la propria e altrui dimensione umana, segnata dalla paradossale feconda esperienza della fallibilità.
Solo quando ne interiorizzassero il senso e vivessero così, le autorità e i credenti farebbero davvero l’esperienza di provare compassione verso i limiti della carne - comprensione caratteristica dell’essere “umani”.
In tale opera il Signore parte sempre dalle masse abbandonate dai loro pastori.
L’incipit autentico viene da gente insignificante ma svincolata dalle autorità del tessuto religioso-politico, e dalle linee di successione dinastica ufficiali.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Quando hai notato virtù di religione convertite in vizi di fede?
Cosa intendi per Salvezza assicurata dal Regno di Dio?
Teologia e simbologia della Mano:
«Riflettiamo perciò nuovamente sui segni nei quali il Sacramento ci è stato donato. Al centro c'è il gesto antichissimo dell'imposizione delle mani, col quale Egli ha preso possesso di me dicendomi: "Tu mi appartieni". Ma con ciò ha anche detto: "Tu stai sotto la protezione delle mie mani. Tu stai sotto la protezione del mio cuore. Tu sei custodito nel cavo delle mie mani e proprio così ti trovi nella vastità del mio amore. Rimani nello spazio delle mie mani e dammi le tue".
Ricordiamo poi che le nostre mani sono state unte con l'olio che è il segno dello Spirito Santo e della sua forza. Perché proprio le mani? La mano dell'uomo è lo strumento del suo agire, è il simbolo della sua capacità di affrontare il mondo, appunto di "prenderlo in mano". Il Signore ci ha imposto le mani e vuole ora le nostre mani affinché, nel mondo, diventino le sue. Vuole che non siano più strumenti per prendere le cose, gli uomini, il mondo per noi, per ridurlo in nostro possesso, ma che invece trasmettano il suo tocco divino, ponendosi a servizio del suo amore. Vuole che siano strumenti del servire e quindi espressione della missione dell'intera persona che si fa garante di Lui e lo porta agli uomini. Se le mani dell'uomo rappresentano simbolicamente le sue facoltà e, generalmente, la tecnica come potere di disporre del mondo, allora le mani unte devono essere un segno della sua capacità di donare, della creatività nel plasmare il mondo con l'amore – e per questo, senz'altro, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Nell'Antico Testamento l'unzione è segno dell'assunzione in servizio: il re, il profeta, il sacerdote fa e dona più di quello che deriva da lui stesso. In un certo qual modo è espropriato di sé in funzione di un servizio, nel quale si mette a disposizione di uno più grande di lui. Se Gesù si presenta oggi nel Vangelo come l'Unto di Dio, il Cristo, allora questo vuol proprio dire che Egli agisce per missione del Padre e nell'unità con lo Spirito Santo e che, in questo modo, dona al mondo una nuova regalità, un nuovo sacerdozio, un nuovo modo d'essere profeta, che non cerca se stesso, ma vive per Colui, in vista del quale il mondo è stato creato. Mettiamo le nostre mani oggi nuovamente a sua disposizione e preghiamolo di prenderci sempre di nuovo per mano e di guidarci».
[Papa Benedetto, omelia del Crisma 13 aprile 2006]
La dottrina della giustificazione: dalle opere alla fede.
Cari fratelli e sorelle,
nel cammino che stiamo compiendo sotto la guida di san Paolo, vogliamo ora soffermarci su un tema che sta al centro delle controversie del secolo della Riforma: la questione della giustificazione. Come diventa giusto l’uomo agli occhi di Dio? Quando Paolo incontrò il Risorto sulla strada di Damasco era un uomo realizzato: irreprensibile quanto alla giustizia derivante dalla Legge (cfr Fil 3,6), superava molti suoi coetanei nell’osservanza delle prescrizioni mosaiche ed era zelante nel sostenere le tradizioni dei padri (cfr Gal 1,14). L’illuminazione di Damasco gli cambiò radicalmente l'esistenza: cominciò a considerare tutti i meriti, acquisiti in una carriera religiosa integerrima, come “spazzatura” di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo (cfr Fil 3,8). La Lettera ai Filippesi ci offre una toccante testimonianza del passaggio di Paolo da una giustizia fondata sulla Legge e acquisita con l'osservanza delle opere prescritte, ad una giustizia basata sulla fede in Cristo: egli aveva compreso che quanto fino ad allora gli era parso un guadagno in realtà di fronte a Dio era una perdita e aveva deciso perciò di scommettere tutta la sua esistenza su Gesù Cristo (cfr Fil 3,7). Il tesoro nascosto nel campo e la perla preziosa nel cui acquisto investire tutto il resto non erano più le opere della Legge, ma Gesù Cristo, il suo Signore.
Il rapporto tra Paolo e il Risorto diventò talmente profondo da indurlo a sostenere che Cristo non era più soltanto la sua vita ma il suo vivere, al punto che per poterlo raggiungere persino il morire diventava un guadagno (cfr Fil 1,21). Non che disprezzasse la vita, ma aveva compreso che per lui il vivere non aveva ormai altro scopo e non nutriva perciò altro desiderio che di raggiungere Cristo, come in una gara di atletica, per restare sempre con Lui: il Risorto era diventato l’inizio e il fine della sua esistenza, il motivo e la mèta della sua corsa. Soltanto la preoccupazione per la maturazione nella fede di coloro che aveva evangelizzato e la sollecitudine per tutte le Chiese da lui fondate (cfr 2 Cor 11,28) lo inducevano a rallentare la corsa verso il suo unico Signore, per attendere i discepoli affinché con lui potessero correre verso la mèta. Se nella precedente osservanza della Legge non aveva nulla da rimproverarsi dal punto di vista dell’integrità morale, una volta raggiunto da Cristo preferiva non pronunciare giudizi su se stesso (cfr 1 Cor 4,3-4), ma si limitava a proporsi di correre per conquistare Colui dal quale era stato conquistato (cfr Fil 3,12).
È proprio per questa personale esperienza del rapporto con Gesù Cristo che Paolo colloca ormai al centro del suo Vangelo un’irriducibile opposizione tra due percorsi alternativi verso la giustizia: uno costruito sulle opere della Legge, l’altro fondato sulla grazia della fede in Cristo. L’alternativa fra la giustizia per le opere della Legge e quella per la fede in Cristo diventa così uno dei motivi dominanti che attraversano le sue Lettere: “Noi, che per nascita siamo Giudei e non pagani peccatori, sapendo tuttavia che l'uomo non è giustificato per le opere della Legge, ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù, per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della Legge; poiché per le opere della Legge non verrà mai giustificato nessuno” (Gal 2,15-16). E ai cristiani di Roma ribadisce che “tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, per mezzo della redenzione che è in Cristo Gesù (Rm 3,23-24). E aggiunge “Noi riteniamo, infatti che l’uomo è giustificato per la fede, indipendentemente dalle opere della Legge” (Ibid 28). Lutero a questo punto tradusse: “giustificato per la sola fede”. Ritornerò su questo punto alla fine della catechesi. Prima dobbiamo chiarire che cosa è questa “Legge” dalla quale siamo liberati e che cosa sono quelle “opere della Legge” che non giustificano. Già nella comunità di Corinto esisteva l’opinione che sarebbe poi ritornata sistematicamente nella storia; l’opinione consisteva nel ritenere che si trattasse della legge morale e che la libertà cristiana consistesse quindi nella liberazione dall’etica. Così a Corinto circolava la parola “πάντα μοι έξεστιν” (tutto mi è lecito). E’ ovvio che questa interpretazione è sbagliata: la libertà cristiana non è libertinismo, la liberazione della quale parla san Paolo non è liberazione dal fare il bene.
Ma che cosa significa dunque la Legge dalla quale siamo liberati e che non salva? Per san Paolo, come per tutti i suoi contemporanei, la parola Legge significava la Torah nella sua totalità, cioè i cinque libri di Mosè. La Torah implicava, nell’interpretazione farisaica, quella studiata e fatta propria da Paolo, un complesso di comportamenti che andava dal nucleo etico fino alle osservanze rituali e cultuali che determinavano sostanzialmente l’identità dell’uomo giusto. Particolarmente la circoncisione, le osservanze circa il cibo puro e generalmente la purezza rituale, le regole circa l’osservanza del sabato, ecc. Comportamenti che appaiono spesso anche nei dibattiti tra Gesù e i suoi contemporanei. Tutte queste osservanze che esprimono una identità sociale, culturale e religiosa erano divenute singolarmente importanti al tempo della cultura ellenistica, cominciando dal III secolo a.C. Questa cultura, che era diventata la cultura universale di allora, ed era una cultura apparentemente razionale, una cultura politeista, apparentemente tollerante, costituiva una pressione forte verso l’uniformità culturale e minacciava così l’identità di Israele, che era politicamente costretto ad entrare in questa identità comune della cultura ellenistica con conseguente perdita della propria identità, perdita quindi anche della preziosa eredità della fede dei Padri, della fede nell’unico Dio e nelle promesse di Dio.
Contro questa pressione culturale, che minacciava non solo l’identità israelitica, ma anche la fede nell’unico Dio e nelle sue promesse, era necessario creare un muro di distinzione, uno scudo di difesa a protezione della preziosa eredità della fede; tale muro consisteva proprio nelle osservanze e prescrizioni giudaiche. Paolo, che aveva appreso tali osservanze proprio nella loro funzione difensiva del dono di Dio, dell’eredità della fede in un unico Dio, ha visto minacciata questa identità dalla libertà dei cristiani: per questo li perseguitava. Al momento del suo incontro con il Risorto capì che con la risurrezione di Cristo la situazione era cambiata radicalmente. Con Cristo, il Dio di Israele, l’unico vero Dio, diventava il Dio di tutti i popoli. Il muro – così dice nella Lettera agli Efesini – tra Israele e i pagani non era più necessario: è Cristo che ci protegge contro il politesimo e tutte le sue deviazioni; è Cristo che ci unisce con e nell’unico Dio; è Cristo che garantisce la nostra vera identità nella diversità delle culture. Il muro non è più necessario, la nostra identità comune nella diversità delle culture è Cristo, ed è lui che ci fa giusti. Essere giusto vuol semplicemente dire essere con Cristo e in Cristo. E questo basta. Non sono più necessarie altre osservanze. Perciò l’espressione “sola fide” di Lutero è vera, se non si oppone la fede alla carità, all’amore. La fede è guardare Cristo, affidarsi a Cristo, attaccarsi a Cristo, conformarsi a Cristo, alla sua vita. E la forma, la vita di Cristo è l’amore; quindi credere è conformarsi a Cristo ed entrare nel suo amore. Perciò san Paolo nella Lettera ai Galati, nella quale soprattutto ha sviluppato la sua dottrina sulla giustificazione, parla della fede che opera per mezzo della carità (cfr Gal 5,14).
Paolo sa che nel duplice amore di Dio e del prossimo è presente e adempiuta tutta la Legge. Così nella comunione con Cristo, nella fede che crea la carità, tutta la Legge è realizzata. Diventiamo giusti entrando in comunione con Cristo che è l'amore. Vedremo la stessa cosa nel Vangelo della prossima domenica, solennità di Cristo Re. È il Vangelo del giudice il cui unico criterio è l'amore. Ciò che domanda è solo questo: Tu mi hai visitato quando ero ammalato? Quando ero in carcere? Tu mi hai dato da mangiare quando ho avuto fame, tu mi hai vestito quando ero nudo? E così la giustizia si decide nella carità. Così, al termine di questo Vangelo, possiamo quasi dire: solo amore, sola carità. Ma non c'è contraddizione tra questo Vangelo e San Paolo. È la medesima visione, quella secondo cui la comunione con Cristo, la fede in Cristo crea la carità. E la carità è realizzazione della comunione con Cristo. Così, essendo uniti a Lui siamo giusti e in nessun altro modo.
Alla fine, possiamo solo pregare il Signore che ci aiuti a credere. Credere realmente; credere diventa così vita, unità con Cristo, trasformazione della nostra vita. E così, trasformati dal suo amore, dall’amore di Dio e del prossimo, possiamo essere realmente giusti agli occhi di Dio.
[Papa Benedetto, Udienza Generale 19 novembre 2008]
La contrapposizione tra carne e spirito e la “giustificazione” nella fede
Gesù di Nazaret, il Bimbo che vagisce nella mangiatoia di Betlemme, è il Verbo eterno di Dio che si è incarnato per amore dell’uomo ( Gv 1,14). Questa è la grande verità alla quale il cristiano aderisce con profonda fede. Con la fede di Maria Santissima che, nella gloria della sua intatta verginità, concepì e generò il Figlio di Dio fatto uomo. Con la fede di San Giuseppe che lo custodì e lo protesse con immensa dedizione d’amore. Con la fede dei pastori che accorsero subito alla grotta della natività. Con la fede dei Magi che lo intravidero nel segno della stella e, dopo lunghe ricerche, poterono contemplarlo e adorarlo nelle braccia della Vergine Madre.
Che il nuovo anno sia vissuto da tutti sotto il segno di questa grande gioia interiore, frutto della certezza che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.
È l’augurio che rivolgo a tutti voi che siete presenti a questa prima udienza generale del 1981 ed a tutti i vostri cari.
1. Che cosa significa l’affermazione: "La carne... ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne"? (Gal 5,17) Questa domanda sembra importante, anzi fondamentale nel contesto delle nostre riflessioni sulla purezza di cuore, di cui parla il Vangelo. Tuttavia, l’Autore della lettera ai Galati apre davanti a noi, a questo riguardo, orizzonti ancor più vasti. In questa contrapposizione della "carne" allo Spirito (Spirito di Dio), e della vita "secondo la carne" alla vita "secondo lo Spirito" è contenuta la teologia paolina circa la giustificazione, cioè l’espressione della fede nel realismo antropologico ed etico della redenzione compiuta da Cristo, che Paolo, nel contesto a noi già noto, chiama anche "redenzione del corpo". Secondo la Lettera ai Romani (Rm 8,23), la "redenzione del corpo" ha anche una dimensione "cosmica" (riferita a tutta la creazione), ma al centro di essa vi è l’uomo: l’uomo costituito nell’unità personale dello spirito e del corpo. E appunto in questo uomo, nel suo "cuore", e conseguentemente in tutto il suo comportamento, fruttifica la redenzione di Cristo, grazie a quelle forze dello Spirito che attuano la "giustificazione", cioè fanno sì che la giustizia "abbondi" nell’uomo come è inculcato nel discorso della montagna: Matteo (Mt 5,20), cioè "abbondi" nella misura che Dio stesso ha voluto e che Egli attende.
2. È significativo che Paolo, parlando delle "opere della carne" (cf. Gal 5,11-21), menziona non soltanto "fornicazione, impurità, libertinaggio... ubriachezza, orge" – quindi, tutto ciò che, secondo un modo di comprendere oggettivo, riveste il carattere dei "peccati carnali" e del godimento sensuale collegato con la carne – ma nomina anche altri peccati, ai quali non saremmo portati ad attribuire un carattere anche "carnale" e "sensuale": "idolatria, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, invidie..." (Gal 5,20-21). Secondo le nostre categorie antropologiche (ed etiche) noi saremmo propensi piuttosto a chiamare tutte le "opere" qui elencate "peccati dello spirito" umano, anziché peccati della "carne". Non senza motivo avremmo potuto intravedere in esse piuttosto gli effetti della "concupiscenza degli occhi" o della "superbia della vita" che non gli effetti della "concupiscenza della carne". Tuttavia, Paolo le qualifica tutte come "opere della carne". Ciò s’intende esclusivamente sullo sfondo di quel significato più ampio (in certo senso metonimico), che nelle lettere paoline assume il termine "carne", contrapposto non soltanto e non tanto allo "spirito" umano quanto allo Spirito Santo che opera nell’anima (nello spirito) dell’uomo.
3. Esiste, dunque, una significativa analogia tra ciò che Paolo definisce come "opere della carne" e le parole con cui Cristo spiega ai suoi discepoli ciò che prima aveva detto ai farisei circa la "purezza" e l’"impurità" rituale (cf. Mt 15,2-20). Secondo le parole di Cristo, la vera "purezza" (come anche l’"impurità") in senso morale sta nel "cuore" e proviene "dal cuore" umano. Come "opere impure" nello stesso senso, sono definiti non soltanto gli "adulteri" e le "prostituzioni", quindi i "peccati della carne" in senso stretto, ma anche i "propositi malvagi... i furti, le false testimonianze, le bestemmie". Cristo, come abbiamo già potuto costatare, si serve qui del significato tanto generale quanto specifico dell’"impurità" (e quindi indirettamente anche della "purezza"). San Paolo si esprime in maniera analoga: le opere "della carne" sono intese nel testo paolino in senso tanto generale quanto specifico. Tutti i peccati sono espressione della "vita secondo la carne", che è in contrasto con la "vita secondo lo Spirito". Quello che, conformemente alla nostra convenzione linguistica (del resto parzialmente giustificata), viene considerato come "peccato della carne", nell’elenco paolino è una delle tante manifestazioni (o specie) di ciò che egli denomina "opere della carne", e, in questo senso, uno dei sintomi, cioè delle attualizzazioni della vita "secondo la carne" e non "secondo lo Spirito".
4. Le parole di Paolo scritte ai Romani: "Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere secondo la carne; poiché se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece con l’aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete" (Rm 8,12-13), c’introducono nuovamente nella ricca e differenziata sfera dei significati, che i termini "corpo" e "spirito" hanno per lui. Tuttavia, il significato definitivo di quell’enunciato è parenetico, esortativo, quindi valido per l’ethos evangelico. Paolo, quando parla della necessità di far morire le opere del corpo con l’aiuto dello Spirito, esprime appunto ciò di cui Cristo ha parlato nel Discorso della Montagna, facendo richiamo al cuore umano ed esortandolo al dominio dei desideri, anche di quelli che si esprimono nello "sguardo" dell’uomo rivolto verso la donna al fine di appagare la concupiscenza della carne. Tale superamento, ossia, come scrive Paolo, il "far morire le opere del corpo con l’aiuto dello Spirito", è condizione indispensabile della "vita secondo lo Spirito", cioè della "vita" che è antitesi della "morte" di cui si parla nello stesso contesto. La vita "secondo la carne" fruttifica infatti la "morte", cioè comporta come effetto la "morte" dello Spirito.
Dunque, il termine "morte" non significa soltanto morte corporale, ma anche il peccato, che la teologia morale chiamerà mortale. Nelle Lettere ai Romani e ai Galati l’Apostolo allarga continuamente l’orizzonte del "peccato-morte", sia verso il "principio" della storia dell’uomo, sia verso il suo termine. E perciò, dopo aver elencato le multiformi "opere della carne", afferma che "chi le compie non erediterà il regno di Dio" ( Gal 5,21). Altrove scriverà con simile fermezza: "Sappiatelo bene, nessun fornicatore, o impuro, o avaro – che è roba da idolatri – avrà parte al regno di Cristo e di Dio" ( Ef 5,5). Anche in questo caso, le opere che escludono dall’aver "parte al regno di Cristo e di Dio" – cioè le "opere della carne" – vengono elencate come esempio e con valore generale, sebbene al primo posto stiano qui i peccati contro la "purezza" nel senso specifico (cf. Ef 5,3-7).
5. Per completare il quadro della contrapposizione tra il "corpo" e il "frutto dello Spirito" bisogna osservare che in tutto ciò che è manifestazione della vita e del comportamento secondo lo Spirito, Paolo vede ad un tempo la manifestazione di quella libertà, per la quale Cristo "ci ha liberati" (Gal 5,1). Così egli scrive appunto: "Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non divenga un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il prossimo tuo come te stesso" (Gal 5,13-14). Come già in precedenza abbiamo rilevato, la contrapposizione "corpo-Spirito", vita "secondo la carne", vita "secondo lo Spirito", permea profondamente tutta la dottrina paolina sulla giustificazione. L’Apostolo delle Genti, con eccezionale forza di convinzione, proclama che la giustificazione dell’uomo si compie in Cristo e per Cristo. L’uomo consegue la giustificazione nella "fede che opera per mezzo della carità" (Gal 5,6), e non solo mediante l’osservanza delle singole prescrizioni della Legge anticotestamentaria (in particolare, della circoncisione). La giustificazione viene quindi "dallo Spirito" (di Dio) e non "dalla carne". Egli esorta, perciò, i destinatari della sua lettera a liberarsi dalla erronea concezione "carnale" della giustificazione, per seguire quella vera, cioè, quella "spirituale", in questo senso li esorta a ritenersi liberi dalla Legge, e ancor più ad esser liberi della libertà, per la quale Cristo "ci ha liberati".
Così, dunque, seguendo il pensiero dell’Apostolo, ci conviene considerare e soprattutto realizzare la purezza evangelica, cioè la purezza di cuore, secondo la misura di quella libertà per la quale Cristo "ci ha liberati".
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 7 gennaio 1981]
Intimidated by the nightmare of demons and concrete dangers, the crowds could not see the possibility of emancipation from an existence of obsessions - slavish, frightened, lost, overwhelmed...
Intimidite dall’incubo di demoni e pericoli concreti, le folle non riuscivano a vedere possibilità di emancipazione da un’esistenza di ossessioni - pedissequa, spaventata, smarrita, sopraffatta…
Justification incorporates us into the long history of salvation that demonstrates God’s justice: faced with our continual falls and inadequacies, he did not give up, but wanted to make us righteous (Pope Francis)
La giustificazione ci inserisce nella lunga storia della salvezza, che mostra la giustizia di Dio: di fronte alle nostre continue cadute e alle nostre insufficienze, Egli non si è rassegnato, ma ha voluto renderci giusti (Papa Francesco)
Against this cultural pressure, which not only threatened the Israelite identity but also the faith in the one God and in his promises, it was necessary to create a wall of distinction, a shield of defence to protect the precious heritage of the faith; this wall consisted precisely in the Judaic observances and prescriptions (Pope Benedict)
Contro questa pressione culturale, che minacciava non solo l’identità israelitica, ma anche la fede nell’unico Dio e nelle sue promesse, era necessario creare un muro di distinzione, uno scudo di difesa a protezione della preziosa eredità della fede; tale muro consisteva proprio nelle osservanze e prescrizioni giudaiche (Papa Benedetto)
It is not an anecdote. It is a decisive historical fact! This scene is decisive for our faith; and it is also decisive for the Church’s mission (Pope Francis)
Non è un aneddoto. E’ un fatto storico decisivo! Questa scena è decisiva per la nostra fede; ed è decisiva anche per la missione della Chiesa (Papa Francesco)
Being considered strong, capable of commanding, excellent, pristine, magnificent, performing, extraordinary, glorious… harms people. It puts a mask on us, makes us one-sided; takes away understanding. It floats the character we are sitting in, above reality
Essere considerati forti, capaci di comandare, eccellenti, incontaminati, magnifici, performanti, straordinari, gloriosi… danneggia le persone. Ci mette una maschera, rende unilaterali; toglie la comprensione. Fa galleggiare il personaggio in cui siamo seduti, al di sopra della realtà
The paralytic is not a paralytic
Il paralitico non è un paralitico
The Kingdom of God is precisely the presence of truth and love and thus is healing in the depths of our being. One therefore understands why his preaching and the cures he works always go together: in fact, they form one message of hope and salvation (Pope Benedict)
Il Regno di Dio è proprio la presenza della verità e dell’amore e così è guarigione nella profondità del nostro essere. Si comprende, pertanto, perché la sua predicazione e le guarigioni che opera siano sempre unite: formano infatti un unico messaggio di speranza e di salvezza (Papa Benedetto)
To repent and believe in the Gospel are not two different things or in some way only juxtaposed, but express the same reality (Pope Benedict)
Convertirsi e credere al Vangelo non sono due cose diverse o in qualche modo soltanto accostate tra loro, ma esprimono la medesima realtà (Papa Benedetto)
The fire of God's creative and redeeming love burns sin and destroys it and takes possession of the soul, which becomes the home of the Most High! (Pope John Paul II)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.