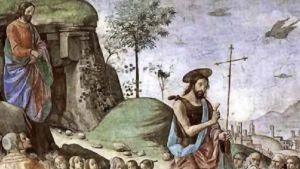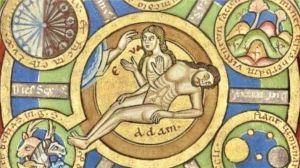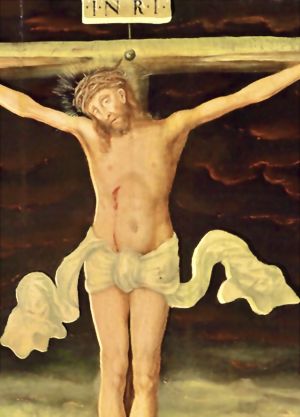don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
3a Domenica di Avvento (anno A)
3a Domenica di Avvento (anno A) [14 dicembre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! “Rallegratevi sempre nel Signore… il Signore è vicino”. L’annuncio di questa terza domenica di Avvento è l’annuncio della gioia del Natale vicino. L’Avvento ci educa a saper attendere con paziente speranza Gesù che certamente verrà.
*Prima Lettura dal libro del profeta Isaia (35, 1...10)
Questo passo proviene dalla Piccola Apocalisse di Isaia detta “Apocalisse minore”(cc34-35), probabilmente scritta da un autore anonimo, e racconta il gioioso ritorno di Israele dall’esilio a Babilonia. Siamo nel periodo in cui il popolo ha subito il sacco di Gerusalemme e trascorso oltre cinquanta anni lontano dalla propria terra, vivendo umiliazioni e sofferenze che scoraggiano anche i più forti. Isaia, vissuto nel VI secolo a.C. durante l’esilio a Babilonia, rassicura il popolo spaventato: “Ecco il vostro Dio: giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi”. Il risultato sarà la liberazione dei sofferenti: ciechi vedranno, sordi udranno, zoppi salteranno di gioia, muti grideranno di gioia. Il popolo ha patito anni di dominazione, deportazione con umiliazioni e tante prove anche religiose: un tempo che scoraggia e fa temere per il futuro. L’autore usa l’espressione “vendetta di Dio”, che oggi può sorprendere. Ma qui la vendetta non è punizione sugli uomini: è la sconfitta del male che li opprime e la liberazione che Dio dona. Dio interviene personalmente per salvare, riscattare e ridare dignità: i ciechi vedranno, i sordi udranno, i zoppi salteranno e i muti grideranno di gioia. Il ritorno dall’esilio è descritto come una marcia trionfale attraverso il deserto: l’arido paesaggio si trasforma in terra fertile e lussureggiante, bella quanto le montagne del Libano, le colline del Carmelo e la pianura del Sarone, simboli di abbondanza e bellezza nella terra di Israele. Questo percorso indica che anche le prove più dure possono diventare un cammino di gioia e speranza quando Dio interviene. Il deserto, simbolo di difficoltà e prova, si trasforma così in un percorso di gioia e speranza grazie all’intervento di Dio. Il popolo liberato è chiamato “riscattato” e la liberazione è paragonata al “riscatto” della legge ebraica: così come un parente vicino liberava un debito o riscattava uno schiavo, Dio stesso è il nostro “Go’el”, il Parente che libera chi è oppresso o prigioniero del male. In questo senso, la redenzione significa liberazione: fisica, morale e spirituale. Cantare “Alleluia” significa riconoscere che Dio ci conduce dalla servitù alla libertà, trasformando la disperazione in gioia e il deserto in fioritura. Questo testo ci ricorda che Dio non ci abbandona mai: anche nei momenti più difficili, la sua misericordia e il suo amore ci liberano e ci ridanno speranza e mostra come il linguaggio della Bibbia sappia trasformare parole che sembrano minacciose in promesse di salvezza e speranza, ricordandoci che Dio interviene sempre per liberarci e restaurare la nostra dignità.
.Elementi principali +Contesto: esilio babilonese, Israele lontano dalla terra, autore anonimo. +Piccola Apocalisse di Isaia: profezia di speranza e ritorno alla terra promessa. +Vendetta di Dio: sconfitta del male, non punizione sugli uomini. +Liberazione concreta: ciechi, sordi, zoppi, muti e prigionieri riscattati. +Deserto fiorirà: difficoltà trasformate in gioia e bellezza. +Riscatto/Redenzione: Dio come Go’el, liberatore di chi è oppresso. +Alleluia: canto di lode per la liberazione ricevuta. +Messaggio spirituale: Dio interviene per liberarci e ridarci speranza anche nei momenti più duri.
*Salmo responsoriale (145/146, 7-8. 9-10
Questo salmo, un “salmo dell’Alleluia” è un canto pieno di gioia e di riconoscenza, scritto dopo il ritorno del popolo d’Israele dall’esilio di Babilonia, probabilmente per la dedicazione del Tempio ricostruito. Il Tempio era stato distrutto nel 587 a.C. da Nabucodonosor, re di Babilonia. Nel 538 a.C., dopo la conquista di Babilonia da parte del re persiano Ciro, gli Ebrei furono autorizzati a tornare nella loro terra e a ricostruire il Tempio. La ricostruzione non fu facile a causa delle tensioni tra chi rientrava da Babilonia e chi era rimasto in Israele, ma grazie alla forza dei profeti Aggeo e Zaccaria i lavori terminarono nel 515 a.C., sotto il re Dario. La dedicazione del nuovo Tempio fu celebrata con grande gioia (Esdra 6,16). Il salmo riflette questa gioia: Israele riconosce che Dio è rimasto fedele all’Alleanza, come già durante l’Esodo. Dio è colui che libera gli oppressi, scioglie le catene, dà pane agli affamati, dona la vista ai ciechi e rialza i deboli. Questa immagine di Dio, un Dio che prende le parti dei poveri e prova compassione (“misericordia”indica come se le viscere fremessero), non era scontata nell’antichità. È il grande contributo di Israele alla fede dell’umanità: rivelare un Dio di amore e di misericordia. Il salmo lo esprime dicendo che il Signore sostiene la vedova e l’orfano. Il popolo è invitato a imitare Dio nella stessa misericordia, e la Legge d’Israele contiene molte norme a protezione dei deboli (vedove, orfani, stranieri). I profeti giudicavano la fedeltà d’Israele all’Alleanza anche sulla base di questo comportamento. A un livello più profondo, il salmo mostra che Dio non libera solo dalle oppressioni esteriori, ma anche da quelle interiori: la fame spirituale trova il suo cibo nella Parola; le cecità interiori vengono illuminate; le catene dell’odio, dell’orgoglio e della gelosia vengono sciolte. Anche se qui non lo vediamo, in realtà questo salmo è incorniciato dalla parola “Alleluia”, che secondo la tradizione ebraica significa cantare la lode di Dio perché Egli conduce dalla schiavitù alla libertà, dalle tenebre alla luce, dalla tristezza alla gioia. Noi cristiani leggiamo questo salmo alla luce di Gesù Cristo: Egli ha dato il pane ai suoi contemporanei e continua a dare il “pane della vita” nell’Eucaristia; Egli è la luce del mondo (Gv 8,12); nella sua risurrezione ha liberato definitivamente gli uomini dalle catene della morte. Infine, siccome l’uomo è creato a immagine di Dio, ogni volta che soccorre un povero, un malato, un prigioniero, uno straniero, manifesta l’immagine stessa di Dio. E ogni gesto fatto “al più piccolo” contribuisce a far crescere il Regno di Dio. Una catecumena, leggendo il miracolo della moltiplicazione dei pani, chiese: “Perché Gesù non lo fa ancora oggi per tutti gli affamati?” E dopo un attimo rispose: “Forse conta su di noi per farlo.”
Elementi importanti da ricordare +Contesto storico: salmo nato dopo il ritorno dall’esilio e la ricostruzione del Tempio (587–515 a.C.). +Tema centrale: la gioia del popolo per la fedeltà di Dio e la sua liberazione. +Rivelazione di Dio: Dio è misericordioso e difende gli oppressi, i poveri, i deboli. +Impegno del popolo: imitare Dio nelle opere di misericordia verso tutti gli oppressi. +Lettura spirituale: Dio libera dalle catene interiori (odio, orgoglio, cecità spirituale). +Alleluia: simbolo del passaggio dalla schiavitù alla libertà e dalla tristezza alla gioia. +Lettura cristiana: compimento in Cristo, che dà il pane vero, illumina, libera, salva. +Immagine di Dio nell’uomo: ogni gesto di amore verso i più fragili rende visibile l’immagine di Dio. + Responsabilità cristiana: Dio conta anche sul nostro impegno per nutrire, liberare e sostenere i sofferenti.
*Seconda Lettura dalla lettera d san Giacomo apostolo (5,7-10)
La tradizione cristiana conosce tre figure di Giacomo vicine a Gesù: Giacomo il Maggiore, figlio di Zebedeo e fratello di Giovanni, dal carattere impetuoso, presente alla Trasfigurazione e a Getsemani; Giacomo figlio di Alfeo, uno dei Dodici; Giacomo “fratello/cugino” del Signore, guida della Chiesa di Gerusalemme e probabile autore della Lettera di Giacomo. Nel testo emerge un tema fondamentale per i primi cristiani: l’attesa della venuta del Signore. Come Paolo, anche Giacomo guarda sempre all’orizzonte del compimento finale del progetto di Dio. È significativo che proprio all’inizio della predicazione cristiana si desiderasse più ardentemente la fine del mondo, forse perché la Risurrezione aveva dato un assaggio della gloria futura. In questa attesa, Giacomo ripete un invito cruciale: la pazienza, parola che nel greco originale (makrothyméo) significa “avere il fiato lungo, avere un animo lungo”. L’attesa della venuta del Signore è una corsa di resistenza, non uno scatto: la fede deve imparare a durare nel tempo. Quando i primi cristiani si resero conto che la parusía non arrivava subito, l’attesa divenne una vera prova di fedeltà.
Per vivere questa resistenza, Giacomo offre due modelli: il contadino, che conosce il ritmo delle stagioni fiducioso in Dio che manda la pioggia “a suo tempo” (Dt 11,14) e l’altro modello: i profeti, che hanno sopportato ostilità e persecuzioni per rimanere fedeli alla loro missione. Giacomo chiede ai cristiani di avere fiato (costanza/pazienza) e cuore saldo (“Rinfrancate i vostri cuori”). Proprio nel versetto 11 che segue questo testo Giacomo cita anche Giobbe, unico caso nel Nuovo Testamento, come esempio supremo di perseveranza: chi rimane saldo come lui sperimenterà la misericordia del Signore. La pazienza non è solo personale: si vive nelle relazioni comunitarie. Giacomo riprende l’insegnamento di Gesù: non lamentatevi gli uni degli altri, non giudicatevi, non mormorate. “Il Giudice è alle porte”: solo Dio giudica davvero, perché vede il cuore. L’uomo rischia di confondere facilmente grano e zizzania. La lezione è anche per noi: spesso ci manca il respiro della speranza, e allo stesso tempo cediamo alla tentazione di giudicare. Eppure la parola di Gesù sulla pagliuzza e la trave rimane sempre attuale.
Elementi importanti da ricordare: + dei tre Giacomo, è il Maggiore, il figlio di Alfeo, il “fratello” del Signore il probabile autore di questa Lettera che riflette il tema centrale dell’attesa della venuta del Signore. +La pazienza è ripetuta più volte ed è intesa come “fiato lungo”, una corsa di resistenza. +L’attesa cristiana iniziale era molto intensa: si pensava che il ritorno di Cristo fosse imminente. +Due modelli di perseveranza: il contadino (fiducia nel tempo di Dio) e i profeti (coraggio nella missione). + v.11 non in questo testo ma subito dopo giovanni
cita Giobbe come esempio di tenuta: unica citazione nel NT, simbolo di perseveranza nella prova. +Missione comunitaria: non giudicare, non mormorare, non lamentarsi perché Il Giudice è alle porte” E invita a vivere sapendo che solo Dio giudica rettamente. +Pericolo anche oggi è la mancanza di respiro spirituale e rischio di giudicare gli altri.
*Dal Vangelo secondo Matteo (11, 2-11)
Domenica scorsa abbiamo visto Giovanni Battista battezzare lungo il Giordano e annunciare: “Dopo di me viene uno”. Quando Gesù chiese il battesimo, Giovanni riconobbe in lui il Messia atteso, ma i mesi passarono e Giovanni fu messo in prigione da Erode intorno all’anno 28, momento in cui Gesù iniziò la sua predicazione pubblica in Galilea. Gesù iniziò la vita pubblica con discorsi famosi, come il Discorso della Montagna e le Beatitudini, e con molte guarigioni. Tuttavia, il suo comportamento era strano agli occhi della gente: si circondava di discepoli poco “raccomandabili” (pubblicani, persone diverse per origine e carattere); non era un asceta come Giovanni, mangiava e beveva come tutti, e si mostrava tra la gente comune; non rivendicava mai il titolo di Messia, né cercava potere. Dalla prigione, Giovanni riceveva notizie da chi lo teneva informato e iniziò a dubitare: “Sarò stato ingannato? Sei tu il Messia?” Questa domanda è cruciale, perché riguarda sia Giovanni sia Gesù, costretto a confrontarsi con le aspettative di chi lo attendeva. Gesù non risponde con un sì o un no, ma cita le profezie sulle opere del Messia:i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi ascoltano, i morti risuscitano, i poveri ricevono la buona notizia (Isaia 35,5-6; 61,1). Con queste parole, Gesù invita Giovanni a verificare da sé se sta compiendo le opere del Messia, confermando che sì, è il Messia, anche se le sue maniere appaiono strane. Il vero volto di Dio si mostra al servizio dell’uomo, non secondo le aspettative di potere o gloria. Infine, Gesù elogia Giovanni che è beato perché “non trova in me motivo di scandalo”. Giovanni dà un esempio di fede: anche nel dubbio, non perde fiducia e cerca direttamente la verità da Gesù stesso. Gesù conclude spiegando che Giovanni è il più grande dei profeti perché apre la strada al Messia, ma con la venuta di Gesù, anche il più piccolo nel Regno dei cieli è più grande di Giovanni, sottolineando che il contenuto del messaggio di Cristo supera qualsiasi aspettativa umana: “Il Verbo si è fatto carne e ha abitato tra noi”.
Elementi importanti da ricordare +Giovanni Battista annuncia il Messia e battezza lungo il Giordano.+Gesù inizia la vita pubblica dopo l’arresto di Giovanni, in Galilea, con discorsi e miracoli.+Comportamento “strano” di Gesù che frequenta tutti, anche i più emarginati, non rivendica titoli o potere, si nutre e si mostra come la gente comune.+Dubbi di Giovanni: manda i discepoli a chiedere se Gesù è davvero il Messia.+ Risposta di Gesù: cita le opere profetiche del Messia (guarigioni, liberazioni, annuncio ai poveri).+Fede attiva di Giovanni: non resta nel dubbio, chiede chiarimenti direttamente a Gesù. +Gioia e sorpresa: il volto di Dio si rivela al servizio dell’uomo, non secondo le aspettative tradizionali. +Giovanni come precursore: il più grande dei profeti, ma con Gesù il più piccolo nel Regno è più grande. +Messaggio finale: Cristo è il Verbo incarnato, la realizzazione delle promesse di Dio.
*Ecco una citazione di San Gregorio Magno nell’Omelia 6 sui Vangeli, che commenta così l’episodio: “Giovanni non ignora chi sia Gesù: egli lo indica come l’Agnello di Dio. Ma, mandato in prigione, invia i discepoli non per sapere lui, bensì perché essi imparino dal Cristo ciò che egli già sapeva. Giovanni non cerca di istruirsi, ma di istruire. E Cristo non risponde con parole, ma con le opere: fa capire che è Lui il Messia non dicendo di esserlo, ma mostrando le opere annunciate dai profeti.” E aggiunge: “Il Signore proclama beato chi non si scandalizza di Lui, perché in Lui vi è grandezza nascosta sotto umile apparenza: chi non si scandalizza della sua umiltà, riconosce la sua divinità.” Questo commento illumina perfettamente il cuore del Vangelo: Giovanni non dubita per sé, ma per aiutare i suoi discepoli a riconoscere che Gesù è il Messia atteso, anche se si presenta in modo sorprendente e umile.
+Giovanni D’Ercole
Immacolata Concezione
Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria [8 Dicembre]
Testi biblici: Gn3, 9…20 – Ep 1, 3…12 – Lc 1, 26-38 Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Invece di commentare le letture propongo una meditazione teologica e spirituale sulla Immacolata Concezione a partire da San Paolo e facendo riferimento alla tradizione della Chiesa e alla liturgia.
1. San Paolo e Maria: un legame nascosto ma reale Anche se Paolo parla quasi per nulla direttamente della Vergine Maria, il suo insegnamento sull’elezione, santità e predestinazione dei cristiani (Ef 1,4-11) illumina profondamente il mistero di Maria. San Paolo afferma che tutti i battezzati sono eletti, santi e immacolati. Applicando questo a Maria, comprendiamo che ciò che vale per l’intera Chiesa si realizza in lei in modo perfetto e anticipato.
2. Il mistero della Chiesa illumina il mistero di Maria Nella cammino della teologia soprattutto nei primi secoli, si è compreso Maria a partire dalla Chiesa: Maria è ciò che la Chiesa è chiamata a diventare. Ciò che in noi è parziale, in lei è perfetto. È “la prima in cammino”: prima per tempo, prima per perfezione. Maria è la “prima” in due sensi: cronologicamente prima ad accogliere Cristo, prima a condividere la sua Passione, prima ad entrare nella gloria con corpo e anima. Qualitativamente: nessuno ha accolto Cristo con maggiore purezza, amore e libertà. La sua grazia unica non la separa da noi, ma manifesta ciò che Dio vuole realizzare in tutta la Chiesa. L’Immacolata Concezione non è un privilegio isolato, ma la piena realizzazione della vocazione di ogni cristiano: Maria è preservata dal peccato in vista dei meriti di Cristo. Noi siamo salvati dal peccato attraverso i meriti di Cristo (battesimo, sacramenti, conversione). Le traiettorie sono le stesse; in Maria sono solo anticipate e portate a perfezione grazie alla sua totale obbedienza e totale abbandono nella volontà di Dio: Maria non ha fatto la volontà divina ma ha vissuto interamente nella volontà di Dio. E’ qui la chiave della sua vita: tentata come tutti compreso Gesù, ha sconfitto Satana scegliendo di vivere sempre e completamente nella volontà del Padre e per questo è ora segno di sicura speranza per noi tutti
3. Perché Maria è Immacolata? La ragione è profondamente semplice: per essere veramente Madre di Dio. Per amare Gesù per ciò che è realmente — vero Dio e vero uomo — Maria doveva essere totalmente libera dal peccato, totalmente aperta all’amore, capace di accogliere Dio senza ostacoli. L’Immacolata Concezione è un dono d’amore: Dio la forma così per amore del Figlio e per amore nostro, perché Maria diventi Madre del Salvatore e Madre della Chiesa. Scrive san Giovanni Damasceno: “Come Eva ha collaborato alla caduta, Maria ha cooperato alla redenzione: immacolata, ha portato la vita a colui che doveva dare la vita al mondo.” E san Bartolo Longo recentemente canonizzato osserva: “L’Immacolata non è solo un titolo, ma un mistero vivo: Dio l’ha creata tutta pura per farne la Madre del Redentore.”
4. Maria ci precede per indicarci il nostro destino. Maria non schiaccia, non umilia, non allontana: mostra ciò che noi saremo nella gloria; è anticipo di ciò che la Chiesa diventerà; la sua santità è promessa della nostra. In lei vediamo la meta della vita cristiana. Maria riceve l’annuncio dell’angelo liberamente e Il suo “fiat” apre la porta alla salvezza. Oggi anche la Chiesa, come Maria, è chiamata ad annunciare Cristo, a portare il suo amore nel mondo, a dire il proprio “sì” nella storia. Dio ha bisogno delle nostre mani, dei nostri occhi, delle nostre abbra, del nostro cuore: come Maria, siamo chiamati a essere portatori di luce e lo possiamo essere nella misura in cui in noi vive la volontà di Dio come protagonista di tutta la nostra esistenza.
5. Che significa essere “immacolati” oggi? Per noi non significa essere senza peccato, ma accogliere l’azione di Dio nella nostra vita. Significa vivere aperti alla grazia, dire il nostro “sì” quotidiano, lasciarci purificare e trasformare dallo Spirito, diventare trasparenti per mostrare Cristo nel mondo. L’Immacolata Concezione diventa così una vocazione e un cammino. “La verità sull’Immacolata Concezione mi sembrava la più difficile da accettare … quando finalmente l’ho accolta, tutto si è chiarito: la mia fede ha trovato senso.” (testimonianza riportata sul sito CatholicConvert.com nel racconto di Delores, una donna che narra la sua conversione al cattolicesimo).
Elementi importanti da ricordare: +Maria è compresa a partire dalla Chiesa: ciò che è vero per tutti i battezzati è perfetto in lei. +Immacolata perché Madre di Dio: per amare pienamente il Figlio, doveva essere totalmente libera dal peccato +“Prima in cammino”: prima nel tempo e nella qualità dell’amore e della santità.+La sua grazia è promessa per noi: ciò che lei vive già, la Chiesa e i cristiani lo vivranno appieno nella gloria. +Predestinazione condivisa: Maria è preservata dal peccato; noi siamo salvati dal peccato. +Il “fiat” di Maria come modello: Dio chiama, ma attende la nostra libertà; il sì apre la via alla missione. +Essere immacolati oggi: significa accogliere Dio, lasciarsi purificare, diventare trasparenza della sua luce. +Maria non toglie nulla a Dio: è “eco di Dio”; venerarla significa onorare l’opera di Dio in lei. +Maria indica il nostro destino: in lei vediamo ciò che Dio vuole realizzare in ognuno di noi. +L’Immacolata è un dono d’amore: di Dio a Maria e di Maria al mondo.
*Ecco una brevissima sintesi storica dei principali difensori medievali dell’Immacolata Concezione: Sant’Alberto Magno (1200‑1280) – Teologo domenicano; aperto all’idea della preservazione di Maria dal peccato originale, ma senza definirla definitivamente. San Tommaso d’Aquino (1225‑1274) – Teologo domenicano; sosteneva che Maria fosse redenta «dopo il peccato originale», quindi non immacolata fin dal concepimento. Duns Scoto (1266‑1308) – Teologo francescano; difensore principale dell’Immacolata Concezione. Maria fu preservata dal peccato originale fin dal primo istante, grazie ai meriti di Cristo anticipati da Dio. Guglielmo di Ockham (1287‑1347) – Francescano; sostenitore della posizione di Scoto, pur con alcune sfumature filosofiche. L’idea centrale di Scoto: Maria immacolata fin dal concepimento, preservata dalla grazia di Dio grazie ai meriti futuri di Cristo, anticipando il dogma ufficiale definito nel 1854.
+ Giovanni D’Ercole
Perplessità del Battista. La crisi dello spirito titanico
2a Domenica di Avvento (anno A)
2a Domenica di Avvento (anno A) [7 Dicembre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga! Da questa domenica oltre al finale riassunto sintetico degli elementi più importanti di ogni lettura unisco un breve commento di un Padre della Chiesa al Vangelo.
*Prima Lettura dal libro del profeta Isaia (11,1-10)
Isaia parla della radice di Iesse e si riferisce alla discendenza del re Davide. Iesse aveva otto figli, Dio fece scegliere a Samuele non il più forte o il maggiore, ma il più giovane: Davide, il pastore, che divenne il più grande re d’Israele. Da quel momento Iesse divenne il capostipite di una dinastia rappresentata spesso come un albero destinato a un grande futuro, che non sarebbe mai dovuto morire. Il profeta Natan aveva promesso a Davide che i suoi discendenti avrebbero regnato per sempre e avrebbero portato al popolo unità e pace. Ma nella storia, i re della sua discendenza non hanno mantenuto pienamente queste promesse. Tuttavia, proprio dalle delusioni nasce una speranza più forte: se Dio ha promesso, allora si compirà. Come nasce l’idea di Messia? Il termine “messia” (in ebraico mashiach = “unto”) in origine indicava ogni re, perché veniva “unto” con l’olio nel giorno dell’incoronazione. Col tempo, però, la parola “messia” ha assunto il senso di “re ideale”, colui che porta giustizia, pace e felicità. Quando Isaia dice: “Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse”, significa: anche se la dinastia di Davide sembra un albero morto, Dio può far nascere un germoglio nuovo, un re ideale: il Messia, che sarà guidato dallo Spirito del Signore. Su di lui riposeranno i sette doni dello Spirito, simbolo della pienezza: sapienza, intelligenza, spirito di consiglio, e di fortezza, conoscenza, di timore del Signore che non è paura, ma fiducia e rispetto da figlio. Il Messia governerà come Dio vuole: con giustizia e fedeltà e il suo compito sarà fare guerra all’ingiustizia: Giudicherà con giustizia i miseri … non secondo l’apparenza… farà morire la malvagità con il soffio delle sue labbra. “L’empio” non indica una persona, ma la malvagità stessa come dire “fare la guerra alla guerra”. Isaia descrive un mondo dove il lupo vive con l’agnello, il bambino gioca senza paura, non c’è più violenza né conflitto. Non è un ritorno al paradiso terrestre, ma il compimento finale del progetto di Dio, quando la conoscenza del Signore riempirà la terra. La radice di Iesse sarà un segno per tutti i popoli e il Messia non riguarda solo Israele, ma tutte le nazioni. Gesù stesso riprenderà questa idea: “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.” (Gv 12,32) Isaia predica nel VIII secolo a.C., in un tempo di pressione politica e minacce da parte di imperi vicini. L’albero di Davide sembra proprio morto, ma Isaia invita a non perdere la speranza. La “favola degli animali” usa simboli per parlare degli uomini, come farà molti secoli dopo La Fontaine e costituisce una promessa di pace, di fraternità e di riconciliazione universale. Martin Luther King, nel suo discorso “I have a dream”, si ispirerà direttamente a queste immagini usate da Isaia (Cf.11, 2): un mondo dove giustizia e fraternità vincono la violenza.
Il tema centrale si riassume in una frase: Dal tronco apparentemente morto della dinastia di Davide, Dio è così fedele che, quando tutto sembra finito, fa rinascere la sua promessa da un frammento, da un ceppo: la speranza nasce proprio là dove l’uomo non vede più nulla. Dio farà sorgere un Messia guidato dallo Spirito, che combatterà l’ingiustizia e porterà la pace universale a tutti i popoli. Dio è fedele, e anche da un tronco morto può far nascere vita nuova. È la pace messianica, la riconciliazione finale della creazione.Ci sono momenti in cui anche noi ci sentiamo come un albero tagliato: fallimenti, delusioni, peccati ripetuti, relazioni spezzate, progetti che non si realizzano, comunità che sembrano perdere forza. Isaia annuncia: Dio non ha finito anche con te e proprio dove tu non vedi futuro, Lui vede un germoglio. Continua anche tu a sperare perché Dio vede germogli dove noi vediamo solo legno secco.
*Salmo responsoriale (71/72, 1-2.7-8.12-13.17)
Il Salmo 71/72 è una preghiera nata dopo l’esilio babilonese, in un tempo in cui non esisteva più un re in Israele. Ciò significa che il salmo non parla più di un sovrano terreno, ma del re promesso da Dio: il Messia. Poiché è Dio a prometterlo, la realizzazione è certa. L’intera Bibbia è attraversata da una speranza indistruttibile: la storia ha un significato e una direzione e Dio ha un progetto di felicità per l’umanità. Questo progetto assume nomi diversi (Giorno del Signore, Regno dei cieli, Disegno benevolo), ma è sempre lo stesso: come un innamorato che ripete parole d’amore, Dio ripropone senza stancarsi il suo piano di salvezza.
Questo progetto è annunciato fin dall’inizio, nella vocazione di Abramo (Gen 12,3): “In te saranno benedette tutte le famiglie della terra”. La rivelazione è dunque universale fin dall’origine. Israele è eletto non per gestire un privilegio, ma per essere servizio e segno per tutti i popoli. Il salmo riprende questa promessa: nel Messia tutte le nazioni saranno benedette e lo chiameranno beato. Riprende anche l’altra promessa ad Abramo (Gen 15,18), cioè il dono della terra “dal torrente d’Egitto al grande fiume”. In eco, il salmo dice: “Dominerà da mare a mare e dal Fiume ai confini della terra”. Il libro del Siracide (Sir 44,21) conferma questa lettura, collegando insieme benedizione universale, moltiplicazione della discendenza ed eredità estesa. Anche se oggi un’idea di sovrano universale può sembrare lontana dalla sensibilità democratica e anzi si teme l’imposizione di un’autorità mondiale occulta che dominerebbe l’intera umanità, la Bibbia ricorda che ogni sovrano è solo uno strumento nelle mani di Dio, e ciò che conta è il popolo considerando un solo vasto opolo l’intera umanitàe il salmo annuncia un’umanità pacificata: In quei giorni fiorirà la giustizia, grande pace fino alla fine dei tempi, sconfitte la povertà e l’oppressione. Il sogno di giustizia e pace attraversa tutta la Scrittura: Gerusalemme significa “città della pace”; Deuteronomio 15 afferma che non ci sarà più alcun povero. Il salmo si inserisce in questa linea: il Messia soccorrerà il povero che invoca, il debole senza aiuto, il misero che non ha difesa. La preghiera del salmo non serve a ricordare a Dio le sue promesse, perché Dio non dimentica. Serve invece all’uomo per imparare a guardare il mondo con gli occhi di Dio, ricordare il suo progetto e trovare la forza per lavorare alla sua realizzazione. Giustizia, pace e liberazione dei poveri non arriveranno magicamente: Dio invita i credenti a cooperare, lasciandosi guidare dallo Spirito Santo con luce, forza e grazia.
Elementi importanti da ricordare: +Il Salmo 72 è messianico: scritto quando non c’erano più re, annuncia il Messia promesso da Dio.+La storia ha un senso: Dio ha un progetto di felicità per tutta l’umanità.+Le promesse ad Abramo sono il fondamento: benedizione universale e eredità senza confini.+Il Messia sarà strumento di Dio, al servizio del popolo e non del potere.+Il mondo che viene sarà segnato da giustizia, pace e fine della povertà. +La preghiera non serve a convincere Dio, ma educa noi: apre gli occhi al progetto divino. +La pace e la giustizia arriveranno anche attraverso l’impegno umano guidato dallo Spirito.
*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo ai Romani (15, 4-9)
San Paolo scrive ai Romani: “Tutto ciò che è stato scritto prima di noi , è stato scritto per la nostra istruzione …perché teniamo viva la speranza”. Questa frase è la chiave per leggere tutta la Bibbia: la Scrittura esiste per illuminare, liberare, dare speranza. Se un testo sembra oscuro o duro, ciò significa semplicemente che non l’abbiamo ancora compreso fino in fondo: la Buona Notizia è sempre presente e bisogna scavare per trovarla, come in un tesoro nascosto. La Scrittura alimenta la speranza perché annuncia in ogni pagina un unico progetto di Dio: quel “disegno misericordioso” che è la grande storia d’amore di Dio con l’umanità. Tutta la Bibbia, dall’Antico al Nuovo Testamento, ha un solo soggetto: il progetto di salvezza e di comunione che Dio vuole realizzare nel Messia. Paolo passa poi a un tema concreto: i cristiani di Roma erano divisi. C’erano due gruppi: cristiani provenienti dal giudaismo, ancora legati alle pratiche religiose e alimentari ebraiche; cristiani provenienti dal paganesimo, che consideravano tali osservanze superate. Da questa diversità nascevano discordie, giudizi reciproci e sospetto. Le divergenze liturgiche e culturali diventavano scontri veri e propri. Una situazione molto simile alle tensioni che esistono anche oggi nella Chiesa tra sensibilità diverse. Paolo non propone di dividere la comunità in due gruppi separati. Propone invece la via della coabitazione, la costruzione della pace, la pazienza e la tolleranza reciproca, invitando tutti a ricercare ciò che favorisce la pace e ciò che edifica la comunità. Ognuno cerchi il bene dell’altro e “il Dio della perseveranza e della consolazione” vi conceda di vivere concordi secondo Cristo. Il principio fondamentale è: “Accoglietevi gli uni gli altri come Cristo ha accolto voi”. Paolo ricorda che Cristo ha preso su di sé la missione del Servo di Dio annunciato da Isaia: scelto ed eletto da Dio, formato ogni mattina dalla Parola, donatore della propria vita, portatore di salvezza a tutte le nazioni. Cristo, morendo e risorgendo, ha unito i Giudei, salvati in continuità con la loro Alleanza e i pagani, salvati dalla gratuita misericordia divina. Per questo nessuno può vantare una superiorità, anzi tutto è grazia, tutto è dono del Cristo e il vero culto è questo: superare il passato, riconoscere il dono ricevuto, accogliersi senza distinzioni, cantare insieme la fedeltà e la misericordia di Dio.
Elementi importanti da ricordare: +La Scrittura esiste per dare speranza. Ogni pagina della Bibbia è Buona Notizia. Se non troviamo liberazione, non abbiamo ancora capito il testo. + La Bibbia annuncia un unico progetto. Il “disegno provvidenziale” di Dio: portare l’umanità alla comunione e alla salvezza tramite il Messia. +Paolo corregge una comunità divisa: A Roma c’erano tensioni tra cristiani di origine ebraica e pagana. Le differenze pratiche e culturali creavano giudizi e conflitti. La soluzione cristiana non è separarsi. Paolo propone coabitazione, pazienza, edificazione reciproca. La comunità è un “edificio” che va costruito con pace e tolleranza. +Il modello è Cristo Servo che ha unito tutti: ebrei e pagani. Nessuno può vantarsi: tutto è grazia. +Parola d’ordine: accoglienza: Accoglietevi come Cristo vi ha accolti. La Chiesa è viva quando supera le divisioni e vive la misericordia.
*Dal Vangelo secondo Matteo (3,1-12)
Quando Giovanni Battista inizia la sua predicazione, la Giudea è sotto dominazione romana da 90 anni, Erode è al potere ma profondamente detestato; le correnti religiose sono divise e confuse; ci sono collaborazionisti, resistenti, falsi profeti, agitatori messianici. Il popolo è stanco e disorientato e in questo clima nasce la predicazione di Giovanni che vive nel deserto di Giudea (tra Gerusalemme e il Giordano). Matteo insiste sul senso spirituale del deserto: ricorda l’Esodo, l’Alleanza, la purificazione, il rapporto d’amore tra Dio e Israele (Osea) e vede il deserto come il luogo del ritorno alla verità e della decisione. In Giovanni tutto richiama i grandi profeti: Veste di peli di cammello, si ciba di locuste e miele, vive con uno stile ascetico. Molti lo considerano il possibile ritorno di Elia, atteso per preparare la venuta di Dio (Ml 3,23). La sua predicazione ha il doppio tono profetico: Dolce e consolante per gli umili; duro e provocatorio per gli orgogliosi. L’espressione “razza di vipere” non è un insulto personale, ma un modo per dire: “state seguendo la logica del serpente tentatore”, ed è quindi un invito a cambiare atteggiamento. Giovanni invita tutti a compiere un retto discernimento nella propria vita: ciò che è sano rimanga, ciò che è corrotto venga eliminato. E per essere incisivo usa immagini forti: Fuoco che brucia la paglia (richiamo al profeta Malachia), setaccio che separa grano e pula, aia dove si compie la scelta - e questo è il significato: Tutto ciò che in noi è morte sarà purificato; tutto ciò che è autentico sarà salvato e custodito. È un giudizio liberante, non distruttivo. Giovanni annuncia Gesù: “Io vi battezzo nell’acqua, ma colui che viene dopo di me…vi battezzerà nello Spirito Santo e fuoco”. Solo Dio può dare lo Spirito e dunque Giovanni afferma implicitamente la divinità di Gesù. Le immagini usate:“Più forte di me” è un attributo tipico di Dio. “Non sono degno di portargli o sciogliergli i sandali”: con questo riconosce in Gesù una dignità divina. Pur essendo maestro seguito da discepoli, Giovanni si mette in seconda fila; riconosce la superiorità di Gesù e apre la strada al Messia. La sua grandezza consiste proprio nel far spazio. Matteo lo mostra come “voce nel deserto” con riferimento a Isaia 40,3, legato anche a Elia (2 Re 1,8; Ml 3,23), nella linea dei profeti per introdurre Gesù come Dio presente e giudice. I capitoli 3-4 di Matteo sono una cerniera: Qui comincia la predicazione del Regno.
Elementi importanti da ricordare: +Giovanni appare in un contesto di oppressione e confusione morale: la sua parola porta luce e discernimento. +Il deserto è luogo di nuova alleanza, verità e conversione. +Giovanni si presenta con segni profetici (vestito, cibo, stile) che ricordano Elia. +La sua predicazione è doppia: consolazione ai piccoli, provocazione per chi è sicuro di sé. +Il giudizio è interiore, non contro categorie di persone: purifica il male in ciascuno. Il fuoco non distrugge l’uomo, ma ciò che in lui è morto: è un fuoco d’amore e verità. +Gesù compie la purificazione battezzando nello Spirito Santo, cosa che solo Dio può fare e Giovanni riconosce la divinità di Gesù con gesti di grande umiltà. +La grandezza del Precursore sta nel farsi da parte per lasciare spazio al Messia e Matteo lo colloca come ponte tra l’Antica e la Nuova Alleanza, inaugurando la predicazione del Regno.
San Giovanni Crisostomo – Commento a Matteo 3,1-12
“Giovanni appare nel deserto non per caso, ma per richiamare l’antico cammino di Israele.
Nel deserto Israele fu educato, e nel deserto ora ricomincia la conversione. Il suo abito rude e il cibo semplice mostrano che egli è libero da ogni vanità, come Elia. Per questo il popolo, stanco dei capi del tempo, accorre a lui: vede in Giovanni un uomo veritiero, che non cerca la gloria ma conduce alla verità.” Poi Crisostomo spiega il contenuto profetico e morale della predicazione di Giovanni: Chiamando “razza di vipere” non li insulta, ma li scuote perché si rendano conto del veleno che li corrompe. Non attacca le persone, ma il male che le possiede.
Il giudizio che annuncia non è contro gli uomini, ma contro le loro opere cattive: il fuoco brucia la colpa, non la natura dell’uomo.” E riguardo all’annuncio del Messia: “Dicendo: “Viene dopo di me Uno più forte di me”, Giovanni non si paragona a un altro uomo, ma a Dio. Poiché solo di Dio si dice che è il Forte. E quando aggiunge: “Vi battezzerà nello Spirito Santo”, confessa apertamente che Colui che viene ha potere divino. Per questo dichiara di non essere degno neppure di sciogliergli i sandali: non perché disprezzi se stesso, ma perché riconosce la grandezza di Cristo.” Infine, Crisostomo interpreta la missione del Precursore:
“La sua grandezza consiste nel diminuire perché Cristo cresca. È la voce che prepara la Parola; è il ponte che congiunge l’Antica Alleanza alla Nuova. Egli mostra che tutto ciò che i profeti attendevano si compie ora: il Re è vicino, e il Regno comincia.»
+Giovanni D’Ercole
Immacolata: Personalismo fatto salvo
OSSESSIONE E COMPULSIONE - (di Francesco Giovannozzi, psicologo e psicoterapeuta)
Ossessione e Compulsione
Un signore mi confida che da tempo ha bisogno di controllare se ha chiuso il portone della sua casa. Una signora invece deve essere certa che ha chiuso il gas in cucina.
Dopo aver controllato, sia il gas che il portone stavano bene e in ordine.
Un altro signore di mezza età sente il bisogno di dover vedere se la sua auto è a posto, poi deve andare a controllarla, deve fare un giro intorno alla stessa, toccarla in diversi punti, e solo dopo aver compiuto queste sequenze comportamentali, può rientrare tranquillamente. A volte sente il bisogno di farlo più volte in una giornata.
Nel vocabolario Treccani al termine «ossessione» si legge: «rappresentazione mentale che la volontà non riesce ad eliminare accompagnata da ansia».
Alla voce «compulsione»: «costrizione, l’essere spinto da necessità a fare qualcosa».
Molte persone hanno dei pensieri verso i quali non hanno alcun interesse; spesso sono delle idee senza alcun senso, ma che richiedono loro un notevole sforzo mentale.
Senza volerlo queste idee ci invadono, e fanno “lambiccare” il cervello come se fossero questioni fondamentali.
Possono trattarsi di pensieri, immagini che generano preoccupazione - e di solito vengono seguiti da costrizioni che la persona deve compiere per calmare l’inquietudine.
Tra l’idea ”fissa” e il bisogno di compiere qualche atto, gesto per far sì che non succeda nulla di male, insorge spesso un dubbio, che intacca le nostre convinzioni più certe .
Il tutto sfocia in una indecisione sempre più grande che limita la propria libertà di azione: per fare una scelta anche semplice si impiega tanto tempo.
A volte ci fa giungere a non saper prendere una decisione. Il dubbio può riguardare un pensiero, un ricordo, un’azione, ecc. e può sconfinare da un contenuto all’altro.
Una persona con questi problemi, uscendo di casa a volte si sente costretta a tornarci per essere certa di non aver lasciato la luce accesa, e per essere sicura a volte lo deve fare parecchie volte.
In letteratura vengono citati esempi di persone che nello spedire una lettera sentivano poi il bisogno di riaprirla per controllare ciò che avevano scritto.
In quadri psicologici come questo si parla anche di «ruminazione», che è sempre associato al dubbio.
In campo biologico essa si configura quale processo digestivo di alcuni animali, tipo i bovini. Il cibo ingerito viene riportato in bocca per essere masticato nuovamente, in maniera migliore; quindi inghiottito di nuovo per ultimare la digestione.
In campo psicologico la «ruminazione» descrive un pensiero ripetitivo e durevole focalizzato su eventi passati, diverso dal «rimuginio» che invece riguarda più gli eventi futuri.
Vengono descritti anche dei cerimoniali. In essi l’individuo deve fare una sequenza di atti come lavarsi sovente le mani, pulire tante volte oggetti della vita quotidiana.
Interviene qui un aspetto del quadro psicologico descritto: la «rupofobia» e contaminazione. La rupofobia è la paura morbosa dello sporco e di poter essere infettati. Può riguardare qualsiasi aspetto della nostra vita: sia oggetti che persone, o luoghi pubblici. È un aspetto che può nuocere anche all’intimità.
Il periodo del Covid ha aumentato la paura del contagio, ma questo era un evento reale. Anche tanti anni fa intorno agli anni 1986 ci fu il fenomeno di Chernobyl e lì veramente dovevamo essere attenti a ciò che si mangiava poiché il cibo e soprattutto le verdure potevano essere state contaminate.
Chiunque ha queste idee, passeggiando potrà contare le auto nel parcheggio, o toccare i pali dei lampioni, oppure cercare di evitare le fenditure dei pavimenti, ecc.
Nei casi gravi queste persone possono sentire di far del male a qualcuno; così questi pensieri lo fanno “indietreggiare”. Costoro devono darsi uno “scossone” onde cercare di scacciare tali idee che terrorizzano.
Le persone con queste caratteristiche generalmente sono delle persone rigorose, si preoccupano dei particolari, osservano minuziosamente regole e formalità.
Tuttavia dando importanza ai dettagli, spesso trascurano l’essenziale.
Quanta gente nel loro ambito lavorativo sente il bisogno di mettere in fila e in eccessivo ordine i loro oggetti.
Ordine e controllo sono strettamente interconnessi, perché l’ordine esterno può essere una modalità per raggiungere un ordine interno che può ridurre lo stress.
Parliamo però di ordine eccessivo. Un minimo di ordine è necessario per non creare confusione e poter ritrovare le nostre cose
Anche la balbuzie è un’alterazione del linguaggio collegata a questo quadro psicologico.
La persona che balbetta si impegna all’inizio, alla prima lettera o sillaba, e la ripete finché non finisce la parola.
Come si sa, il suo linguaggio è sciolto quando è solo o quando recita, quando canta.
Altrimenti mortificato dal suo difetto tenderà a isolarsi e a parlare il meno possibile. Oppure insisterà ostinatamente a parlare con intensi sforzi fisici.
La balbuzie «è un conflitto tra la tendenza erotico uretrale all’espulsione e la tendenza erotico-anale alla ritenzione, spostata alla bocca» (Manuale di Psichiatria, Arieti, vol. I pag.353).
Dott. Francesco Giovannozzi, Psicologo-Psicoterapeuta.
1a Domenica di Avvento (A)
Prima Domenica di Avvento (anno A) [30 Novembre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci progetta! Inizia con l’Avvento un nuovo anno liturgico (Anno A) accompagnati dall’evangelista Matteo che già c’invita a farci collaboratori del progetto di salvezza che Dio ha preordinato per la Chiesa. e il mondo. Una piccola novità: da ora offro ogni volta anche una sintesi degli elementi principali di ogni testo.
Prima Lettura dal libro del profeta Isaia (2, 1-5)
Si sa che gli autori biblici amano le immagini! Eccone due, bellissime, nella predicazione di Isaia: prima quella di una folla immensa in cammino, poi quella di tutte le armate del mondo che decidono di trasformare le armi in strumenti agricoli. Vediamo queste immagini una dopo l’altra. La folla in cammino sale su una montagna: alla fine del percorso c’è Gerusalemme e il Tempio. Isaia, invece, è già a Gerusalemme e vede arrivare questa folla, una vera e propria marea umana. È naturalmente un’immagine, un’anticipazione, probabilmente ispirata dai grandi pellegrinaggi degli Israeliti a Gerusalemme durante la festa delle Capanne (Succot). In questa occasione, per otto giorni si vive sotto capanne, anche in città, ricordando il soggiorno nel deserto durante l’Esodo. Tutte le comunità ebraiche vi affluiscono e il Deuteronomio invita a partecipare con gioia, anche con figli, servi, stranieri, orfani e vedove (Dt 16,14-15). il profeta Isaia, osservando questo straordinario raduno annuale, ne intuì uno futuro e, ispirato dallo Spirito Santo, annunciò che un giorno non solo Israele, ma tutte le nazioni parteciperanno a questo pellegrinaggio e il Tempio diventerà il luogo di raccolta di tutti i popoli, perché l’umanità intera conoscerà l’amore di Dio. Il testo intreccia Israele e le nazioni: “il monte del tempio del Signore s’innalzerà sopra i colli … e ad esso affluiranno tutte le genti”. Questa affluenza simboleggia l’ingresso delle altre nazioni nell’Alleanza. La legge uscirà da Sion e la parola del Signore da Gerusalemme: Israele è eletto da Dio, ma ha anche la responsabilità di collaborare all’inclusione delle nazioni nel progetto divino. Così l’Alleanza ha una dimensione doppia: particolare (Israele eletto) e universale (tutte le nazioni). L’ingresso delle nazioni nel Tempio non riguarda il sacrificio, ma l’ascolto della Parola di Dio e la vita secondo la sua Legge: “Venite, saliamo sul monte del Signore … perché c’insegni le sue vie e possiamo camminare peri suoi sentieri”. La seconda immagine mostra il frutto di questa obbedienza: le nazioni vivranno in pace, Dio sarà giudice e arbitro, e le armi saranno trasformate in strumenti di lavoro: Dalle loro spade forgeranno aratri, dalle loro lance falci. Non alzeranno più la spada contro un popolo. Infine Isaia invita Israele a camminare nella luce del Signore, a realizzare la propria vocazione e a guidare tutti verso la Luce: salire al Tempio significa celebrare l’Alleanza, camminare nella luce significa vivere secondo la Legge.
In sintesi ecco tutti gli elementi principali del testo:
+Due immagini simboliche di Isaia: la folla in pellegrinaggio e la trasformazione delle armi in strumenti di pace.
+Gerusalemme e il Tempio: meta del pellegrinaggio, simbolo della presenza di Dio e centro dell’Alleanza.
+Festa delle Capanne (Succot): riferimento storico al pellegrinaggio annuale degli Israeliti.
+Universalità della salvezza: Israele eletto guida tutte le nazioni, che saranno incluse nell’Alleanza.
+Dimensione dell’Alleanza: particolare (Israele) e universale (tutte le nazioni).
+Ascolto della Parola e vita secondo la Legge: la partecipazione non è solo rituale, ma impegno concreto di vita.
+Pace e trasformazione delle armi: simbolo della realizzazione del progetto divino di giustizia e concordia.
+Invito finale: Israele deve camminare nella luce del Signore e guidare l’umanità verso Dio.
+Profezia come promessa, non predizione: i profeti parlano della volontà di Dio, non del futuro in senso divinatorio.
Salmo responsoriale (121/122, 1-9)
Abbiamo qui la migliore traduzione possibile della parola ebraica “Shalom”: “Pace a chi ti ama! Che la pace regni nelle tue mura, la felicità nei tuoi palazzi…”. Quando si saluta qualcuno con questo termine, gli si augura tutto questo. Qui questo augurio è rivolto a Gerusalemme: “Chiedete pace per Gerusalemme… Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò: Sia su di te pace! Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene”. Nel nome stesso di Gerusalemme è contenuta la parola shalom; essa è, dovrebbe essere, e sarà la città della pace. Questo augurio di pace e felicità è però ancora lontano dall’essere realizzato. La storia di Gerusalemme è turbolenta: intorno al 1000 a.C. era un piccolo villaggio chiamato Jebus, abitato dai Gebusei. Davide scelse questo luogo per la capitale del suo regno: inizialmente la capitale era Ebron, e Davide era re solo della tribù di Giuda; poi, con l’adesione delle altre tribù, fu scelta Jebus, che diventò Gerusalemme, “città di Davide”. Qui Davide trasferì l’Arca dell’Alleanza e acquistò il campo di Arauna per il Tempio, seguendo la volontà di Dio. La definizione di Gerusalemme come “città santa” significa che appartiene a Dio: è il luogo dove si deve vivere secondo Dio. Con Davide e Salomone, la città raggiunge il suo splendore culturale e spirituale, e diventa centro della vita religiosa con il Tempio, meta dei pellegrinaggi tre volte l’anno, in particolare per la festa delle Capanne. Il profeta Natan ricorda a Davide che Dio è più interessato al popolo che al Tempio: “Tu vuoi costruire una casa a Dio, ma è Dio che ti costruirà una casa (discendenza)”. Così Dio promette di mantenere per sempre la discendenza di Davide, da cui verrà il Messia. Alla fine, fu Salomone a costruire il Tempio, rendendo Gerusalemme il centro cultuale. La città conoscerà poi distruzioni e ricostruzioni: la conquista di Nabucodonosor nel 587 a.C., l’Esilio a Babilonia, il ritorno autorizzato da Ciro nel 538 a.C. e la ricostruzione del Tempio di Salomone. Anche dopo le persecuzioni di Antioco Epifane e la distruzione del Tempio nel 70 d.C., Gerusalemme resta la città santa, simbolo della presenza di Dio, e la speranza della sua piena restaurazione rimane viva. I credenti, ovunque siano, continuano a rivolgersi a Gerusalemme nelle preghiere quotidiane, ricordando la fedeltà di Dio alle promesse fatte a Davide. Questo salmo 121/122, cantico dei pellegrinaggi, celebrava questa centralità di Gerusalemme, invitando i fedeli a salire verso la casa del Signore e a camminare nella luce di Dio.
Sintesi dei punti principali
+Shalom e Gerusalemme: Shalom significa pace e felicità; Gerusalemme è la città della pace.
+Storia della città: da Jebus a capitale di Davide, trasferimento dell’Arca, costruzione del Tempio.
+Città santa: appartiene a Dio; vivere a Gerusalemme significa vivere secondo Dio.
+Natan e la discendenza di Davide: Dio più interessato al popolo che al Tempio; promessa del Messia.
+Pellegrinaggi e vita religiosa: Gerusalemme centro cultuale con pellegrinaggi tre volte l’anno.
+Distruzioni e ricostruzioni: Nabucodonosor, Esilio, Ciro, persecuzioni di Antioco, distruzione del Tempio nel 70 d.C.
+Speranza e fede: Gerusalemme resta simbolo della fedeltà di Dio; i fedeli pregano orientandosi verso di essa.
+Psalmo 121/122: cantico dei pellegrinaggi, invita a salire verso la casa del Signore e camminare nella luce divina.
Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (13, 11 – 14)
In questo testo san Paolo sviluppa la classica contrapposizione fra “luce e tenebre”. “La nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti”. Questa frase resta sempre vera! Uno degli articoli della fede cattolica è che la storia non è un continuo ripetersi, ma al contrario il progetto di Dio avanza inesorabilmente. Ogni giorno possiamo dire che il disegno provvidenziale di Dio è più avanti di ieri: si sta compiendo, procede… lentamente ma con sicurezza. Dimenticare di annunciare questo significa dimenticare un punto essenziale della fede cristiana. I cristiani non hanno diritto a essere tristi, perché ogni giorno “la salvezza è più vicina”, come dice Paolo. Questo disegno provvidenziale e misericordioso di Dio ha bisogno di noi: non è tempo di dormire. Chi conosce il progetto di Dio non può rischiare di ritardarlo. Come dice la seconda lettera di Pietro: «Il Signore non tarda nel compiere la sua promessa… ma è paziente verso di voi, non volendo che alcuno perisca, ma che tutti giungano alla conversione» (2 Pt 3,9). La nostra inattività, il nostro “sonno” ha conseguenze sul compiersi del progetto di Dio; lasciare dormienti le nostre capacità significa comprometterlo o almeno ritardarlo. Ecco perché i peccati di omissione sono gravi. Paolo dice: “La notte è avanzata, il giorno è vicino”; e altrove parla di un tempo breve, usando un termine marinaro: la nave ha spiegato le vele, si avvicina al porto (1 Cor 7,26.29). Può sembrare presuntuoso pensare che la nostra condotta influisca sul progetto di Dio, ma è proprio questo il valore e la gravità della nostra vita. Paolo ricorda: «Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie”. Esistono comportamenti di luce e di tenebra, quando il battezzato non vive secondo il vangelo. Paolo non dice solo ci scegliere le opere della luce, ma di rifiutare quelle delle tenebre combattendo sempre per la luce. Ciò significa due cose: Ogni giorno dobbiamo scegliere la luce, un vero combattimento, soprattutto di fronte alle sfide antropologiche, sociali, al perdono, al rifiuto dei compromessi e dei privilegi (cfr. Fil 2,12). Anche altrove san Paolo parla delle armature della giustizia, della corazza della fede e dell’amore, del casco della speranza della salvezza (cf.2 Cor 6,7; 1 Tess 5,8). Qui la veste di luce è Gesù Cristo stesso, la cui luce ci avvolge come un mantello. Nel battesimo l’immersione simboleggia la morte al peccato e il rivestirsi di Cristo (Ga 3,27). Il combattimento cristiano non è solo nostro, ma è Cristo che combatte in noi e ci promette che quando siamo perseguitati, dobbiamo non prepararci perché è lui a dirci parole e darci saggezza che nessuno potrà contrastare.
Sintesi dei punti principali
+La salvezza è sempre più vicina: la storia non è un ciclo, ma un progresso del progetto di Dio.
+I credenti non possono essere passivi: la nostra inattività ritarda il compiersi del disegno divino e i peccati di omissione sono gravi perché ogni giorno dobbiamo realizzare il progetto di Dio.
+Esistono attività di luce e di tenebra: comportamenti cristiani e non cristiani che non coincidono sempre con la fede o il battesimo.
+Il combattimento cristiano è quotidiano: scegliere la luce, il perdono, rifiutare compromessi e immoralità.
+L’immagine della veste di luce rappresenta Gesù Cristo che ci avvolge e guida la nostra vita. Il battesimo simboleggia il rivestirsi di Cristo e l’inizio del combattimento della luce.
+La forza del cristiano non è solo propria: Cristo combatte in noi, garantendo saggezza e parole contro le persecuzioni.
Dal Vangelo secondo Matteo (24, 37 – 44)
Una cosa è certa: questo testo non è stato scritto per spaventarci, ma per illuminarci. Testi come questo vengono definiti apocalittici, il che significa letteralmente che “sollevano un lembo del velo”: rivelano la realtà. E la realtà, l’unica che conta, è la venuta di Cristo. Notate il linguaggio: venire, venuta, avvento, sempre riferito a Gesù: Gesù parlava ai discepoli della sua venuta che sarà come ai tempi di Noè. Anche voi non conoscete il giorno in cui il Signore verrà perché sarà proprio all’ora in cui non pensate. Il cuore del messaggio è dunque l’annuncio che Gesù Cristo verrà. Curiosamente, Gesù parla al futuro: “Il Signore vostro verrà”. Sarebbe più logico parlare al passato perché Gesù era già venuto... Questo ci mostra che la “venuta” non è la nascita, ma qualcosa che riguarda il compimento del progetto di Dio. Molto spesso ci disturbano le immagini del giudizio, come la comparazione con il diluvio: “Due uomini saranno nel campo nei campi, uno verrà portato via e l’altro lasciato”. Questo non è un arbitrio divino, ma un invito alla fiducia: come Noè fu trovato giusto e salvato, così tutto ciò che è giusto sarà salvato. Il giudizio distingue il buono dal cattivo, il buon grano dalla zizzania, e questo avviene nel cuore di ciascuno. Gesù usa il titolo Figlio dell’Uomo per parlare di sé, ma non solo di sé come individuo: riprende la visione del profeta Daniele, in cui il “Figlio dell’Uomo” rappresenta anche il popolo dei santi, un essere collettivo. Così, la venuta di Cristo riguarda l’intera umanità. Come dice san Paolo, Cristo è la testa e noi siamo i membri; sant’Agostino parla del Cristo totale: testa nei cieli, membri sulla terra. Quando diciamo pregando che attendiamo il bene che Dio ci prometti, cioè l’avvento di Gesù Cristo, ci riferiamo a Cristo totale: l’uomo Gesù è già venuto, ma il Cristo totale è in crescita e compimento continuo. San Paolo e recentemente Teilhard de Chardin sottolineano che la creazione intera geme in attesa del compimento di Cristo, che si completa progressivamente nella storia e in ciascuno di noi. Quando Gesù invita a vegliare, è un invito a custodire il grande progetto di Dio, dedicando la nostra vita a farlo avanzare. Infine, questo discorso avviene poco prima della Passione: Gesù avverte della distruzione del Tempio, il simbolo della sua presenza e dell’Alleanza, ma non risponde a domande precise sulla fine del mondo; invita invece alla vigilanza, rassicurando i discepoli davanti alle prove.
Sintesi dei punti principali
+Scopo del testo: non spaventare, ma illuminare; rivelare la realtà della venuta di Cristo.
+Venuta di Cristo: Gesù parla al futuro perché la venuta completa riguarda Cristo totale, non solo la nascita storica di Gesù.
+Giudizio e giustizia: distinguere il buono dal cattivo avviene nel cuore di ciascuno; il giusto sarà salvato.
+Titolo Figlio dell’Uomo: indica non solo Gesù, ma il popolo dei santi, cioè l’umanità salvata. Cristo totale: Cristo come testa e i credenti come membri; il compimento è progressivo nella storia.
+Veglia e vigilanza: i discepoli sono chiamati a custodire il progetto di Dio e dedicare la loro vita al suo compimento.
+Tempio e passione: il discorso precede la Passione, annuncia la distruzione del Tempio e invita di discepoli alla fiducia nonostante le prove che dovranno subire.
+ Giovanni D’Ercole
Avvento, Venuta. Perché? e Dove
Cristo Re
Solennità di Cristo Re dell’Universo [23 Novembre 2025]
Dio ci benedica e la Vergine ci protegga. Chiudiamo con animo grato al l’Anno liturgico C preparandoci a riprendere il cammino con l’Avvento.
*Prima Lettura dal secondo libro di Samuele (5,1-3)
Questi sono i primi passi della monarchia in Israele. Tutto comincia a Ebron, antica città delle montagne di Giudea, dove riposano i patriarchi d’Israele: Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lea, e persino Giuseppe, le cui ossa furono riportate dall’Egitto. È un luogo carico di memoria e di fede, e proprio qui Davide diventa re di tutte le dodici tribù d’Israele. Dopo la morte di Mosè, verso il 1200 a.C., il popolo d’Israele si stabilì in Palestina. Le tribù vivevano in modo autonomo, unite soltanto dal ricordo della liberazione dall’Egitto e dalla fede nel loro unico Dio. Nei momenti di pericolo, Dio suscitava dei capi temporanei, i Giudici, che guidavano il popolo e spesso agivano anche come profeti. Uno di questi fu Samuele, grande uomo di Dio. Col tempo, però, gli Israeliti vollero essere “come gli altri popoli” e chiesero a Samuele di avere un re. Il profeta ne fu turbato, perché Israele doveva riconoscere solo Dio come Re, ma alla fine, su comando divino, consacrò Saul, il primo re d’Israele. Dopo un inizio promettente, Saul cadde nella disobbedienza e nella follia e Dio scelse un altro uomo: Davide, il giovane pastore di Betlemme, al quale Samuele versò l’olio dell’unzione. Davide non prese subito il potere: servì Saul con fedeltà, divenne suo musicista e valoroso guerriero, amato dal popolo e legato da profonda amicizia a Gionata, il figlio di Saul. Ma la gelosia del re si trasformò in odio, e Davide fu costretto a fuggire, pur rifiutandosi sempre di alzare la mano contro “l’unto del Signore”. Dopo la morte di Saul, Israele si divise: Davide regnava a Ebron sulla tribù di Giuda, mentre al Nord un figlio di Saul regnava per breve tempo. Quando quest’ultimo fu ucciso, le tribù del Nord si radunarono a Ebron e riconobbero Davide come loro re. Quel giorno nacque il regno unito d’Israele: dodici tribù sotto un solo pastore, scelto da Dio e riconosciuto dai fratelli. L’unzione con l’olio sacro fece di Davide il “Messia”, cioè l’“unto del Signore”. Egli doveva essere un re secondo il cuore di Dio, un pastore che guida il suo popolo verso l’unità e la pace. Ma la storia mostrò quanto fosse difficile realizzare questo ideale. Tuttavia, la speranza non morì: Israele attese sempre il vero Messia, il discendente di Davide che avrebbe instaurato un regno eterno. E mille anni dopo, Gesù Cristo, chiamato “Figlio di Davide”, si presentò come il Buon Pastore, colui che offre la vita per il suo gregge. Ogni domenica, nell’Eucaristia, Egli rinnova la sua alleanza e ci dice: “Voi siete del mio stesso sangue.”
*Salmo responsoriale (121/122,1-2,3-4,5-6a.7a)
“Quale gioia quando mi dissero: Andremo alla casa del Signore” . Un pellegrino racconta la sua emozione: dopo un lungo viaggio, finalmente i suoi piedi si fermano alle porte di Gerusalemme. Siamo nel tempo del ritorno dall’esilio babilonese: la città è stata ricostruita, il Tempio restaurato (attorno al 515 a.C.), e il popolo ritrova nella casa del Signore il segno vivo dell’Alleanza. Davanti alla città risorta, il pellegrino esclama: Gerusalemme, eccoti dentro le tue mura, città ben compatta, dove tutto insieme forma un solo corpo! Gerusalemme non è solo un luogo geografico: è il cuore del popolo di Dio, simbolo della unità e della comunione. Ogni pietra, ogni muro ricorda che Israele è un popolo radunato da un’unica promessa e da un destino comune. Dio stesso ha voluto che Israele salisse ogni anno in pellegrinaggio a Gerusalemme, perché il cammino comune e la fatica condivisa mantenessero vivo il legame dell’Alleanza. Per questo il Salmo proclama:”E’ là che salgono le tribù, le tribù del Signore…per lodare il nome del Signore”. Il verbo “salire” indica sia la posizione elevata della città, sia la salita spirituale del popolo verso il suo Dio liberatore, lo stesso che li fece salire cioè uscire dall’Egitto. La formula “le tribù del Signore” richiama l’appartenenza reciproca dell’Alleanza: “Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.” Il pellegrinaggio, fatto a piedi, tra fatica, sete e canti, è un cammino di fede e di fraternità. Quando il pellegrino esclama: Ora il nostro cammino ha fine!, esprime la gioia di chi ha raggiunto non solo una meta geografica, ma anche spirituale: l’incontro con Dio nella città della sua presenza. Rendere grazie al Signore è la vocazione di Israele. Finché il mondo intero non riconoscerà Dio, Israele è chiamato a essere nel mondo il popolo dell’azione di grazie, testimone della fedeltà divina. Così ogni pellegrinaggio a Gerusalemme rinnova la missione di Israele: ringraziare, lodare e mostrare la via alle altre nazioni. Il profeta Isaia aveva preannunciato questo disegno universale:”Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti,e tutte le nazioni affluiranno ad esso…Da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore.” (Is 2,2-3) Gerusalemme diventa allora segno profetico del mondo rinnovato, dove tutti i popoli saranno uniti nella stessa lode e nella stessa pace. Il Salmo ricorda ancora:”Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide.” Con queste parole, Israele rievoca la promessa fatta da Dio a Davide per mezzo del profeta Natan: “Susciterò dalla tua discendenza un re, e renderò stabile il suo regno.” (2 Sam 7,12). Dopo l’esilio, non c’è più un re sul trono, ma la promessa resta viva: Dio non si smentisce. Nelle celebrazioni al Tempio, questo ricordo diventa preghiera e speranza: verrà il giorno in cui Dio susciterà un re secondo il suo cuore, giusto e fedele, che ristabilirà la pace e la giustizia. Il nome stesso di Gerusalemme significa “città della pace”. Quando si prega: «Domandate pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano!» (Sal 122,6) non si pronuncia un semplice augurio, ma una professione di fede: solo Dio può dare la pace vera, e Israele è chiamato a esserne testimone nel mondo. Con il passare dei secoli, la speranza di un re giusto trova compimento in Gesù Cristo, il Figlio di Davide. È Lui che inaugura il Regno di vita e di verità, di grazia e di santità, di giustizia, d’amore e di pace, come proclama la liturgia della festa di Cristo Re. In Lui la Gerusalemme terrena diventa Gerusalemme nuova, la città dell’incontro definitivo tra Dio e l’uomo. Ogni Eucaristia è una salita verso quella città, un pellegrinaggio dell’anima che termina nel cuore di Dio. Il pellegrinaggio di Israele verso Gerusalemme diventa allora simbolo del cammino di tutta l’umanità verso la comunione con Dio. E come i pellegrini del Salmo, anche noi, Chiesa del Nuovo Testamento, possiamo dire con gioia: “Quale gioia quando mi dissero: andremo alla casa del Signore”
*Seconda Lettura dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi (1,12-20)
Il volto invisibile di Dio. C’era una volta un mondo che cercava Dio, ma non sapeva come vederlo. Gli uomini alzavano gli occhi al cielo, costruivano templi, offrivano sacrifici, ma Dio restava invisibile, lontano. Poi, un giorno, il Verbo si fece carne: il Dio che nessuno aveva mai visto prese un volto umano, e quel volto fu quello di Gesù di Nazareth. Da allora, ogni volta che un uomo guarda Gesù, guarda Dio.San Paolo lo ha detto con parole che sembrano un canto: ”Egli è immagine del Dio invisibile, il primogenito di tutta la creazione”. In Lui, tutto ciò che esiste trova origine e senso. Non è solo il principio del mondo, ma anche il suo cuore: in Lui tutto è stato creato, e in Lui tutto è stato riconciliato. Questo piano di Dio non è nato ieri e Paolo parla di un disegno pensato da sempre: “Egli ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel Regno del Figlio del suo amore.” Da sempre Dio ha sognato l’uomo libero, luminoso, capace di comunione. Ma ciò che Dio aveva preparato nell’eternità si è realizzato nel tempo, nel presente del Cristo. Per questo Paolo scrive: “In Lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.” Il mistero di Gesù non è un ricordo, è una realtà viva che ogni giorno continua a operare nel cuore dei credenti. Dio aveva fatto l’uomo “a sua immagine e somiglianza”. Ma quell’immagine, nel peccato, si era come appannata. Allora Dio stesso è venuto a mostrarci che cosa significa essere uomo. In Gesù, l’uomo è restituito alla sua bellezza originaria. Quando Pilato lo mostra alla folla e dice: “Ecco l’uomo!” non sa di pronunciare una profezia: in quel volto ferito, in quel silenzio umile, si manifesta l’uomo vero, come Dio lo aveva voluto. Ma in quel volto c’è anche il volto di Dio. Gesù è la visibilità dell’invisibile. È Dio che si lascia guardare, toccare, ascoltare. “Chi ha visto me, ha visto il Padre”, dirà a Filippo. E Paolo aggiungerà: “In Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità.” In Gesù, Dio e l’uomo si incontrano per sempre. L’infinito ha preso corpo, il cielo si è fatto carne. E’ il mistero della Croce. Ma come può la Croce essere segno di pace e di riconciliazione? Paolo lo spiega così: “Dio ha voluto riconciliare a sé tutte le cose, facendo la pace per mezzo del sangue della sua croce.” Non è Dio a volere la sofferenza del Figlio. È l’odio degli uomini che lo uccide. Eppure, Dio trasforma quell’odio in amore redentore. È il grande rovesciamento della storia: la violenza si fa perdono, la morte diventa vita, la croce diventa albero di pace. Abbiamo visto nella storia uomini che hanno testimoniato la pace e sono stati uccisi per questo — Gandhi, Martin Luther King, Itzhak Rabin, Sadat… — ma solo Cristo, essendo uomo e Dio insieme, ha potuto trasformare il male in grazia per tutto il mondo. Nel suo perdono ai crocifissori — “Padre, perdonali” — si rivela il perdono stesso di Dio. Da quel giorno, sappiamo che nessun peccato è più grande dell’amore di Dio. Sulla croce, tutto è compiuto. Paolo scrive: “Dio ha voluto che in Lui abitasse tutta la pienezza, e che tutto, per mezzo di Lui, fosse riconciliato.” La creazione trova finalmente la sua unità, la sua pace. Il primo a entrare in questo Regno è il ladrone pentito: “Oggi sarai con me in paradiso”. E da allora, ogni uomo che si apre al perdono entra in quella stessa luce. L’Ecaristia è cuore del mistero Di fronte a un tale dono, la risposta possibile è una sola: rendere grazie. Per questo Paolo invita: “Rendete grazie a Dio Padre, che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.” L’Eucaristia — in greco eucharistia significa proprio “rendimento di grazie” — è il luogo dove la Chiesa rivive questo mistero. Ogni Messa è memoria viva di questa riconciliazione: Dio si dona, il mondo viene rinnovato, l’uomo ritrova se stesso. È lì che tutto si ricompone: il visibile e l’invisibile, la terra e il cielo, l’uomo e Dio. E così, nella storia del mondo, un volto ha rivelato l’invisibile. Un cuore trafitto ha portato la pace. Un pane spezzato continua a rendere presente la pienezza dell’amore. E ogni volta che la Chiesa si raduna per l’Eucaristia, il canto di Paolo si rinnova come una lode cosmica: Cristo è l’immagine del Dio invisibile, il primo e l’ultimo, colui che riconcilia il mondo con il Padre, colui nel quale tutto sussiste. In Lui, tutto trova senso. In Lui, tutto è grazia. In Lui, il Dio invisibile ha finalmente un volto: Gesù Cristo, Signore del cielo e della terra.
*Dal Vangelo secondo Luca (23, 35-43)
La logica degli uomini e la logica di Dio. Tre volte, ai piedi della croce, risuona la stessa provocazione a Gesù:”Se tu sei…” — “Se tu sei il Messia”, deridono i capi religiosi; “Se tu sei il re dei Giudei”, sogghignano i soldati romani;” Se tu sei il Messia”, lo insulta uno dei malfattori crocifissi con lui. Ognuno parla a partire dal proprio punto di vista: i capi d’Israele aspettano un Messia potente, ma davanti a loro c’è un uomo vinto e crocifisso; i soldati, uomini del potere terreno, ridono di un “re” senza difese; il malfattore, invece, attende un salvatore che lo liberi dalla morte. Queste tre voci ricordano le tre tentazioni nel deserto (Lc 4): anche allora il tentatore ripeteva: «Se tu sei Figlio di Dio…». Tentazioni di potere, di dominio e di miracolo. Gesù aveva risposto ogni volta con la Parola: “Sta scritto: l’uomo non vive di solo pane…” “Adorerai il Signore Dio tuo e a lui solo renderai culto…” “Non tenterai il Signore tuo Dio”. La Scrittura era stata la sua forza per rimanere fedele alla missione del Messia povero e obbediente. Sulla croce, invece, Gesù tace. Non risponde più alle provocazioni. Eppure sa bene chi è: il Messia, il Salvatore. Ma non secondo la logica degli uomini, che vorrebbero un Dio capace di salvarsi da solo, di dominare, di vincere con la forza. Gesù muore proprio perché non corrisponde a questa logica umana. La sua logica è quella di Dio: salvare donandosi, senza imporsi. Il suo silenzio non è vuoto, ma pieno di fiducia. Il suo stesso nome, Gesù, significa: «Dio salva». Attende il suo riscatto da Dio solo, non da sé stesso. Le tentazioni sono vinte per sempre: egli rimane fedele, consegnato totalmente nelle mani degli uomini, ma confidando nel Padre. In mezzo alle offese, due parole racchiudono il mistero della Croce. La prima: “Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno”. La seconda, rivolta al “buon ladrone”: “Oggi sarai con me in Paradiso”. Il perdono e la salvezza: due gesti divini e umani insieme. In Gesù, Dio stesso perdona e riconcilia l’umanità. Il ladrone pentito — che si rivolge a lui dicendo: “Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo Regno” — è il primo a comprendere chi è veramente Cristo. Non chiede di scendere dalla croce, ma di essere accolto. In quella supplica di umiltà e fiducia, il “ricordati” diventa la preghiera che apre il Paradiso. Là dove Adamo, nel giardino dell’Eden, aveva ceduto alla tentazione di “essere come Dio”, Gesù, il nuovo Adamo, vince attendendo tutto da Dio. Adamo aveva voluto decidere da solo la propria grandezza ed era stato cacciato dal Paradiso; Gesù, invece, accettando di essere Figlio nel totale abbandono, riapre il Paradiso all’umanità. Nel racconto della Passione, si incrociano due logiche: quella degli uomini, che cercano un Dio potente, e quella di Dio, che salva attraverso l’amore e la debolezza. Gesù rifiuta la tentazione di dimostrare la propria forza; sceglie invece di fidarsi del Padre fino alla fine. Nel suo silenzio e nel suo perdono, la potenza divina si manifesta come misericordia. Accanto a lui, il ladrone pentito diventa il primo testimone del Regno: riconosce in Cristo il vero Re, non dei potenti, ma dei salvati. Dove Adamo aveva chiuso le porte del Paradiso, Gesù le riapre: “Oggi sarai con me in Paradiso” è la risposta definitiva di Dio alla logica del mondo.
+ Giovanni D’Ercole
33a Domenica T.O. (anno C)
XXXIII Domenica Tempo Ordinario C [16 Novembre 2025]
Prima Lettura dal libro del profeta Malachia (3,19-20 a)
Quando Malachia scrive queste parole, verso il 450 a.C., il popolo è scoraggiato: la fede sembra spegnersi, persino tra i sacerdoti di Gerusalemme, che ormai celebrano il culto in modo superficiale. Tutti si chiedono: “Che cosa fa Dio? Ci ha dimenticati? La vita è ingiusta! Ai malvagi tutto riesce, a che serve essere il popolo eletto e osservare i comandamenti? Dov’è la giustizia di Dio?”. Il profeta allora compie il suo compito: risvegliare la fede e le energie interiori. Rimprovera sacerdoti e laici, ma soprattutto proclama che Dio è giusto e che il suo progetto di giustizia sta avanzando irresistibilmente. “Ecco, sta per venire il giorno del Signore”: la storia non è un ciclo che si ripete, ma cammina verso un compimento. Per chi crede, questa è una verità di fede: il giorno del Signore viene. Secondo l’immagine che ciascuno ha di Dio, questa venuta può far paura o suscitare attesa ardente. Ma per chi riconosce che Dio è Padre, il giorno del Signore è una buona notizia, un giorno di amore e di luce. Malachia usa l’immagine del sole: “Ecco, viene il giorno del Signore, ardente come un forno”. Non è una minaccia! All’inizio del libro Dio dice: “Vi amo” (Ml 1,2) e “Io sono Padre” (Ml 1,6). La “il forno” non è punizione, ma simbolo dell’amore incandescente di Dio. Come i discepoli di Emmaus sentivano il cuore ardere nel petto, così chi incontra Dio è avvolto nel calore del suo amore. Il “sole di giustizia” è dunque fuoco d’amore: nel giorno dell’incontro con Dio saremo immersi in questo oceano ardente di misericordia. Dio non può che amare, soprattutto tutto ciò che è povero, nudo, senza difesa. È il senso stesso della misericordia: un cuore che si piega sulla miseria. Malachia parla anche di giudizio. Il sole, infatti, può bruciare o guarire: è ambivalente. Allo stesso modo, il “Sole di Dio” rivela tutto, illumina senza lasciare zone d’ombra: nessuna menzogna o ipocrisia può nascondersi davanti alla sua luce. Il giudizio di Dio non è distruzione, ma rivelazione e purificazione. Il sole “brucerà” gli arroganti e gli empi, ma “guarirà” coloro che temono il suo nome. L’arroganza, il cuore chiuso, si consumeranno come paglia; l’umiltà e la fede saranno trasfigurate. In ciascuno di noi convivono orgoglio e umiltà, egoismo e amore. Il giudizio di Dio avverrà dentro di noi: ciò che è “paglia” brucerà, ciò che è “buon seme” germoglierà al sole di Dio. Sarà un processo di purificazione interiore, fino a che in noi risplenderà l’immagine e somiglianza di Dio. Malachia usa anche altre due immagini: quella del fonditore, che purifica l’oro non per distruggerlo, ma perché brilli di tutta la sua bellezza; e quella del candeggiatore, che non rovina la veste, ma la rende splendente. Così, il giudizio di Dio è un’opera di luce: tutto ciò che è amore, servizio e misericordia sarà esaltato; tutto ciò che non è amore sparirà. Alla fine resterà solo ciò che riflette il volto di Dio. Il contesto storico: ci aiuta a capire questo testo: Israele vive una crisi di fede e di speranza dopo l’esilio; i sacerdoti sono tiepidi e il popolo è disilluso. Messaggio del profeta: Dio non è assente né ingiusto. Il suo “giorno” verrà: è il momento in cui la sua giustizia e il suo amore si manifesteranno pienamente. Immagine centrale è il Sole di giustizia, simbolo dell’amore purificatore di Dio. Come il sole, l’amore divino brucia e guarisce, consuma il male e fa fiorire il bene. In ognuno di noi Dio non condanna, ma trasforma tutto in salvezza compiendo un discernimento che glorifica l’amore e dissolve l’orgoglio. Il fuoco, il sole, il fonditore e il candeggiatore indicano la purificazione che porta alla bellezza originaria dell’uomo creato a immagine di Dio. Infine: non c’è nulla da temere: per chi crede, il giorno del Signore rivela è l’amore. “sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia” (Ml 3,20).
Salmo Responsoriale (97/98, 5-6, 7-8, 9)
Questo salmo ci trasporta idealmente alla fine dei tempi, quando tutta la creazione rinnovata acclama con gioia l’avvento del Regno di Dio. Il testo parla infatti del mare e delle sue ricchezze, del mondo e dei suoi abitanti, dei fiumi e dei monti: tutta la creazione è coinvolta. San Paolo, nella Lettera agli Efesini (1,9-10), ricorda che questo è il disegno eterno di Dio: «ricapitolare in Cristo tutte le cose, quelle del cielo e quelle della terra». Dio vuole riunire tutto, creare una comunione piena fra il cosmo e le creature, instaurare l’armonia universale. Nel salmo questa armonia è già cantata come realizzata: il mare rimbomba, i fiumi battono le mani, le montagne esultano. È il sogno di Dio, annunciato già dal profeta Isaia (11,6-9): «Il lupo dimorerà con l’agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto… nessuno farà più del male né distruzione su tutto il mio monte santo». Ma la realtà è ben diversa: l’uomo conosce i pericoli del mare, i conflitti con la natura e con i suoi simili. La creazione è segnata da lotta e disarmonia. Tuttavia, la fede biblica sa che verrà il giorno in cui il sogno diventerà realtà, perché è il progetto di Dio stesso. l ruolo dei profeti, come Isaia, è quello di ravvivare la speranza di questo Regno messianico di giustizia e fedeltà. Anche i Salmi ripetono instancabilmente i motivi di questa speranza: nel Salmo 97(98) si canta il Regno di Dio come ristabilimento dell’ordine e della pace universale. Dopo tanti re ingiusti, si attende un Regno di giustizia e rettitudine. Il popolo canta come se tutto fosse già compiuto“Cantate inni al Signore che viene a giudicare la terra…e i popoli con rettitudine” All’inizio del salmo si ricordano le meraviglie del passato — l’esodo dall’Egitto, la fedeltà di Dio nella storia d’Israele — ma ora si proclama che Dio viene: il suo Regno è certo, anche se non ancora pienamente visibile. L’esperienza del passato diventa garanzia dell’avvenire: Dio ha già mostrato la sua fedeltà, e ciò permette al credente di anticipare con gioia l’avvento del Regno.Come dice il Salmo 89(90): “Mille anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri”. E san Pietro (2 Pt 3,8-9) ricorda che Dio non ritarda la sua promessa, ma attende la conversione di tutti. Questo salmo dunque fa eco alle promesse del profeta Malachia: “Sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia” (Ml 3,20). I cantori di questo salmo sono i poveri del Signore, coloro che attendono la venuta del Cristo come luce e calore.Un tempo era Israele solo a cantare: “Acclama al Signore, terra intera, acclama il tuo re!” Ma nei tempi ultimi sarà tutta la creazione a unirsi in questo canto di vittoria, non più soltanto il popolo eletto. In ebraico, il verbo “acclamare” evoca il grido di trionfo del vincitore sul campo di battaglia (“teru‘ah”). Ma nel mondo nuovo, questo grido non sarà più di guerra, bensì di gioia e salvezza, perché — come dice Isaia (51,8): “La mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione”.Gesù ci insegna a pregare: “Venga il tuo Regno”, che è il compimento del sogno eterno di Dio: la riconciliazione e la comunione universale, in cui tutta la creazione canterà all’unisono la giustizia e la pace del suo Signore.
Seconda Lettura dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi (3, 7-12)
San Paolo scrive: “Chi non vuole lavorare, neppure mangi” (2 Ts 3,10). Questa frase, oggi, non potrebbe essere ripetuta alla lettera, perché non si riferisce ai disoccupati di buona volontà del nostro tempo, ma a una situazione del tutto diversa. Paolo non parla di chi non può lavorare, ma di chi non vuole lavorare, approfittando dell’attesa della venuta imminente del Signore per vivere nell’inerzia. Nel mondo di Paolo il lavoro non mancava. Egli stesso, arrivato a Corinto, trovò facilmente impiego presso Priscilla e Aquila, che esercitavano il suo stesso mestiere: fabbricanti di tende (At 18,1-3). Il suo lavoro manuale, tessere tele di capra, un’arte imparata a Tarso in Cilicia, era faticoso e poco redditizio, ma gli permetteva di non essere di peso a nessuno: «Nella fatica e nella pena, notte e giorno abbiamo lavorato per non essere di peso a nessuno» (2 Ts 3,8). Questo lavoro continuo, sostenuto anche dall’aiuto economico dei Filippesi, diventa per Paolo una testimonianza viva contro l’ozio di coloro che, convinti dell’imminente ritorno di Cristo, avevano abbandonato ogni impegno. La sua frase «chi non vuole lavorare, non mangi» non è un’invenzione personale, ma un detto rabbinico corrente, espressione di una saggezza antica che univa fede e responsabilità concreta. Il primo motivo che Paolo addduce è il rispetto degli altri: non approfittare della comunità, non vivere a spese altrui.La fede nell’avvento del Regno non deve diventare un pretesto per la passività. Al contrario, l’attesa del Regno si traduce in un impegno operoso e solidale: il cristiano collabora alla costruzione del mondo nuovo con le proprie mani, la propria intelligenza, la propria dedizione. Paolo ricorda implicitamente il mandato della Genesi:«Dominate la terra e sottomettetela» (Gn 1,28), che non significa sfruttare, ma prendere parte al progetto di Dio, trasformando la terra in un luogo di giustizia e di amore, anticipo del suo Regno. Il Regno non nasce fuori dal mondo, ma cresce dentro la storia, attraverso la collaborazione degli uomini. Come canta il padre Aimé Duval: “Il tuo cielo si farà sulla terra con le tue braccia”. E come scrive Khalil Gibran ne Il Profeta: “Quando lavorate, realizzate una parte del sogno della terra… Il lavoro è l’amore reso visibile”. In questa prospettiva, ogni gesto di amore, di cura, di servizio, anche se non retribuito, è una partecipazione alla costruzione del Regno di Dio. Lavorare, creare, servire, è collaborare con il Creatore. San Pietro ricorda: «Per il Signore, un giorno è come mille anni e mille anni come un giorno… Egli non ritarda nel compiere la sua promessa, ma usa pazienza, volendo che tutti giungano alla conversione» (2 Pt 3,8-9). Questo significa che il tempo dell’attesa non è un vuoto, ma un tempo affidato alla nostra responsabilità. Ogni atto di giustizia, ogni opera buona, ogni gesto d’amore accelera la venuta del Regno. Perciò — conclude il testo — se desideriamo davvero che il Regno di Dio arrivi più presto, non abbiamo un minuto da perdere. Ecco una piccola sintesi spirituale: L’ozio non è semplice mancanza di lavoro, ma rinuncia alla collaborazione con Dio. l lavoro, in qualunque forma, è parte del sogno divino: rendere la terra luogo di comunione e di giustizia. Attendere il Regno non significa evadere dal mondo, ma impegnarsi a trasfigurarlo. Ogni gesto d’amore è una pietra posata per il Regno che viene. Chi lavora con cuore puro accelera l’alba del “Sole di giustizia” promesso dai profeti.
Dal Vangelo secondo Luca (21, 5-19)
“Nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto” Qui c’è un linguaggio profetico, non letterale. Constatiamo ogni giorno che i capelli si perdono davvero! Ciò dimostra che le parole di Gesù non vanno prese alla lettera, ma come un linguaggio simbolico. Gesù, come i profeti prima di lui, non fa predizioni sul futuro: fa predicazioni. Non annuncia cronache di avvenimenti, ma chiavi di fede per interpretare la storia. Anche il suo discorso sulla fine del Tempio va compreso così: non è un oroscopo dell’apocalisse, ma un insegnamento per vivere con fede il presente, soprattutto quando tutto sembra crollare. Il messaggio è chiaro: “Qualunque cosa accada… non abbiate paura!» Gesù invita a non fondare la vita su ciò che passa. Il Tempio di Gerusalemme, restaurato da Erode e coperto d’oro, era splendido, ma destinato a crollare. Ogni realtà terrena, anche la più sacra o solida, è provvisoria. La vera stabilità non sta nelle pietre, ma in Dio. Gesù non offre dettagli sul “quando” o sul “come” del Regno; egli sposta la questione: “Fate attenzione a non lasciarvi ingannare…” Non ci serve conoscere il calendario del futuro, ma vivere il presente nella fedeltà. Gesù avverte i suoi discepoli: “Prima di tutto questo vi perseguiteranno, vi trascineranno davanti ai re e ai governatori a causa del mio Nome». Luca, che scrive dopo anni di persecuzioni, sa bene quanto questo si sia avverato: da Stefano a Giacomo, da Pietro a Paolo, fino a tanti altri. Ma anche nelle persecuzioni, Gesù promette: «Io vi darò una parola e una sapienza alla quale nessuno potrà resistere». Questo non significa che i cristiani saranno risparmiati dalla morte — «uccideranno alcuni di voi» —, ma che nessuna violenza potrà distruggere ciò che siete in Dio :«Neppure un capello del vostro capo andrà perduto». È un modo per dire: la vostra vita è custodita nelle mani del Padre. Anche attraverso la morte, rimanete vivi della vita di Dio Gesù pronuncia due volte l’espressione «a causa del mio Nome». Nel linguaggio ebraico, “Il Nome” indica Dio stesso: dire “a causa del Nome” è dire “a causa di Dio”. Così Gesù rivela la sua stessa divinità: soffrire per il suo Nome è partecipare al mistero del suo amore. San Luca, negli Atti degli Apostoli, mostra Pietro e Giovanni che, dopo essere stati flagellati, «se ne andarono pieni di gioia, perché si erano sentiti degni di soffrire per il Nome di Gesù» (At 5,41).È la stessa certezza che san Paolo esprimerà nella Lettera ai Romani: «Né la morte né la vita, né alcuna creatura potrà separarci dall’amore di Dio che è in Cristo Gesù» (Rm 8,38-39). Le catastrofi, le guerre, le epidemie — tutte queste “scosse” del mondo — non devono toglierci la pace. Il vero segno dei credenti è la serenità che viene dalla fiducia. Nell’agitazione del mondo, la calma dei figli di Dio è già una testimonianza. Gesù lo riassume in una parola: Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!» (Gv 16,33). Ed ecco una sintesi spirituale: Gesù non promette una vita senza prove, ma una salvezza più forte della morte. Neppure un capello…» significa: nessun frammento di te è dimenticato da Dio. La persecuzione non distrugge, ma purifica la fede. Niente potrà separarci dall’amore di Dio: la nostra sicurezza è il Cristo risorto. Credere è rimanere saldi, anche quando tutto trema.
+ Giovanni D’Ercole
Anyone who welcomes the Lord into his life and loves him with all his heart is capable of a new beginning. He succeeds in doing God’s will: to bring about a new form of existence enlivened by love and destined for eternity (Pope Benedict)
Chi accoglie il Signore nella propria vita e lo ama con tutto il cuore è capace di un nuovo inizio. Riesce a compiere la volontà di Dio: realizzare una nuova forma di esistenza animata dall’amore e destinata all’eternità (Papa Benedetto)
You ought not, however, to be satisfied merely with knocking and seeking: to understand the things of God, what is absolutely necessary is oratio. For this reason, the Saviour told us not only: ‘Seek and you will find’, and ‘Knock and it shall be opened to you’, but also added, ‘Ask and you shall receive’ [Verbum Domini n.86; cit. Origen, Letter to Gregory]
Non ti devi però accontentare di bussare e di cercare: per comprendere le cose di Dio ti è assolutamente necessaria l’oratio. Proprio per esortarci ad essa il Salvatore ci ha detto non soltanto: “Cercate e troverete”, e “Bussate e vi sarà aperto”, ma ha aggiunto: “Chiedete e riceverete” [Verbum Domini n.86; cit. Origene, Lettera a Gregorio]
In the crucified Jesus, a kind of transformation and concentration of the signs occurs: he himself is the “sign of God” (John Paul II)
In Gesù crocifisso avviene come una trasformazione e concentrazione dei segni: è Lui stesso il "segno di Dio" (Giovanni Paolo II)
Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)
Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)
In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)
Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))
Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello (Papa Benedetto)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.