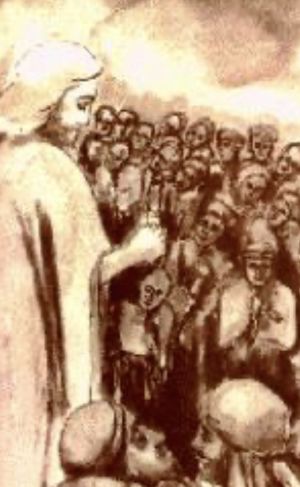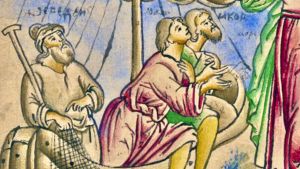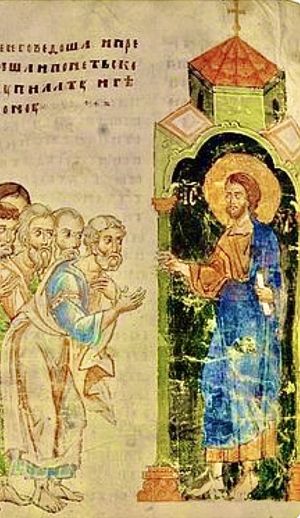don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Futuro “glorioso”, che reca vita
Nella liturgia odierna l'evangelista Matteo, che ci accompagnerà lungo tutto questo anno liturgico, presenta l'inizio della missione pubblica di Cristo. Essa consiste essenzialmente nella predicazione del Regno di Dio e nella guarigione dei malati, a dimostrare che questo Regno si è fatto vicino, anzi, è ormai venuto in mezzo a noi. Gesù comincia a predicare in Galilea, la regione in cui è cresciuto, territorio di "periferia" rispetto al centro della nazione ebraica, che è la Giudea, e in essa Gerusalemme. Ma il profeta Isaia aveva preannunciato che quella terra, assegnata alle tribù di Zabulon e di Neftali, avrebbe conosciuto un futuro glorioso: il popolo immerso nelle tenebre avrebbe visto una grande luce (cfr Is 8, 23-9, 1), la luce di Cristo e del suo Vangelo (cfr Mt 4, 12-16). Il termine "vangelo", ai tempi di Gesù, era usato dagli imperatori romani per i loro proclami. Indipendentemente dal contenuto, essi erano definiti "buone novelle", cioè annunci di salvezza, perché l'imperatore era considerato come il signore del mondo ed ogni suo editto come foriero di bene. Applicare questa parola alla predicazione di Gesù ebbe dunque un senso fortemente critico, come dire: Dio, non l'imperatore, è il Signore del mondo, e il vero Vangelo è quello di Gesù Cristo.
La "buona notizia" che Gesù proclama si riassume in queste parole: "Il regno di Dio - o regno dei cieli - è vicino" (Mt 4, 17; Mc 1, 15). Che significa questa espressione? Non indica certo un regno terreno delimitato nello spazio e nel tempo, ma annuncia che è Dio a regnare, che è Dio il Signore e la sua signoria è presente, attuale, si sta realizzando. La novità del messaggio di Cristo è dunque che Dio in Lui si è fatto vicino, regna ormai in mezzo a noi, come dimostrano i miracoli e le guarigioni che compie. Dio regna nel mondo mediante il suo Figlio fatto uomo e con la forza dello Spirito Santo, che viene chiamato "dito di Dio" (cfr Lc 11, 20). Dove arriva Gesù, lo Spirito creatore reca vita e gli uomini sono sanati dalle malattie del corpo e dello spirito. La signoria di Dio si manifesta allora nella guarigione integrale dell'uomo. Con ciò Gesù vuole rivelare il volto del vero Dio, il Dio vicino, pieno di misericordia per ogni essere umano; il Dio che ci fa dono della vita in abbondanza, della sua stessa vita. Il regno di Dio è pertanto la vita che si afferma sulla morte, la luce della verità che disperde le tenebre dell'ignoranza e della menzogna.
Preghiamo Maria Santissima, affinché ottenga sempre alla Chiesa la stessa passione per il Regno di Dio che animò la missione di Gesù Cristo: passione per Dio, per la sua signoria d'amore e di vita; passione per l'uomo, incontrato in verità col desiderio di donargli il tesoro più prezioso: l'amore di Dio, suo Creatore e Padre.
[Papa Benedetto, Angelus 27 gennaio 2008]
Chiamata: nuova Creazione e lavoro dedicato, si integrano
Cari fratelli e sorelle.
1. […] Carissimi, il trovarci qui, nell’Abbazia di Pomposa, dove - fin dal secolo IX - numerose persone vissero insieme, per porsi alla sequela esclusiva di Cristo, mi offre l’occasione per ricordare che ogni cristiano, e anche ognuno di voi, è chiamato a ripercorrere le tracce del Figlio di Dio.
Il lavoro ascetico e quello materiale dei monaci fu, infatti, sempre in funzione della crescita religiosa e umana anche delle popolazioni di questa zona. E la bellezza artistica dell’Abbazia esprime la verità, la libertà e la dignità dell’uomo che lavora cristianamente.
Qui ci è dato di constatare con chiarezza che il “lavoro non deve essere una pura necessità, ma deve essere considerato come autentica vocazione, una chiamata di Dio a costruire un mondo nuovo, nel quale coabitano la giustizia, la fratellanza, anticipo del regno di Dio, nel quale non vi saranno né carenze né limitazioni” (Discorso agli operai, 30 gennaio 1979).
2. Alcuni fra voi potrebbero chiedersi come sia possibile rendersi conto del dono sublime che è la vocazione a figli del Signore onnipotente. Molte sono le difficoltà, che l’uomo incontra nel riconoscere il disegno di Dio nella propria vita. Oltre l’amor proprio, che lo spinge a rinchiudersi in se stesso, fanno spesso da ostacolo le condizioni della vita sociale, frequentemente concepita e strutturata prescindendo da Dio, il quale - purtroppo - viene considerato da tanti come estraneo agli interessi autenticamente umani.
Eppure Cristo, che ha chiamato il santo abate Guido, san Pier Damiani, Guido d’Arezzo e i molti altri monaci, il nome dei quali non è a noi noto, rivolge ugualmente a voi il suo invito, perché nel vostro contesto di vita quotidiana e lavorativa possiate accogliere il suo invito a seguirlo.
Ci si potrebbe allora domandare: “Quale forma deve prendere la vocazione del fedele laico, che vive e opera nel mondo?”. Configurato a Cristo mediante il Battesimo, ogni credente è testimone della misericordia divina, che, come ha rigenerato noi, mediante noi ricrea ogni cosa, associandoci al disegno di “ricapitolare in Gesù tutte le cose” (Ef 1, 10).
In questa “nuova creazione” il cristiano è chiamato a lavorare con “il Verbo della vita” (1 Gv 1, 1). Nella condizione laicale che gli è propria, egli si pone con tenacia al proprio posto di lavoro, in terra o per mare, consapevole che, quanto sta compiendo, non è solamente cooperazione, ma unione con Cristo nella sua opera redentiva (cf. Gaudium et spes, 67).
3. La fede è dono e il credente, riconoscendo Dio come Padre, raggiunge la pienezza della propria umanità: egli, allora, sa vivere e morire, sa sperare, sa amare, diffondendo attorno a sé la serenità e la pace. Contribuisce, così, alla costruzione della nuova terra e dei nuovi cieli (1 Pt 3, 13).
Vi esorto, fratelli e sorelle carissimi, a non porre resistenze a Cristo, a non rifiutare il Verbo che si è fatto carne. Accoglietelo piuttosto senza riserve, perché attorno a lui tutta l’esistenza umana e il mondo intero sono chiamati a raccogliersi in unità e a rinnovarsi.
L’Abbazia, nella quale ci troviamo, mostra, nella sua storia, come questo sia possibile. Il monaco, infatti - ben sapendo che la dipendenza religiosa da Dio non porta alla morte, ma realizza la vita nella sua pienezza - a lui si consacra in modo esclusivo. Nel ritmo scandito dall’“Ora et labora”, egli loda il Signore e indica al mondo verso Chi ciascuno di noi deve volgere costantemente lo sguardo e la mente. Segue il Cristo nella povertà, nell’obbedienza e nella consacrazione verginale; a lui si offre in modo totale e definitivo. Anche il fedele laico vive di Cristo se con lui si intrattiene nella preghiera, se lo incontra nei sacramenti e se gli manifesta il proprio amore con l’osservanza dei comandamenti.
L’orazione, personale e liturgica, e l’impegno morale sono intimamente connessi all’amicizia con il Redentore e al compito apostolico, missionario che ne consegue.
Cari fratelli, sentitevi sempre in profonda comunione con quanti nei monasteri incessantemente lodano il Signore e, sostenuti anche dalla loro preghiera, portate frutti di santità con una condotta di vita irreprensibile in ogni momento della vostra esistenza.
4. Questa solidarietà spirituale dimostra che il lavoro e il tempo dedicato esclusivamente a Dio non si contrappongono, ma si integrano, come possiamo ben vedere già nell’“Ora et labora” dei monaci di san Benedetto. La devozione a Dio (l’“ora”) fonda la dedizione autentica (il “labora”) agli uomini e alla terra, che è loro dimora.
In qualsiasi settore si svolge la vostra attività, voi siete chiamati sempre ad essere testimoni ed evangelizzatori, vale a dire a rendere visibile il Cristo, che “è stato rappresentato al vivo dinanzi a voi” (cf. Gal 3, 1). Il lavoro sgorga dalla preghiera, come la carità fluisce dalla fede. L’aderire a Cristo e l’abbandonarsi fiducioso nelle sue mani generano una totale disponibilità alla volontà divina.
Inoltre il lavoro, pur faticoso, quando è compiuto in stretta unione con Cristo, fa amare la vita non più vista come sorgente di inquietudini, ma come palestra di virtù che forma alla serenità e alla pace.
5. Fratelli e sorelle, vi invito, infine, a offrire il vostro generoso apporto alla nuova evangelizzazione, di cui tanto ha bisogno la società contemporanea e a operare attivamente per la diffusione del Vangelo nei vostri ambienti di lavoro. Portate a tutti quella speranza e quella solidarietà cui ogni uomo incessantemente anela e che solo in Cristo è possibile trovare. Nutritevi, sempre, di Dio e di un amore concreto che parli di lui a quanti incontrate. Affido ciascuno alla Vergine Maria perché sappiate come lei ascoltare, accogliere e custodire il Verbo fatto carne.
La consapevolezza della materna presenza della Madre di Dio, sia per voi e per le vostre famiglie quotidiano conforto e stimolo a ben operare.
Ancora una volta vi ringrazio per questo invito, per questo incontro molto suggestivo. Qui sono sempre presenti con la loro ispirazione i monaci benedettini che ci hanno lasciato il santuario. Ma qui, nello stesso tempo, durante i secoli, ha vissuto e vive una popolazione che, di generazione in generazione, si distingue soprattutto per il lavoro agricolo e per la pesca. Tutto ciò costituisce una sintesi speciale, direi evangelica. Sappiamo bene come nel Vangelo siano presenti coloro che lavorano la terra così come i pescatori, persone predilette da Gesù, trasformate in apostoli.
Oggi il Papa, il successore di Pietro, che era uno di questi pescatori, viene per dire a voi pescatori e a voi lavoratori della terra: siete chiamati a essere apostoli, non cambiando la vostra professione e le condizioni della vostra vita, ma seguendo Cristo, secondo le parole semplici e profetiche dell’Abbazia benedettina, di san Benedetto: “Ora et labora”. Ecco il vostro metodo nell’apostolato, il più semplice e il più efficace. Vi auguro che questo “Ora et labora” diventi per voi programma quotidiano e, nonostante tutte le difficoltà della vita agricola e di quella del mare, vi renda anche sereni, felici e portatori del bene verso gli altri.
[Papa Giovanni Paolo II, discorso a Pomposa, 22 settembre 1990]
Inizio della missione pubblica. Apertura, non sforzo
Il Vangelo di oggi (cfr Mt 4,12-23) ci presenta l’inizio della missione pubblica di Gesù. Questo avvenne in Galilea, una terra di periferia rispetto a Gerusalemme, e guardata con sospetto per la mescolanza con i pagani. Da quella regione non ci si aspettava nulla di buono e di nuovo; invece, proprio lì Gesù, che era cresciuto a Nazaret di Galilea, incomincia la sua predicazione.
Egli proclama il nucleo centrale del suo insegnamento sintetizzato nell’appello: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (v. 17). Questo annuncio è come un potente fascio di luce che attraversa le tenebre e fende la nebbia, ed evoca la profezia di Isaia che si legge nella notte di Natale: «Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che camminavano in terra tenebrosa una luce rifulse» (9,1). Con la venuta di Gesù, luce del mondo, Dio Padre ha mostrato all’umanità la sua vicinanza e amicizia. Esse ci sono donate gratuitamente al di là dei nostri meriti. La vicinanza di Dio e l’amicizia di Dio non sono un merito nostro: sono un dono gratuito di Dio. Noi dobbiamo custodire questo dono.
L’appello alla conversione, che Gesù rivolge a tutti gli uomini di buona volontà, si comprende in pienezza proprio alla luce dell’evento della manifestazione del Figlio di Dio, su cui abbiamo meditato nelle scorse domeniche. Tante volte risulta impossibile cambiare vita, abbandonare la strada dell’egoismo, del male, abbandonare la strada del peccato perché si incentra l’impegno di conversione solo su sé stessi e sulle proprie forze, e non su Cristo e il suo Spirito. Ma la nostra adesione al Signore non può ridursi ad uno sforzo personale, no. Credere questo anche sarebbe un peccato di superbia. La nostra adesione al Signore non può ridursi ad uno sforzo personale, deve invece esprimersi in un’apertura fiduciosa del cuore e della mente per accogliere la Buona Notizia di Gesù. È questa – la Parola di Gesù, la Buona Notizia di Gesù, il Vangelo – che cambia il mondo e i cuori! Siamo chiamati, pertanto, a fidarci della parola di Cristo, ad aprirci alla misericordia del Padre e lasciarci trasformare dalla grazia dello Spirto Santo.
È da qui che comincia il vero percorso di conversione. Proprio come è capitato ai primi discepoli: l’incontro con il Maestro divino, col suo sguardo, con la sua parola ha dato loro la spinta a seguirlo, a cambiare vita mettendosi concretamente al servizio del Regno di Dio.
L’incontro sorprendente e decisivo con Gesù ha dato inizio al cammino dei discepoli, trasformandoli in annunciatori e testimoni dell’amore di Dio verso il suo popolo. Ad imitazione di questi primi araldi e messaggeri della Parola di Dio, ciascuno di noi possa muovere i passi sulle orme del Salvatore, per offrire speranza a quanti ne sono assetati.
La Vergine Maria, alla quale ci rivolgiamo in questa preghiera dell’Angelus, sostenga questi propositi e li avvalori con la sua materna intercessione.
[Papa Francesco, Angelus 26 gennaio 2020]
Crisi, Buona Novella e aspetto sociale
Superlavoro Missione Famiglia, da squilibrati
(Mc 3,20-21)
Il breve Vangelo di oggi può essere interpretato secondo diversi piani di lettura: iniziamo con un approccio vocazionale.
La famiglia nucleo della società dovrebbe configurarsi anche come un trampolino di lancio verso l’avventura di Fede che sollecita altri legami.
I consanguinei possono rimanere costernati dal nostro desiderio di darsi interamente a Dio nei fratelli.
E a volte gli affetti e i vincoli naturali possono impedire l’adempimento della Missione cui siamo chiamati.
Talora, anche importanti impegni nell’azione della Chiesa rimangono a metà o del tutto frustrati - causa un “debole” e impedimenti che non riusciamo a ‘tagliare’.
Veniamo al livello storico.
Gesù ha avuto bei problemi anche in casa sua, ma il brano di Vangelo si riferisce alla Chiesa nascente nella dimora di Pietro a Cafarnao, vicinissima alla Sinagoga.
Nel tempo, le due realtà quasi adiacenti si sono trovate a fronteggiarsi aspramente.
Eppure nella Dimora di Pietro a un certo punto esplode il numero dei provenienti dal giudaismo, nonché pagani, che si convertivano alla proposta del Signore.
Il Popolo stesso e la cultura religiosa che hanno generato Cristo [la sua «Famiglia»] faceva fatica a interrogarsi. E la prima reazione è stata di rifiuto.
Quella nuova porzione della stirpe giudaica che riconosceva Gesù Messia sembrava volesse fare sempre più di testa sua.
Aspetto sociale:
Effettivamente il focolare e il clan propri si erano allarmati, perché Gesù adulto non seguiva un comportamento da sottomesso.
Così i parenti decidono di riportarlo a forza (cf. vv.31-35) considerandolo uno squilibrato che logorava i loro rapporti interni e le relazioni con autorità sul territorio.
Ma le convinzioni ormai cristallizzate nella Sinagoga - nonché il portato teologico e ‘cordiale’ di tutta la sua realtà di compromesso - non sembravano più vitali. Perché?
Il sistema imperiale impiantato in Galilea aveva debilitato il senso di condivisione e fraternità. Chiusure rafforzate dalla religiosità dell’epoca.
L’osservanza sempre più accentuata delle norme di purezza era un fattore di grave emarginazione sociale e culturale.
Intere fasce di popolazione erano escluse dal rapporto con Dio: proprio quelle più bisognose di speranza, e di un ‘volto’.
Invece che promuovere accoglienza e partecipazione, le norme devote addirittura favorivano separazioni ed esclusioni.
Struttura politica, economica e sociale, e ideologia sacra, cospiravano a favore dell’indebolimento dei valori centrali dello spirito di comunione.
Nel passo di Vangelo di oggi si nota appunto come i limiti stretti della famiglia andassero a confliggere con la proposta del nuovo Rabbi, di recuperare l’afflato solidale.
Era insomma nella Casa di Pietro che la piccola famiglia acquisiva respiro, aprendosi non solo alla Nazione, bensì alla più ampia Famiglia umana.
Assemblea integrale, anche di donne e malfermi, o incerti e lontani.
Realtà assolutamente nuova; non più radunata per il culto ma incapace di fare ‘convivenza’.
[Sabato 2.a sett. T.O. 24 gennaio 2026]
Crisi e aspetto sociale
Superlavoro Missione Famiglia, da squilibrati
(Mc 3,20-21)
«E viene in Casa; e di nuovo si riunisce la folla, così che essi non potevano neppure mangiare Pane. E avendo udito, i suoi [i presso di lui] uscirono per prenderlo, perché dicevano: È fuori di sé».
Il breve Vangelo di oggi può essere interpretato secondo diversi piani di lettura: iniziamo con un approccio vocazionale.
La famiglia è nucleo della società di tutti i tempi, ma Cristo e il credente sanno che essa non deve costituire una gabbia.
Piuttosto dovrebbe configurarsi quale trampolino di lancio verso l’avventura della Fede, che sollecita altri legami.
La vita nello Spirito ci attiva per la costruzione del Centuplo, nella grande famiglia ecclesiale e umana.
I consanguinei possono rimanere costernati dal nostro desiderio di darsi interamente a Dio nei fratelli.
Di fronte all'attività estenuante si mettono in apprensione, perché procediamo sempre controcorrente… quindi i parenti stretti si preoccupano della nostra salute, o dell’onore di casa.
A volte, affetti e vincoli naturali possono impedire l’adempimento della Missione cui siamo chiamati.
Certo, quando a non capire sono proprio coloro da cui ci si aspetta più aiuto, la sofferenza si fa grande.
Talora, anche importanti impegni nell’azione della Chiesa rimangono a metà o del tutto frustrati - causa affetti e impedimenti che non riusciamo a tagliare.
Veniamo al livello storico.
Gesù ha avuto bei problemi anche in casa sua, ma il brano di Vangelo si riferisce alla Chiesa nascente nella dimora di Pietro a Cafarnao.
Realtà più istintiva e meno “qualificata”, però vicinissima alla tradizionale casa di preghiera [sinagoga] del luogo, collocata sulla medesima stradina perpendicolare al lago, appena poco più in alto.
Nel tempo, le due realtà quasi adiacenti si sono trovate a fronteggiarsi aspramente nella teologia - sino a competere perfino sul piano architettonico, come ben sanno gli archeologi.
La più “nobile” e antica delle due accusava l’altra di essere una sradicata - quindi inaccettabile, eccentrica per le sacre consuetudini identitarie del popolo eletto.
Eppure nella Dimora di Pietro a un certo punto esplode il numero dei provenienti dal giudaismo, nonché pagani che si convertono alla proposta del Signore.
Così la prima comunità dei credenti nel Signore inizia a essere forse più più corposa dell’assemblea in Sinagoga, a pochi passi.
Il Popolo stesso e la cultura religiosa che hanno generato Cristo [la sua «Famiglia»] faceva fatica a interrogarsi. E la prima reazione è di rifiuto.
Quella porzione della stirpe giudaica che riconosceva Gesù Messia sembrava volesse fare sempre più di testa sua.
Aspetto sociale:
Effettivamente il focolare e il clan propri si erano allarmati, perché Gesù adulto non seguiva un comportamento da sottomesso.
Comprometteva il nome del suo casato, spendeva energie per gli altri - sino a sfinire… assurdamente in favore di estranei, forse “nemici” della nazione giudaica.
Così i parenti decisero di riportarlo a forza (vv.31-35) considerandolo uno squilibrato che logorava i rapporti interni e le relazioni dell’intera dinastia con le autorità sul territorio.
Ma sappiamo che allargando il legame di “sangue” a coloro che ascoltano, Gesù non permise che fossero valutazioni esterne ad allontanarlo dal suo compito.
Vediamo quale era la situazione.
Nell’antico Israele il senso di comunità e il clan costituivano la base della convivenza. L’obbiettivo della Legge era: «Non vi sarà alcun bisognoso in mezzo a voi» (Dt 15,4).
E come i grandi profeti, Cristo e i suoi intimi hanno tentato di rafforzare il senso di condivisione, tornando allo spirito profondo di ciò che un tempo erano articolazioni della coesistenza.
Appunto: clan, focolare, comunità - espressioni dell’amore di Dio che si manifesta.
La “grande Famiglia” assicurava protezione alle famiglie particolari e alle persone meno abbienti.
Essa era garanzia di proprietà della terra; quindi dava senso di libertà - e si faceva veicolo della possibilità di aderire alla propria tradizione.
Oltre che difesa di carattere culturale, era nella vita comunitaria che la gente di quell’epoca esprimeva lo spirito di solidarietà concreta.
Anche per Cristo, difendere il clan, il suo bagaglio spirituale, la sua azione fraterna... era difendere la stessa Alleanza.
Ma la Casa di Pietro [la Chiesa nascente] iniziava a sopravanzare tutta la realtà antica.
Le convinzioni ormai cristallizzate nella Sinagoga, nonché il portato teologico e benevolo di tutta la sua verità di compromesso - non sembravano più vitali. Perché?
Il sistema imperiale impiantato in Galilea aveva debilitato il senso di comunione larga e minuta, appunto di clan e focolare.
Erode il Grande - morto a Gerico nel 4 a.C. - e suo figlio Erode Antipa (37a.C.-39d.C.) avevano portato le famiglie a un livello di crisi tale da dover badare a se stesse e chiudersi nelle necessità più impellenti.
Le imposte da pagare al governo e al tempio erano sempre più esose, il che accentuava l’indebitamento.
Qua e là la mentalità ellenista s’insinuava con tratti d’individualismo prima sconosciuti alla mentalità semitica.
Il dovere imposto di accogliere le soldatesche e dare loro ospitalità in casa dove facevano quello che volevano anche sulle donne, e le frequenti minacce di repressione violenta, obbligavano la gente a dover badare a problemi di sopravvivenza.
Tutto ciò induceva alla chiusura, al ripiegamento sulle proprie necessità immediate.
Si praticava sempre meno l'ospitalità, la condivisione dei beni, quella della mensa, e l’asilo dei marginali. Espressioni di fraternità e cura in cui già i primi cristiani erano campioni.
In tal guisa, le chiusure erano rafforzate dalla religiosità dell’epoca.
L’osservanza sempre più accentuata delle norme di purezza costituiva un fattore di grave emarginazione sociale e culturale.
Intere fasce di popolazione venivano escluse dal rapporto con Dio: proprio quelle più bisognose di speranza, e di un volto.
Invece che promuovere accoglienza e compartecipazione, le norme devote addirittura favorivano separazioni ed esclusioni [in particolare: tutte le donne, i bambini, stranieri, malati o impediti...].
Struttura politica, economica e sociale, e ideologia sacra, cospiravano a favore dell’indebolimento dei valori centrali dello spirito, e la pratica di mettere in comune.
Nel passo di Vangelo di oggi si nota appunto come i limiti stretti della famiglia nucleare andassero a confliggere con la proposta del nuovo Rabbi: di recuperare l’afflato unitivo, sia in senso largo che di dettaglio.
Era insomma nella Casa di Pietro che la piccola famiglia acquisiva respiro, aprendosi non solo alla Nazione, bensì alla più ampia Famiglia della Comunità umana.
Assemblea integrale, anche di donne e malfermi, o incerti e lontani.
Realtà assolutamente nuova, non più radunata per il culto ma incapace di fare convivenza.
Pace che scaturisce dalla verità
Quando Gesù, nel periodo trascorso sulla terra, si spostava di villaggio in villaggio predicando la Buona Novella di verità e di amore, catturava l'attenzione di quanti lo ascoltavano. Diversamente dagli Scribi, che venivano rifiutati a causa della loro ipocrisia, ci viene detto che il Signore stupiva perché "insegnava loro come uno che ha autorità" (Mc, 1, 22). Infatti, ogni comunità umana ha bisogno, e quindi ne va alla ricerca, di responsabili forti ed ispiratori che guidino gli altri lungo un cammino di speranza […]
Nessuno può esimersi da questo processo. Sebbene nessuna cultura possa utilizzare i danni subiti in passato come pretesto per evitare di affrontare le difficoltà insite nel soddisfacimento delle esigenze sociali contemporanee del proprio popolo, è anche vero che solo attraverso la disponibilità ad accettare la verità storica è possibile acquisire una sana comprensione della realtà contemporanea e aderire alla visione di un futuro armonioso […]
L'impegno per la verità apre la via alla riconciliazione duratura attraverso un processo di guarigione che implica il chiedere e il concedere il perdono, due indispensabili elementi di pace. In tal modo, la nostra memoria viene purificata, il nostro cuore reso sereno e il nostro futuro riempito di una speranza ben fondata sulla pace che scaturisce dalla verità.
[Papa Benedetto, Lettera per il XX anniversario della visita di Giovanni Paolo II in Australia, 22 settembre 2006]
Pienezza di Rivelazione, Spirito principio di vita e Maestro interiore
1. La vita spirituale ha bisogno di illuminazione e di guida. Per questo Gesù, nel fondare la Chiesa e nel mandare gli Apostoli nel mondo, ha affidato loro il compito di ammaestrare tutte le genti, come leggiamo nel Vangelo secondo Matteo (Mt 28, 19-20), ma anche di “predicare il Vangelo a tutta la creazione”, come dice il testo canonico del Vangelo di Marco (Mc 16, 15). Anche San Paolo parla dell’apostolato come di una “illuminazione di tutti” (Ef 3, 9).
Ma quest’opera della Chiesa evangelizzatrice e docente appartiene al ministero degli Apostoli e dei loro successori e, a titolo diverso, a tutti i membri della Chiesa, per continuare per sempre l’opera di Cristo “unico Maestro” (Mt 23, 8), che ha portato all’umanità la pienezza della rivelazione di Dio. Rimane la necessità di un Maestro interiore, che faccia penetrare nello spirito e nel cuore degli uomini l’insegnamento di Gesù. È lo Spirito Santo, che Gesù stesso chiama “Spirito di verità”, e che promette come Colui che guiderà verso tutta la verità (cf. Gv 14, 17; 16, 13). Se Gesù ha detto di sé: “Io sono la verità” (Gv 14, 6), è questa verità di Cristo che lo Spirito Santo fa conoscere e diffonde: “Non parlerà di sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito . . . prenderà del mio e ve l’annunzierà” (Gv 16, 13-14). Lo Spirito è Luce dell’anima: “Lumen cordium”, come lo invochiamo nella Sequenza di Pentecoste.
2. Lo Spirito Santo è stato Luce e Maestro interiore per gli Apostoli che dovevano conoscere Cristo in profondità per poter assolvere il compito di suoi evangelizzatori. Lo è stato e lo è per la Chiesa, e, nella Chiesa, per i credenti di tutte le generazioni e in modo particolare per i teologi e i maestri di spirito, per i catechisti e i responsabili di comunità cristiane. Lo è stato e lo è anche per tutti coloro che, dentro e fuori dei confini visibili della Chiesa, vogliono seguire le vie di Dio con cuore sincero, e senza loro colpa non trovano chi li aiuti a decifrare gli enigmi dell’anima e a scoprire la verità rivelata. Voglia il Signore concedere a tutti i nostri fratelli - milioni e anzi miliardi di uomini - la grazia del raccoglimento e della docilità allo Spirito Santo in momenti che possono essere decisivi nella loro vita.
Per noi cristiani il magistero intimo dello Spirito Santo è una gioiosa certezza, fondata sulla parola di Cristo circa la venuta dell’“altro Paraclito”, che - diceva - “il Padre manderà nel mio nome. Egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto” (Gv 14, 26). “Egli vi guiderà verso tutta la verità” (Gv 16, 13).
3. Come risulta da questo testo, Gesù non affida la sua parola soltanto alla memoria dei suoi uditori: questa memoria sarà aiutata dallo Spirito Santo, che ravviverà continuamente negli apostoli il ricordo degli eventi e il senso dei misteri evangelici.
Di fatto, lo Spirito Santo ha guidato gli Apostoli nella trasmissione della parola e della vita di Gesù, ispirando sia la loro predicazione orale e i loro scritti, sia la redazione dei Vangeli, come abbiamo visto a suo tempo nella catechesi sullo Spirito Santo e la rivelazione.
Ma è ancora Lui che ai lettori della Scrittura dà l’aiuto per capire il significato divino incluso nel testo di cui Egli stesso è l’ispiratore e l’autore principale: Lui solo può far conoscere “le profondità di Dio” (1 Cor 2, 10), quali sono contenute nel testo sacro; Lui che è stato mandato per istruire i discepoli sugli insegnamenti del loro Maestro (cf. Gv 16, 13).
4. Di questo intimo magistero dello Spirito Santo ci parlano gli Apostoli stessi, primi trasmettitori della parola di Cristo. Scrive San Giovanni: “Ora voi avete l’unzione ricevuta dal Santo (Cristo) e tutti siete ammaestrati. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna viene dalla verità” (1 Gv 2, 20-21). Secondo i Padri della Chiesa e la maggioranza degli esegeti moderni, questa “unzione” (chrisma) designa lo Spirito Santo. San Giovanni afferma anzi che coloro che vivono secondo lo Spirito non hanno bisogno di altri maestri: “Quanto a voi - egli scrive - l’unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno che alcuno vi ammaestri; ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa, è veritiera e non mentisce, così state saldi in Lui, come essa vi insegna” (1 Gv 2, 27).
Anche l’apostolo Paolo parla di una comprensione secondo lo Spirito, che non è frutto di sapienza umana, ma di illuminazione divina: “L’uomo naturale (psichicòs) non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follie per lui, e non è capace di intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L’uomo spirituale (pneumaticòs) invece giudica ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno” (1 Cor 2, 14-15).
Dunque i cristiani, avendo ricevuto lo Spirito Santo, unzione di Cristo, possiedono in se stessi una fonte di conoscenza della verità, e lo Spirito Santo è il Maestro sovrano che li illumina e guida.
5. Se sono docili e fedeli al suo magistero divino, lo Spirito Santo li preserva dall’errore rendendoli vittoriosi nel continuo conflitto tra “spirito della verità” e “spirito dell’errore” (cf. 1 Gv 4, 6). Lo spirito dell’errore, che non riconosce Cristo (cf. 1 Gv 4, 3), viene sparso dai “falsi profeti”, sempre presenti nel mondo, anche in mezzo al popolo cristiano, con un’azione ora scoperta e persino clamorosa, ora subdola e strisciante. Come Satana, anch’essi a volte si rivestono da “angeli di luce” (cf. 2 Cor 11, 14) e si presentano con apparenti carismi di ispirazione profetica e apocalittica. Questo avveniva già nei tempi apostolici. Perciò San Giovanni avverte: “Non prestate fede a ogni ispirazione, ma mettete alla prova le ispirazioni, per saggiare se provengono veramente da Dio, perché molti falsi profeti sono comparsi nel mondo” (1 Gv 4, 1). Lo Spirito Santo, come ha ricordato il Concilio Vaticano II (cf. Lumen gentium, 12), protegge il cristiano dall’errore facendogli discernere ciò che è genuino da ciò che è spurio. Da parte del cristiano, ci vorranno sempre buoni criteri di discernimento circa le cose che ascolta o legge in materia di religione, di Sacra Scrittura, di manifestazioni del soprannaturale ecc. Tali criteri sono la conformità al Vangelo, perché lo Spirito Santo non può non “prendere da Cristo”; la sintonia con l’insegnamento della Chiesa, fondata e mandata da Cristo a predicare la sua verità; la rettitudine della vita di chi parla o scrive; i frutti di santità derivanti da ciò che viene presentato o proposto.
6. Lo Spirito Santo insegna al cristiano la verità come principio di vita. Mostra l’applicazione concreta delle parole di Gesù nella vita di ognuno. Fa scoprire l’attualità del Vangelo e il suo valore per tutte le situazioni umane. Adatta l’intelligenza della verità ad ogni circostanza, affinché questa verità non rimanga soltanto astratta e speculativa, e liberi il cristiano dai pericoli della doppiezza e dell’ipocrisia.
Per questo lo Spirito Santo illumina ciascuno personalmente, per guidarlo nel suo comportamento, indicandogli la via da seguire, aprendogli almeno qualche spiraglio sul progetto del Padre circa la sua vita. È la grande grazia di luce che San Paolo chiedeva per i Colossesi: “l’intelligenza spirituale”, capace di far loro capire la volontà divina. Li assicurava infatti: “Non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate una piena conoscenza della sua (di Dio) volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona . . .” (Col 1, 9-10). Per noi tutti è necessaria questa grazia di luce, per conoscere bene la volontà di Dio su di noi e per essere in grado di vivere pienamente la nostra vocazione personale.
Non mancano mai i problemi, che a volte sembrano insolubili. Ma lo Spirito Santo soccorre nelle difficoltà ed illumina. Egli può rivelare la soluzione divina, come al momento dell’Annunciazione per il problema della conciliazione della maternità col desiderio di conservare la verginità. Anche quando non si tratti di un mistero unico come quello dell’intervento di Maria nell’Incarnazione del Verbo, si può dire che lo Spirito Santo possiede un’inventiva infinita, propria della mente divina, che sa provvedere a sciogliere i nodi delle vicende umane anche più complesse e impenetrabili.
7. Tutto ciò viene concesso e operato nell’anima dallo Spirito Santo mediante i suoi doni, grazie ai quali è possibile praticare un buon discernimento non secondo i criteri della sapienza umana, che è stoltezza davanti a Dio, ma di quella divina, che può sembrare stoltezza agli occhi degli uomini (cf. 1 Cor 1, 18.25). In realtà solo lo Spirito “scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio” (1 Cor 2, 10-11). E se vi è opposizione fra lo spirito del mondo e lo Spirito di Dio, Paolo rammenta ai cristiani: “Noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato” (1 Cor 2, 12). A differenza dell’“uomo naturale”, quello “spirituale” (pneumaticòs) è sinceramente aperto allo Spirito Santo, docile e fedele alle sue ispirazioni (cf. 1 Cor 2, 14-16). Perciò egli ha abitualmente la capacità di un retto giudizio sotto la guida della sapienza divina.
8. Un segno del reale contatto con lo Spirito Santo nel discernimento è e sarà sempre l’adesione alla verità rivelata come viene proposta dal magistero della Chiesa. Il Maestro interiore non ispira il dissenso, la disubbidienza, o anche solo la resistenza ingiustificata ai pastori e maestri stabiliti da Lui stesso nella Chiesa (cf. At 20, 29). All’autorità della Chiesa, come dice il Concilio nella costituzione Lumen gentium, spetta “di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono (cf. 1 Ts 5, 12.19-21)” (Lumen gentium, 12). È la linea di sapienza ecclesiale e pastorale che viene, anch’essa, dallo Spirito Santo.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 24 aprile 1991]
Segni dei tempi
«I tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente». Papa Francesco ha ripetuto più volte questo invito al cambiamento, durante la messa celebrata venerdì mattina, 23 ottobre, nella cappella di Casa Santa Marta. Un invito ad agire «senza paura» e «con libertà», tenendosi alla larga dai conformismi tranquillizzanti e restando «saldi nella fede in Gesù» e «nella verità del Vangelo», ma muovendosi «continuamente secondo i segni dei tempi».
Lo spunto per la riflessione è stato offerto al Pontefice dalle letture di questa ultima parte dell’anno liturgico, che propongono in particolare la lettera ai Romani. «Abbiamo sottolineato — ha ricordato in proposito — come Paolo predica con tanta forza, la libertà che noi abbiamo in Cristo». Si tratta, ha spiegato il Papa, di «un dono, il dono della libertà, di quella libertà che ci ha salvato dal peccato, che ci ha fatto liberi, figli di Dio come Gesù; quella libertà che ci porta a chiamare Dio Padre». Quindi Francesco ha aggiunto che «per avere questa libertà dobbiamo aprirci alla forza dello Spirito e capire bene cosa accade dentro di noi e fuori di noi». E se nei «giorni passati, la settimana scorsa», ci si era soffermati «su come distinguere quello che succede dentro di noi: cosa viene dal buono Spirito o cosa non viene da lui», ovvero sul discernimento di quanto «succede dentro di noi», nella liturgia del giorno il brano del Vangelo di Luca (12, 54-59) esorta a «guardare fuori», facendo «riflettere su come noi valutiamo le cose che accadono fuori di noi».
Ecco allora la necessità di interrogarci su «come giudichiamo: siamo capaci di giudicare?». Per il Papa «le capacità le abbiamo» e lo stesso Paolo «ci dice che noi giudicheremo il mondo: noi cristiani giudicheremo il mondo». Anche l’apostolo Pietro dice una cosa analoga quando «ci chiama stirpe scelta, sacerdozio santo, nazione eletta proprio per la santità».
Insomma, ha chiarito il Pontefice, noi cristiani «abbiamo questa libertà di giudicare quello che succede fuori di noi». Ma — ha avvertito — «per giudicare dobbiamo conoscere bene quello che accade fuori di noi». E allora, si è domandato Francesco, «come si può fare questo, che la Chiesa chiama “conoscere i segni dei tempi”?».
In proposito il Papa ha osservato che «i tempi cambiano. È proprio della saggezza cristiana conoscere questi cambiamenti, conoscere i diversi tempi e conoscere i segni dei tempi. Cosa significa una cosa e cosa un’altra». Certo, il Papa è consapevole che ciò «non è facile. Perché noi sentiamo tanti commenti: “Ho sentito che quello che è accaduto là è questo o quello che accade là è l’altro; ho letto questo, mi hanno detto questo...». Però, ha subito aggiunto, «io sono libero, io devo fare il mio proprio giudizio e capire cosa significhi tutto ciò». Mentre «questo è un lavoro che di solito noi non facciamo: ci conformiamo, ci tranquillizziamo con “mi hanno detto; ho sentito; la gente dice; ho letto...”. E così siamo tranquilli». Quando invece dovremmo chiederci: «Qual è la verità? Qual è il messaggio che il Signore vuole darmi con quel segno dei tempi?».
Come di consueto il Papa ha anche proposto suggerimenti pratici «per capire i segni dei tempi». Anzitutto, ha detto, «è necessario il silenzio: fare silenzio e guardare, osservare. E dopo riflettere dentro di noi. Un esempio: perché ci sono tante guerre adesso? Perché è successo qualcosa? E pregare». Dunque «silenzio, riflessione e preghiera. Soltanto così potremo capire i segni dei tempi, cosa Gesù vuol dirci».
E in questo senso non ci sono alibi. Sebbene infatti ognuno di noi possa essere tentato di dire: «Ma, io non ho studiato tanto... Non sono andato all’università e neppure alla scuola media...», le parole di Gesù non lasciano spazio ai dubbi. Egli infatti non dice: «Guardate come fanno gli universitari, guardate come fanno i dottori, guardate come fanno gli intellettuali...». Al contrario, dice: «Guardate ai contadini, ai semplici: loro, nella loro semplicità, sanno capire quando arriva la pioggia, come cresce l’erba; sanno distinguere il grano dalla zizzania». Di conseguenza «quella semplicità — se viene accompagnata dal silenzio, dalla riflessione e dalla preghiera — ci farà capire i segni dei tempi». Perché, ha ribadito, «i tempi cambiano e noi cristiani dobbiamo cambiare continuamente. Dobbiamo cambiare saldi nella fede in Gesù Cristo, saldi nella verità del Vangelo, ma il nostro atteggiamento deve muoversi continuamente secondo i segni dei tempi».
Al termine della sua riflessione il Pontefice è ritornato sui pensieri iniziali. «Siamo liberi — ha affermato — per il dono della libertà che ci ha dato Gesù Cristo. Ma il nostro lavoro è esaminare cosa succede dentro di noi, discernere i nostri sentimenti, i nostri pensieri; e analizzare cosa accade fuori di noi, discernere i segni dei tempi». Come? «Col silenzio, con la riflessione e con la preghiera», ha ripetuto a conclusione dell’omelia.
[Papa Francesco, s. Marta, in L’Osservatore Romano 24/10/2015]
Pescatori, Conversione, Regno vicino. Felicità non scadente
L’asse è stare con Lui
Chiama a Sé e ‘fa’ i Dodici: emergenza grande, per piccolo Nome
(Mc 3,13-19)
In Cristo, medico dell'umanità sofferente, le cose dell’anima sembrano diverse, e così le relazioni.
Tutto questo porta il suo gruppo a una differente visione di sé, della storia, del mondo, delle moltitudini (vv.7-9) e dei problemi.
L’asse è stare con Lui (v.14) ossia formare Chiesa in Lui. Infatti è fondamentale prima maturare, ovunque viviamo.
Chi coltiva molte brame, le proietta; procura i suoi stessi influssi torbidi. Per questo è necessaria la riflessone; quella critica, che scava davvero.
Essa trasmette il senso del nostro scendere in campo, e una retta disposizione.
Lo stare con Gesù annienta le infedeltà che non proponendo semplicità di vita e valori dello spirito, allontanano, edificando altri templi e santuari.
La carica di universalità contenuta nel radicamento ai valori trasmesso dal dialogo con Lui, c’interroga; nelle relazioni così come nella conoscenza di sé.
Comprendiamo che… stimoli, flessioni, princìpi virtuosi, lacune, lati nascosti, traguardi e momenti-no sono aspetti energetici complementari.
Sembra un paradosso, ma l’apertura ai bisogni delle moltitudini resta un problema squisitamente non esteriore.
È da se stessi e a partire dalla comunità già variegata che si guarda il mondo, sapendone recuperare i lati opposti.
È la Via dell’Interno che compenetra la via dell’esterno.
È la strada intima a poter combattere il potere del male che soffoca gli aneliti di vita e annienta le personalità.
Bisogna anzitutto guarire ciò ch’è essenziale e prossimo.
Certo, chi non accetta il rischio, non può essere missionario; chi non è inserito fra i poveri, non conosce il loro mondo.
Ma chi non è ‘fatto’ libero [v.14: «fece Dodici»] non può liberare (v.15).
Chi non è formato non può educare; non può ‘rifare la storia dall’inizio’.
Unico modo poi di scrutare lontano e senza confini è ‘attenersi alla ragione delle cose’.
Principio che si conosce in Cristo Logos e solo se non fuorviati dalla superficialità delle riduzioni.
Intesa in Dio la natura delle creature, e conformandovisi, tutti vengono ispirati a trasmutare e completarsi, senza forzature alienanti.
Esercitando una pratica di ‘bontà anche con se stessi’.
Per capire questo e avvicinarsi al senso della loro Unicità missionale, il Figlio stesso deve salire su «‘il’ Monte» (v.13), assimilandosi alla Visione del Padre.
Nessuno degli apostoli era per sé degno della Chiamata.
Gran parte di loro ha nomi tipici del giudaismo, addirittura del tempo dei patriarchi - il che indica un’estrazione culturale e spirituale radicata più nella religione comune che nella Fede personale; non facile da gestire.
Eppure fatti suoi ‘intimi, per Nome’ - catena che ha unito il Cielo con il destino della loro missione sanante, ormai senza steccati.
Annuncio di nuova Luce accolta in Dono: dove appunto non appare una sola forma o un solo colore.
Per un contagio non allarmistico né unilaterale, ma florido, poliedrico, talora “nascosto” - e inquieto.
[Venerdì 2.a sett. T.O. 23 gennaio 2026]
In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)
Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))
Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello di accoglienza della misericordia di Dio e lasciarne intravedere i meravigliosi effetti nella propria esistenza (Papa Benedetto)
Man is involved in penance in his totality of body and spirit: the man who has a body in need of food and rest and the man who thinks, plans and prays; the man who appropriates and feeds on things and the man who makes a gift of them; the man who tends to the possession and enjoyment of goods and the man who feels the need for solidarity that binds him to all other men [CEI pastoral note]
Nella penitenza è coinvolto l'uomo nella sua totalità di corpo e di spirito: l'uomo che ha un corpo bisognoso di cibo e di riposo e l'uomo che pensa, progetta e prega; l'uomo che si appropria e si nutre delle cose e l'uomo che fa dono di esse; l'uomo che tende al possesso e al godimento dei beni e l'uomo che avverte l'esigenza di solidarietà che lo lega a tutti gli altri uomini [nota pastorale CEI]
St John Chrysostom urged: “Embellish your house with modesty and humility with the practice of prayer. Make your dwelling place shine with the light of justice; adorn its walls with good works, like a lustre of pure gold, and replace walls and precious stones with faith and supernatural magnanimity, putting prayer above all other things, high up in the gables, to give the whole complex decorum. You will thus prepare a worthy dwelling place for the Lord, you will welcome him in a splendid palace. He will grant you to transform your soul into a temple of his presence” (Pope Benedict)
San Giovanni Crisostomo esorta: “Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà con la pratica della preghiera. Rendi splendida la tua abitazione con la luce della giustizia; orna le sue pareti con le opere buone come di una patina di oro puro e al posto dei muri e delle pietre preziose colloca la fede e la soprannaturale magnanimità, ponendo sopra ogni cosa, in alto sul fastigio, la preghiera a decoro di tutto il complesso. Così prepari per il Signore una degna dimora, così lo accogli in splendida reggia. Egli ti concederà di trasformare la tua anima in tempio della sua presenza” (Papa Benedetto)
And He continues: «Think of salvation, of what God has done for us, and choose well!». But the disciples "did not understand why the heart was hardened by this passion, by this wickedness of arguing among themselves and seeing who was guilty of that forgetfulness of the bread" (Pope Francis)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.