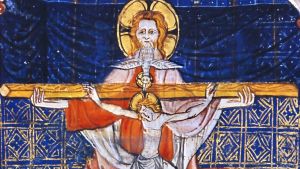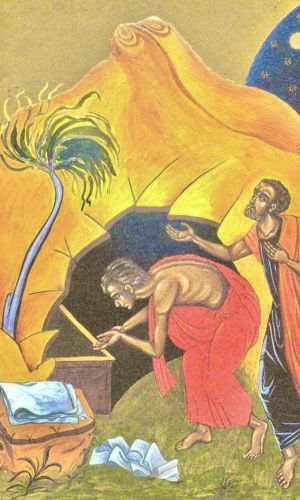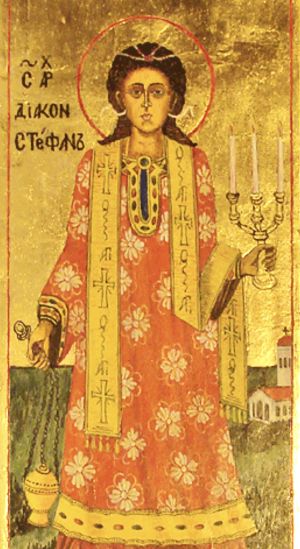don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Permesso, Grazie, Scusa
La liturgia ci invita a fissare lo sguardo sulla Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. È bello riflettere sul fatto che il Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come tutti i bambini, del calore di una famiglia. Proprio per questo, perché è la famiglia di Gesù, quella di Nazaret è la famiglia-modello, in cui tutte le famiglie del mondo possono trovare il loro sicuro punto di riferimento e una sicura ispirazione. A Nazaret è germogliata la primavera della vita umana del Figlio di Dio, nel momento in cui Egli è stato concepito per opera dello Spirito Santo nel grembo verginale di Maria. Tra le mura ospitali della Casa di Nazaret si è svolta nella gioia l’infanzia di Gesù, circondato dalle premure materne di Maria e dalla cura di Giuseppe, nel quale Gesù ha potuto vedere la tenerezza di Dio (cfr Lett. apost. Patris corde, 2).
Ad imitazione della Sacra Famiglia, siamo chiamati a riscoprire il valore educativo del nucleo familiare: esso richiede di essere fondato sull’amore che sempre rigenera i rapporti aprendo orizzonti di speranza. In famiglia si potrà sperimentare una comunione sincera quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono seri, profondi e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana del vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio. In questo modo, la famiglia si apre alla gioia che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con gioia. Al tempo stesso, trova l’energia spirituale di aprirsi all’esterno, agli altri, al servizio dei fratelli, alla collaborazione per la costruzione di un mondo sempre nuovo e migliore; capace, perciò, di farsi portatrice di stimoli positivi; la famiglia evangelizza con l’esempio di vita. È vero, in ogni famiglia ci sono dei problemi, e a volte anche si litiga. “Padre, ho litigato…” – siamo umani, siamo deboli, e tutti abbiamo a volte questo fatto che litighiamo in famiglia. Io vi dirò una cosa: se litighiamo in famiglia, che non finisca la giornata senza fare la pace. “Sì, ho litigato”, ma prima di finire la giornata, fai la pace. E sai perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non aiuta. E poi, in famiglia ci sono tre parole, tre parole da custodire sempre: “permesso”, “grazie”, “scusa”. “Permesso”, per non essere invadenti nella vita degli altri. “Permesso: posso fare qualcosa? Ti sembra che possa fare questo?”. “Permesso”. Sempre, non essere invadente. “Permesso”, la prima parola. “Grazie”: tanti aiuti, tanti servizi che ci facciamo in famiglia. Ringraziare sempre. La gratitudine è il sangue dell’anima nobile. “Grazie”. E poi, la più difficile da dire: “Scusa”. Perché noi sempre facciamo delle cose brutte e tante volte qualcuno si sente offeso di questo. “Scusami”, “scusami”. Non dimenticatevi le tre parole: “permesso”, “grazie”, “scusa”. Se in una famiglia, nell’ambiente familiare ci sono queste tre parole, la famiglia va bene.
All’esempio di evangelizzare con la famiglia ci chiama la festa di oggi, riproponendoci l’ideale dell’amore coniugale e familiare, così come è stato sottolineato nell’Esortazione apostolica Amoris laetitia […]
Affidiamo alla Santa Famiglia di Nazareth, in particolare a San Giuseppe sposo e padre sollecito, questo cammino con le famiglie di tutto il mondo.
La Vergine Maria, alla quale ci rivolgiamo ora con la preghiera dell’Angelus, ottenga alle famiglie del mondo intero di essere sempre più affascinate dall’ideale evangelico della Santa Famiglia, così da diventare fermento di nuova umanità e di una solidarietà concreta e universale.
[Papa Francesco, Angelus 27 dicembre 2020]
Prologo. Logos: carne
Discepolo amato e Pietro
Per non affievolire l’Incontro personale
(Gv 20,2-8)
In Gv il discepolo amato ai piedi della Croce insieme alla Madre è figura di ciascuno, e della nuova comunità che nasce attorno a Gesù.
Sorge la Chiesa; non sulla base d’una successione prevista, bensì per adesione piena e spontanea.
Nell’Asia Minore gli amici del Signore, ellenisti meno legati alle consuetudini, intendevano contrapporsi all’atteggiamento incerto e compromissorio dei giudaizzanti.
Buona parte dei fedeli delle chiese giovannee pensavano di abbandonare sinagoga e Primo Testamento, che li attardavano.
In alternativa, essi desideravano abbracciare esclusivamente il Nuovo, mediante la Fede personale nel Cristo vivo, senza incertezze.
Il quarto Vangelo tenta di riequilibrare le posizioni estremiste.
“Figlio” e Madre - ossia il popolo del Patto antico [in ebraico «Israèl» è di genere femminile] - devono rimanere uniti (Gv 19,26-27).
Insomma, Fede e ‘opere di legge’ vanno di pari passo.
La Fede è una relazione progressiva che si accende in una ‘ricerca’ colma di tensione e passione [«correre»].
Essa trasmette percezioni progressive, le quali fanno accedere a un mondo nuovo [«entrare»], dove ‘vediamo’ cose che non sappiamo.
Era già stata questa in parte la reazione costernata della Maddalena, che in Gv accorre sola alla tomba - non accompagnata da altre “donne” come narrano i sinottici.
Uno sgomento che però spinge all’Annuncio: il sepolcro (la condizione dello Sheôl, anfratto di tenebre) non era più nell’assetto in cui era stato lasciato dopo la sepoltura del Cristo.
E appunto, quel lenzuolo «ravvolto [con cura] a parte» dice che non avrà mai bisogno di alcun sudario. La morte non ha più potere su di Lui.
Così, sebbene il giovane sia più veloce del veterano e arrivi primo ad avvistare i segni della verità e del mondo nuovo, cede il passo.
Al pari d’un profeta che coglie tutto anzitempo, il discepolo schietto e la comunità genuina aspettano che anche gli attardati giungano alla medesima esperienza, all’identico acume delle cose; al credere nel misterioso processo che porta guadagno nella perdita e vita dalla morte.
L’occhio dell’innamorato «percepisce» immediatamente; ha lo sguardo intimo e acuto che afferra e fa propria la Novità del Risorto.
Prima dei semplici ammiratori, il fratello empatico e verace «coglie Vita fra segni di morte».
Come se per relazione di Fede che ci anima, nell’attenzione degli accadimenti, fossimo già introdotti in una realtà che comunica ‘sensi nuovi’. E il distinguere-udire del cuore.
Un Ascolto che fa acuto l’occhio - proiettando l’Annuncio.
Sorge in tal guisa un nuovo Popolo, che “vede dentro”, che avverte l’Infinito affacciarsi nella finitezza, e vita completa che si svela nella fragilità dell’evento (persino oscuro).
Forse non pochi restano ancora sorpresi dalla «tomba vuota»: ossia un Gesù Risorto solo ‘personale’, vissuto nell’amore, nel gratis normale, nel dono di sé che vince la morte. Ma senza ‘mausoleo’ alcuno.
Il Discepolo Amato - sgorgato dal Cuore del Trafitto e che porta in vetta anche la Tradizione - nella sua sensibilità ‘avverte’ il Signore vivente ben prima di quello commemorato.
Ne viene rapito, e nella sua esperienza ‘si accorge’ all’istante della potenza della Vita su qualsiasi legaccio.
Condizione divina, illuminante, dispiegata nella storia.
[San Giovanni Apostolo ed Evangelista, 27 dicembre]
I silenziosi conoscono il misterioso scambio dei cuori
Giovanni, figlio di Zebedeo
Cari fratelli e sorelle,
dedichiamo l'incontro di oggi al ricordo di un altro membro molto importante del collegio apostolico: Giovanni, figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo. Il suo nome, tipicamente ebraico, significa “il Signore ha fatto grazia”. Stava riassettando le reti sulla sponda del lago di Tiberìade, quando Gesù lo chiamò insieme con il fratello (cfr Mt 4,21; Mc 1,19). Giovanni fa sempre parte del gruppo ristretto, che Gesù prende con sé in determinate occasioni. E’ insieme a Pietro e a Giacomo quando Gesù, a Cafarnao, entra in casa di Pietro per guarirgli la suocera (cfr Mc 1,29); con gli altri due segue il Maestro nella casa dell'archisinagògo Giàiro, la cui figlia sarà richiamata in vita (cfr Mc 5,37); lo segue quando sale sul monte per essere trasfigurato (cfr Mc 9,2); gli è accanto sul Monte degli Olivi quando davanti all’imponenza del Tempio di Gerusalemme pronuncia il discorso sulla fine della città e del mondo (cfr Mc 13,3); e, finalmente, gli è vicino quando nell'Orto del Getsémani si ritira in disparte per pregare il Padre prima della Passione (cfr Mc 14,33). Poco prima della Pasqua, quando Gesù sceglie due discepoli per mandarli a preparare la sala per la Cena, a lui ed a Pietro affida tale compito (cfr Lc 22,8).
Questa sua posizione di spicco nel gruppo dei Dodici rende in qualche modo comprensibile l’iniziativa presa un giorno dalla madre: ella si avvicinò a Gesù per chiedergli che i due figli, Giovanni appunto e Giacomo, potessero sedere uno alla sua destra e uno alla sua sinistra nel Regno (cfr Mt 20,20-21). Come sappiamo, Gesù rispose facendo a sua volta una domanda: chiese se essi fossero disposti a bere il calice che egli stesso stava per bere (cfr Mt 20,22). L’intenzione che stava dietro a quelle parole era di aprire gli occhi dei due discepoli, di introdurli alla conoscenza del mistero della sua persona e di adombrare loro la futura chiamata ad essergli testimoni fino alla prova suprema del sangue. Poco dopo infatti Gesù precisò di non essere venuto per essere servito ma per servire e dare la propria vita in riscatto per la moltitudine (cfr Mt 20,28). Nei giorni successivi alla risurrezione, ritroviamo “i figli di Zebedeo” impegnati con Pietro ed alcuni altri discepoli in una notte infruttuosa, a cui segue per intervento del Risorto la pesca miracolosa: sarà “il discepolo che Gesù amava” a riconoscere per primo “il Signore” e a indicarlo a Pietro (cfr Gv 21,1-13).
All'interno della Chiesa di Gerusalemme, Giovanni occupò un posto di rilievo nella conduzione del primo raggruppamento di cristiani. Paolo infatti lo annovera tra quelli che chiama le “colonne” di quella comunità (cfr Gal 2,9). In realtà, Luca negli Atti lo presenta insieme con Pietro mentre vanno a pregare nel Tempio (cfr At 3,1-4.11) o compaiono davanti al Sinedrio a testimoniare la propria fede in Gesù Cristo (cfr At 4,13.19). Insieme con Pietro viene inviato dalla Chiesa di Gerusalemme a confermare coloro che in Samaria hanno accolto il Vangelo, pregando su di loro perché ricevano lo Spirito Santo (cfr At 8,14-15). In particolare, va ricordato ciò che afferma, insieme con Pietro, davanti al Sinedrio che li sta processando: “Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato” (At 4,20). Proprio questa franchezza nel confessare la propria fede resta un esempio e un monito per tutti noi ad essere sempre pronti a dichiarare con decisione la nostra incrollabile adesione a Cristo, anteponendo la fede a ogni calcolo o umano interesse.
Secondo la tradizione, Giovanni è “il discepolo prediletto”, che nel Quarto Vangelo poggia il capo sul petto del Maestro durante l'Ultima Cena (cfr Gv 13,21), si trova ai piedi della Croce insieme alla Madre di Gesù (cfr Gv 19, 25) ed è infine testimone sia della Tomba vuota che della stessa presenza del Risorto (cfr Gv 20,2; 21,7). Sappiamo che questa identificazione è oggi discussa dagli studiosi, alcuni dei quali vedono in lui semplicemente il prototipo del discepolo di Gesù. Lasciando agli esegeti di dirimere la questione, ci contentiamo qui di raccogliere una lezione importante per la nostra vita: il Signore desidera fare di ciascuno di noi un discepolo che vive una personale amicizia con Lui. Per realizzare questo non basta seguirlo e ascoltarlo esteriormente; bisogna anche vivere con Lui e come Lui. Ciò è possibile soltanto nel contesto di un rapporto di grande familiarità, pervaso dal calore di una totale fiducia. E’ ciò che avviene tra amici; per questo Gesù ebbe a dire un giorno: “Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici ... Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi” (Gv 15,13.15).
Negli apocrifi Atti di Giovanni l'Apostolo viene presentato non come fondatore di Chiese e neppure alla guida di comunità già costituite, ma in continua itineranza come comunicatore della fede nell'incontro con “anime capaci di sperare e di essere salvate” (18,10; 23,8). Tutto è mosso dal paradossale intento di far vedere l'invisibile. E infatti dalla Chiesa orientale egli è chiamato semplicemente “il Teologo”, cioè colui che è capace di parlare in termini accessibili delle cose divine, svelando un arcano accesso a Dio mediante l'adesione a Gesù.
Il culto di Giovanni apostolo si affermò a partire dalla città di Efeso, dove, secondo un’antica tradizione, avrebbe a lungo operato, morendovi infine in età straordinariamente avanzata, sotto l'imperatore Traiano. Ad Efeso l'imperatore Giustiniano, nel secolo VI, fece costruire in suo onore una grande basilica, di cui restano tuttora imponenti rovine. Proprio in Oriente egli godette e gode tuttora di grande venerazione. Nell’iconografia bizantina viene spesso raffigurato molto anziano – secondo la tradizione morì sotto l’imperatore Traiano - e in atto di intensa contemplazione, quasi nell’atteggiamento di chi invita al silenzio.
In effetti, senza adeguato raccoglimento non è possibile avvicinarsi al mistero supremo di Dio e alla sua rivelazione. Ciò spiega perché, anni fa, il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Atenagora, colui che il Papa Paolo VI abbracciò in un memorabile incontro, ebbe ad affermare: “Giovanni è all'origine della nostra più alta spiritualità. Come lui, i ‘silenziosi’ conoscono quel misterioso scambio dei cuori, invocano la presenza di Giovanni e il loro cuore si infiamma” (O. Clément, Dialoghi con Atenagora, Torino 1972, p. 159). Il Signore ci aiuti a metterci alla scuola di Giovanni per imparare la grande lezione dell’amore così da sentirci amati da Cristo “fino alla fine” (Gv 13,1) e spendere la nostra vita per Lui.
[Papa Benedetto, Udienza Generale 5 luglio 2006]
La Ricerca di Dio
1. Ci incontriamo nel tempo liturgico del Natale. Desidero quindi che le parole, che oggi vi rivolgerò, corrispondano alla gioia di questa festa e di questa ottava. Desidero inoltre che corrispondano a quella semplicità e insieme profondità che il Natale irradia su tutti. Affiora spontaneo alla mia mente il ricordo dei miei sentimenti e delle mie vicende, cominciando dagli anni della mia infanzia nella casa paterna, attraverso gli anni difficili della giovinezza, il periodo della seconda guerra, la guerra mondiale. Possa essa non ripetersi mai più nella storia dell’Europa e del mondo! Eppure, perfino negli anni peggiori, il Natale ha sempre portato con sé qualche raggio. E questo raggio penetrava anche nelle più dure esperienze di disprezzo dell’uomo, di annientamento della sua dignità, di crudeltà. Basta, per rendersene conto, prendere in mano le memorie degli uomini che sono passati per le carceri o per i campi di concentramento, per i fronti di guerra e per gli interrogatori e i processi.
Questo raggio della Notte natalizia, raggio della nascita di Dio, non è soltanto un ricordo delle luci dell’albero, accanto al presepio nella casa, nella famiglia o nella chiesa parrocchiale, ma è qualcosa di più. Esso è il più profondo barlume dell’umanità che è stata visitata da Dio, l’umanità nuovamente accolta e assunta da Dio stesso; assunta nel Figlio di Maria nell’unità della Persona divina: il Figlio-Verbo. Natura umana assunta misticamente dal Figlio di Dio in ciascuno di noi, che siamo stati adottati nella nuova unione col Padre. L’irradiazione di questo mistero si estende lontano, molto lontano; raggiunge anche quelle parti e quelle sfere dell’esistenza degli uomini, nelle quali qualsiasi pensiero su Dio è stato quasi offuscato, sembra essere assente, come se fosse bruciato e spento del tutto. Ed ecco, con la notte di Natale, spunta un barlume: forse nonostante tutto? Felice questo “forse nonostante tutto”: esso è già un barlume di fede e di speranza.
2. Nella festività del Natale leggiamo dei pastori di Betlemme, che per primi furono chiamati al presepe, a vedere il Neonato: “Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia” (Lc 2,16).
Fermiamoci a quel “trovarono”. Questa parola indica la ricerca. Infatti, i pastori di Betlemme, mettendosi a riposare col loro gregge, non sapevano che era giunto il tempo, in cui sarebbe avvenuto ciò che da secoli avevano preannunziato i profeti di quel Popolo, a cui essi stessi appartenevano; e che si sarebbe compiuto proprio in quella notte; e che sarebbe avvenuto nelle vicinanze del luogo dove sostavano. Anche dopo il risveglio dal sonno in cui erano immersi, essi non sapevano né che cosa fosse successo né dove fosse successo. Il loro arrivo alla grotta della Natività era il risultato di una ricerca. Ma, nello stesso tempo, essi erano stati condotti, erano – come leggiamo – guidati dalla voce e dalla luce. E se risaliamo ancor più nel passato, li vediamo guidati dalla tradizione del loro Popolo, dalla sua attesa. Sappiamo che Israele aveva ottenuto la promessa del Messia.
Ed ecco l’Evangelista parla dei semplici, dei modesti, dei poveri d’Israele: dei pastori che per primi l’hanno trovato. Parla, del resto, con tutta semplicità, come se si trattasse di un avvenimento “esteriore”: hanno cercato dove potesse essere, e infine hanno trovato. Allo stesso tempo questo “trovarono” di Luca indica una dimensione interiore: ciò che si è avverato negli uomini la notte di Natale, in quei semplici pastori di Betlemme. “Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia”, e poi: “...se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro” (Lc 2,16-20).
3.“Trovarono” indica “la ricerca”.
L’uomo è un essere che cerca. Tutta la sua storia lo conferma. Anche la vita di ciascuno di noi lo testimonia. Molti sono i campi in cui l’uomo cerca e ricerca e poi trova e, talvolta, dopo aver trovato, ricomincia nuovamente a cercare. Fra tutti questi campi in cui l’uomo si rivela come un essere che cerca, ve n’è uno, il più profondo. È quello che penetra più intimamente nella stessa umanità dell’essere umano. Ed è il più unito al senso di tutta la vita umana.
L’uomo è l’essere che cerca Dio.
Diverse sono le vie di questa ricerca. Molteplici sono le storie delle anime umane proprio su queste strade. Talvolta le vie sembrano molto semplici e vicine. Altre volte sono difficili, complicate, lontane. A volte l’uomo arriva facilmente al suo “heureka”: “ho trovato!”. A volte lotta con le difficoltà, come se non potesse penetrare se stesso e il mondo, e soprattutto come se non potesse comprendere il male che c’è nel mondo. Si sa che perfino nel contesto della Natività questo male ha mostrato il suo volto minaccioso.
Non pochi sono gli uomini che hanno descritto la loro ricerca di Dio sulle strade della propria vita. Ancor più numerosi sono coloro che tacciono, considerando come il proprio mistero più profondo e più intimo tutto ciò che su queste strade hanno vissuto: quello che hanno sperimentato, come hanno cercato, come hanno perduto l’orientamento e come l’hanno nuovamente ritrovato.
L’uomo è l’essere che cerca Dio.
E perfino dopo averlo trovato, continua a cercarlo. E se lo cerca con sincerità, lo ha già trovato; come, in un celebre frammento di Pascal, Gesù dice all’uomo: “Consolati, tu non mi cercheresti, se non mi avessi già trovato” (Pascal, Pensées, 553: “Il mistero di Gesù”).
Questa è la verità sull’uomo.
Non la si può falsificare. Non la si può nemmeno distruggere. La si deve lasciare all’uomo perché essa lo definisce.
Che cosa dire dell’ateismo di fronte a questa verità? Bisogna dire moltissime cose, più di ciò che è possibile racchiudere nella cornice di questo mio breve discorso. Ma almeno una cosa è necessario dire: è indispensabile applicare un criterio, cioè il criterio della libertà dello spirito umano. Non va d’accordo con questo criterio – fondamentale criterio – l’ateismo, sia quando nega a priori che l’uomo è l’essere che cerca Dio, sia quando mutila in vari modi tale ricerca nella vita sociale, pubblica e culturale. Tale atteggiamento è contrario ai diritti fondamentali dell’uomo.
4.Ma non voglio fermarmi su questo. Se vi accenno, lo faccio per dimostrare tutta la bellezza e la dignità della ricerca di Dio.
Questo pensiero mi è stato suggerito dalla festa del Natale.
Come è nato il Cristo? Come è venuto al mondo? Perché è venuto al mondo? È venuto al mondo perché Lo possano trovare gli uomini; coloro che lo cercano. Così come l’hanno trovato i pastori nella grotta di Betlemme.
Dirò ancor di più. Gesù è venuto al mondo per rivelare tutta la dignità e nobiltà della ricerca di Dio, che è il più profondo bisogno dell’anima umana, e per venire incontro a questa ricerca.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 27 dicembre 1978]
Quella mattina
Nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato (cfr Gv 20,1-8), Giovanni ci racconta quella mattina inimmaginabile che ha cambiato per sempre la storia dell’umanità. Figuriamocela, quella mattina: alle prime luci dell’alba del giorno dopo il sabato, attorno alla tomba di Gesù tutti si mettono a correre. Maria di Magdala corre ad avvisare i discepoli; Pietro e Giovanni corrono verso il sepolcro... Tutti corrono, tutti sentono l’urgenza di muoversi: non c’è tempo da perdere, bisogna affrettarsi... Come aveva fatto Maria – ricordate? – appena concepito Gesù, per andare ad aiutare Elisabetta.
Abbiamo tanti motivi per correre, spesso solo perché ci sono tante cose da fare e il tempo non basta mai. A volte ci affrettiamo perché ci attira qualcosa di nuovo, di bello, di interessante. A volte, al contrario, si corre per scappare da una minaccia, da un pericolo…
I discepoli di Gesù corrono perché hanno ricevuto la notizia che il corpo di Gesù è sparito dalla tomba. I cuori di Maria di Magdala, di Simon Pietro, di Giovanni sono pieni d’amore e battono all’impazzata dopo il distacco che sembrava definitivo. Forse si riaccende in loro la speranza di rivedere il volto del Signore! Come in quel primo giorno quando aveva promesso: «Venite e vedrete» (Gv 1,39). Chi corre più forte è Giovanni, certamente perché è più giovane, ma anche perché non ha smesso di sperare dopo aver visto coi suoi occhi Gesù morire in croce; e anche perché è stato vicino a Maria, e per questo è stato “contagiato” dalla sua fede. Quando noi sentiamo che la fede viene meno o è tiepida, andiamo da Lei, Maria, e Lei ci insegnerà, ci capirà, ci farà sentire la fede.
Da quella mattina, cari giovani, la storia non è più la stessa. Quella mattina ha cambiato la storia. L’ora in cui la morte sembrava trionfare, in realtà si rivela l’ora della sua sconfitta. Nemmeno quel pesante macigno, messo davanti al sepolcro, ha potuto resistere. E da quell’alba del primo giorno dopo il sabato, ogni luogo in cui la vita è oppressa, ogni spazio in cui dominano violenza, guerra, miseria, là dove l’uomo è umiliato e calpestato, in quel luogo può ancora riaccendersi una speranza di vita.
Cari amici, vi siete messi in cammino e siete venuti a questo appuntamento. E ora la mia gioia è sentire che i vostri cuori battono d’amore per Gesù, come quelli di Maria Maddalena, di Pietro e di Giovanni. E poiché siete giovani, io, come Pietro, sono felice di vedervi correre più veloci, come Giovanni, spinti dall’impulso del vostro cuore, sensibile alla voce dello Spirito che anima i vostri sogni. Per questo vi dico: non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo alla fila. Non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo alla fila. Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in avanti, un balzo audace e temerario per sognare e realizzare come Gesù il Regno di Dio, e impegnarvi per un’umanità più fraterna. Abbiamo bisogno di fraternità: rischiate, andate avanti!
Sarò felice di vedervi correre più forte di chi nella Chiesa è un po’ lento e timoroso, attratti da quel Volto tanto amato, che adoriamo nella santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci, come Giovanni aspettò Pietro davanti al sepolcro vuoto. E un’altra cosa: camminando insieme, in questi giorni, avete sperimentato quanto costa fatica accogliere il fratello o la sorella che mi sta accanto, ma anche quanta gioia può darmi la sua presenza se la ricevo nella mia vita senza pregiudizi e chiusure. Camminare soli permette di essere svincolati da tutto, forse più veloci, ma camminare insieme ci fa diventare un popolo, il popolo di Dio. Il popolo di Dio che ci dà sicurezza, la sicurezza dell’appartenenza al popolo di Dio… E col popolo di Dio ti senti sicuro, nel popolo di Dio, nella tua appartenenza al popolo di Dio hai identità. Dice un proverbio africano: “Se vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno”.
Il Vangelo dice che Pietro entrò per primo nel sepolcro e vide i teli per terra e il sudario avvolto in un luogo a parte. Poi entrò anche l’altro discepolo, il quale – dice il Vangelo – «vide e credette» (v. 8). È molto importante questa coppia di verbi: vedere e credere. In tutto il Vangelo di Giovanni si narra che i discepoli vedendo i segni che Gesù compiva credettero in Lui. Vedere e credere. Di quali segni si tratta? Dell’acqua trasformata in vino per le nozze; di alcuni malati guariti; di un cieco nato che acquista la vista; di una grande folla saziata con cinque pani e due pesci; della risurrezione dell’amico Lazzaro, morto da quattro giorni. In tutti questi segni Gesù rivela il volto invisibile di Dio.
Non è la rappresentazione della sublime perfezione divina, quella che traspare dai segni di Gesù, ma il racconto della fragilità umana che incontra la Grazia che risolleva. C’è l’umanità ferita che viene risanata dall’incontro con Lui; c’è l’uomo caduto che trova una mano tesa alla quale aggrapparsi; c’è lo smarrimento degli sconfitti che scoprono una speranza di riscatto. E Giovanni, quando entra nel sepolcro di Gesù, porta negli occhi e nel cuore quei segni compiuti da Gesù immergendosi nel dramma umano per risollevarlo. Gesù Cristo, cari giovani, non è un eroe immune dalla morte, ma Colui che la trasforma con il dono della sua vita. E quel lenzuolo piegato con cura dice che non ne avrà più bisogno: la morte non ha più potere su di Lui.
Cari giovani, è possibile incontrare la Vita nei luoghi dove regna la morte? Sì, è possibile. Verrebbe da rispondere di no, che è meglio stare alla larga, allontanarsi. Eppure questa è la novità rivoluzionaria del Vangelo: il sepolcro vuoto di Cristo diventa l’ultimo segno in cui risplende la vittoria definitiva della Vita. E allora non abbiamo paura! Non stiamo alla larga dai luoghi di sofferenza, di sconfitta, di morte. Dio ci ha dato una potenza più grande di tutte le ingiustizie e le fragilità della storia, più grande del nostro peccato: Gesù ha vinto la morte dando la sua vita per noi. E ci manda ad annunciare ai nostri fratelli che Lui è il Risorto, è il Signore, e ci dona il suo Spirito per seminare con Lui il Regno di Dio. Quella mattina della domenica di Pasqua è cambiata la storia: abbiamo coraggio!
Quanti sepolcri – per così dire – oggi attendono la nostra visita! Quante persone ferite, anche giovani, hanno sigillato la loro sofferenza “mettendoci – come si dice – una pietra sopra”. Con la forza dello Spirito e la Parola di Gesù possiamo spostare quei macigni e far entrare raggi di luce in quegli anfratti di tenebre.
E’ stato bello e faticoso il cammino per venire a Roma; pensate voi, quanta fatica, ma quanta bellezza! Ma altrettanto bello e impegnativo sarà il cammino del ritorno alle vostre case, ai vostri paesi, alle vostre comunità. Percorretelo con la fiducia e l’energia di Giovanni, il “discepolo amato”. Sì, il segreto è tutto lì, nell’essere e nel sapere di essere “amato”, “amata” da Lui, Gesù, il Signore, ci ama! E ognuno di noi, tornando a casa, metta questo nel cuore e nella mente: Gesù, il Signore, mi ama. Sono amato. Sono amata. Sentire la tenerezza di Gesù che mi ama. Percorre con coraggio e con gioia il cammino verso casa, percorretelo con la consapevolezza di essere amati da Gesù. Allora, con questo amore, la vita diventa una corsa buona, senza ansia, senza paura, quella parola che ci distrugge. Senza ansia e senza paura. Una corsa verso Gesù e verso i fratelli, col cuore pieno di amore, di fede e di gioia. Andate così!
[Papa Francesco, Riflessione finale alla Veglia di preghiera al Circo Massimo 11 agosto 2018]
Valori e indipendenza emotiva
Collocarsi negli eventi di persecuzione
(Mt 10,17-22)
Il corso della storia è tempo in cui Dio compone il confluire della nostra libertà e delle circostanze.
In tali pieghe c’è spesso un vettore di vita, un aspetto essenziale, una sorte definitiva, che ci sfugge.
Ma all’occhio non mediocre della persona di Fede, anche i soprusi e perfino il martirio sono un dono.
Per imparare le lezioni importanti della vita, ogni giorno il credente si avventura in ciò che ha paura di fare, superando i timori.
L’amore sponsale e gratuito ricevuto colloca in una condizione di reciprocità, d’attivo desiderio di unire la vita al Cristo - sebbene nell’esiguità delle nostre risposte.
Continuando invece a lamentarsi degli insuccessi, pericoli, calamità, tutti vedranno in noi donne come le altre e uomini comuni - e ogni cosa terminerà a questo livello.
Non saremo sull’altro lato. Al massimo tenteremo di sottrarci alle asprezze, o si finirà per cercare alleati di circostanza (vv.19-20).
Mt intende aiutare le sue comunità a urtare la logica mondana e collocarsi negli eventi di persecuzione in maniera fervente.
Le angherie sociali non sono fatalità, bensì occasioni per la missione; luoghi di alta testimonianza eucaristica (vv.16-18).
I perseguitati non hanno bisogno di stampelle esterne, né devono vivere nell’angoscia del crollo.
Essi hanno il compito di essere segni del Regno di Dio, che man mano porta i lontani e gli stessi usurpatori a una diversa consapevolezza.
Nessuno è arbitro della realtà e tutti sono fuscelli soggetti a rovesci, ma nella condizione umanizzante degli apostoli traluce un’indipendenza emotiva.
Ciò avviene per il senso intimo, vivo, di una Presenza, e la lettura delle vicende esterne come azione eccezionale del Padre che si rivela.
In tale magma energetico plasmabile, ecco affiorare percorsi unici, inedite opportunità di crescita... anche nelle avversità.
Atteggiamento senz’alibi né certezze granitiche: con la sola convinzione che tutto verrà rimesso in gioco.
Tempo sacro e profano vengono a coincidere in un Patto fervente, che si annida e cova frutti persino nei momenti del travaglio e paradosso.
Qui unica risorsa necessaria è la forza spirituale di andare sino in fondo… nei controsensi d’altro versante.
È nel Signore e nella realtà insidiosa o sommaria il “posto” per ciascuno di noi. Non senza lacerazioni.
Eppure traiamo energia spirituale dalla conoscenza del Cristo, dal senso di legame profondo con Lui e la realtà anche minuta e variegata, o temibile - sempre personale (v.22b).
La nostra vicenda non sarà come un romanzo facile e a lieto fine.
Ma avremo possibilità di testimoniare nel presente le più genuine radici antiche: che in ogni istante Dio chiama, si manifesta - e ciò che sembra fallimento diviene Cibo e sorgente di Vita.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Che tipo di lettura fai, e come ti collochi negli eventi di persecuzione?
Sei consapevole che gli intoppi non vengono per la disperazione, bensì per liberarti dalla chiusura in schemi culturali stagnanti (e non tuoi)?
[S. Stefano protomartire, 26 dicembre]
Forza della Speranza: sofferenza in gioia
Cari fratelli e sorelle!
All’indomani del Natale, la liturgia ci fa celebrare la "nascita al cielo" del primo martire, santo Stefano. "Pieno di fede e di Spirito Santo" (At 6,5), egli fu scelto come diacono nella Comunità di Gerusalemme, insieme con altri sei discepoli di cultura greca. Con la forza che gli veniva da Dio, Stefano compiva numerosi miracoli ed annunciava nelle sinagoghe il Vangelo con "sapienza ispirata". Fu lapidato alle porte della città e morì, come Gesù, invocando il perdono per i suoi uccisori (At 7,59-60). Il legame profondo che unisce Cristo al suo primo martire Stefano è la Carità divina: lo stesso Amore che spinse il Figlio di Dio a spogliare se stesso e a farsi obbediente fino alla morte di croce (cfr Fil 2,6-8), ha poi spinto gli Apostoli e i martiri a dare la vita per il Vangelo.
Bisogna sempre rimarcare questa caratteristica distintiva del martirio cristiano: esso è esclusivamente un atto d’amore, verso Dio e verso gli uomini, compresi i persecutori. Perciò noi oggi, nella santa Messa, preghiamo il Signore che ci insegni "ad amare anche i nostri nemici sull’esempio di [Stefano] che morendo pregò per i suoi persecutori" (Orazione "colletta"). Quanti figli e figlie della Chiesa nel corso dei secoli hanno seguito questo esempio! Dalla prima persecuzione a Gerusalemme a quelle degli imperatori romani, fino alle schiere dei martiri dei nostri tempi. Non di rado, infatti, anche oggi giungono notizie da varie parti del mondo di missionari, sacerdoti, vescovi, religiosi, religiose e fedeli laici perseguitati, imprigionati, torturati, privati della libertà o impediti nell’esercitarla perché discepoli di Cristo e apostoli del Vangelo; a volte si soffre e si muore anche per la comunione con la Chiesa universale e la fedeltà al Papa. Nella Lettera Enciclica Spe salvi (cfr n. 37), ricordando l’esperienza del martire vietnamita Paolo Le-Bao-Thin (morto nel 1857), faccio notare che la sofferenza è trasformata in gioia mediante la forza della speranza che proviene dalla fede. Il martire cristiano, come Cristo e mediante l’unione con Lui, "accetta nel suo intimo la croce, la morte e la trasforma in un’azione d’amore. Quello che dall’esterno è violenza brutale, dall’interno diventa un atto d’amore che si dona totalmente. La violenza così si trasforma in amore e quindi la morte in vita" (Omelia a Marienfeld - Colonia, 21 agosto 2005). Il martire cristiano attualizza la vittoria dell’amore sull’odio e sulla morte.
Preghiamo per quanti soffrono a motivo della fedeltà a Cristo e alla sua Chiesa. Maria Santissima, Regina dei Martiri, ci aiuti ad essere testimoni credibili del Vangelo, rispondendo ai nemici con la forza disarmante della verità e della carità.
[Papa Benedetto, Angelus 26 dicembre 2007]
La passione di un soldato
Fratelli e figli carissimi!
Mi è caro, anche quest’oggi, rivolgermi a voi, che siete qui convenuti per la preghiera dell’Angelus nel clima così tipico ed intimo del santo Natale. Oggi, infatti, il Natale continua la sua salutare e tonificante atmosfera, ed in essa ancora respirano le nostre anime per il senso di perdurante meraviglia e stupore dinanzi al grande evento che si è verificato e che, inesauribile nella sua efficacia, si proietta nell’intero corso del tempo. Intendo l’evento o, più esattamente, il mistero del Figlio di Dio che nasce a Betlemme come Figlio dell’uomo, per farsi a noi fratello e per noi salvatore.
Tanto augusto ed insondabile è un tale mistero, che noi non lo mediteremo mai abbastanza. Per questo, la Chiesa nella sua sapienza liturgica e catechetica ce lo ripropone ogni anno, per una commemorazione che si prolunga per non pochi giorni e si articola in uno speciale ciclo che chiamiamo “ciclo liturgico natalizio”.
2. E desidero venerare insieme con voi santo Stefano, primo martire cristiano, così come lo fa la Chiesa il giorno dopo la solennità del Natale.
“Ieri abbiamo celebrato la nascita temporale dell’eterno nostro re; oggi celebriamo la passione gloriosa di un suo soldato. Difatti, ieri il nostro re, rivestito della nobile veste della sua carne, uscendo dalla reggia del seno verginale, si è degnato di far visita al mondo; oggi un suo soldato, lasciando la tenda del corpo, è salito da trionfatore nel cielo”. Sono queste le suggestive espressioni di un santo della Chiesa antica, san Fulgenzio (S. Fulgenzio, Sermo 3, 1), ed esse conservano intatto il loro significato perché enucleano un rapporto non soltanto di continuità liturgica tra la festa di Natale e quella del protomartire, ma anche soprattutto di intrinseco collegamento nell’ordine della santità e della grazia. Cristo, re della storia e redentore dell’uomo, si pone al centro di quell’itinerario verso la perfezione, a cui chiama l’uomo, ogni uomo.
Mentre veneriamo santo Stefano e l’invitto suo esempio di testimone di Cristo, quale egli si dimostrò con la parola animosa, con la premura nel servizio dei poveri, con la sua costanza durante il processo e, soprattutto, con la sua morte eroica, noi vediamo che la sua figura s’illumina e s’ingigantisce nella luce del suo Signore e maestro, che volle seguire nel sacrificio supremo. È il Signore Gesù che solo dà il soccorso ed il conforto necessario alle anime per esser fedeli fino alla morte.
Da ciò deriva una preziosa lezione per noi: guardando a Stefano nella prospettiva del Natale, noi dobbiamo raccogliere il suo esempio ed il suo insegnamento, i quali univocamente ci riportano a Cristo che, nato nella grotta di Betlemme, è già incamminato - nell’intenzione finalistica dell’opera redentiva - verso il colle del Calvario. Fatti da lui figli di Dio, chiamati a vivere da figli di Dio, saremo anche noi coronati come Stefano lassù, nella patria, se saremo fedeli.
[Papa Giovanni Paolo II, Angelus 26 dicembre 1980]
Potrebbe apparire fuori luogo
Si celebra oggi la festa di Santo Stefano, primo martire. Il Libro degli Atti degli Apostoli ci parla di lui (cfr cap. 6-7) e nella pagina della liturgia di oggi ce lo presenta nei momenti finali della sua vita, quando viene catturato e lapidato (cfr 6,12; 7,54-60). Nel clima gioioso del Natale, questa memoria del primo cristiano ucciso per la fede potrebbe apparire fuori luogo. Tuttavia, proprio nella prospettiva della fede, l’odierna celebrazione si pone in sintonia con il vero significato del Natale. Nel martirio di Stefano, infatti, la violenza è sconfitta dall’amore, la morte dalla vita: egli, nell’ora della testimonianza suprema, contempla i cieli aperti e dona ai persecutori il suo perdono (cfr v. 60).
Questo giovane servitore del Vangelo, pieno di Spirito Santo, ha saputo narrare Gesù con le parole, e soprattutto con la sua vita. Guardando a lui, vediamo realizzarsi la promessa di Gesù ai suoi discepoli: “Quando vi maltratteranno per causa mia, lo Spirito del Padre vi darà la forza e le parole per dare testimonianza” (cfr Mt 10,19-20). Alla scuola di Santo Stefano, diventato simile al suo Maestro sia nella vita sia nella morte, anche noi fissiamo lo sguardo su Gesù, testimone fedele del Padre. Impariamo che la gloria del Cielo, quella che dura per la vita eterna, non è fatta di ricchezze e potere, ma di amore e donazione di sé.
Abbiamo bisogno di tenere lo sguardo fisso su Gesù, «autore e perfezionatore della nostra fede» (Eb 12,2), per poter rendere ragione della speranza che ci è stata donata (cfr 1Pt 3,15), attraverso le sfide e le prove che dobbiamo affrontare quotidianamente. Per noi cristiani, il cielo non è più lontano, separato dalla terra: in Gesù, il Cielo è disceso sulla terra. E grazie a Lui, con la forza dello Spirito Santo, noi possiamo assumere tutto ciò che è umano e orientarlo verso il Cielo. Così che la prima testimonianza sia proprio il nostro modo di essere umani, uno stile di vita plasmato secondo Gesù: mite e coraggioso, umile e nobile, non violento.
Stefano era diacono, uno dei primi sette diaconi della Chiesa (cfr At 6,1-6). Egli ci insegna ad annunciare Cristo attraverso gesti di fraternità e di carità evangelica. La sua testimonianza, culminata nel martirio, è fonte di ispirazione per il rinnovamento delle nostre comunità cristiane. Esse sono chiamate a diventare sempre più missionarie, tutte protese all’evangelizzazione, decise a raggiungere gli uomini e le donne nelle periferie esistenziali e geografiche, dove più c’è sete di speranza e di salvezza. Comunità che non seguono la logica mondana, che non mettono al centro sé stesse, la propria immagine, ma unicamente la gloria di Dio e il bene della gente, specialmente dei piccoli e dei poveri.
La festa di questo primo martire Stefano ci chiama a ricordare tutti i martiri di ieri e di oggi, - oggi sono tanti! - a sentirci in comunione con loro, e a chiedere a loro la grazia di vivere e morire con il nome di Gesù nel cuore e sulle labbra. Maria, Madre del Redentore, ci aiuti a vivere questo tempo di Natale fissando lo sguardo su Gesù, per diventare ogni giorno più simili a Lui.
[Papa Francesco, Angelus 26 dicembre 2019]
Only through Christ can we converse with God the Father as children, otherwise it is not possible, but in communion with the Son we can also say, as he did, “Abba”. In communion with Christ we can know God as our true Father. For this reason Christian prayer consists in looking constantly at Christ and in an ever new way, speaking to him, being with him in silence, listening to him, acting and suffering with him (Pope Benedict)
Solo in Cristo possiamo dialogare con Dio Padre come figli, altrimenti non è possibile, ma in comunione col Figlio possiamo anche dire noi come ha detto Lui: «Abbà». In comunione con Cristo possiamo conoscere Dio come Padre vero. Per questo la preghiera cristiana consiste nel guardare costantemente e in maniera sempre nuova a Cristo, parlare con Lui, stare in silenzio con Lui, ascoltarlo, agire e soffrire con Lui (Papa Benedetto)
In today’s Gospel passage, Jesus identifies himself not only with the king-shepherd, but also with the lost sheep, we can speak of a “double identity”: the king-shepherd, Jesus identifies also with the sheep: that is, with the least and most needy of his brothers and sisters […] And let us return home only with this phrase: “I was present there. Thank you!”. Or: “You forgot about me” (Pope Francis)
Nella pagina evangelica di oggi, Gesù si identifica non solo col re-pastore, ma anche con le pecore perdute. Potremmo parlare come di una “doppia identità”: il re-pastore, Gesù, si identifica anche con le pecore, cioè con i fratelli più piccoli e bisognosi […] E torniamo a casa soltanto con questa frase: “Io ero presente lì. Grazie!” oppure: “Ti sei scordato di me” (Papa Francesco)
Thus, in the figure of Matthew, the Gospels present to us a true and proper paradox: those who seem to be the farthest from holiness can even become a model of the acceptance of God's mercy and offer a glimpse of its marvellous effects in their own lives (Pope Benedict))
Nella figura di Matteo, dunque, i Vangeli ci propongono un vero e proprio paradosso: chi è apparentemente più lontano dalla santità può diventare persino un modello di accoglienza della misericordia di Dio e lasciarne intravedere i meravigliosi effetti nella propria esistenza (Papa Benedetto)
Man is involved in penance in his totality of body and spirit: the man who has a body in need of food and rest and the man who thinks, plans and prays; the man who appropriates and feeds on things and the man who makes a gift of them; the man who tends to the possession and enjoyment of goods and the man who feels the need for solidarity that binds him to all other men [CEI pastoral note]
Nella penitenza è coinvolto l'uomo nella sua totalità di corpo e di spirito: l'uomo che ha un corpo bisognoso di cibo e di riposo e l'uomo che pensa, progetta e prega; l'uomo che si appropria e si nutre delle cose e l'uomo che fa dono di esse; l'uomo che tende al possesso e al godimento dei beni e l'uomo che avverte l'esigenza di solidarietà che lo lega a tutti gli altri uomini [nota pastorale CEI]
St John Chrysostom urged: “Embellish your house with modesty and humility with the practice of prayer. Make your dwelling place shine with the light of justice; adorn its walls with good works, like a lustre of pure gold, and replace walls and precious stones with faith and supernatural magnanimity, putting prayer above all other things, high up in the gables, to give the whole complex decorum. You will thus prepare a worthy dwelling place for the Lord, you will welcome him in a splendid palace. He will grant you to transform your soul into a temple of his presence” (Pope Benedict)
San Giovanni Crisostomo esorta: “Abbellisci la tua casa di modestia e umiltà con la pratica della preghiera. Rendi splendida la tua abitazione con la luce della giustizia [...]
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.