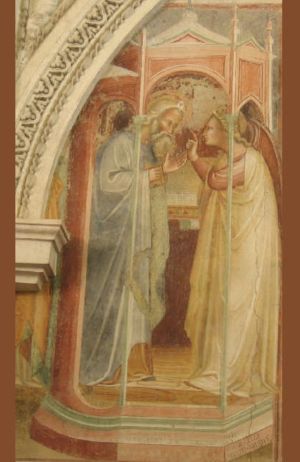don Giuseppe Nespeca
Giuseppe Nespeca è architetto e sacerdote. Cultore della Sacra scrittura è autore della raccolta "Due Fuochi due Vie - Religione e Fede, Vangeli e Tao"; coautore del libro "Dialogo e Solstizio".
Annunciazione a Zaccaria, l’uomo piantato sulla religiosità senza balzi
Genitore dei genitori, per una diversa lettura degli eventi
(Lc 1,5-25)
Lc colloca la visita dell’angelo Gabriele a Zaccaria accanto all’Annunciazione a Maria (vv.26ss), in modo da aiutare le sue comunità a percepire le differenze tra assetto religioso e vita di Fede.
Anche oggi la comparazione consente di leggere in filigrana il balzo fra Primo e Secondo Patto.
Nella religione antica si dà per scontato che il luogo dell’incontro e dialogo con Dio sia come previsto: un recinto inviolabile e venerando, profumato d’incenso - nell’eco d’invocazioni e canti a formula fissa.
Qui senza spunti eccezionali, il credere di Zaccaria [«zachàr-Ja»: il Signore d’Israele ‘ricorda’] non diventa personale, bensì ripetitivo, immobile.
A furia di commemorare e aspettare, il sacerdote di Dio e del popolo non attende più nulla di decisivo.
Impegnato nella meccanica del rito, egli non è «beato» (v.45) ma infelice; ‘muto’ perché non ha più nulla da dire a chi è in attesa fuori del tempio.
Nessuna benedizione reale da trasmettere alla gente (vv.21-22).
Così in parte Elisabetta, che si nasconde (v.24), mentre la Vergine - senza chiedere permesso - fa Esodo dal suo ambiente e si precipita a servirla (vv.39ss).
E per innescare una vita più giusta e comunitaria, del «popolo ben disposto» (v.17c) - ecco un primo scatto: la missione di Giovanni, figura dell’atteso ritorno del profeta Elia (v.17a). Testimone chiamato a recuperare le speranze del popolo e il suo tessuto sociale dilaniato.
Infine, tale “ricostruzione” avrà un esito imprevisto, lungi da pregiudizi: non più la normale continuità di un ovvio patto generazionale (Mal 3,23-24) bensì il definitivo ritorno del cuore dei padri verso i figli (v.17b)!
Il significato del nome ‘Giovanni’ [Yhwh è Misericordioso, ha manifestato la sua Benevolenza, ha fatto Grazia] non allude a un qualche atto di paternalismo compassionevole da parte divina - bensì a un preciso discrimine dalla stirpe e dalle aspettative o costumanze antiche, ormai fini a se stesse.
Nella Bibbia il termine Misericordia descrive l’attenzione diversa e l’azione fecondante dell’Eterno in favore di chiunque abbia bisogno - in situazioni disperate. Intervento necessario per una differente genesi: epocale, che fa germogliare vita incredibile e missione temeraria, non secondo previsioni - neppure ricalcando propositi.
Il Nome che devia dalla tradizione è parabola della testimonianza fedele di Dio: d’ora in poi non bisogna solo “ricordare” le profezie ancora immobilizzate, senza vederne l’attuazione imprevedibile.
Pur assimilando le ricchezze spirituali del popolo, la discontinuità segna l’inizio di un’età completamente nuova.
È il passaggio alla realizzazione ‘personale’ - e a un Regno che dice Sì a tutto quanto si affaccia: che non decurta più la vita di ciascuno, delle cose, del mondo.
La diversa lettura degli eventi e delle ispirazioni consente di divenire ormai fecondi - persino padri e madri dei propri genitori e avi.
[Feria propria del 19 dicembre]
Il Primato di Dio
Giovanni è il dono divino lungamente invocato dai suoi genitori, Zaccaria ed Elisabetta (cfr Lc 1,13); un dono grande, umanamente insperabile, perché entrambi erano avanti negli anni ed Elisabetta era sterile (cfr Lc 1,7); ma nulla è impossibile a Dio (cfr Lc 1,36). L’annuncio di questa nascita avviene proprio nel luogo della preghiera, al tempio di Gerusalemme, anzi avviene quando a Zaccaria tocca il grande privilegio di entrare nel luogo più sacro del tempio per fare l’offerta dell’incenso al Signore (cfr Lc 1,8-20). Anche la nascita del Battista è segnata dalla preghiera: il canto di gioia, di lode e di ringraziamento che Zaccaria eleva al Signore e che recitiamo ogni mattina nelle Lodi, il «Benedictus», esalta l’azione di Dio nella storia e indica profeticamente la missione del figlio Giovanni: precedere il Figlio di Dio fattosi carne per preparargli le strade (cfr Lc 1,67-79). L’esistenza intera del Precursore di Gesù è alimentata dal rapporto con Dio, in particolare il periodo trascorso in regioni deserte (cfr Lc 1,80); le regioni deserte che sono luogo della tentazione, ma anche luogo in cui l’uomo sente la propria povertà perché privo di appoggi e sicurezze materiali, e comprende come l’unico punto di riferimento solido rimane Dio stesso. Ma Giovanni Battista non è solo uomo di preghiera, del contatto permanente con Dio, ma anche una guida a questo rapporto. L’Evangelista Luca riportando la preghiera che Gesù insegna ai discepoli, il «Padre nostro», annota che la richiesta viene formulata dai discepoli con queste parole: «Signore insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli» (cfr Lc 11,1).
Cari fratelli e sorelle, celebrare il martirio di san Giovanni Battista ricorda anche a noi, cristiani di questo nostro tempo, che non si può scendere a compromessi con l’amore a Cristo, alla sua Parola, alla Verità. La Verità è Verità, non ci sono compromessi. La vita cristiana esige, per così dire, il «martirio» della fedeltà quotidiana al Vangelo, il coraggio cioè di lasciare che Cristo cresca in noi e sia Cristo ad orientare il nostro pensiero e le nostre azioni. Ma questo può avvenire nella nostra vita solo se è solido il rapporto con Dio. La preghiera non è tempo perso, non è rubare spazio alle attività, anche a quelle apostoliche, ma è esattamente il contrario: solo se se siamo capaci di avere una vita di preghiera fedele, costante, fiduciosa, sarà Dio stesso a darci capacità e forza per vivere in modo felice e sereno, superare le difficoltà e testimoniarlo con coraggio. San Giovanni Battista interceda per noi, affinché sappiamo conservare sempre il primato di Dio nella nostra vita. Grazie.
[Papa Benedetto, Udienza Generale 29 agosto 2012]
Annunciazione e inadeguatezza
2. Anche il contesto in cui si realizzano le due annunciazioni contribuisce ad esaltare l’eccellenza della fede di Maria. Nel racconto di Luca cogliamo la situazione più favorevole di Zaccaria e la inadeguatezza della sua risposta. Egli riceve l’annuncio dell’angelo nel tempio di Gerusalemme, all’altare davanti al "Santo dei Santi" (cf. Es 30, 6-8 ); l’angelo gli si rivolge mentre offre l’incenso, durante quindi il compimento della sua funzione sacerdotale, in un momento saliente della sua vita; la decisione divina gli viene comunicata durante una visione. Queste particolari circostanze favoriscono una più facile comprensione dell’autenticità divina del messaggio e costituiscono un motivo d’incoraggiamento ad accoglierlo prontamente.
L’annuncio a Maria avviene, invece, in un contesto più semplice e feriale, senza gli elementi esterni di sacralità che accompagnano quello fatto a Zaccaria. Luca non indica il luogo preciso in cui avviene l’Annunciazione della nascita del Signore: riferisce solo che Maria si trovava a Nazaret, villaggio poco importante, che non appare predestinato all’evento. Inoltre, l’evangelista non attribuisce singolare rilevanza al momento in cui l’angelo si rende presente, non precisandone le circostanze storiche. Nel contatto con il messaggero celeste l’attenzione verte sul contenuto delle sue parole, che esigono da Maria un ascolto intenso e una fede pura.
Quest’ultima considerazione ci permette di apprezzare la grandezza della fede in Maria, soprattutto se confrontata con la tendenza a chiedere con insistenza, ieri come oggi, segni sensibili per credere. L’assenso della Vergine alla Volontà divina è motivato, invece, solo dal suo amore per Dio.
3. A Maria è proposto di aderire ad una verità molto più alta di quella annunciata a Zaccaria. Questi è invitato a credere in una nascita meravigliosa che si realizzerà all’interno di un’unione matrimoniale sterile, che Dio vuole rendere feconda: intervento divino analogo a quelli di cui avevano beneficiato alcune donne dell’Antico Testamento: Sara ( Gen 17, 15-21 ; 18,10-14 ), Rachele ( Gen 30, 22 ), la madre di Sansone ( Gdc 13, 1-7 ), Anna, madre di Samuele ( 1Sam 1, 11-20 ).In tali episodi viene sottolineata soprattutto la gratuità del dono di Dio.
[Papa Giovanni Paolo II, Udienza Generale 3 luglio1996]
Supera la nostra immaginazione
Questi anziani genitori avevano sognato e anche preparato quel giorno, ma ormai non l’aspettavano più: si sentivano esclusi, umiliati, delusi: non avevano figli. Di fronte all’annuncio della nascita di un figlio, Zaccaria era rimasto incredulo, perché le leggi naturali non lo consentivano: erano vecchi, erano anziani; di conseguenza il Signore lo rese muto per tutto il tempo della gestazione.
E’ un segnale. Ma Dio non dipende dalle nostre logiche e dalle nostre limitate capacità umane. Bisogna imparare a fidarsi e a tacere di fronte al mistero di Dio e a contemplare in umiltà e silenzio la sua opera, che si rivela nella storia e che tante volte supera la nostra immaginazione.
[Papa Francesco, commento del 24 giugno 2018:
https://www.lalucedimaria.it/vangelo-oggi-luca-1-5-17/]
Qui c’è una culla vuota, la possiamo guardare. Può essere simbolo di speranza perché verrà il Bambino, può essere un oggetto da museo, vuota tutta la vita. Il nostro cuore è una culla. Com’è il mio cuore? E’ vuoto, sempre vuoto, ma è aperto per ricevere continuamente vita e dare vita? Per ricevere ed essere fecondo? O sarà un cuore conservato come un oggetto da museo che mai è stato aperto alla vita e a dare la vita?
[Papa Francesco, commento del 19 dicembre 2017:
https://www.lalucedimaria.it/vangelo-oggi-luca-15-25-audio-commento/]
Senso e valore del Dubbio. Annunciazione a Giuseppe
Annunciazione a Giuseppe: senso e valore del Dubbio
(Mt 1,18-24)
«Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande» [Patris Corde n.2].
Incarnazione: il Padre si colloca a fianco dei suoi figli e figlie. Non solo non teme di rendersi impuro nel contatto con le cose che riguardano le dinamiche umane: addirittura si riconosce nella loro Condizione.
Per questo motivo, dall’imbarazzo di Giuseppe scaturisce addirittura il culmine dell’intera Storia di Salvezza.
Le fonti attestano che non era affatto un personaggio col giglio in mano, ma forse questo può interessarci sino a un certo punto.
La narrazione di Mt colpisce, perché il discrimine e le possibilità d’irruzione (della vetta stessa) del Disegno di Dio sull’umanità sembrano scaturiti non da una certezza, ma da un Dubbio.
Il punto interrogativo coinvolge. Il disagio semina dentro un nuovo Germe. Strappa e abbatte le pianticelle tutte uguali dell’erba infestante la vita piena - che era Legge cesellata sulle apparenze.
Il “problema” guida a sognare ben altri orizzonti da aprire, e in prima persona. L’esitazione conduce fuori dalle gabbie mentali che mortificano i rapporti, prima ridotti a casistiche.
La perplessità fa valicare l’opinione comune, che attenua e spegne la Novità di Dio.
L’esitazione cerca fenditure esistenziali, perché vuole introdurci in territori di vita - dove anche gli altri possono attingere esperienze differenti, percezioni variegate, e momenti in cui avere in dono intuizioni decisive.
La sua Energia sapiente trova brecce e piccoli varchi; agisce per farci evolvere come figli dell’Eternità - anche suscitando disagi, che inondano l’esistenza di sospensioni creative e nuova passione.
La sua lucida Azione s’introduce attraverso Sogni che scrollano di dosso i progetti consueti, o stati d’animo che mettono in bilico; e le strettoie di un pensiero emarginato che fa ritrovare il motivo per cui siamo nati, scoprire la nostra parte nel mondo.
Ogni oscillazione, ogni dolore, ogni pericolo, ogni trasloco, possono diventare un ‘parto’ verso l’Originalità - senza prima le identificazioni.
L’Unicità non fa smarrire la Fonte che ‘veglia’ in noi. Guai a sottrarsi: perderemmo la nostra destinazione.
Lo Spirito che s’infila nei pertugi delle mentalità standard trova un punto intimo che consente di fiorire diversamente adesso, in grado di far venir fuori l’essenza di chi siamo autenticamente, smettendo di copiare cliché.
Allora non continueremo a chiederci Ma di chi è la colpa? Come tamponare la situazione? A chi conviene appoggiarsi?. Bensì: Qual è la nuova ‘vita’ che devo esplorare? Cosa c’è ancora da scoprire?.
Infatti il morso dei dubbi non fa diventare credenti-spazzatura, come ipotizzato nelle religioni disciplinate, legaliste - nelle filosofie puritane dalla sapienza artificiosa - bensì amici, figli adottivi [ossia scelti] ed eredi.
Grazie alla Relazione di Fede, non siamo più persi nel deserto - perché le tante cose e gli azzardi diventano dialogo di peso specifico: siamo a Casa, nel rispetto del nostro misterioso carattere e Chiamata.
Iniziamo come Giuseppe a essere presenti a noi stessi. E cambiando sguardo, si godrà la Bellezza del Nuovo.
«San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine» [Patris Corde intr.].
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
In quale occasione il ‘dubbio’ ti ha aperto orizzonti da sbalordire? Nei momenti belli e colorati della vita sei forse partito da una tua certezza?
[Feria propria del 18 dicembre]
Annunciazione a Giuseppe
Contatto con la terra: devianze e Risalita
Incarnazione disinvolta, in tenuità e densità
(Mt 1,1-17)
Nell’oriente antico le genealogie indicavano solo uomini, e sorprende che Mt riporti il nome di ben cinque donne - considerate creature solo servili, inaffidabili, impure per natura.
Ma nella vicenda delle quattro compagne di Maria c’è non poco di a-normale [anche per il modello di vita scelto] che però vale la pena.
Eccoci allora interpellati dal Vangelo sul peso da dare alla rigidità delle norme, le quali nella storia della spiritualità hanno spesso divorato l’essere spontaneo dei chiamati dal Padre (semplicemente a esprimersi).
Anche le culture animate da Sapienza di Natura ne attestano il peso.
Scrive il Tao Tê Ching (LVII): «Quando con la correzione si governa il mondo, con la falsità s’adopran l’armi [...] Per questo il santo dice: io non agisco e il popolo da sé si trasforma [...] io non bramo e il popolo da sé si fa semplice».
Per giungere alla pienezza umana del Figlio, Dio non ha preteso superare le vicende concrete, viceversa le ha assunte e valorizzate.
Il cammino che porta a Cristo non è questione di scalate, né di risultati o performance da calibrare sempre meglio in un crescendo lineare quindi moralizzatore e dirigista (che non impone svolte che contano, né risolve i veri problemi).
Commentando il Tao (i) il maestro Ho-shang Kung scrive: «Mistero è il Cielo. Dice che tanto l’uomo che ha desideri quanto quello che non ne ha ricevono parimenti il ch’ì dal Cielo. All’interno del cielo c’è un altro cielo; nel ch’ì c’è densità e tenuità».
Nella storia, l’Eterno riesce a dare ali spiegate non tanto alla forza e al genio, ma a tutte le povere origini, alla pochezza della nostra natura, la quale d’improvviso si tramuta in ricchezza totalmente imprevedibile.
E se di continuo strappiamo il filo, il Signore lo riannoda - non per aggiustare, metterci una pezza e riprendere come prima, ma per rifare un’intera trama nuova. Proprio a partire dalle cadute.
Sono quei momenti del discrimine terra-terra che costringono l'umanità a cambiare direzione simbolo e non ripetersi, stagnando nel circuito dei soliti perimetri cerebrali e puristi - abitudinari, e dove tutto è normale.
In seguito a schianti interiori e ripensamenti, quante persone hanno realizzato il proprio destino, deviando il percorso tracciato, quieto, protetto e confortevole (Cottolengo, madre Teresa, così via)!
Dal fango della palude spuntano fiori splendidi e puliti, che neppure somigliano a quelli cui nelle varie fasi della vita avevamo mai immaginato di poter contemplare.
I ruzzoloni dei protagonisti della storia della salvezza non sono arrivati per debolezza. Erano segnali d’un cattivo o parziale utilizzo delle risorse; stimoli a modificare l’occhio, rivalutare il punto di vista e tante speranze.
Quei crolli hanno configurato nuove sfide: sono state interpretati come provocazioni forti: a spostare energie e cambiare binario.
Le Risalite conseguenti ai ribassi si sono tramutate in nuove opportunità, affatto impreviste, appieno discordanti con le soluzioni già pronte che spengono i caratteri.
Anche la nostra crisi diventa seria solo quando i fallimenti non sfociano in nuove cognizioni e differenti percorsi che non avevamo pensato (forse in nessuno dei nostri buoni propositi).
Strano questo legame tra i nostri abissi e gli apici dello Spirito: è l’Incarnazione, nessuna teoria - tutta realtà.
Non esiste Dono che ci rassomiglia al top divino e che giunga a noi senza passare e coinvolgere la dimensione della finitudine.
I buchi nell’acqua trasmettono la cifra tutta umana di quel che siamo - dietro le illusioni o le stesse apparenze che non vogliamo deporre, per autoconvincerci di essere invece “personaggi” identificati.
Ma le ambivalenze e le falle continuano a voler schiodare il nostro sguardo e destino altrove, rispetto alle attese comuni [oggi anche il parossismo del punto nei sondaggi].
Dietro la maschera e oltre le convinzioni acquisite dall’ambiente, dai modi o dalle procedure... c’è il grande Segreto del Padre su di noi.
Proprio le discese spiritualizzano, attraverso un lavorio dell’anima che viene speronata dalle vicende, affinché volga ad acquistare nuove consapevolezze, interiorizzi differenti valutazioni, veda e abbracci altri variegati orizzonti anche missionari.
Il crack che butta giù può essere più consistente di ogni progresso; non perché avvia un’ascesi: diventa contatto con la “terra” - dove troviamo la linfa che ci corrisponde davvero, per rigenerare.
Il calo o addirittura la rovina di uno status rassicurante ha in ogni accadimento una funzione propulsiva, rigenerativa, trasmutativa; normale, in fondo, e in cui la storia di Dio si riconosce totalmente.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Quali sono stati i tuoi momenti di svolta?
Quale deviazione ti ha realizzato?
Non solo mediante uomini, bensì Con loro
Con l’odierna Liturgia entriamo nell’ultimo tratto del cammino dell’Avvento, che esorta ad intensificare la nostra preparazione, per celebrare con fede e con gioia il Natale del Signore, accogliendo con intimo stupore Dio che si fa vicino all’uomo, a ciascuno di noi.
La prima lettura ci presenta l’anziano Giacobbe che raduna i suoi figli per la benedizione: è un evento di grande intensità e commozione. Questa benedizione è come un sigillo della fedeltà all’alleanza con Dio, ma è anche una visione profetica, che guarda in avanti e indica una missione. Giacobbe è il padre che, attraverso le vie non sempre lineari della propria storia, giunge alla gioia di radunare i suoi figli attorno a sé e tracciare il futuro di ciascuno e della loro discendenza. In particolare, oggi abbiamo ascoltato il riferimento alla tribù di Giuda, di cui si esalta la forza regale, rappresentata dal leone, come pure alla monarchia di Davide, rappresentata dallo scettro, dal bastone del comando, che allude alla venuta del Messia. Così, in questa duplice immagine, traspare il futuro mistero del leone che si fa agnello, del re il cui bastone di comando è la Croce, segno della vera regalità. Giacobbe ha preso progressivamente coscienza del primato di Dio, ha compreso che il suo cammino è guidato e sostenuto dalla fedeltà del Signore, e non può che rispondere con adesione piena all’alleanza e al disegno di salvezza di Dio, diventando a sua volta, insieme con la propria discendenza, anello del progetto divino.
Il brano del Vangelo di Matteo ci presenta la "genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo" (Mt 1,1), sottolineando ed esplicitando ulteriormente la fedeltà di Dio alla promessa, che Egli attua non soltanto mediante gli uomini, ma con loro e, come per Giacobbe, talora attraverso vie tortuose e impreviste. Il Messia atteso, oggetto della promessa, è vero Dio, ma anche vero uomo; Figlio di Dio, ma anche Figlio partorito dalla Vergine, Maria di Nazaret, carne santa di Abramo, nel cui seme saranno benedetti tutti i popoli della terra (cfr Gen 22,18). In questa genealogia, oltre a Maria, vengono ricordate quattro donne. Non sono Sara, Rebecca, Lia, Rachele, cioè le grandi figure della storia d’Israele. Paradossalmente, invece, sono quattro donne pagane: Racab, Rut, Betsabea, Tamar, che apparentemente "disturbano" la purezza di una genealogia. Ma in queste donne pagane, che appaiono in punti determinanti della storia della salvezza, traspare il mistero della chiesa dei pagani, l’universalità della salvezza. Sono donne pagane nelle quali appare il futuro, l’universalità della salvezza. Sono anche donne peccatrici e così appare in loro anche il mistero della grazia: non sono le nostre opere che redimono il mondo, ma è il Signore che ci dà la vera vita. Sono donne peccatrici, sì, in cui appare la grandezza della grazia della quale noi tutti abbiamo bisogno. Queste donne rivelano tuttavia una risposta esemplare alla fedeltà di Dio, mostrando la fede nel Dio di Israele. E così vediamo trasparire la chiesa dei pagani, mistero della grazia, la fede come dono e come cammino verso la comunione con Dio. La genealogia di Matteo, pertanto, non è semplicemente l’elenco delle generazioni: è la storia realizzata primariamente da Dio, ma con la risposta dell’umanità. È una genealogia della grazia e della fede: proprio sulla fedeltà assoluta di Dio e sulla fede solida di queste donne poggia la prosecuzione della promessa fatta a Israele
[Papa Benedetto, omelia al Centro Aletti, 17 dicembre 2009]
L’uomo, cognome di Dio
L’uomo è il cognome di Dio: il Signore infatti prende il nome da ognuno di noi — sia che siamo santi, sia che siamo peccatori — per farlo diventare il proprio cognome. Perché incarnandosi il Signore ha fatto storia con l’umanità: la sua gioia è stata condividere la sua vita con noi, «e questo fa piangere: tanto amore, tanta tenerezza».
È con il pensiero rivolto al Natale ormai imminente che Papa Francesco ha commentato martedì 17 dicembre le due letture proposte dalla liturgia della parola, tratte rispettivamente dalla Genesi (49, 2.8-10) e dal Vangelo di Matteo (1, 1-17). Nel giorno del suo settantasettesimo compleanno, il Santo Padre ha presieduto come di consueto la messa mattutina nella cappella di Santa Marta. Ha concelebrato tra gli altri il cardinale decano Angelo Sodano, che gli ha espresso gli auguri di tutto il collegio cardinalizio.
All’omelia, incentrata sulla presenza di Dio nella storia dell’umanità, il vescovo di Roma ha individuato in due termini — eredità e genealogia — le chiavi per interpretare rispettivamente la prima lettura (riguardante la profezia di Giacobbe che raduna i propri figli e predice una discendenza gloriosa per Giuda) e il brano evangelico contenente la genealogia di Gesù. Soffermandosi in particolare su quest’ultima, ha sottolineato che non si tratta di «un elenco telefonico», ma di «un argomento importante: è pura storia», perché «Dio ha inviato il suo figlio» in mezzo agli uomini. E, ha aggiunto, «Gesù è consostanziale al padre, Dio; ma anche consostanziale alla madre, una donna. E questa è quella consostanzialità della madre: Dio si è fatto storia, Dio ha voluto farsi storia. È con noi. Ha fatto cammino con noi».
Un cammino — ha proseguito il vescovo di Roma — iniziato da lontano, nel Paradiso, subito dopo il peccato originale. Da quel momento, infatti, il Signore «ha avuto questa idea: fare cammino con noi». Perciò «ha chiamato Abramo, il primo nominato in questa lista, in questo elenco, e lo ha invitato a camminare. E Abramo ha cominciato quel cammino: ha generato Isacco, e Isacco Giacobbe, e Giacobbe Giuda». E così via, avanti nella storia dell’umanità. «Dio cammina con il suo popolo», dunque, perché «non ha voluto venire a salvarci senza storia; lui ha voluto fare storia con noi».
Una storia, ha affermato il Pontefice, fatta di santità e di peccato, perché nell’elenco della genealogia di Gesù ci sono santi e peccatori. Tra i primi il Papa ha ricordato «il nostro padre Abramo» e «Davide, che dopo il peccato si è convertito». Tra i secondi ha individuato «peccatori di alto livello, che hanno fatto peccati grossi», ma con i quali Dio ugualmente «ha fatto storia». Peccatori che non hanno saputo rispondere al progetto che Dio aveva immaginato per loro: come «Salomone, tanto grande e intelligente, finito come un poveraccio che non sapeva nemmeno come si chiamasse». Eppure, ha constatato Papa Francesco, Dio era anche con lui. «E questo è il bello: Dio fa storia con noi. Di più, quando Dio vuol dire chi è, dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe».
Ecco perché alla domanda «qual è il cognome di Dio?» per Papa Francesco è possibile rispondere: «Siamo noi, ognuno di noi. Lui prende da noi il nome per farne il suo cognome». E nell’esempio offerto dal Pontefice non ci sono solo i padri della nostra fede, ma anche gente comune. «Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Pedro, di Marietta, di Armony, di Marisa, di Simone, di tutti. Da noi prende il cognome. Il cognome di Dio è ognuno di noi», ha spiegato.
Da qui la constatazione che prendendo «il cognome dal nostro nome, Dio ha fatto storia con noi»; anzi, di più: «si è lasciato scrivere la storia da noi». E noi ancora oggi continuiamo a scrivere «questa storia», che è fatta «di grazia e di peccato», mentre il Signore non si stanca di venirci dietro: «questa è l’umiltà di Dio, la pazienza di Dio, l’amore di Dio». Del resto, anche «il libro della Sapienza dice che la gioia del Signore è tra i figli dell’uomo, con noi».
Ecco allora che «avvicinandosi il Natale», a Papa Francesco — com’egli stesso ha confidato concludendo la sua riflessione — è venuto naturale pensare: «Se lui ha fatto la sua storia con noi, se lui ha preso il suo cognome da noi, se lui ha lasciato che noi scrivessimo la sua storia», noi da parte nostra dovremmo lasciare che Dio scriva la nostra. Perché, ha chiarito, «la santità» è proprio «lasciare che il Signore scriva la nostra storia». E questo è l’augurio di Natale che il Pontefice ha voluto fare «per tutti noi». Un augurio che è un invito ad aprire il cuore: «Fa’ che il Signore ti scriva la storia e che tu lasci che te la scriva».
[Papa Francesco, omelia s. Marta, in L’Osservatore Romano 18/12/2013]
Annunciazione a Giuseppe: senso e valore del Dubbio
(Mt 1,16.18-21.24)
«Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande» [Patris Corde n.2].
Nei Vangeli dell’infanzia di Mt Dio assume due Nomi: Redentore [Yeshua: Dio è Salvatore] e Con-noi. Il senso di tali prerogative divine non è meccanico, bensì teologico.
Il Nome proprio del Figlio Gesù descrive la sua Opera di recupero di tutto l’essere. E l’attributo caratteristico Immanu’el (tratto da Isaia) ne puntualizza i molti recapiti - i suoi tanti indirizzi, che siamo ciascuno di noi, in crescita nel tempo.
Incarnazione: il Padre si colloca a fianco dei suoi figli e figlie. Non solo non teme di rendersi impuro nel contatto con le cose che riguardano le dinamiche umane: addirittura si riconosce nella loro Condizione.
Per questo motivo, dall’imbarazzo di Giuseppe scaturisce addirittura il culmine dell’intera Storia di Salvezza.
Le fonti attestano che non era affatto un personaggio col giglio in mano, ma forse questo può interessarci sino a un certo punto.
La narrazione di Mt colpisce, perché il discrimine e le possibilità d’irruzione (della vetta stessa) del Disegno di Dio sull’umanità sembrano scaturiti non da una certezza, ma da un Dubbio.
Il punto interrogativo coinvolge. Il disagio semina dentro un nuovo Germe. Strappa e abbatte le pianticelle tutte uguali dell’erba infestante la vita piena - che era Legge cesellata sulle apparenze.
Il “problema” guida a sognare ben altri orizzonti da aprire, e in prima persona; perché la soluzione non è a portata di mano.
La perplessità conduce fuori dalle gabbie mentali che mortificano i rapporti prima ridotti a casistiche - sorvolando gl’ingranaggi che spersonalizzano.
La perplessità fa valicare l’opinione comune, che attenua e spegne la Novità di Dio.
L’esitazione cerca fenditure esistenziali, perché vuole introdurci in territori di vita - dove anche gli altri possono attingere esperienze differenti, percezioni variegate, e momenti in cui avere in dono intuizioni decisive.
La sua Energia sapiente trova brecce e piccoli varchi; agisce per farci evolvere come figli dell’Eternità - anche suscitando disagi che inondano l’esistenza di sospensioni creative e nuova passione.
La sua lucida Azione s’introduce attraverso Sogni che scrollano di dosso i progetti consueti, o stati d’animo che mettono in bilico; e le strettoie di un pensiero emarginato che fa ritrovare il motivo per cui siamo nati, scoprire la nostra parte nel mondo.
Ogni oscillazione, ogni dolore, ogni pericolo, ogni trasloco, possono diventare un parto verso l’Originalità - senza prima le identificazioni.
L’Unicità non fa smarrire la Fonte che “veglia” in noi. Guai a sottrarsi: perderemmo la nostra destinazione.
Ciò mentre le cerchie dei risoluti restano lì e inaridiscono, proprio perché sempre pronte alla spiegazione di tutto.
Così ad es. come per la Famiglia di Nazaret, la vita in solitudine - costretta o non - diventa rigenerante, più che terribile.
Lo Spirito che s’infila nei pertugi delle mentalità standard trova un “punto” intimo che consente di fiorire diversamente adesso, in grado di far venir fuori l’essenza di chi siamo autenticamente, smettendo di copiare cliché.
Così invece di chiedersi come mai sia capitato qualcosa, dopo la prima esperienza discriminante che non teme la paura di restare isolati, forse rientriamo più di frequente nel nostro Nucleo, il quale senza posa zampilla per un Dialogo superiore.
Allora non continueremo a chiederci ‘Ma di chi è la colpa? Come tamponare la situazione? A chi conviene appoggiarsi?’. Bensì: ‘Qual è la nuova vita che devo esplorare? Cosa c’è ancora da scoprire?’.
Si uscirà con ben altra virtù di vocazione, perché lo Spirito Santo che fa breccia nelle crepe delle norme che rendono conformisti, poi smantella e rovescia quei muri. Infine dilaga, per costruire la sua storia - che non è prevedibile, “a modo” come quella di tutti i legati alla comparazione.
Sentire il fastidio di partecipare a rituali di composta identificazione causa molti problemi, ma può essere la grande occasione della vita per dilatare gli orizzonti... anche di coloro che non gradiscono percorrere la via mediocre dell’assicurarsi - rendendosi per timore dipendenti dall’opinione, dai luoghi comuni, dal sentirsi subito festeggiati.
Felicità apparente. Infatti il morso dei dubbi non fa diventare credenti-spazzatura, come ipotizzato nelle religioni disciplinate, legaliste - nelle filosofie puritane dalla sapienza artificiosa - bensì amici, figli adottivi [ossia scelti] ed eredi.
Grazie alla Relazione di Fede, non siamo più persi nel deserto - perché le tante cose e gli azzardi diventano dialogo di peso specifico: siamo a Casa, nel rispetto del nostro misterioso carattere e Chiamata.
Già qui e ora ci spostiamo dalle tante cose che vincolano di costrizioni e pretese il nostro Centro - e sia il pensiero che l’azione.
Solo in tal guisa non siamo più folla mitologica o assuefatta, stracolma di colpe, doveri e appartenenze - bensì Famiglia e informalità colloquiale delle dissonanze.
Non più massa, ma (a tutto tondo) Persone: proprio nel nostro essere nel limite facciamo rima con grande-Missione.
Iniziamo come Giuseppe a essere presenti a noi stessi. E cambiando sguardo, si godrà la Bellezza del Nuovo.
«San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine» [Patris Corde intr.].
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Quali sono stati i tuoi momenti di svolta? Quale deviazione ti ha realizzato?
In quale occasione il dubbio ti ha aperto orizzonti da sbalordire?
Quando e se hai cambiato lo sguardo conformista, hai conosciuto o meno l’accendersi nel tuo mondo interiore di prospettive, relazioni ed energie rigeneranti?
Come hai percepito accanto e “visto” o “sognato” ciò che prima restava Invisibile e Altrove?
Sei forse partito da una tua certezza?
Contatto con la terra: devianze e Risalita
Incarnazione disinvolta, in tenuità e densità
(Mt 1,1-17)
Nell’oriente antico le genealogie indicavano solo uomini, e sorprende che Mt riporti il nome di ben cinque donne - considerate creature solo servili, inaffidabili, impure per natura.
Ma nella vicenda delle quattro compagne di Maria c’è non poco di a-normale [anche per il modello di vita scelto] che però vale la pena.
Eccoci allora interpellati dal Vangelo sul peso da dare alla rigidità delle norme, le quali nella storia della spiritualità hanno spesso divorato l’essere spontaneo dei chiamati dal Padre (semplicemente a esprimersi).
Anche le culture animate da Sapienza di Natura ne attestano il peso.
Scrive il Tao Tê Ching (LVII): «Quando con la correzione si governa il mondo, con la falsità s’adopran l’armi [...] Per questo il santo dice: io non agisco e il popolo da sé si trasforma [...] io non bramo e il popolo da sé si fa semplice».
Per giungere alla pienezza umana del Figlio, Dio non ha preteso superare le vicende concrete, viceversa le ha assunte e valorizzate.
Il cammino che porta a Cristo non è questione di scalate, né di risultati o performance da calibrare sempre meglio in un crescendo lineare quindi moralizzatore e dirigista (che non impone svolte che contano, né risolve i veri problemi).
Commentando il Tao (i) il maestro Ho-shang Kung scrive: «Mistero è il Cielo. Dice che tanto l’uomo che ha desideri quanto quello che non ne ha ricevono parimenti il ch’ì dal Cielo. All’interno del cielo c’è un altro cielo; nel ch’ì c’è densità e tenuità».
Nella storia, l’Eterno riesce a dare ali spiegate non tanto alla forza e al genio, ma a tutte le povere origini, alla pochezza della nostra natura, la quale d’improvviso si tramuta in ricchezza totalmente imprevedibile.
E se di continuo strappiamo il filo, il Signore lo riannoda - non per aggiustare, metterci una pezza e riprendere come prima, ma per rifare un’intera trama nuova. Proprio a partire dalle cadute.
Sono quei momenti del discrimine terra-terra che costringono l'umanità a cambiare direzione simbolo e non ripetersi, stagnando nel circuito dei soliti perimetri cerebrali e puristi - abitudinari, e dove tutto è normale.
In seguito a schianti interiori e ripensamenti, quante persone hanno realizzato il proprio destino, deviando il percorso tracciato, quieto, protetto e confortevole (Cottolengo, madre Teresa, così via)!
Dal fango della palude spuntano fiori splendidi e puliti, che neppure somigliano a quelli cui nelle varie fasi della vita avevamo mai immaginato di poter contemplare.
I ruzzoloni dei protagonisti della storia della salvezza non sono arrivati per debolezza. Erano segnali d’un cattivo o parziale utilizzo delle risorse; stimoli a modificare l’occhio, rivalutare il punto di vista e tante speranze.
Quei crolli hanno configurato nuove sfide: sono state interpretati come provocazioni forti: a spostare energie e cambiare binario.
Le Risalite conseguenti ai ribassi si sono tramutate in nuove opportunità, affatto impreviste, appieno discordanti con le soluzioni già pronte che spengono i caratteri.
Anche la nostra crisi diventa seria solo quando i fallimenti non sfociano in nuove cognizioni e differenti percorsi che non avevamo pensato (forse in nessuno dei nostri buoni propositi).
Strano questo legame tra i nostri abissi e gli apici dello Spirito: è l’Incarnazione, nessuna teoria - tutta realtà.
Non esiste Dono che ci rassomiglia al top divino e che giunga a noi senza passare e coinvolgere la dimensione della finitudine.
I buchi nell’acqua trasmettono la cifra tutta umana di quel che siamo - dietro le illusioni o le stesse apparenze che non vogliamo deporre, per autoconvincerci di essere invece “personaggi” identificati.
Ma le ambivalenze e le falle continuano a voler schiodare il nostro sguardo e destino altrove, rispetto alle attese comuni [oggi anche il parossismo del punto nei sondaggi].
Dietro la maschera e oltre le convinzioni acquisite dall’ambiente, dai modi o dalle procedure... c’è il grande Segreto del Padre su di noi.
Proprio le discese spiritualizzano, attraverso un lavorio dell’anima che viene speronata dalle vicende, affinché volga ad acquistare nuove consapevolezze, interiorizzi differenti valutazioni, veda e abbracci altri variegati orizzonti anche missionari.
Il crack che butta giù può essere più consistente di ogni progresso; non perché avvia un’ascesi: diventa contatto con la “terra” - dove troviamo la linfa che ci corrisponde davvero, per rigenerare.
Il calo o addirittura la rovina di uno status rassicurante ha in ogni accadimento una funzione propulsiva, rigenerativa, trasmutativa; normale, in fondo, e in cui la storia di Dio si riconosce totalmente.
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Quali sono stati i tuoi momenti di svolta?
Quale deviazione ti ha realizzato?
Non solo mediante uomini, bensì Con loro
Con l’odierna Liturgia entriamo nell’ultimo tratto del cammino dell’Avvento, che esorta ad intensificare la nostra preparazione, per celebrare con fede e con gioia il Natale del Signore, accogliendo con intimo stupore Dio che si fa vicino all’uomo, a ciascuno di noi.
La prima lettura ci presenta l’anziano Giacobbe che raduna i suoi figli per la benedizione: è un evento di grande intensità e commozione. Questa benedizione è come un sigillo della fedeltà all’alleanza con Dio, ma è anche una visione profetica, che guarda in avanti e indica una missione. Giacobbe è il padre che, attraverso le vie non sempre lineari della propria storia, giunge alla gioia di radunare i suoi figli attorno a sé e tracciare il futuro di ciascuno e della loro discendenza. In particolare, oggi abbiamo ascoltato il riferimento alla tribù di Giuda, di cui si esalta la forza regale, rappresentata dal leone, come pure alla monarchia di Davide, rappresentata dallo scettro, dal bastone del comando, che allude alla venuta del Messia. Così, in questa duplice immagine, traspare il futuro mistero del leone che si fa agnello, del re il cui bastone di comando è la Croce, segno della vera regalità. Giacobbe ha preso progressivamente coscienza del primato di Dio, ha compreso che il suo cammino è guidato e sostenuto dalla fedeltà del Signore, e non può che rispondere con adesione piena all’alleanza e al disegno di salvezza di Dio, diventando a sua volta, insieme con la propria discendenza, anello del progetto divino.
Il brano del Vangelo di Matteo ci presenta la "genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo" (Mt 1,1), sottolineando ed esplicitando ulteriormente la fedeltà di Dio alla promessa, che Egli attua non soltanto mediante gli uomini, ma con loro e, come per Giacobbe, talora attraverso vie tortuose e impreviste. Il Messia atteso, oggetto della promessa, è vero Dio, ma anche vero uomo; Figlio di Dio, ma anche Figlio partorito dalla Vergine, Maria di Nazaret, carne santa di Abramo, nel cui seme saranno benedetti tutti i popoli della terra (cfr Gen 22,18). In questa genealogia, oltre a Maria, vengono ricordate quattro donne. Non sono Sara, Rebecca, Lia, Rachele, cioè le grandi figure della storia d’Israele. Paradossalmente, invece, sono quattro donne pagane: Racab, Rut, Betsabea, Tamar, che apparentemente "disturbano" la purezza di una genealogia. Ma in queste donne pagane, che appaiono in punti determinanti della storia della salvezza, traspare il mistero della chiesa dei pagani, l’universalità della salvezza. Sono donne pagane nelle quali appare il futuro, l’universalità della salvezza. Sono anche donne peccatrici e così appare in loro anche il mistero della grazia: non sono le nostre opere che redimono il mondo, ma è il Signore che ci dà la vera vita. Sono donne peccatrici, sì, in cui appare la grandezza della grazia della quale noi tutti abbiamo bisogno. Queste donne rivelano tuttavia una risposta esemplare alla fedeltà di Dio, mostrando la fede nel Dio di Israele. E così vediamo trasparire la chiesa dei pagani, mistero della grazia, la fede come dono e come cammino verso la comunione con Dio. La genealogia di Matteo, pertanto, non è semplicemente l’elenco delle generazioni: è la storia realizzata primariamente da Dio, ma con la risposta dell’umanità. È una genealogia della grazia e della fede: proprio sulla fedeltà assoluta di Dio e sulla fede solida di queste donne poggia la prosecuzione della promessa fatta a Israele
[Papa Benedetto, omelia al Centro Aletti, 17 dicembre 2009]
L’uomo, cognome di Dio
L’uomo è il cognome di Dio: il Signore infatti prende il nome da ognuno di noi — sia che siamo santi, sia che siamo peccatori — per farlo diventare il proprio cognome. Perché incarnandosi il Signore ha fatto storia con l’umanità: la sua gioia è stata condividere la sua vita con noi, «e questo fa piangere: tanto amore, tanta tenerezza».
È con il pensiero rivolto al Natale ormai imminente che Papa Francesco ha commentato martedì 17 dicembre le due letture proposte dalla liturgia della parola, tratte rispettivamente dalla Genesi (49, 2.8-10) e dal Vangelo di Matteo (1, 1-17). Nel giorno del suo settantasettesimo compleanno, il Santo Padre ha presieduto come di consueto la messa mattutina nella cappella di Santa Marta. Ha concelebrato tra gli altri il cardinale decano Angelo Sodano, che gli ha espresso gli auguri di tutto il collegio cardinalizio.
All’omelia, incentrata sulla presenza di Dio nella storia dell’umanità, il vescovo di Roma ha individuato in due termini — eredità e genealogia — le chiavi per interpretare rispettivamente la prima lettura (riguardante la profezia di Giacobbe che raduna i propri figli e predice una discendenza gloriosa per Giuda) e il brano evangelico contenente la genealogia di Gesù. Soffermandosi in particolare su quest’ultima, ha sottolineato che non si tratta di «un elenco telefonico», ma di «un argomento importante: è pura storia», perché «Dio ha inviato il suo figlio» in mezzo agli uomini. E, ha aggiunto, «Gesù è consostanziale al padre, Dio; ma anche consostanziale alla madre, una donna. E questa è quella consostanzialità della madre: Dio si è fatto storia, Dio ha voluto farsi storia. È con noi. Ha fatto cammino con noi».
Un cammino — ha proseguito il vescovo di Roma — iniziato da lontano, nel Paradiso, subito dopo il peccato originale. Da quel momento, infatti, il Signore «ha avuto questa idea: fare cammino con noi». Perciò «ha chiamato Abramo, il primo nominato in questa lista, in questo elenco, e lo ha invitato a camminare. E Abramo ha cominciato quel cammino: ha generato Isacco, e Isacco Giacobbe, e Giacobbe Giuda». E così via, avanti nella storia dell’umanità. «Dio cammina con il suo popolo», dunque, perché «non ha voluto venire a salvarci senza storia; lui ha voluto fare storia con noi».
Una storia, ha affermato il Pontefice, fatta di santità e di peccato, perché nell’elenco della genealogia di Gesù ci sono santi e peccatori. Tra i primi il Papa ha ricordato «il nostro padre Abramo» e «Davide, che dopo il peccato si è convertito». Tra i secondi ha individuato «peccatori di alto livello, che hanno fatto peccati grossi», ma con i quali Dio ugualmente «ha fatto storia». Peccatori che non hanno saputo rispondere al progetto che Dio aveva immaginato per loro: come «Salomone, tanto grande e intelligente, finito come un poveraccio che non sapeva nemmeno come si chiamasse». Eppure, ha constatato Papa Francesco, Dio era anche con lui. «E questo è il bello: Dio fa storia con noi. Di più, quando Dio vuol dire chi è, dice: io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe».
Ecco perché alla domanda «qual è il cognome di Dio?» per Papa Francesco è possibile rispondere: «Siamo noi, ognuno di noi. Lui prende da noi il nome per farne il suo cognome». E nell’esempio offerto dal Pontefice non ci sono solo i padri della nostra fede, ma anche gente comune. «Io sono il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Pedro, di Marietta, di Armony, di Marisa, di Simone, di tutti. Da noi prende il cognome. Il cognome di Dio è ognuno di noi», ha spiegato.
Da qui la constatazione che prendendo «il cognome dal nostro nome, Dio ha fatto storia con noi»; anzi, di più: «si è lasciato scrivere la storia da noi». E noi ancora oggi continuiamo a scrivere «questa storia», che è fatta «di grazia e di peccato», mentre il Signore non si stanca di venirci dietro: «questa è l’umiltà di Dio, la pazienza di Dio, l’amore di Dio». Del resto, anche «il libro della Sapienza dice che la gioia del Signore è tra i figli dell’uomo, con noi».
Ecco allora che «avvicinandosi il Natale», a Papa Francesco — com’egli stesso ha confidato concludendo la sua riflessione — è venuto naturale pensare: «Se lui ha fatto la sua storia con noi, se lui ha preso il suo cognome da noi, se lui ha lasciato che noi scrivessimo la sua storia», noi da parte nostra dovremmo lasciare che Dio scriva la nostra. Perché, ha chiarito, «la santità» è proprio «lasciare che il Signore scriva la nostra storia». E questo è l’augurio di Natale che il Pontefice ha voluto fare «per tutti noi». Un augurio che è un invito ad aprire il cuore: «Fa’ che il Signore ti scriva la storia e che tu lasci che te la scriva».
[Papa Francesco, omelia s. Marta, in L’Osservatore Romano 18/12/2013]
Annunciazione a Giuseppe: senso e valore del Dubbio
(Mt 1,16.18-21.24)
«Anche attraverso l’angustia di Giuseppe passa la volontà di Dio, la sua storia, il suo progetto. Giuseppe ci insegna così che avere fede in Dio comprende pure il credere che Egli può operare anche attraverso le nostre paure, le nostre fragilità, la nostra debolezza. E ci insegna che, in mezzo alle tempeste della vita, non dobbiamo temere di lasciare a Dio il timone della nostra barca. A volte noi vorremmo controllare tutto, ma Lui ha sempre uno sguardo più grande» [Patris Corde n.2].
Nei Vangeli dell’infanzia di Mt Dio assume due Nomi: Redentore [Yeshua: Dio è Salvatore] e Con-noi. Il senso di tali prerogative divine non è meccanico, bensì teologico.
Il Nome proprio del Figlio Gesù descrive la sua Opera di recupero di tutto l’essere. E l’attributo caratteristico Immanu’el (tratto da Isaia) ne puntualizza i molti recapiti - i suoi tanti indirizzi, che siamo ciascuno di noi, in crescita nel tempo.
Incarnazione: il Padre si colloca a fianco dei suoi figli e figlie. Non solo non teme di rendersi impuro nel contatto con le cose che riguardano le dinamiche umane: addirittura si riconosce nella loro Condizione.
Per questo motivo, dall’imbarazzo di Giuseppe scaturisce addirittura il culmine dell’intera Storia di Salvezza.
Le fonti attestano che non era affatto un personaggio col giglio in mano, ma forse questo può interessarci sino a un certo punto.
La narrazione di Mt colpisce, perché il discrimine e le possibilità d’irruzione (della vetta stessa) del Disegno di Dio sull’umanità sembrano scaturiti non da una certezza, ma da un Dubbio.
Il punto interrogativo coinvolge. Il disagio semina dentro un nuovo Germe. Strappa e abbatte le pianticelle tutte uguali dell’erba infestante la vita piena - che era Legge cesellata sulle apparenze.
Il “problema” guida a sognare ben altri orizzonti da aprire, e in prima persona; perché la soluzione non è a portata di mano.
La perplessità conduce fuori dalle gabbie mentali che mortificano i rapporti prima ridotti a casistiche - sorvolando gl’ingranaggi che spersonalizzano.
La perplessità fa valicare l’opinione comune, che attenua e spegne la Novità di Dio.
L’esitazione cerca fenditure esistenziali, perché vuole introdurci in territori di vita - dove anche gli altri possono attingere esperienze differenti, percezioni variegate, e momenti in cui avere in dono intuizioni decisive.
La sua Energia sapiente trova brecce e piccoli varchi; agisce per farci evolvere come figli dell’Eternità - anche suscitando disagi che inondano l’esistenza di sospensioni creative e nuova passione.
La sua lucida Azione s’introduce attraverso Sogni che scrollano di dosso i progetti consueti, o stati d’animo che mettono in bilico; e le strettoie di un pensiero emarginato che fa ritrovare il motivo per cui siamo nati, scoprire la nostra parte nel mondo.
Ogni oscillazione, ogni dolore, ogni pericolo, ogni trasloco, possono diventare un parto verso l’Originalità - senza prima le identificazioni.
L’Unicità non fa smarrire la Fonte che “veglia” in noi. Guai a sottrarsi: perderemmo la nostra destinazione.
Ciò mentre le cerchie dei risoluti restano lì e inaridiscono, proprio perché sempre pronte alla spiegazione di tutto.
Così ad es. come per la Famiglia di Nazaret, la vita in solitudine - costretta o non - diventa rigenerante, più che terribile.
Lo Spirito che s’infila nei pertugi delle mentalità standard trova un “punto” intimo che consente di fiorire diversamente adesso, in grado di far venir fuori l’essenza di chi siamo autenticamente, smettendo di copiare cliché.
Così invece di chiedersi come mai sia capitato qualcosa, dopo la prima esperienza discriminante che non teme la paura di restare isolati, forse rientriamo più di frequente nel nostro Nucleo, il quale senza posa zampilla per un Dialogo superiore.
Allora non continueremo a chiederci ‘Ma di chi è la colpa? Come tamponare la situazione? A chi conviene appoggiarsi?’. Bensì: ‘Qual è la nuova vita che devo esplorare? Cosa c’è ancora da scoprire?’.
Si uscirà con ben altra virtù di vocazione, perché lo Spirito Santo che fa breccia nelle crepe delle norme che rendono conformisti, poi smantella e rovescia quei muri. Infine dilaga, per costruire la sua storia - che non è prevedibile, “a modo” come quella di tutti i legati alla comparazione.
Sentire il fastidio di partecipare a rituali di composta identificazione causa molti problemi, ma può essere la grande occasione della vita per dilatare gli orizzonti... anche di coloro che non gradiscono percorrere la via mediocre dell’assicurarsi - rendendosi per timore dipendenti dall’opinione, dai luoghi comuni, dal sentirsi subito festeggiati.
Felicità apparente. Infatti il morso dei dubbi non fa diventare credenti-spazzatura, come ipotizzato nelle religioni disciplinate, legaliste - nelle filosofie puritane dalla sapienza artificiosa - bensì amici, figli adottivi [ossia scelti] ed eredi.
Grazie alla Relazione di Fede, non siamo più persi nel deserto - perché le tante cose e gli azzardi diventano dialogo di peso specifico: siamo a Casa, nel rispetto del nostro misterioso carattere e Chiamata.
Già qui e ora ci spostiamo dalle tante cose che vincolano di costrizioni e pretese il nostro Centro - e sia il pensiero che l’azione.
Solo in tal guisa non siamo più folla mitologica o assuefatta, stracolma di colpe, doveri e appartenenze - bensì Famiglia e informalità colloquiale delle dissonanze.
Non più massa, ma (a tutto tondo) Persone: proprio nel nostro essere nel limite facciamo rima con grande-Missione.
Iniziamo come Giuseppe a essere presenti a noi stessi. E cambiando sguardo, si godrà la Bellezza del Nuovo.
«San Giuseppe ci ricorda che tutti coloro che stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. A tutti loro va una parola di riconoscimento e di gratitudine» [Patris Corde intr.].
Per interiorizzare e vivere il messaggio:
Quali sono stati i tuoi momenti di svolta? Quale deviazione ti ha realizzato?
In quale occasione il dubbio ti ha aperto orizzonti da sbalordire?
Quando e se hai cambiato lo sguardo conformista, hai conosciuto o meno l’accendersi nel tuo mondo interiore di prospettive, relazioni ed energie rigeneranti?
Come hai percepito accanto e “visto” o “sognato” ciò che prima restava Invisibile e Altrove?
Sei forse partito da una tua certezza?
In favore dell’umanità ferita
Il Vangelo di san Matteo narra come avvenne la nascita di Gesù ponendosi dal punto di vista di san Giuseppe. Egli era il promesso sposo di Maria, la quale, “prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo” (Mt 1,18). Il Figlio di Dio, realizzando un’antica profezia (cfr Is 7,14), diventa uomo nel grembo di una vergine, e tale mistero manifesta insieme l’amore, la sapienza e la potenza di Dio in favore dell’umanità ferita dal peccato. San Giuseppe viene presentato come “uomo giusto” (Mt 1,19), fedele alla legge di Dio, disponibile a compiere la sua volontà. Per questo entra nel mistero dell’Incarnazione dopo che un angelo del Signore, apparsogli in sogno, gli annuncia: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati” (Mt 1,20-21). Abbandonato il pensiero di ripudiare in segreto Maria, egli la prende con sé, perché ora i suoi occhi vedono in lei l’opera di Dio.
Sant’Ambrogio commenta che “in Giuseppe ci fu l’amabilità e la figura del giusto, per rendere più degna la sua qualità di testimone” (Exp. Ev. sec. Lucam II, 5: CCL 14,32-33). Egli – prosegue Ambrogio – “non avrebbe potuto contaminare il tempio dello Spirito Santo, la Madre del Signore, il grembo fecondato dal mistero” (ibid., II, 6: CCL 14,33). Pur avendo provato turbamento, Giuseppe agisce “come gli aveva ordinato l’angelo del Signore”, certo di compiere la cosa giusta. Anche mettendo il nome di “Gesù” a quel Bambino che regge tutto l’universo, egli si colloca nella schiera dei servitori umili e fedeli, simile agli angeli e ai profeti, simile ai martiri e agli apostoli – come cantano antichi inni orientali. San Giuseppe annuncia i prodigi del Signore, testimoniando la verginità di Maria, l’azione gratuita di Dio, e custodendo la vita terrena del Messia. Veneriamo dunque il padre legale di Gesù (cfr CCC, 532), perché in lui si profila l’uomo nuovo, che guarda con fiducia e coraggio al futuro, non segue il proprio progetto, ma si affida totalmente all’infinita misericordia di Colui che avvera le profezie e apre il tempo della salvezza.
[Papa Benedetto, Angelus 19 dicembre 2010]
L’uomo giusto di Nazaret
18. L'uomo «giusto» di Nazaret possiede soprattutto le chiare caratteristiche dello sposo. L'Evangelista parla di Maria come di «una vergine, promessa sposa di un uomo... chiamato Giuseppe» (Lc 1,27). Prima che comincia a compiersi «il mistero nascosto da secoli» (Ef 3,9), i Vangeli pongono dinanzi a noi l'immagine dello sposo e della sposa. Secondo la consuetudine del popolo ebraico, il matrimonio si concludeva in due tappe: prima veniva celebrato il matrimonio legale (vero matrimonio), e solo dopo un certo periodo, lo sposo introduceva la sposa nella propria casa. Prima di vivere insieme con Maria, Giuseppe quindi era già il suo «sposo»; Maria però, conservava nell'intimo il desiderio di far dono totale di sè esclusivamente a Dio. Ci si potrebbe domandare in che modo questo desiderio si conciliasse con le «nozze». La risposta viene soltanto dallo svolgimento degli eventi salvifici, cioè dalla speciale azione di Dio stesso. Fin dal momento dell'Annunciazione Maria sa che deve realizzare il suo desiderio verginale di donarsi a Dio in modo esclusivo e totale proprio divenendo madre del Figlio di Dio. La maternità per opera dello Spirito Santo è la forma di donazione, che Dio stesso si attende dalla Vergine, «promessa sposa» di Giuseppe. Maria pronuncia il suo «fiat».
Il fatto di esser lei «promessa sposa» a Giuseppe è contenuto nel disegno stesso di Dio. Ciò indicano entrambi gli evangelisti citati, ma in modo particolare Matteo. Sono molto significative le parole dette a Giuseppe: «Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo» (Mt 1,20). Esse spiegano il mistero della sposa di Giuseppe: Maria è vergine nella sua maternità. In lei «il Figlio dell'Altissimo» assume un corpo umano e diviene «il figlio dell'uomo».
Rivolgendosi a Giuseppe con le parole dell'angelo, Dio si rivolge a lui come allo sposo della Vergine di Nazaret. Ciò che si è compiuto in lei per opera dello Spirito Santo esprime al tempo stesso una speciale conferma del legame sponsale, esistente già prima tra Giuseppe e Maria. Il messaggero chiaramente dice a Giuseppe: «Non temere di prendere con te Maria, tua sposa». Pertanto, ciò che era avvenuto prima - le sue nozze con Maria - era avvenuto per volontà di Dio e, dunque, andava conservato. Nella sua divina maternità Maria deve continuare a vivere come «una vergine, sposa di uno sposo» (cfr. Lc 1,27).
19. Nelle parole dell'«annunciazione» notturna Giuseppe ascolta non solo la verità divina circa l'ineffabile vocazione della sua sposa, ma vi riascolta, altresì, la verità circa la propria vocazione. Quest'uomo «giusto» che, nello spirito delle più nobili tradizioni del popolo eletto, amava la Vergine di Nazaret ed a lei si era legato con amore sponsale, è nuovamente chiamato da Dio a questo amore.
«Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa» (Mt 1,24); quello che è generato in lei «viene dallo Spirito Santo»: da tali espressioni non bisogna forse desumere che anche il suo amore di uomo viene rigenerato dallo Spirito Santo? Non bisogna forse pensare che l'amore di Dio, che è stato riversato nel cuore umano per mezzo dello Spirito Santo (cfr. Rm 5,5), forma nel modo più perfetto ogni amore umano? Esso forma anche - ed in modo del tutto singolare - l'amore sponsale dei coniugi, approfondendo in esso tutto ciò che umanamente è degno e bello, ciò che porta i segni dell'esclusivo abbandono, dell'alleanza delle persone e dell'autentica comunione sull'esempio del mistero trinitario.
«Giuseppe... prese con sè la sua sposa, la quale, senza che egli la conoscesse, partorì un figlio» (Mt 1,24-25). Queste parole indicano un'altra vicinanza sponsale. La profondità di questa vicinanza, la spirituale intensità dell'unione e del contatto tra le persone - dell'uomo e della donna - provengono in definitiva dallo Spirito, che dà la vita (Gv 6,63). Giuseppe, obbidiente allo Spirito, proprio in esso ritrovò la fonte dell'amore, del suo amore sponsale di uomo, e fu questo amore più grande di quello che «l'uomo giusto» poteva attendersi a misura del proprio cuore umano.
[Papa Giovanni Paolo II, Redemptoris Custos]
La Fede che apre una Via diversa
il Vangelo ci racconta i fatti che precedettero la nascita di Gesù, e l’evangelista Matteo li presenta dal punto di vista di san Giuseppe, il promesso sposo della Vergine Maria.
Giuseppe e Maria vivevano a Nazareth; non abitavano ancora insieme, perché il matrimonio non era ancora compiuto. In quel frattempo, Maria, dopo aver accolto l’annuncio dell’Angelo, divenne incinta per opera dello Spirito Santo. Quando Giuseppe si accorge di questo fatto, ne rimane sconcertato. Il Vangelo non spiega quali fossero i suoi pensieri, ma ci dice l’essenziale: egli cerca di fare la volontà di Dio ed è pronto alla rinuncia più radicale. Invece di difendersi e di far valere i propri diritti, Giuseppe sceglie una soluzione che per lui rappresenta un enorme sacrificio. E il Vangelo dice: «Poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto» (1,19).
Questa breve frase riassume un vero e proprio dramma interiore, se pensiamo all’amore che Giuseppe aveva per Maria! Ma anche in una tale circostanza, Giuseppe intende fare la volontà di Dio e decide, sicuramente con gran dolore, di congedare Maria in segreto. Bisogna meditare su queste parole, per capire quale sia stata la prova che Giuseppe ha dovuto sostenere nei giorni che hanno preceduto la nascita di Gesù. Una prova simile a quella del sacrificio di Abramo, quando Dio gli chiese il figlio Isacco (cfr Gen 22): rinunciare alla cosa più preziosa, alla persona più amata.
Ma, come nel caso di Abramo, il Signore interviene: ha trovato la fede che cercava e apre una via diversa, una via di amore e di felicità: «Giuseppe – gli dice – non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo» (Mt 1,20).
Questo Vangelo ci mostra tutta la grandezza d’animo di san Giuseppe. Egli stava seguendo un buon progetto di vita, ma Dio riservava per lui un altro disegno, una missione più grande. Giuseppe era un uomo che dava sempre ascolto alla voce di Dio, profondamente sensibile al suo segreto volere, un uomo attento ai messaggi che gli giungevano dal profondo del cuore e dall’alto. Non si è ostinato a perseguire quel suo progetto di vita, non ha permesso che il rancore gli avvelenasse l’animo, ma è stato pronto a mettersi a disposizione della novità che, in modo sconcertante, gli veniva presentata. E’ così, era un uomo buono. Non odiava, e non ha permesso che il rancore gli avvelenasse l’animo. Ma quante volte a noi l’odio, l’antipatia pure, il rancore ci avvelenano l’anima! E questo fa male. Non permetterlo mai: lui è un esempio di questo. E così, Giuseppe è diventato ancora più libero e grande. Accettandosi secondo il disegno del Signore, Giuseppe trova pienamente se stesso, al di là di sé. Questa sua libertà di rinunciare a ciò che è suo, al possesso sulla propria esistenza, e questa sua piena disponibilità interiore alla volontà di Dio, ci interpellano e ci mostrano la via.
Ci disponiamo allora a celebrare il Natale contemplando Maria e Giuseppe: Maria, la donna piena di grazia che ha avuto il coraggio di affidarsi totalmente alla Parola di Dio; Giuseppe, l’uomo fedele e giusto che ha preferito credere al Signore invece di ascoltare le voci del dubbio e dell’orgoglio umano. Con loro, camminiamo insieme verso Betlemme.
[Papa Francesco, Angelus 22 dicembre 2013]
The Kingdom of God grows here on earth, in the history of humanity, by virtue of an initial sowing, that is, of a foundation, which comes from God, and of a mysterious work of God himself, which continues to cultivate the Church down the centuries. The scythe of sacrifice is also present in God's action with regard to the Kingdom: the development of the Kingdom cannot be achieved without suffering (John Paul II)
Il Regno di Dio cresce qui sulla terra, nella storia dell’umanità, in virtù di una semina iniziale, cioè di una fondazione, che viene da Dio, e di un misterioso operare di Dio stesso, che continua a coltivare la Chiesa lungo i secoli. Nell’azione di Dio in ordine al Regno è presente anche la falce del sacrificio: lo sviluppo del Regno non si realizza senza sofferenza (Giovanni Paolo II)
For those who first heard Jesus, as for us, the symbol of light evokes the desire for truth and the thirst for the fullness of knowledge which are imprinted deep within every human being. When the light fades or vanishes altogether, we no longer see things as they really are. In the heart of the night we can feel frightened and insecure, and we impatiently await the coming of the light of dawn. Dear young people, it is up to you to be the watchmen of the morning (cf. Is 21:11-12) who announce the coming of the sun who is the Risen Christ! (John Paul II)
Per quanti da principio ascoltarono Gesù, come anche per noi, il simbolo della luce evoca il desiderio di verità e la sete di giungere alla pienezza della conoscenza, impressi nell'intimo di ogni essere umano. Quando la luce va scemando o scompare del tutto, non si riesce più a distinguere la realtà circostante. Nel cuore della notte ci si può sentire intimoriti ed insicuri, e si attende allora con impazienza l'arrivo della luce dell'aurora. Cari giovani, tocca a voi essere le sentinelle del mattino (cfr Is 21, 11-12) che annunciano l'avvento del sole che è Cristo risorto! (Giovanni Paolo II)
Christ compares himself to the sower and explains that the seed is the word (cf. Mk 4: 14); those who hear it, accept it and bear fruit (cf. Mk 4: 20) take part in the Kingdom of God, that is, they live under his lordship. They remain in the world, but are no longer of the world. They bear within them a seed of eternity a principle of transformation [Pope Benedict]
Cristo si paragona al seminatore e spiega che il seme è la Parola (cfr Mc 4,14): coloro che l’ascoltano, l’accolgono e portano frutto (cfr Mc 4,20) fanno parte del Regno di Dio, cioè vivono sotto la sua signoria; rimangono nel mondo, ma non sono più del mondo; portano in sé un germe di eternità, un principio di trasformazione [Papa Benedetto]
In one of his most celebrated sermons, Saint Bernard of Clairvaux “recreates”, as it were, the scene where God and humanity wait for Mary to say “yes”. Turning to her he begs: “[…] Arise, run, open up! Arise with faith, run with your devotion, open up with your consent!” [Pope Benedict]
San Bernardo di Chiaravalle, in uno dei suoi Sermoni più celebri, quasi «rappresenta» l’attesa da parte di Dio e dell’umanità del «sì» di Maria, rivolgendosi a lei con una supplica: «[…] Alzati, corri, apri! Alzati con la fede, affrettati con la tua offerta, apri con la tua adesione!» [Papa Benedetto]
«The "blasphemy" [in question] does not really consist in offending the Holy Spirit with words; it consists, instead, in the refusal to accept the salvation that God offers to man through the Holy Spirit, and which works by virtue of the sacrifice of the cross [It] does not allow man to get out of his self-imprisonment and to open himself to the divine sources of purification» (John Paul II, General Audience July 25, 1990)
duevie.art
don Giuseppe Nespeca
Tel. 333-1329741
Disclaimer
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge N°62 del 07/03/2001.
Le immagini sono tratte da internet, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog che provvederà alla loro pronta rimozione.
L'autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.