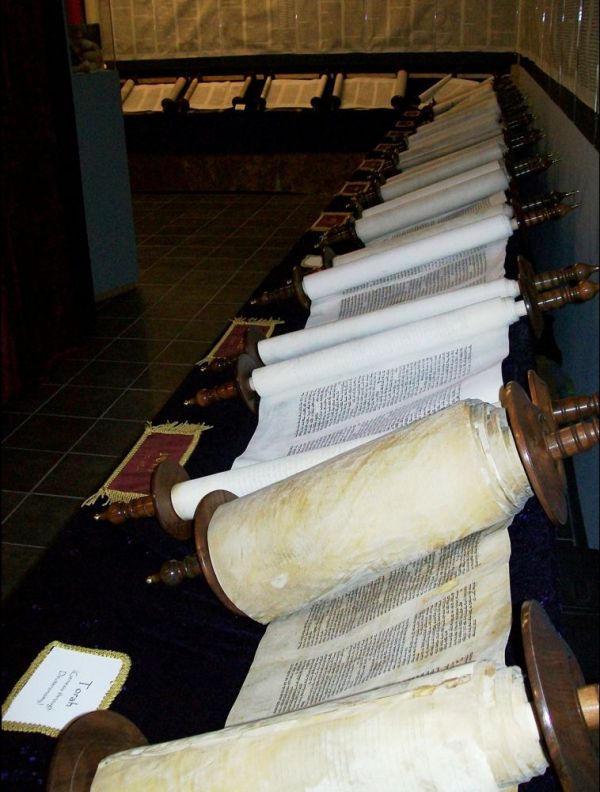(Lc 18,9-14)
Luca 18:9 Disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di esser giusti e disprezzavano gli altri:
Luca 18:10 «Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano.
Luca 18:11 Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano.
Luca 18:12 Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo.
Luca 18:13 Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: O Dio, abbi pietà di me peccatore.
Luca 18:14 Io vi dico: questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato».
Questa parabola è una catechesi sulla preghiera, la quale deve essere umilmente fiduciosa, rimettendosi al Padre. Vengono presentati due uomini che salgono a Gerusalemme per pregare e fin da subito vengo descritti come diametralmente contrapposti: un fariseo e un pubblicano. Due figure paradigmatiche, di cui si metteranno subito in evidenza l'oscurità della luce farisaica e la luce dell'oscurità del pubblicano. Due figure poste lì per interpellare la coscienza di chi sta salendo a Gerusalemme con Gesù. In ultima analisi ci si trova di fronte ad un giudizio di condanna su chi fa affidamento su se stesso e di premio su chi, invece, si affida a Dio.
Il v. 9 fornisce la chiave di lettura della parabola. Benché ci si trovi di fronte ad una valutazione comportamentale di taluni verso altri, tuttavia questo ha a che vedere con la preghiera, che, non va dimenticato, è un relazionarsi a Dio, in cui pesa in modo determinante il proprio relazionarsi verso gli altri. Un piccolo racconto che va a colpire un atteggiamento interiore che crea discriminazione, rifiuto e chiusura nei confronti degli altri e tale da rendere precari i propri rapporti con Dio stesso. Non è un caso, infatti, che la parabola, iniziatasi mettendo in rilievo i propri rapporti con gli altri, si concluda rilevando i propri rapporti con Dio e tali da coinvolgere la propria giustificazione (v. 14).
Quella del fariseo è una figura emblematica, che Paolo descriverà magistralmente in Rm 2,1: “Sei dunque inescusabile, chiunque tu sia, o uomo che giudichi”. Un giudicare che nasce da una convinzione di santità legale. Una santità legale che tuttavia non trova riscontro nella quotidianità del loro vivere. Una classe, insomma, di benpensanti, che amano presentarsi come scrupolosi osservanti della Legge, che si scontra, tuttavia, con il loro modo di vivere.
Accanto a questa figura, icona di purità rituale e di santità legale, viene accostata quella del disprezzato pubblicano, che nei vangeli sovente viene associato con i peccatori o con le prostitute, personaggi questi che erano socialmente e religiosamente ghettizzati e considerati già destinati alla perdizione eterna. Gente, dunque, da evitare anche per non contaminarsi, diventando ritualmente impuri. L'accostarsi a loro o soffermarsi con loro, inoltre, certamente ledeva la dignità di questa classe di religiosi. Un accostamento, quello della parabola, che stride fortemente, ma che servirà a rendere più dirompente la sentenza finale (v. 14), evidenziando così il modo di pensare di Dio, che sovente contrasta con quello degli uomini. La figura sociale del pubblicano, proprio per il suo lavoro di esattore delle tasse per conto dell'oppressore Romano, era considerata, da un punto di vista religioso, in un costante stato di impurità rituale, in quanto in continuo rapporto con il mondo dei pagani. Era socialmente malvisto e odiato perché faceva parte del sistema oppressivo dell'invasore e non di rado caricava le tasse con propri interessi. A tutti gli effetti era considerato un pubblico peccatore.
I vv. 11-12 sono dedicati al fariseo, che manifesta, nel suo relazionarsi con Dio, tutta la sua protervia e che contrasta profondamente con il comportamento del pubblicano. Il fariseo si pone di fronte a Dio “stando in piedi”. Anche se questo era il modo di pregare del pio ebreo, tuttavia il verbo statheìs dice ben più di un semplice stare in piedi davanti a Dio. Egli si pone in una sorta di atteggiamento di sfida davanti a Dio, sollecitandolo quasi in modo provocatorio a trovare in lui, perfetto osservante della Legge, una qualche ombra. E qui sciorina tutta la sua bravura di osservanza legale, che non fa una grinza, ma che rivela tutta la sua insolente arroganza nei confronti di Dio, mettendosi, di fatto, al suo pari. E per meglio farla risaltare chiama in causa non solo la generale peccaminosità degli uomini, ponendosi al di sopra dell'umanità (“non sono come gli altri uomini”), ma anche il perdente e disprezzato pubblicano, lì presente con lui, sul quale sente di sopravanzare indiscutibilmente di gran lunga. L'intera preghiera del fariseo si snoda all'interno di un serrato confronto con gli altri, definiti ladri, ingiusti, adulteri, e la sua scrupolosa osservanza della Legge, che va ben oltre a quanto essa richiedeva in termini di digiuno, previsto soltanto una volta all'anno nel giorno dell'Espiazione. Al centro della sua preghiera e del suo rapporto con Dio non c'è Dio, ma soltanto il suo Io, che qui s'impone davanti a Dio a detrimento degli altri.
A fronte di tanta superbia, viene accostata la figura del pubblicano, diametralmente all'opposto di quella del fariseo. Allo “stando in piedi” del fariseo si contrappone il “fermatosi a distanza” del pubblicano, che indica non solo la distanza che intercorre tra lui e il fariseo, ma anche quella tra lui e Dio. Egli è e si sente peccatore. E ciò che può offrire a Dio è soltanto la sua fragilità, che non gli consente neppure di alzare gli occhi verso di Lui, tanta è la coscienza del suo nulla, rimettendosi, invece, alla misericordia divina, senza nulla pretendere, perché ha la consapevolezza del suo peccato. Ma quel suo essere salito al Tempio, il suo esservi entrato, lo associa in qualche modo alla figura del Figliol prodigo, ritornato alla casa del Padre, il quale neppure sta ad ascoltare le parole di quel suo figlio perduto e ritrovato, ma lo accoglie in un abbraccio, che è una promessa di vita eterna.
Argentino Quintavalle, autore dei libri
- Apocalisse – commento esegetico
- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?
- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario
- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)
- Tutte le generazioni mi chiameranno beata
- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede
- La Chiesa e Israele secondo San Paolo – Romani 9-11
(Disponibili su Amazon)