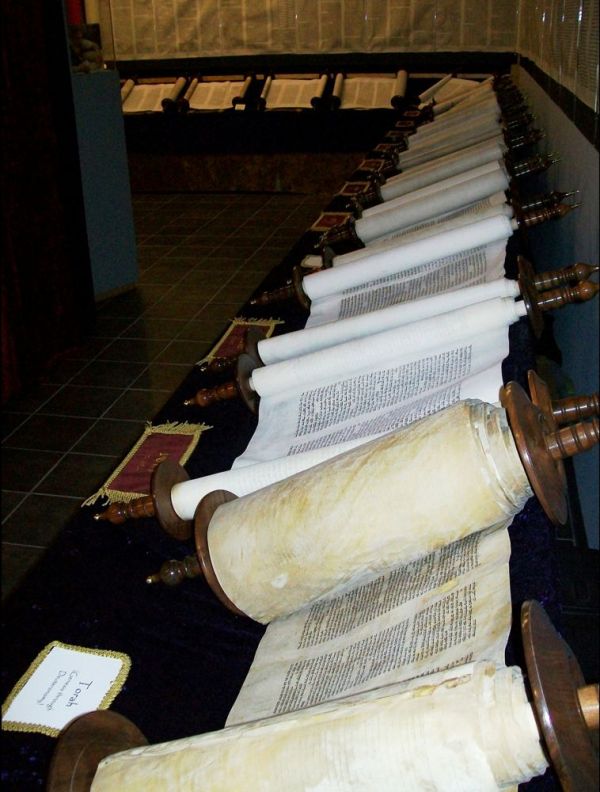(Lc 22,14 - 23,56)
Luca 22:14 Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui,
Luca 22:15 e disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione,
Luca 22:16 poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio».
Luca 22:17 E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi,
Luca 22:18 poiché vi dico: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché non venga il regno di Dio».
Luca 22:19 Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di me».
Luca 22:20 Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi».
Luca 22:39 Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono.
Il v. 14 funge da cornice al racconto della cena pasquale al cui interno si colloca l'istituzione dell'eucaristia. Un versetto molto denso, scandito in tre parti. La prima è una nota temporale molto significativa, che introduce il racconto pasquale: “Quando fu l'ora”. L'ora è giunta. È la cena pasquale. Qui avviene l'incontro e il completamento-sostituzione di due eventi salvifici, che vengono strettamente legati alla passione-morte-risurrezione di Gesù: la celebrazione della pasqua ebraica, l'evento della liberazione di Israele. L'altro evento, complementare e sostitutivo del primo, sono il pane e il vino, elementi essenziali e propri della pasqua ebraica, ma che qui, in questa “ora”, vengono risignificati, perché rappresentativi di una nuova liberazione, che ha come fondamento un pane-corpo spezzato e un vino-sangue versato “per voi”, dove in quel “per voi” si ritrova chiunque abbia deciso la propria vita per quel pane spezzato e per quel vino versato. Si tratta, dunque, di un'ora che costituisce il vertice della storia della salvezza, dove tutto ciò che è stato prefigurato trova in quest'ora il suo compimento, che ritualizza in quel pane-corpo spezzato e in quel vino-sangue versato l'evento salvifico che si fa offerta di salvezza per chiunque lo accolga nella propria vita.
La seconda parte del v. 14 presenta un Gesù che prende posto a tavola. Non si parla di sedersi, ma di reclinarsi, adagiarsi, sdraiarsi, distendersi (greco: “anepesen”), alla maniera propria del mondo greco-romano, ma che aveva assunto per l'ebreo il significato di una posizione che qualificava l'uomo libero; mentre la terza parte del v. 14 afferma “gli apostoli con lui”. Gli apostoli sono quelli che Gesù ha chiamato con sé perché condividessero la sua sorte, il ceppo fondativo della chiesa. Ed è proprio in questa prospettiva che l'evangelista attesta che anche gli apostoli si adagiano con Gesù a quella tavola del pane-corpo spezzato e del vino-sangue versato, condividendone in tal modo la sorte. Si tratta - lo sdraiarsi alla mensa con Gesù in cui viene ritualizzata la sua morte - di una vera e propria sequela che in qualche modo riecheggia, anticipandolo, il v. 39 in cui si racconta che Gesù “uscito, se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo seguirono”.
Il v. 15 apre la pericope relativa alla pasqua ebraica che qui, in quel “prima della mia passione”, viene legata alla passione e morte di Gesù; ma si intuisce anche come in quel “prima” questa pasqua ebraica sia anche l'ultima. Si comprende in tal modo l'esprimersi di Gesù (“ho desiderato ardentemente”), per dire la sua grande attesa per questa pasqua, posta alle soglie del suo patire e morire. Una pasqua di addio, quindi, ma non di abbandono, poiché saranno proprio i vv. 19-20, che nel riprendere la gestualità della pasqua ebraica la riscatteranno, divenendone riferimento perpetuo (“in memoria di me”), in cui si ritrova una nuova presenza di Gesù sotto forma di pane e di vino e che ha il suo compimento in lui, vero agnello pasquale immolato.
Luca, nel rilevare il grande desiderio e la grande attesa di Gesù per questa pasqua, l'ultima che egli avrebbe celebrato con i suoi, focalizza l'espressione “mangiare questa pasqua con voi”, così che in qualche modo, in quella pasqua, i discepoli sono coinvolti nei destini di Gesù. Una pasqua che, tuttavia, ha la sua compiutezza soltanto nel Regno di Dio, denunciandone in tal modo la sua incompiutezza e, quindi, tutta la sua inconsistenza e fragilità. In altri termini, una pasqua (quella ebraica) che ha liberato, ma non è più liberante.
La questione del valore salvifico di questa pasqua è qui affrontata da Luca nella contrapposizione tra i verbi “mangiare” e “non mangiare” del v. 16, verbo quest'ultimo, come il “non bere” del v. 18, posto al futuro; come dire ‘mai più mangerò e mai più berrò’, togliendo a questa pasqua il senso di “celebrazione liberante”: “finché essa non si compia nel regno di Dio”, assegnandole in tal modo una dimensione escatologica.
Il presente della pasqua ebraica, infatti, che celebra la liberazione di Israele dall'oppressione egiziana, ha in se stessa un senso incompiuto, che era racchiuso in un memoriale ripetitivo che non trova sbocchi nella storia se non in un ricordo glorioso, che simile al muro del pianto, ricorda la grandiosità delle gesta di Yahweh. Una pasqua, quindi, sterile - che non apre Israele al futuro, ma lo rinchiude nel suo passato attraverso una ritualità che non gli consente sbocchi, così che la liberazione in essa celebrata diventa una liberazione incompiuta. Per questo Gesù e con lui i suoi non ne mangeranno più e non solo perché egli verrà ucciso da lì a poco. Liberazione che, tuttavia, ritroverà il suo senso e la sua compiutezza in quel Regno di Dio, che Gesù è venuto a rivelare e a fondare, e che quella pasqua in qualche modo prefigurava, celebrando una liberazione che in realtà ne prefigurava un'altra e nella quale troverà la sua compiutezza, divenendo pasqua liberante.
Gesù, dunque, non mangerà più di questa pasqua, e con lui i suoi discepoli, perché questa è stata trasferita in una nuova pasqua e da questa sostituita, in un nuovo esodo dalla schiavitù alla libertà, significato nel passaggio dalla morte alla vita di Gesù, che incide sulla vita di ogni singolo credente nel suo oggi, il quale mangiando di questa nuova pasqua, annuncia nella testimonianza della propria vita questo passaggio dalla morte alla vita - nell'attesa del suo ritorno. Viene a crearsi in tal modo una forte tensione escatologica tra il ‘già e il non ancora’; orientando l'intera umanità credente verso una meta che va al di là dello spazio e del tempo, dove l'oggi incompiuto trova la sua compiutezza e il suo senso e dove il tempo incompiuto diventa eternità compiuta.
Argentino Quintavalle, autore dei libri
- Apocalisse – commento esegetico
- L'Apostolo Paolo e i giudaizzanti – Legge o Vangelo?
- Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo nel mistero trinitario
- Il discorso profetico di Gesù (Matteo 24-25)
- Tutte le generazioni mi chiameranno beata
- Cattolici e Protestanti a confronto – In difesa della fede
- La Chiesa e Israele secondo San Paolo – Romani 9-11
(Acquistabili su Amazon)