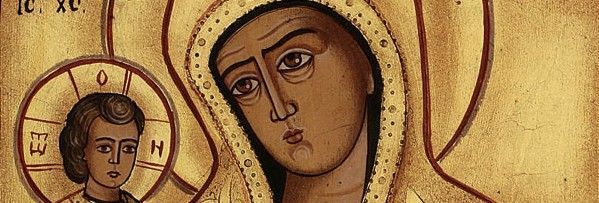I teatranti e la neutralità
(Lc 13,10-17)
La passione per l’esistenza piena vorrebbe guidarci chissà dove, ma c’è talora una forza esterna che trattiene. Potenza tenebrosa, la quale impedisce persino di scoprire la nostra vera natura.
L’opinione altrui, le dottrine, i costumi o le idee comuni vecchie e nuove si frappongono alla vita che chiama, che fa scoprire altro, che accende passioni, che vuole totalità, e attiva la trasformazione.
Nel frattempo, la percezione che forse stiamo mancando di percorrere la strada “giusta”, crea contrapposizioni esterne; intimidisce, fa soffrire, colpevolizza, e talora blocca proprio le anime più sensibili.
Chi poi ci accusa… fa leva sul timore di dover pagare il prezzo della libertà (caratteriale e vocazionale), per gli eventuali “errori” cui si rischia di andare incontro stando fuori dei binari prescritti.
Medesime dinamiche investono da un lato l’ossequio alle consuetudini, dall’altro l’adesione alle mode, anche le più sofisticate e “aggiornate”.
In specie nelle culture o religioni senza il balzo della Fede, tutto questo si radica e mette disagio; fa credere che siamo molto meno di ciò che ci corrisponde.
Viceversa - anche dovesse sembrare che percorriamo sentieri temerari (ma che ci appartengono) i rischi potrebbero recarci gioie, maggiore completezza, e realizzazione.
Come sempre, Gesù si fa Presente in “sinagoga” non per fare orazioni codificate: è tra la sua gente ad «istruire» (v.10).
In particolare, Egli insegna che il Padre non è in conflitto con dei sudditi. Anzi, sostiene tutti i suoi figli, e dona una postura diversa da quella del mondo “animale” - cui le credenze normali potrebbero forse ridurci.
A quel tempo nessuna donna poteva partecipare direttamente a una liturgia, ma nei Vangeli le figure femminili sono parabola del popolo stesso [in ebraico il termine Israel è di genere femminile].
Lc mette in scena una ‘donna’ per alludere anche a tutte le figure oppresse, cui talora la comunità in preghiera non porge conforto alcuno, né concede un’azione concreta di emancipazione.
Persone sottomesse al paradigma “culturale” dell’ambiente particolare e al potere condizionante della tradizione famigliare.
A quei tempi tale cappa trasmetteva a forza una spiritualità paradigmatica, pur rassicurante, ma assolutamente conforme.
La gente minuta era sottoposta in tutto al capofamiglia; in più, suddita del potere politico, e asservita perfino al fondamentalismo delle autorità religiose.
Un panorama umiliante, perfino atroce, “bestiale” appunto.
Il Signore sta educando i suoi intimi, in modo assai deciso.
Nel luogo di culto il Maestro trova un’umanità subalterna, un panorama di minimi ancora vessati dall’ossessione religiosa antica - quindi ripiegati su di sé, fiaccati, incapaci di sollevare la testa.
Lo spirito di debolezza che quello stesso ambiente iniettava proprio ai malfermi, rendeva i fedeli dell’assemblea (o gli abitudiari in essa) totalmente passivi.
Un’esistenza ricurva, trascinata alla meno peggio; senza orizzonti.
L’azione di Cristo estrae dalla folla assuefatta, libera dal conformismo e dalla massificazione; rimette in piedi la “donna” vacillante, che prende a lodare Dio sul serio, con gioia, immediatamente (vv.12-13).
Ella era figura pur “partecipe” del rito, e sempre in mezzo al popolo riunito, ma prima d’incontrare personalmente il Signore non glorificava il Padre in modo reale - né onorava la sua stessa esistenza.
Nessuna espressione lieta per la guarigione, da parte dei leaders religiosi - abituati a inoculare nelle anime un clima soporifero - anzi, solo condanna. Illustri e distanti.
Individualisti negoziatori del potere di turno, incapaci di vicinanza. Ciò anche per vari interessi di cerchia, dottrina, di supremazia, e prestigio istituzionale.
Poi - nell’idea comune - sembrava che in termini legalistici o di rubrica la santificazione del giorno dedicato al Signore escludesse qualsiasi coinvolgimento, e le opere di bene!
In aggiunta a tale credenza malsana, anche toccare una “carne” ferita s’immaginava potesse rendere impuri!
Insomma, lo spirito del comandamento che imponeva il riposo del sabato [nato storicamente per la tutela di vaste esigenze sociali, cultuali, identitarie] era stato completamente manipolato e rovesciato.
La logica del giovane Rabbi è opposta ai protocolli: solo la trascuratezza dei marginali e asserviti disonora Dio.
Unico principio non negoziabile è il bene della donna e dell’uomo reali: questa l’unica chiave di lettura dei Vangeli.
E il rito deve celebrare proprio una vita fraterna d’accoglienza e condivisione, di felicità, personalizzazione, cura, amore.
Il resto è per Gesù una commedia insopportabile, dalla quale i suoi responsabili di chiesa devono tenersi alla larga: «Teatranti» (v.15) li definirebbe anche oggi - altrimenti - nostro Signore.
Valiamo ben più di buoi e asini (vv.15-16).
Il rapporto con Dio è festa, guarigione, salvezza: tutto concreto - frutto di scelta, perfino sociale.
E finalmente anche il nuovo Magistero si distacca dalla mentalità precedente, spesso diplomatica e neutrale:
«La conclusione di Gesù è una richiesta: Va’ e anche tu fa’ così (Lc 10,37). Vale a dire, ci interpella perché mettiamo da parte ogni differenza e, davanti alla sofferenza, ci facciamo vicini a chiunque. Dunque, non dico più che ho dei “prossimi” da aiutare, ma che mi sento chiamato a diventare io un prossimo degli altri» [Fratelli Tutti, n.81].
«Ora costei essendo figlia di Abramo […] non doveva essere sciolta da questo legame il giorno di sabato?» (Lc 13,16).
Spiritualità non vuota, e qualsiasi - dove i piccoli sono costretti a delegare ad altri i loro sogni.