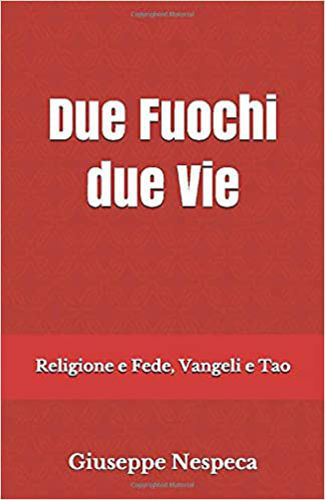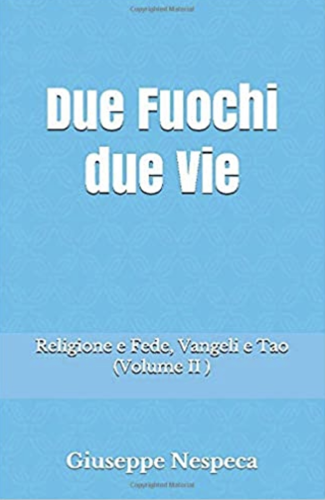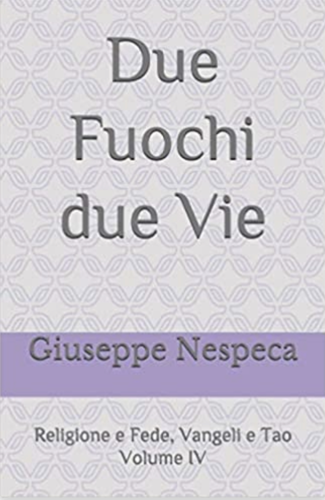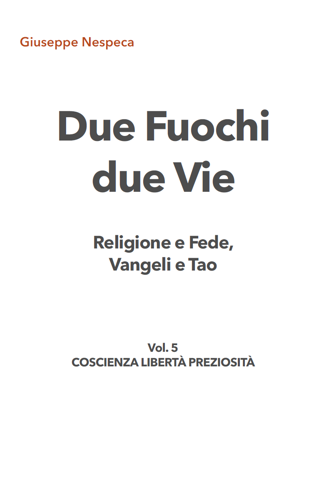Ecco un contributo per entrare nella parola di Dio di domenica prossima. Dio ci benedica e la Vergine ci protegga!
[15 Dicembre 2024] 3a Domenica di Avvento 2024
*Prima Lettura Sof 3, 14-18
Fin dall’VIII secolo a.C. (con Osea), i profeti compresero e annunciavano che Dio è amore sviluppando il tema dell’Alleanza come nozze tra il Signore e il popolo che si è scelto. Quando tornano a parlare dell’infedeltà d’Israele è per denunciare il rischio costante del ritorno all’idolatria e richiamano sempre la promessa del Messia, che suona come annuncio di speranza. Nel libro del profeta Zaccaria leggiamo: “Non temere, poiché io sono in mezzo a te dice il Signore” (2,15), e in Osea: “Non temere…Io sono Dio e non un uomo; sono il Santo in mezzo a te.” (11,9). E alcuni secoli dopo l’angelo Gabriele dirà a Maria: “Rallegrati, Maria… Il Signore è con te” e la Vergine darà alla luce Gesù, l’Emmanuele, il Dio con noi. Oggi la prima lettura ci fa incontrare Sofonia che circa un secolo dopo Osea utilizza i due linguaggi abituali dei profeti: le minacce contro chi compie il male e l’incoraggiamento per quanti s’impegnano a restare fedeli all’Alleanza: “Il Signore gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di gioia” (Sof 3,17-18). Basta questa frase, che conclude l’odierna prima lettura, per comprendere che già nell’Antico Testamento i profeti avevano annunciato che Dio è amore. Non è pertanto esatto affermare che solo nel Nuovo Testamento si parla di Dio che è amore. Le parole di Sofonia non sono nuove anche se ci sono voluti alcuni secoli di rivelazione biblica, cioè di pedagogia divina, per arrivare a tale comprensione. All’inizio dell’Alleanza tra Dio e il suo popolo, l’immagine delle nozze per indicare l’Alleanza sarebbe stata ambigua e per questo In un primo tempo, fu essenziale scoprire il Dio completamente Altro rispetto gli dei delle nazioni limitrofe e al tempo stesso affermare la necessità di instaurare un’Alleanza con Lui. Fu Osea (VIII secolo a.C.) il primo a parlare dell’Alleanza tra Dio e il suo popolo come un vero e proprio legame d’amore, simile a quello del fidanzamento, seguito dai profeti successivi: il Primo Isaia, Geremia, Ezechiele, Zaccaria, il Secondo e il Terzo Isaia, i quali ricorrono al linguaggio tipico del fidanzamento e delle nozze con nomi affettuosi, citando abiti nuziali, corone da sposa, fedeltà. Il cosiddetto Terzo Isaia (VI secolo a.C.) giunse a impiegare il termine “desiderio” (nel senso di desiderio amoroso) per descrivere i sentimenti di Dio verso il suo popolo. Pensiamo poi al Cantico dei Cantici (tra VI e III secolo a.C. anche se qualche parte è anteriore), lungo dialogo d’amore composto da sette poemi, dove non si identificano mai chiaramente chi sono i due innamorati. Israele però l’interpreta come il dialogo tra Dio e il suo popolo e lo proclama durante la celebrazione della Pasqua, festa dell’Alleanza tra Dio e Israele. Se il popolo d’Israele è paragonato a una sposa, ogni infedeltà all’Alleanza diventa non solo una violazione di un contratto, ma un vero e proprio adulterio ed ecco perché i profeti ricorrono a termini come gelosia, ingratitudine, tradimento e riconciliazione: ogni infedeltà è un ritorno all’idolatria. In questo contesto va situato Sofonia (VII secolo a.C.) vissuto a Gerusalemme durante il regno di Giosia (nel 640 a.C.) e il suo libro è composto solo di cinque pagine, ma denso e ricco di messaggi celebri. Egli esorta il re e il popolo alla conversione (cf. 2,3), urgente sotto i regni di Manasse e Amon segnati da idolatria, violenza, frodi, menzogne, ingiustizie sociali, arroganza dei potenti e oppressione dei poveri. Sofonia denuncia chi si prostra davanti al Signore e poi giura per il proprio dio, l’idolo Milkom identificato spesso con Moloch (cf.1,5) e condanna il sincretismo religioso; condanna pure coloro che riempiono la casa del Signore con frutti di violenza e d’inganno (cf.1,9). Ben chiari i due linguaggi profetici: Minacce contro i malvagi, come nel celebre canto del “Dies Irae” tratto dai suoi testi e incoraggiamento per i fedeli umili, come nel brano che leggiamo oggi. Sofonia si rivolge a Gerusalemme “figlia di Sion” con parole di gioia e speranza: “Rallegrati, figlia di Sion… Il Signore, tuo Dio, in mezzo a te è un Salvatore potente”. Malgrado l’infedeltà d’Israele l’amore di Dio persevera verso il suo popolo. Sofonia lo invita alla conversione annunciando una nuova Gerusalemme, terra di umili e fedeli, dove Dio porrà la sua residenza per sempre e anticipa così il messaggio che verrà ripreso da altri (come Gioele e Zaccaria). Messaggio che si realizzerà pienamente nel Nuovo Testamento, quando l’angelo dirà a Maria: “Rallegrati, piena di grazia… Il Signore è con te” (Lc 1,28) e nel vangelo di Giovanni: “Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” (Gv 1,14). L’invito alla gioia risuona in tutta la liturgia di questa domenica che si chiama “domenica Gaudete” (gioite) perché Dio si fa uomo e nasce a Betlemme: ci rende scosì possibile condividere la sua stessa vita, che il peccato dei progenitori aveva precluso e perduto.
*Salmo responsoriale Isaia 12, 2-6
“Mia forza e mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza”. Ecco il canto che Isaia prevede per il giorno in cui il popolo sarà salvato, ma che possiamo già cantare oggi nel cuore delle difficoltà perché proprio nella debolezza possiamo sperimentare la vera fonte della nostra forza. San Paolo scriverà che la potenza del Signore appare in pienezza nella nostra debolezza (cf.2 Cor 12, 9). Questo cantico, pur non facendo parte del Salterio, può benissimo considerarsi un vero salmo perché è intriso di fiducia e di ringraziamento, in un periodo decisamente cupo per Israele che si trovava tra le minacce dell’impero assiro come pure dei due re vicini. In quel tempo Isaia cantava parole di speranza annunciando la non remota fine dell’Assiria e la liberazione di Giuda con uno stile che rassomiglia molto al canto di ringraziamento di Mosè dopo la liberazione dall’Egitto e il passaggio del Mar Rosso (Es 15). Come allora Mosè, anche Isaia canta la sua fede in un Dio liberatore, che mai abbandona il suo popolo ed è anzi costantemente presente in mezzo a esso. Come Mosè, Isaia comprese che l’elezione di Israele non costituiva un’esclusiva; era piuttosto una vocazione e per realizzarla il popolo salvato aveva un’unica missione: testimoniare in mezzo agli uomini che Dio è davvero l’unico liberatore. Questo salmo di fiducia e di ringraziamento a Dio, il salvatore, Isaia lo proclama mentre il contesto politico è oscuro e la paura domina in tutta la regione. Siamo nell’VIII secolo a.C., tra il 740 e il 730 circa, quando l’impero assiro (capitale Ninive) costituiva una potenza emergente con un’espansione apparentemente inarrestabile. Gli Assiri erano il nemico e Ninive, come leggiamo nel libro di Giona, una città empia dove si compivano malvagità d’ogni natura. Dopo la morte di Salomone (930 a.C.) il popolo di Dio si divise in due regni minuscoli, che invece di allearsi come fratelli scelsero politiche diverse e talvolta persino opposte. Il regno del Nord (capitale Samaria) cercò di resistere alla pressione assira e si alleò con il re di Damasco per assediare Gerusalemme per costringere il re Achaz a unirsi alla loro coalizione. Achaz si trovò quindi tra due fuochi: da un lato, i due re vicini meno potenti ma molto prossimi già alle porte di Gerusalemme; dall’altro, Ninive, che forse finirà per schiacciare tutti. Achaz preferì arrendersi prima di combattere diventando vassallo dell’Assiria: compra la sua sicurezza a prezzo della libertà. Questa scelta era umanamente preferibile, ma il popolo di Dio ha il diritto di ragionare secondo logiche umane? I calcoli provenivano dalla paura, ma un credente può permettersi di avere paura? Dov’è finita la fede? Isaia scrive: “Il cuore di Achaz e il cuore del suo popolo si agitarono, come si agitano gli alberi della foresta per il vento” (Is 7,2) e il re Achaz, in preda a dubbi e paure, compie un gesto terribile: sacrifica suo figlio a una divinità pagana, pronto ormai a tutto pur di non perdere la guerra. Fu uomo di poca fede ed è in questo contesto storico che Isaia incoraggia il piccolo resto fedele a sperare perché: “Tu dirai quel giorno: Ti lodo, Signore, perché pur essendoti adirato contro di me, la tua colera si è calmata e tu mi hai consolato” (12,1). Continua a esortare alla calma e a non aver paura (cf 7,4) perché se non crederete, non resisterete(cf 7,9) mentre al contrario, rivolgendosi a uomini di poca fede, avvia un lungo discorso di speranza, che occupa i capitoli dal 7 all’11, proprio quelli che precedono il nostro canto di oggi. I trionfi dell’Assiria furono, come previsto, passeggeri e presto si giunse al canto della libertà. Il profeta Isaia compose questo cantico, che oggi è il salmo responsoriale, proprio per celebrare in anticipo la liberazione operata da Dio, un autentico canto di sollievo dove più che la gioia di essere liberati, emerge una vera professione di fede. Riprendendo il paragone con il cantico di Mosè e degli Israeliti, Isaia, cinquecento anni dopo, rinnova la stessa professione di fede per sostenere i suoi contemporanei perché comprendano che come un giorno Dio liberò Israele dal Faraone, allo stesso modo ora lo libererà dall’impero assiro. Chiudo rimarcando che Israele non si riserva mai l’esclusiva della relazione di Alleanza con Dio: ogni volta che nei salmi ringrazia per l’elezione divina, fa emergere una nota di universalismo perché lungo i secoli ha sempre più compreso che la sua elezione non è un’esclusiva, ma una vocazione. All’epoca di Isaia, questo era già chiaro e nell’odierno testo la nota di universalismo si percepisce nella formula: “Proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime” (v.4). Un messaggio chiaro anche per noi: per rispondere alla nostra vocazione di uomini salvati dall’amore misericordioso di Dio abbiamo, come unica missione, il compito di testimoniare, con il canto e la vita, che Dio è veramente la nostra salvezza: “Mia forza e mio canto è il Signore”.
*Seconda Lettura dalla Lettera di san Paolo ai Filippesi (4,4-7)
Vale la pena ribadire che tutti i testi di questa domenica parlano di gioia e invitano alla gioia.
«Fratelli, il Signore è vicino… , non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere suppliche e ringraziamenti”. In questo testo, che è il paragrafo dell’ultimo capitolo della lettera alla comunità macedone di Filippi, san Paolo ci offre alcune indicazioni spirituali da ben considerare:
1. E’ caratteristico della preghiera ebraica saldare sempre supplica e ringraziamento. Si unisce: Benedetto sei tu, Signore, che ci dai… e, ti preghiamo, concedici, questo perché chi prega Dio per il suo bene è certo di essere esaudito e il fatto di domandare qualcosa è già implicitamente ringraziarlo. In effetti, ogni umana richiesta non rivela nulla di nuovo a Dio, ci prepara però ad accogliere il dono che ci fa. Con la preghiera apriamo la porta a Dio e ci immergiamo nel suo dono.
2. ”Il Signore è vicino”: Quest’espressione, parallela a quella di Sofonia nella prima lettura, e analoga a quanto Giovanni Battista annuncia: “Il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2) evoca un tema centrale in san Paolo e riveste almeno due significati: Dio è vicino perché ci ama e questa consapevolezza è cresciuta gradualmente nell’Antico Testamento. Inoltre Dio è vicino anche perché i tempi sono ormai compiuti, il Regno di Dio è niziato e noi viviamo negli ultimi tempi. Nella prima lettera ai Corinti l’apostolo scrive che “Il tempo si è fatto breve” ( 7,29-31) richiamando l’immagine di un veliero che, giunto ormi vicino al porto, raccoglie le veli in preparazione all’approdo. Chiaro è il messaggio: la storia sta per giungere al suo compimento e, come i passeggeri del naviglio si affollano ai bordi per scorgere la terra ormai vicina, così il cristiano deve orientare la sua vita verso il regno di Dio ormai vicino.
3. Se il Signore è vicino, non abbiamo motivo di preoccuparci perché la nostra dimora definitiva è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo (cf Fil 3,20). Non aveva Gesù ripetuto: “Perché avete paura, uomini di poca fede?”. E non aveva raccomandato: “Non preoccupatevi per la vostra vita, di cosa mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di cosa vi vestirete… Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta» (Mt 6,25-34). Quando cerchiamo il Regno di Dio proclamiamo con la vita :“Venga Signore il tuo regno” e proiettiamo la nostra esistenza decisamente verso Cristo. Si tratta allora, ascoltando san Paolo, di rivedere le priorità della vita e controllare quali sono i valori fondamentali che la muovono: Il regno di Dio è il vero scopo primario della nostra esistenza? E se così è, l’unica testimonianza da offrire è vivere nella serenità dell’abbandono fiducioso: “La vostra amabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino”. Per quanto gravi i problemi ed enormi gli ostacoli, il male sarà sconfitto definitivamente ed allora:“Non angustiatevi per per nulla”. Quando si vive così, l’amabilità/serenità di cui parla san Paolo si trasforma in gioia: “Fratelli, siate sempre lieti nel Signore”.
Oggi, terza domenica di Avvento, è dunque la domenica della gioia e, a sottolineare quest’invito incessante a essere gioiosi, sono anche gli ornamenti rosa che il celebrante indossa. L’esortazione alla gioia è fin dall’inizio della messa che si apre così: “Gaudete – Rallegratevi”, e si tratta più che di un consiglio, di un vero comando. E al riguardo, come dimenticare le parole di Gesù: “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,11). Gioia che non elimina le difficoltà, ma ci fa restare uniti a lui per condividere con lui anche le nostre difficoltà; gioia che non proviene da eventi esterni all’uomo, ma dalla presenza di Dio nel nostro cuore: è la gioia cristiana che non ha nulla da spartire con il piacere mondano e che conquista il mondo.
Vangelo secondo Luca 3,10-18
Quest’oggi nel vangelo domina la figura Giovanni Battista che, come i profeti dell’Antico Testamento, invitava alla pratica della giustizia, alla condivisione e alla non-violenza, temi cari a tutti i profeti. Ad ascoltarlo erano i piccoli, la folla, il popolo, i malvisti (come i pubblicani e i soldati che probabilmente li accompagnavano) e a loro annunciava con linguaggio diretto e severo la conversione per accogliere la venuta del Messia. Anzi la gente, supponendo che fosse lui il Messia che attendevano da lungo tempo, gli domandavano in cosa consistesse la conversione che egli predicava. Assai semplice la risposta: la vera conversione si misura dal nostro atteggiamento verso il prossimo: praticare la giustizia, condividere i nostri beni con gli altri e praticare la non-violenza. Incoraggiati dal suo esempio molti siavvicinavano a lui per ricevere il battesimo, convinti che fosse il Messia. Chiara tuttavia la sua risposta: non sono io il Messia. Vi annuncio comunque che sta per venire colui che è più forte di me e, aggiunge l’evangelista Luca, con queste e molte altre esortazioni, annunciava al popolo il vangelo. Ci sono dunque due poli in questo testo di Luca: il primo è l’attesa e la speranza umana che si esprime nella domanda della gente per tre volte: “Che dobbiamo fare?” e le tre volte richiamano, secondo alcuni esegeti, il rituale del battesimo delle primitive comunità. Il secondo polo è l’annuncio di Cristo al popolo in attesa – non sono io ma lui è già fra voi – come ripete Giovanni. I primi capitoli del vangelo di Luca sono impregnati dell’attesa: gli anziani Simeone e Anna nel Tempio e qui coloro che ascoltano il Battista e quando Luca parla di vangelo, si riferisce proprio a questo: l’annuncio del Messia che il Battista presenta in due modi: Colui che battezza nello Spirito Santo e Colui che esercita il Giudizio di Dio.
1. Colui che battezza nello Spirito Santo. Il profeta Gioele aveva previsto che, alla venuta del Messia, Dio avrebbe effuso il suo Spirito su ogni essere umano (cf Giol. cap.3/ cap. 2 nelle traduzioni ebraiche). Il battesimo non lo ha dunque inventato Gesù perché Giovanni lo faceva già e per questo lo chiamavano il Battista. Anche se a Qumran si praticavano cerimonie di immersione, al tempo di Gesù il battesimo era poco diffuso e assai recente. Nell’Antico Testamento i termini battesimo e battezzare sono rarissimi; infatti, il rito di ingresso nella comunità era la circoncisione, non il battesimo e mai nella Torah si parla di battesimo. La religione ebraica prevedeva dei riti di acqua, delle abluzioni senza mai prevedere l’immersione totale nell’acqua e tutte avevano lo scopo di purificare in senso biblico: non togliere il peccato ma permettere all’uomo di separarsi da tutto ciò che è impuro perché fa parte del mondo profano, per poter entrare in contatto con il sacro cioè con Dio.
Con Giovanni Battista avviene un passaggio importante e del tutto rivoluzionario: il battesimo assume il nuovo significato di conversione e di remissione dei peccati. E’ poi lui stesso ad annunciare che con l’arrivo di Cristo il battesimo sarà ancor più diverso: Io vi battezzo con l’acqua, ma lui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. La grande novità non è nel verbo battezzare perché Giovanni sta battezzando degli ebrei nel Giordano, ma nella frase che segue “in Spirito Santo e fuoco” che deve aver avuto un effetto straordinario ed è per tale ragione che la gente accorreva in massa da Giovanni per farsi battezzare. L’espressione Spirito Santo non esisteva quasi per nulla nell’Antico testamento e le rare volte che appare l’aggettivo santo indicava lo spirito di Dio santo e non lo Spirito Santo, persona distinta della Trinità. Nell’Antico Testamento l’urgenza era liberare il popolo dal rischio del politeismo e rivelare il Dio unico per cui poteva essere eccessivo rivelare subito il mistero di Dio unico in tre persone. Si parlava del soffio di Dio che da forza vitale all’uomo e lo spinge ad agire secondo la volontà divina, ma non si era ancora rgiunti a conoscerlo come Spirito Santo persona. Le parole di Giovanni aprono la porta alla rivelazione quando annuncia un battesimo in Spirito Santo e non più un battesimo con l’acqua, segnando un cambiamento radicale. Il suo battesimo è simbolo di conversione e remissione dei peccati e annuncia un battesimo diverso: Io vi battezzo con acqua… il Messia che è già tra voi vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco dove la preposizione greca “kai” (in italiano e) non indica un’aggiunta, ma un’equivalenza per cui il Battista afferma che il Messia battezzerà nello Spirito Santo che è fuoco, cioè nel fuoco dello Spirito Santo. Luca evidenzia sempre la differenza tra il battesimo di Giovanni e quello di Gesù: Giovanni battezzava con acqua come segno di conversione, mentre il battesimo cristiano è un’immersione nello Spirito Santo, fuoco dell’amore di Dio, battesimo che innesta i credenti nel mistero pasquale di Cristo, sconfiggendo il peccato e la morte.
2. Giovanni presenta il Messia come Colui che esercita il Giudizio di Dio. Nell’Antico Testamento, il Messia veniva atteso come il re che avrebbe eliminato il male e fatto regnare la giustizia. Nei canti del Servo di Dio (nel Secondo Isaia) emerge il giudizio che il Messia avrebbe esercitato con autorità e con il fuoco. Qui Giovanni riprende il segno del fuoco come simbolo di purificazione: “Egli tiene in mano la pala per pulire la sua aiae raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la pula con un fuoco inestinguibile”. Si tratta di un’immagine che i suoi ascoltatori conoscevano e che rappresentava una buona notizia perché questa separazione non sopprimeva nessuno; questo fuoco non distrugge ma purifica. Il fuoco del Giudizio purifica senza nulla distruggere: come l’oro viene purificato e reso splendente tramite il fuoco, così il fuoco dello Spirito Santo libera chi lo riceve da tutto ciò che non è conforme al Regno di giustizia e di pace instaurato dal Messia.
Alcune riflessioni conclusive
*Giovanni invita alla condivisione senza mai giudicare gli altri. Ci capita spesso di aiutare qualcuno solo dopo esserci chiesti se lo merita, ma questo modo di agire si basa ancora sul merito, non sulla gratuità dell’amore.
*Giovanni confessa di non essere degno nemmeno di sciogliere il laccio dei sandali di Cristo. I rabbini raccomandavano di non imporre a uno schiavo d’origine ebraica un compito cosi umile e umiliante come sciogliere i sandali del maestro o lavare i piedi.
*Accorrono da Giovanni tanti publicani cioè gli esattori delle tasse che lavoravano per l’Impero Romano i quali erano tassati dai Romani e spesso recuperavano più di quanto avevano dovuto versare come loro tassa. Per questo ogni funzionario era considerato e temuto come un pubblicano.
*I soldati,dei quali qui si parla, probabilmente erano dei mercenari al servizio dei publicani e non soldati ebrei né romani. Gli ebrei non avevano il diritto di avere un esercito e i soldati romani, che ocupavano la Palestina, non si mischiavano nelle vicende della popolazione.
Buona Domenica!
+Giovanni D’Ercole